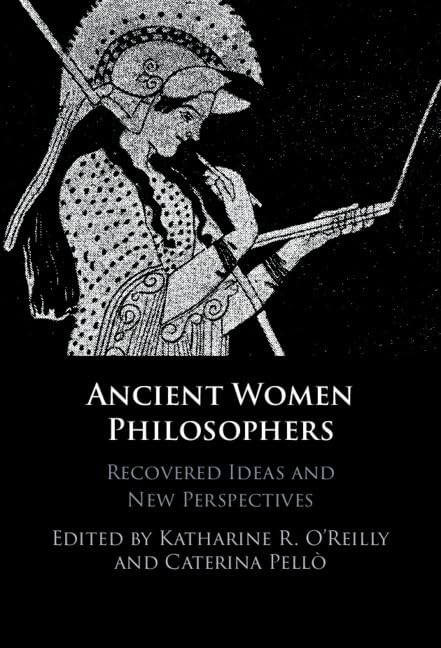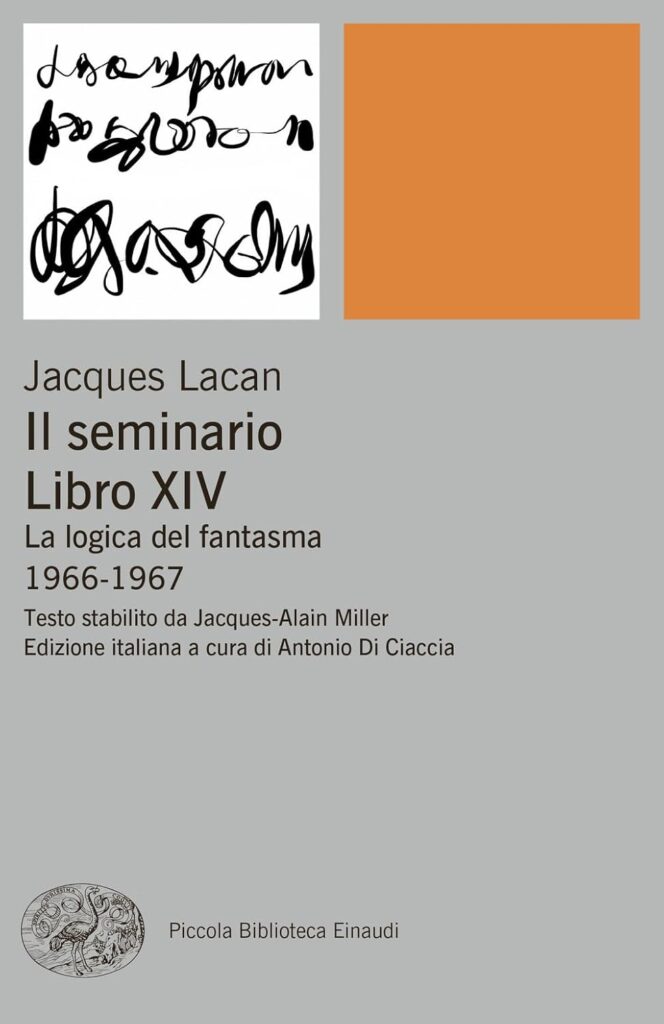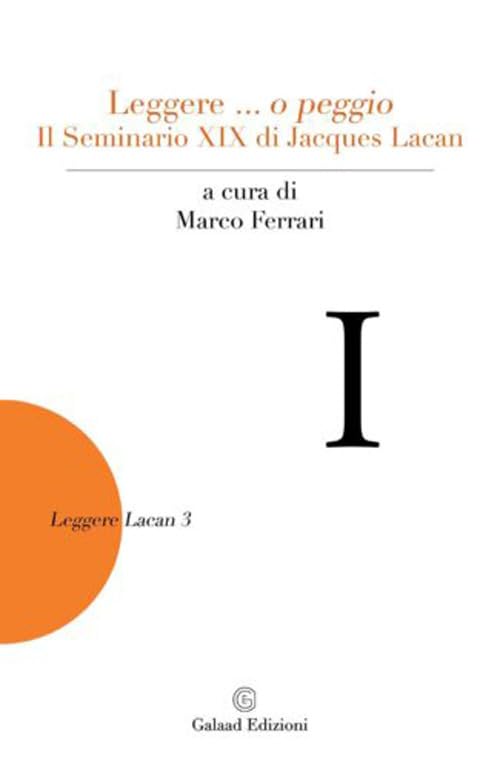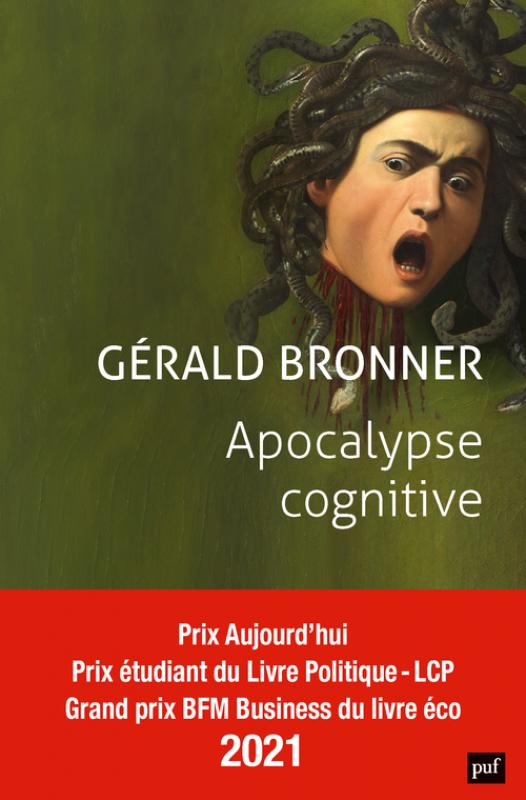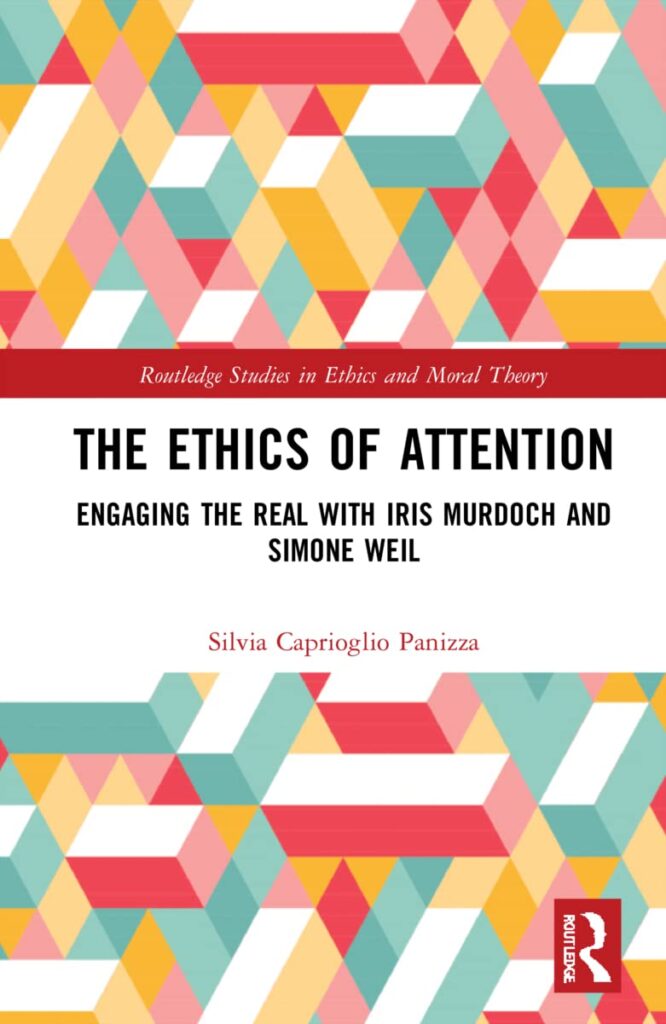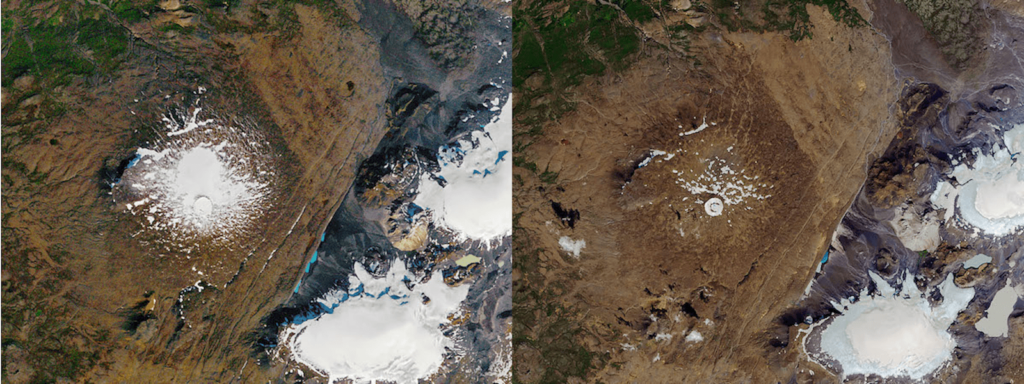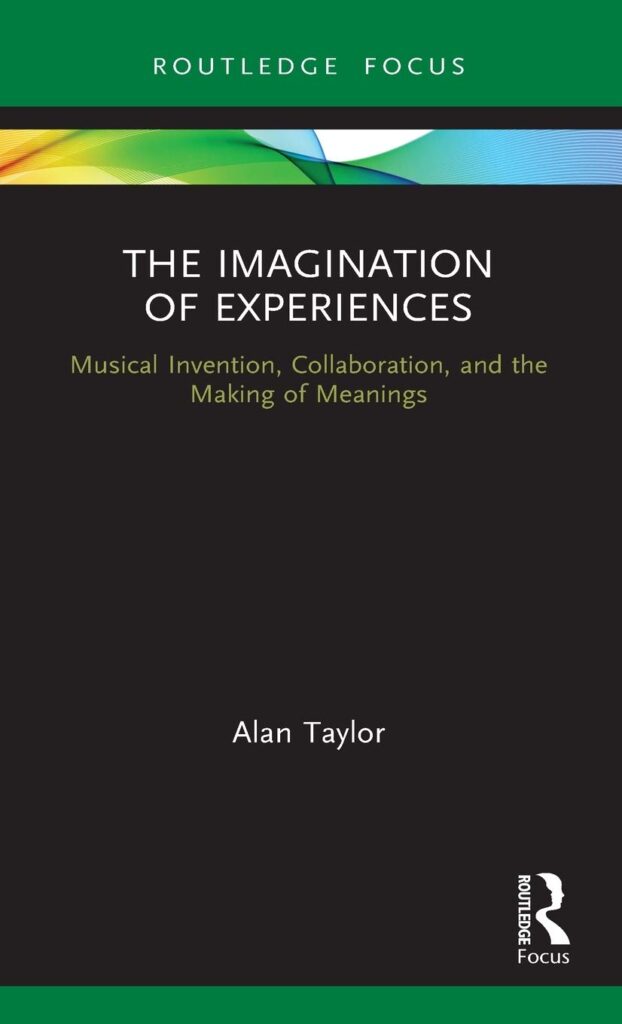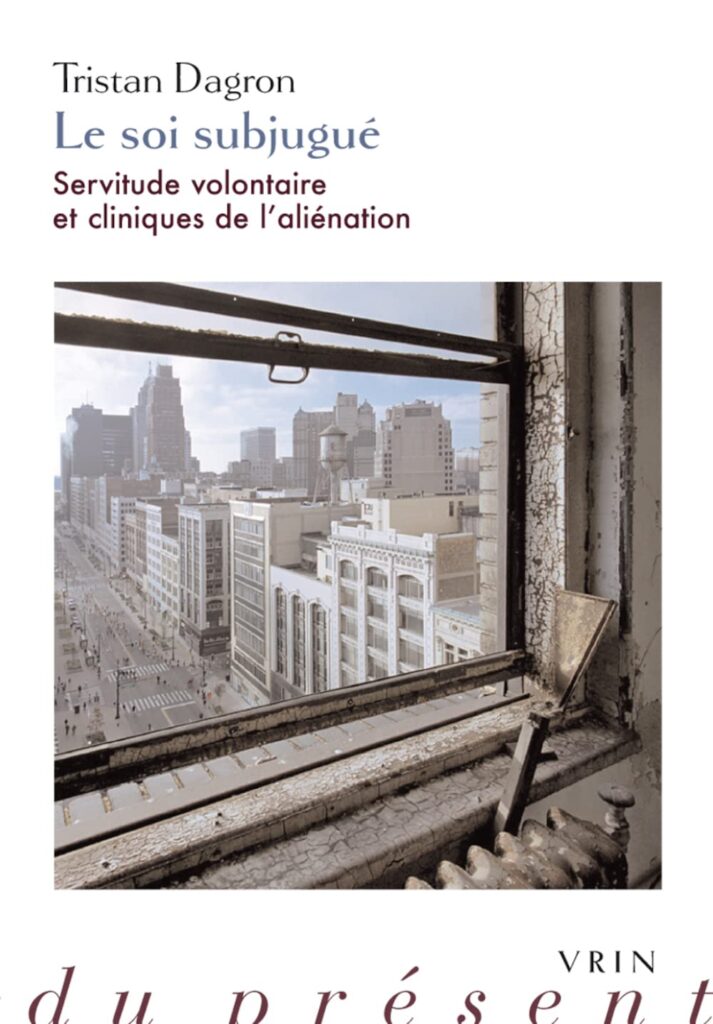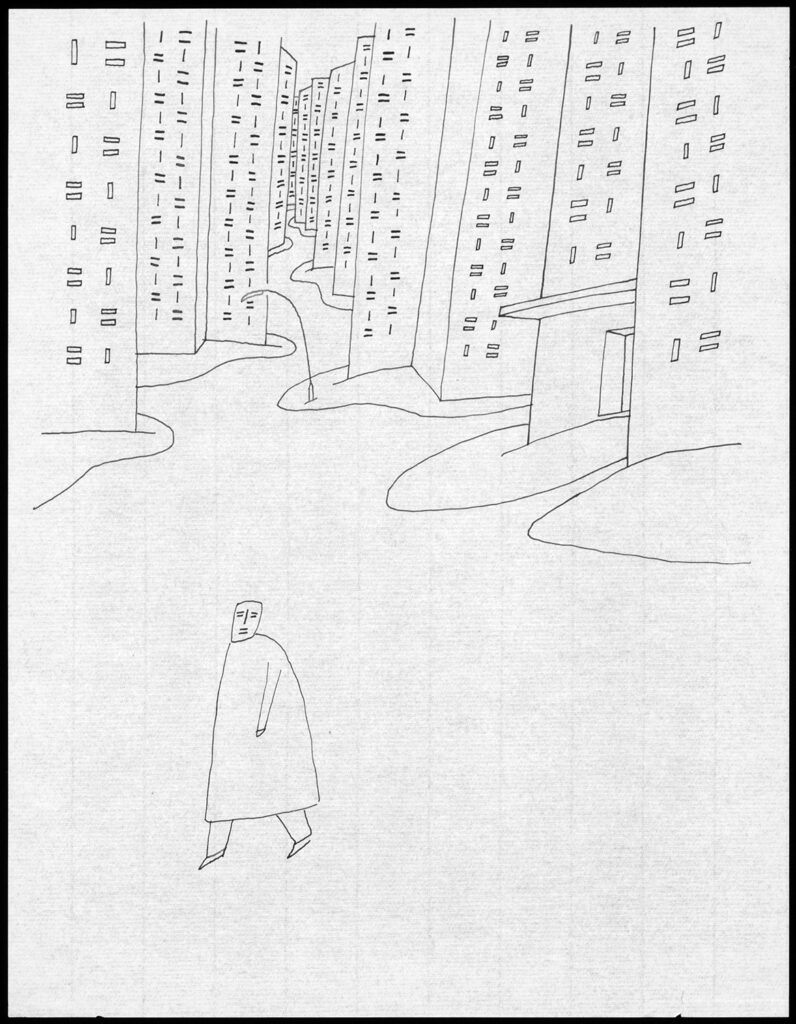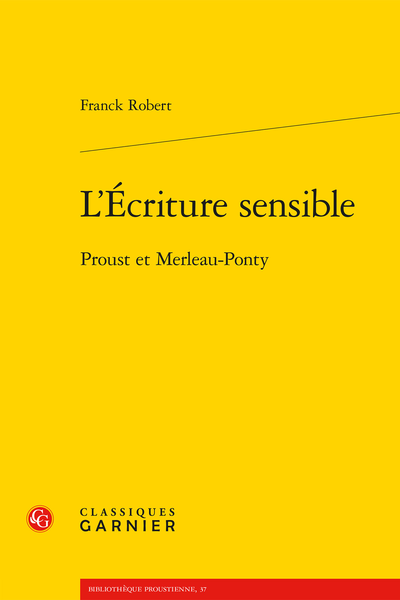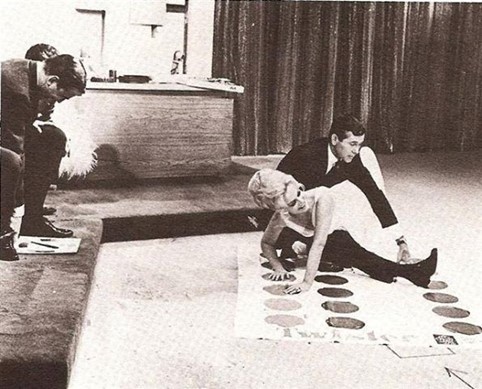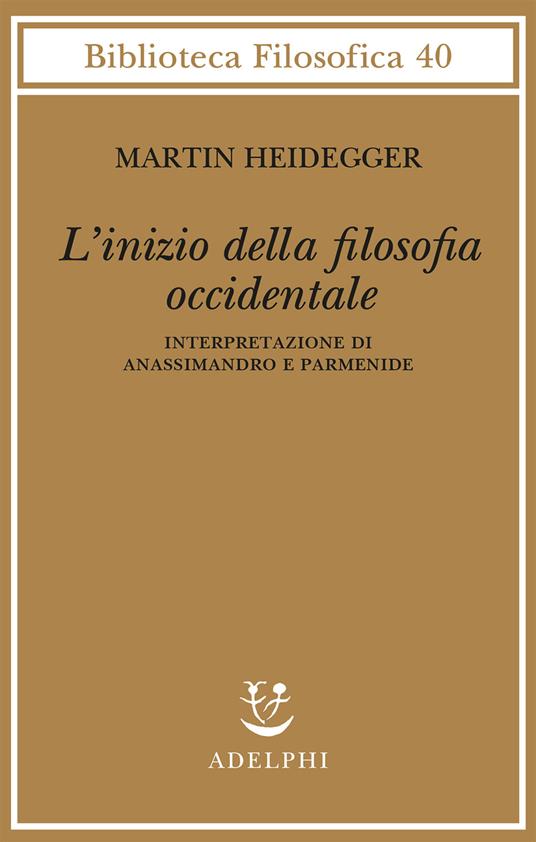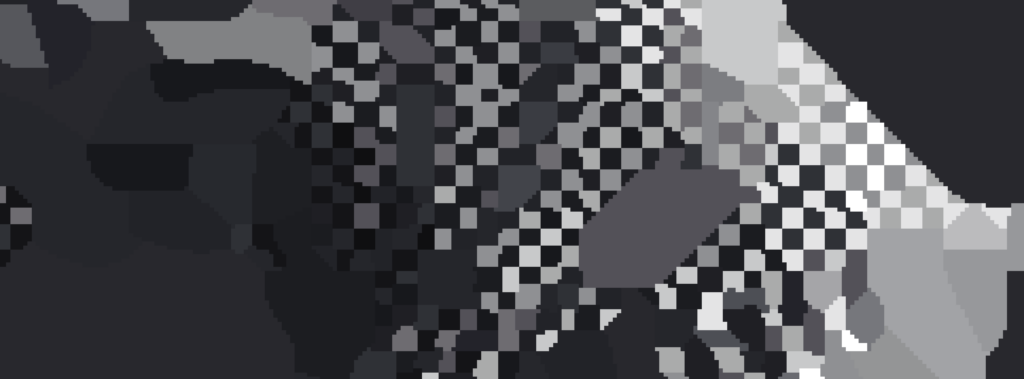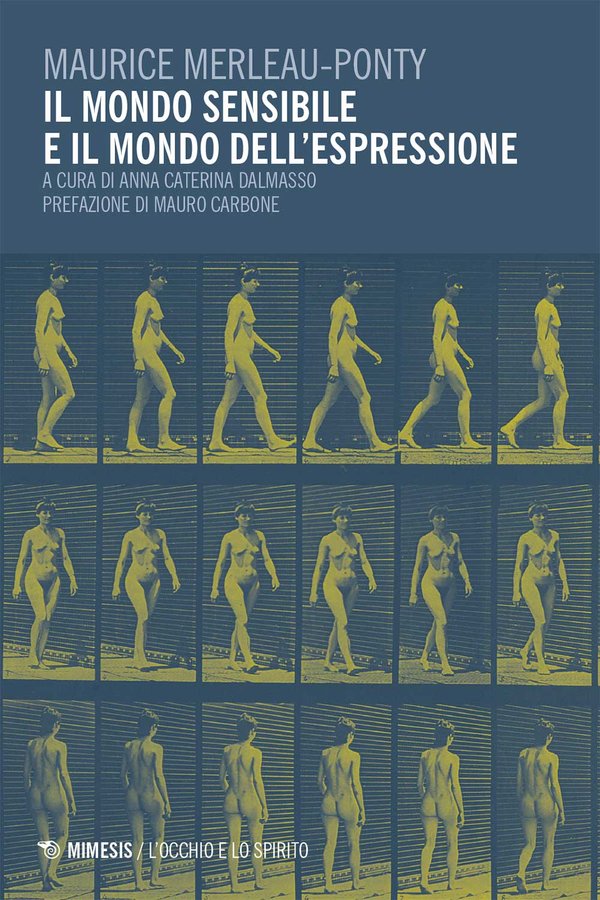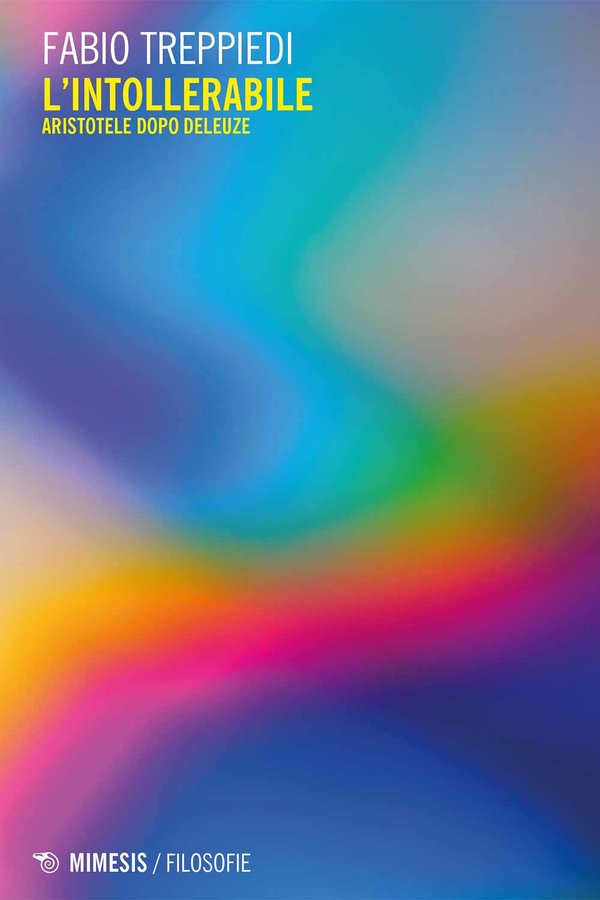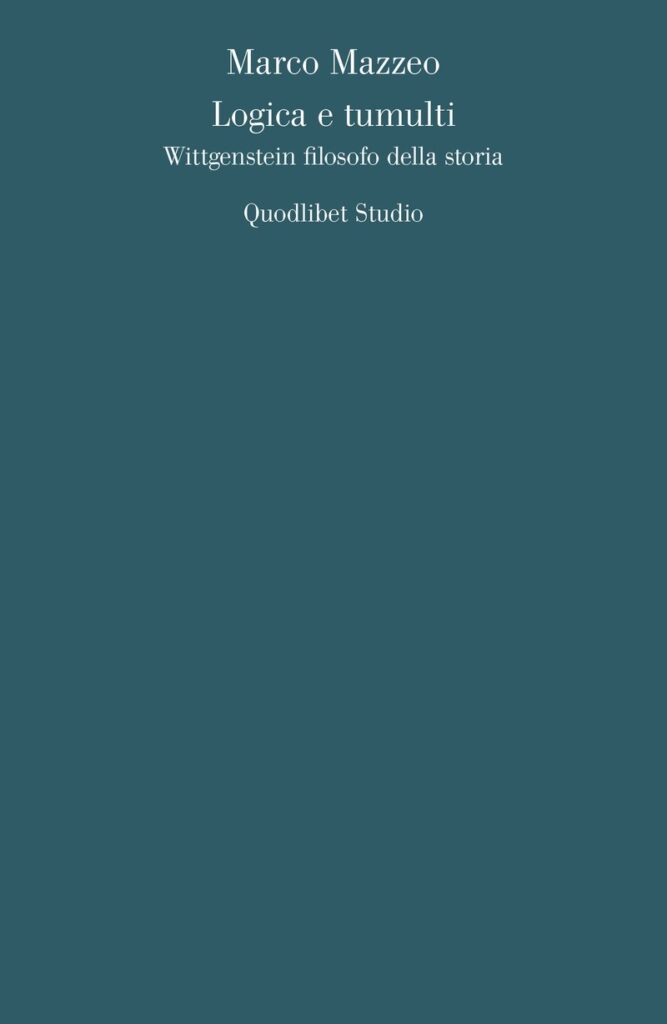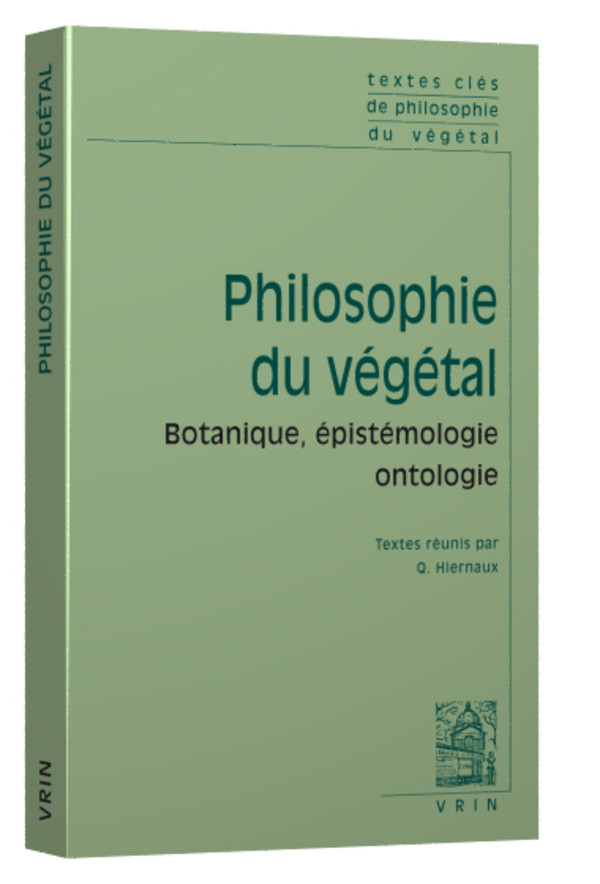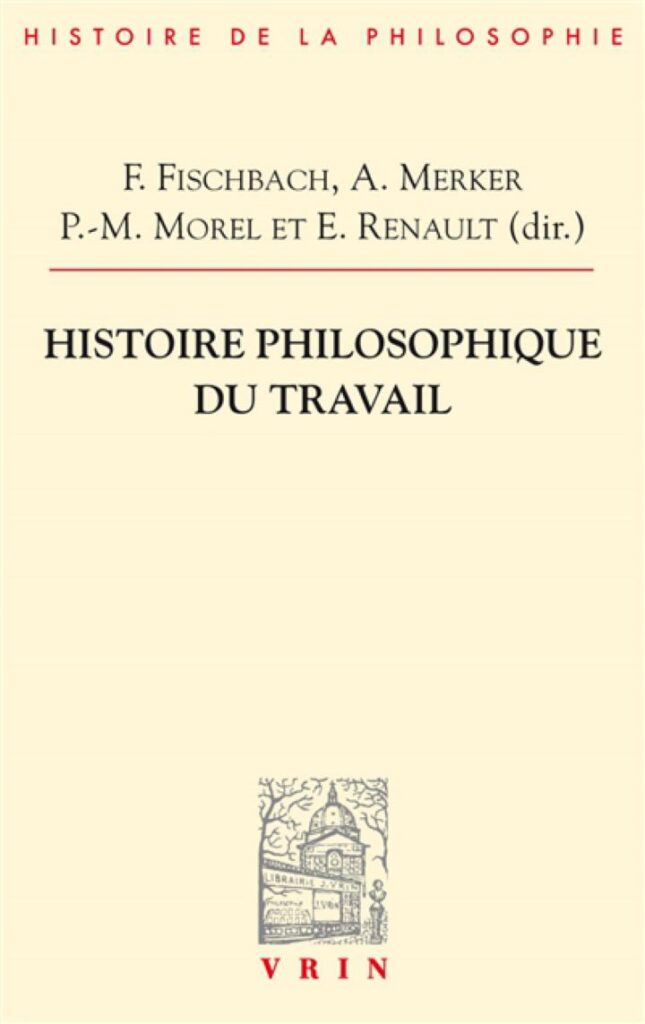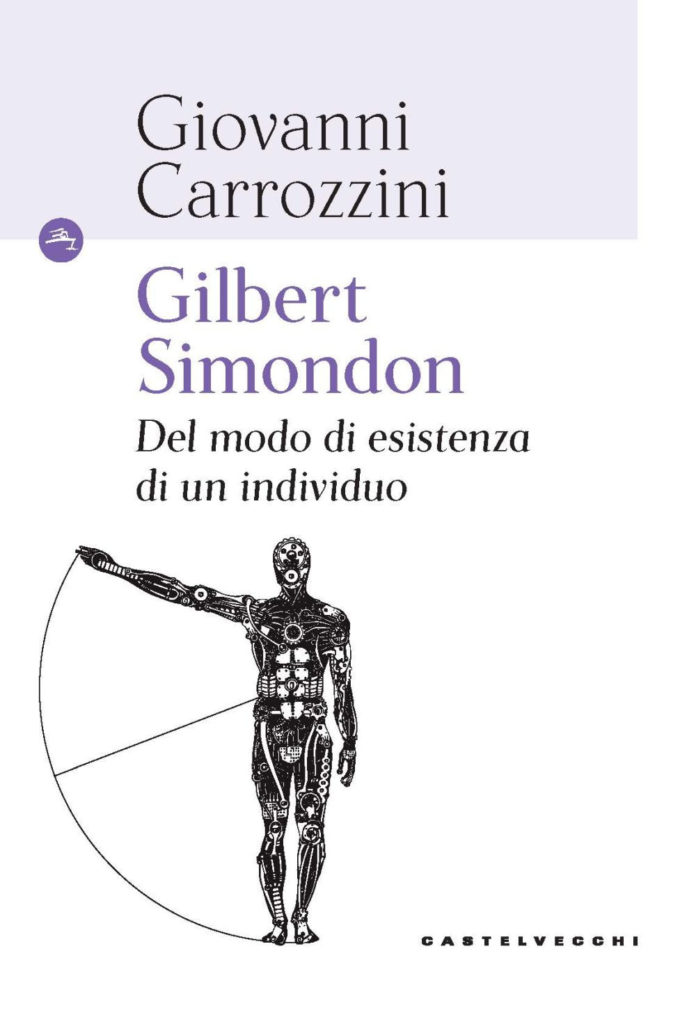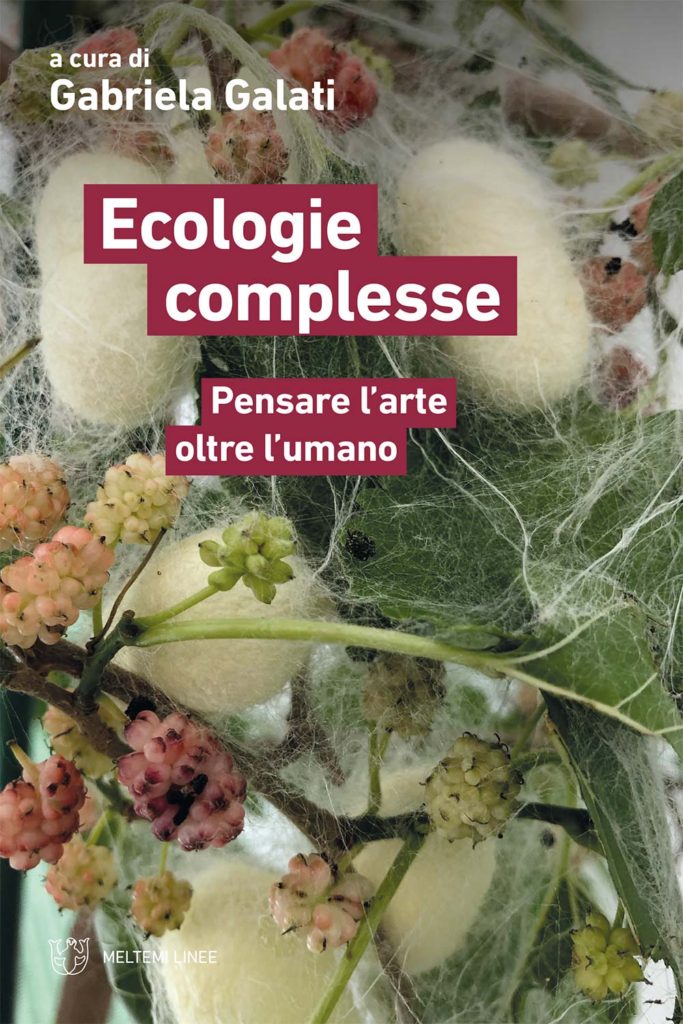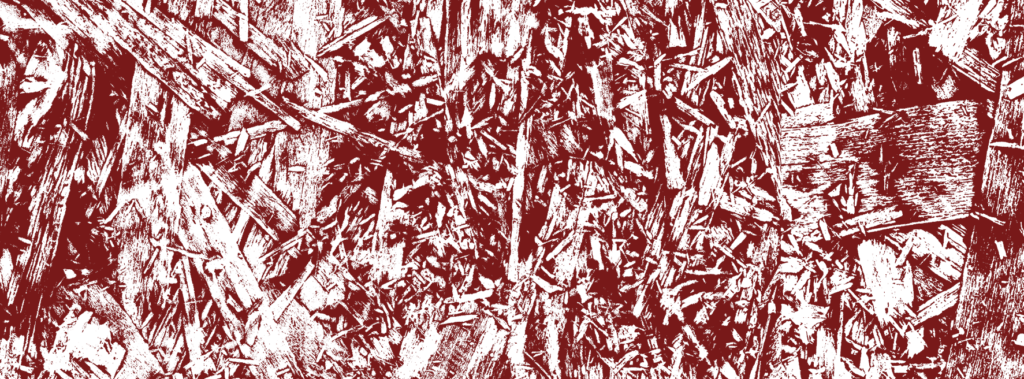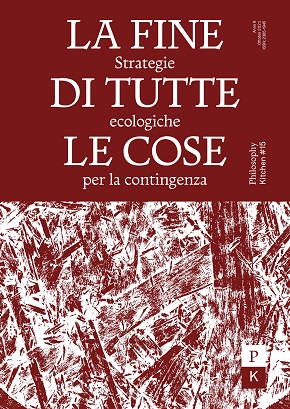-
-
Il fantasma di Jacques Lacan e l’orrore del Reale
Recensioni / Dicembre 2024Un bellissimo film uscito ormai più di vent’anni fa e diretto da Alejandro Aménabar racconta la storia di una famiglia composta da una madre, Grace (interpretata magistralmente da un’incantevole Nicole Kidman), e dai suoi due bambini alle prese con delle strane presenze, degli spiriti che infestano la loro casa di campagna. Dai disegni inquietanti della figlia più piccola, Anna, la madre capisce che la loro dimora è abitata da quella che sembra a tutti gli effetti essere un’altra famiglia: un padre, un’altra madre, un bambino e una quarta figura che Anna dice essere una strega. L’arrivo di due misteriosi anziani signori che si propongono come domestici, il ritrovamento di un album fotografico del diciannovesimo secolo in cui, secondo un’antica usanza, persone decedute vengono ritratte in posa come se fossero vive e l’insistenza ossessiva, da parte di Grace, di non far mai entrare neanche uno spiraglio di luce nelle stanze della casa, poi, sono solo alcuni degli elementi che scandiscono l’incedere di un thriller psicologico tra i più avvincenti e originali, e contribuiscono a rendere The Others (2001) un horror che non si limita a riproporre il classico topos della casa stregata ma, anzi, arriva a sovvertirlo.
In un raccapricciante susseguirsi di scene al cardiopalma, infatti, lo spettatore è accompagnato verso l’agghiacciante realizzazione, da parte di Grace, che in realtà la vera famiglia di spettri che infesta la sua residenza è proprio la sua. Lei e i suoi figli – colpo di scena – sono i veri fantasmi, e la strega che terrorizza la sua bambina è in verità una medium al soldo dell’altra famiglia, quella che si rivela essere nel sorprendente finale una famiglia di persone vive e vegete, benché spaventate a morte. Se si trovano lì, infatti, è solo perché hanno comprato una casa di campagna nella quale era stato compiuto un crimine ignominioso: un doppio infanticidio del quale la responsabile è Grace stessa, che dopo aver soffocato i figli aveva deciso, in preda alla disperazione, di suicidarsi…
Ma lo stesso espediente narrativo per cui il protagonista di una storia di fantasmi si scopre essere, alla fine, un fantasma esso stesso lo incontriamo anche in un altro film, ben più celebre e uscito solo due anni prima: Il sesto senso (1999). Qui Bruce Willis veste i panni di uno psicologo, Malcolm, che aiuta il piccolo Cole a superare l’orrore che gli impedisce di vivere: il bambino è infatti dotato del potere soprannaturale di entrare in contatto con i morti, e la cosa (giustamente) lo terrorizza. Dopo avergli spiegato che i fantasmi lo contattano perché lui, Cole, ha il potere di ascoltarli e quindi di regolare i conti in sospeso che questi hanno lasciato nella loro vita terrena, giunge anch’egli alla fine a realizzare di essere un fantasma. E così, nella celeberrima scena finale, Malcolm si accorge di essere lo spirito disincarnato di sé stesso quando scopre che la moglie, che durante tutto il film sembrava semplicemente ignorarlo e fare finta che egli non esistesse come a seguito di una lite, è in realtà letteralmente incapace di percepirne la presenza in quanto lui, ormai da molto tempo, ha smesso di vivere. Solo Cole, dotato del potere di comunicare con i deceduti, ha davvero interagito con lui durante tutto il film.
Ora: c’è una logica ben precisa che fa funzionare le sceneggiature di questi due film così bene, un criterio che impedisce di far si che i protagonisti realizzino anzitempo, ovvero prima del colpo di scena finale, che tutte le loro azioni sono mosse, in ultima analisi, dal fatale misconoscimento della loro natura di spettri. Ne Il sesto senso è lo stesso Cole a riferire a Malcolm, nell’iconica scena in cui pronuncia la celebre frase “vedo la gente morta…”, la formula di questa logica. I fantasmi dei morti, sussurra il bambino, “vedono solo quello che vogliono vedere”.
Non c’è forse formula migliore di questa per richiamare il tema centrale del quattordicesimo seminario di Lacan, “La logica del fantasma”[1], recentemente – e finalmente… – pubblicato anche in italiano da Einaudi. E quella di Cole è a tutti gli effetti una massima che potrebbe ben figurare accanto ad altri mantra nel formulario psicanalitico lacaniano, come quella che recita “l’inconscio è strutturato come un linguaggio”, o ancora “non esiste rapporto sessuale”. Dire che “i fantasmi vedono solo quello che vogliono vedere” può ben fungere infatti, come queste altre espressioni ormai divenute idiomatiche, da bussola per orientarsi nel fitto labirinto di riflessioni filosofiche e di acrobatiche cogitazioni psicanalitiche che infarciscono i testi di Lacan, e al netto dell’assonanza tra il fantasma che compare nel titolo di questo quattordicesimo seminario ed i fantasmi protagonisti dei due film che abbiamo richiamato. Questo perché il termine francese “fantasme”, che in italiano viene tradotto con “fantasma”, non ha (quasi) nulla a che fare con gli spettri, con i poltergeist in quanto tali – soprattutto da un punto di vista linguistico, in quanto gli spiriti dei morti che appaiono a mezzanotte nei castelli disabitati, sotto forma di lenzuoli volanti o di sagome traslucide, in francese si chiamano fantômes. “Fantasme”,al contrario, è un termine tecnico che nel linguaggio lacaniano indica la dimensione fantasmatica del soggetto, la coappartenenza o la coincidenza strutturali di questo alle sue facoltà immaginarie e simboliche ovvero la sua reale (per quanto spettrale) consistenza ontologica. La stoffa metafisica della soggettività così come questa è intesa dalla psicoanalisi, infatti, è irriducibile a qualsivoglia riduzione deterministica e ben si presta ad essere còlta nei termini del fantasticare, della fantasia e del fantastico. Di qui, insomma, la scelta strategica del temine-chiave francese “fantasme” che, se da una parte segna tutta la distanza possibile tra la disciplina freudiana e le neuroscienze (impegnate nella localizzazione cerebrale, e quindi nella riduzione fisica, delle facoltà psicologiche), dall’altra costringe ognuno di noi a misurarci con la stessa sconcertante verità che coglie Grace e Malcolm alla fine di The Others e Il sesto senso. Anche noi, come loro, conduciamo esistenze fondamentalmente illusorie, annaspiamo nell’inconsapevolezza di noi stessi e anche noi, in fondo, siamo fantasmi che vedono solo quello che vogliono vedere.
Il fulcro della questione, va da sé, come si tratterà di scoprire nel corso del seminario su La logica del fantasma (come nel corso di una psicoanalisi, ma questo è un altro discorso…), sta in quel “vogliono”, in ciò che anche noi vogliamo, e nel grado di consapevolezza riguardo a quei moti più reconditi del nostro stesso spirito che noi, come loro, siamo disposti a tollerare. Grace e Malcolm infatti sono fantasmi, ma in quanto fantasmi inconsapevoli (leggasi: inconsci) il loro stesso essere è confuso durante tutta la durata del film con i pensieri che questi possono e non possono fare. Il loro essere (termine-chiave per la filosofia del novecento, e riferimento imprescindibile per Lacan che non ha mai smesso di guardare ad Heidegger – il filosofo dell’Essere – come ad un maestro) si sostiene quindi su di un regime, su di una logica per l’appunto, che impone un rigido ordine di pensabilità (e quindi di speculare non pensabilità) da cui dipende niente di meno che la tenuta stessa della loro esistenza. E il centro, il nucleo della profonda meditazione condotta nel seminario La logica del fantasma è proprio questo rapporto, oscuro e vertiginoso, che sussiste tra il pensiero, l’inconscio e l’essere dell’ontologia – rapporto dal quale dipende la struttura logica del nostro volere, delle cose che vogliamo vedere e quindi, in senso lato, il nostro stesso essere.

Jacques Lacan (Wikipedia) Sarebbe davvero impossibile provare a riassumere il contenuto o anche solo proporre una breve rassegna ragionata dei temi trattati ne La logica del fantasma, seminario tra i più ricchi dell’intera avventura didattica aperta al pubblico presieduta da Lacan, a Parigi, ogni mercoledì dal 1953 al 1980. Basti dire a tal riguardo che questo corso, che si tiene a cavallo degli anni 1966 e 1967 e che costituisce un unicum con quello dell’anno successivo dedicato all’atto analitico (la cui pubblicazione in italiano è attesa per l’anno prossimo), è quello in cui la questione della formalizzazione logica dell’inconscio entra nella sua fase più viva. Certo, quest’operazione ha da sempre costituito l’obiettivo ultimo dell’approccio di Lacan alla psicoanalisi ed era stata da lungo approntata dal lavoro compiuto nel corso degli anni precedenti. Ma se nel seminario su Il desiderio e la sua interpretazione[2] quest’impresa sembrava essere giunta ad un risultato soddisfacente, con l’elaborazione del grafo del desiderio, nell’anno successivo aveva subito una forte battuta d’arresto ed era entrata in una fase di stallo nella misura in cui l’accento, li, veniva spostato sul godimento. Al corpo intessuto di quella che in lacanese si chiama jouissance e alle sue zone erogene, ovvero al versante pulsionale, ingovernabile ed incandescente della psiche umana, Lacan aveva infatti associato, nel seminario sull’Etica della psicanalisi[3] in cui si consuma questa svolta epocale nel suo insegnamento, il concetto più problematico dell’ontologia heideggeriana: Das Ding. Lo psichiatra francese innestava in questo modo la vexata quaestio del trascendentalismo kantiano (benché mediata dalla lettura esistenzialista di Heidegger) sul corpus freudiano, e rivoluzionava così la psicanalisi in modo talmente radicale ed originale da condannare intere generazioni di psicoanalisti e di filosofi a seguirlo, come uno sherpa metafisico, nelle sue impervie escursioni nel campo di un inconscio, secondo la fortunata formula di Colette Soler, completamente reinventato. Di lì in poi infatti tutti i tentativi di tradurre logicamente i processi psichici e di fondare, in ottemperanza al mandato strutturalista, una scienza il più esatta possibile della psiche umana saranno drammaticamente destinati ad un fallimento speculativo a dir poco delizioso, e ad una disfatta (filosofica in senso lato) tanto inesorabile quanto sublime. Inesorabile, in quanto si rivelerà inattuabile rendere conto di quegli eventi imperscrutabili che sono i desideri ed i godimenti umani in assenza di un saldo fondamento ontologico (e Heidegger, com’è noto, di fondamenti ontologici non ne offre…), e sublime in quanto proprio il tracciato, la mappa di queste stesse sconfitte della ragione andranno a delineare il profilo, la sagoma del sapere psicanalitico – un sapere per definizione zoppicante, incompleto ed imperniato sull’impossibile…Ma di lì in poi, allo stesso tempo, tra desiderio e godimento andrà a scavarsi una voragine che porrà questi due poli della soggettività in un’opposizione sempre più radicale tra di loro.
Sono queste, anche se davvero in breve, le ragioni che decretano la necessità di elaborare il concetto di fantasma ovvero di ciò che funziona come uno schermo che si frappone tra il soggetto e la realtà che questi vive. E Lacan, in questo seminario, tratta di questo fantasma e della logica che lo governa alla stregua di una matrice algoritmica (di cui la sezione aurea, alla quale vengono dedicate pagine e pagine tra le più confusive, non è che una metafora dal forte valore evocativo) che organizza, scandendolo in partizioni ben definite e non ulteriormente scomponibili, il rapporto del soggetto con i suoi oggetti secondo modalità che sono indipendenti, e in un certo senso anteriori, sia al desiderio che al godimento. Per questo Il mathema del fantasma è formulato così: $◊a, e rappresenta graficamente il rapporto (simbolizzato dalla losanga: ◊) del soggetto ($) con la panoplia di oggetti piccoli a dai quali trae come per luce riflessa quel che si potrebbe intendere, anche se non senza qualche riserva, come la sua vera e propria sostanza. Ma se gli oggetti piccoli a sono oggetti di cui il soggetto può godere, o che il soggetto può desiderare, quel che è più importante è che il soggetto non abbia la benché minima idea – come i protagonisti di The Others e Il sesto senso – dei meccanismi che presiedono al rapporto che questi intrattiene con loro. D’altronde i fantasmi, come dice Cole a Malcolm, “vedono solo quello che vogliono vedere”, ma non sanno davvero cosa vogliono, altrimenti non esisterebbe l’analisi…
Sullo sfondo di tutto ciò, e per meglio capire quel che c’è in ballo in questo seminario, vale la pena ricordare quello che è il grande tema che accompagna ogni dibattito filosofico di quegli anni, il problema attorno al quale si avvolgono come in una matassa tutti i fili che intessono la trama della temperie culturale parigina degli anni sessanta e settanta: la destituzione del cogito cartesiano. Lacan ritrova infatti proprio nella psicanalisi, e in quegli stessi anni, un punto di vista elettivo per operare lo smantellamento del cogito ovvero del soggetto moderno, il soggetto della scienza al quale siamo tutti innegabilmente debitori ma che troppo presto, e incautamente, trae la sua folle conclusione: ergo sum. Certo, questo è il soggetto al quale si deve tanto lo sviluppo del sapere scientifico quanto l’avanzamento tecnologico che hanno innalzato l’uomo da uno stato di quasi totale servaggio nei confronti della natura, e di insicura e frugale sussistenza, ad una condizione di dominio della stessa che non trova pari nel mondo animale. Ma la storia del novecento, con le sue trincee e le sue fabbriche di morte, aveva reso ormai palpabile già nel secondo dopoguerra come questo dominio, ed il mito del progresso che alimenta, non fossero altro che il volto imbellettato della più turpe violenza dell’uomo cogitante contro la natura e contro sé stesso. All’impostura del cogito, negli anni in cui Lacan tiene il suo seminario, è imputata allora l’accusa di essere il dispositivo mitopoietico che nel promettere all’uomo il suo essere più autentico non gli riconsegna altro, oltre che al suo ben-essere materiale, se non la smorfia feroce della sua bestialità. Non a caso si profila proprio in quegli anni (siamo in piena Nietzsche reinassance, tant’è che a Nietzsche, in Francia, ogni filosofo che voglia dirsi tale dedica almeno un libro: Foucault, Deleuze, Klossowski, Bataille, per citarne solo alcuni…) l’idea che la storia dell’umanità, la genealogia delle sue morali ed il cammino verso le progressive e magnifiche sorti della stessa sia una storia raccontata solo a metà, una narrazione filtrata dagli interessi di chi, ancora, “vede solo quello che vuole vedere”, ovvero di chi nel celebrare la ragione e nell’esercitare la disciplina si dimentica della follia e trae un piacere perverso dall’infliggere macabre punizioni (si pensi, ovviamente, ancora a Michel Foucault). Una storia, quella del destino di un continente intero e delle sue propaggini che vanno ben al di là dei suoi confini geografici, che è una storia di progresso materiale e civile vero, innegabile, ma sulla quale grava da sempre una fatale e silenziosa rimozione che ha, in gergo psicanalitico, il sapore di un rifiuto (ververfung) senza tempo. Il disagio della civiltà, il nichilismo quale approdo ultimo della cultura europea e la ridda di nevrosi che recinge la vita civile si rivelano essere allora le spie, le timide avvisaglie di una più grande rivelazione ontologica che la finzione del cogito cartesiano aveva impedito di giungere alla luce, e che in quegli stessi anni assurge a tema portante l’intera riflessione filosofica in Europa. Anche Lacan, dal canto suo, partecipa a quest’avventura intellettuale che mira a dissodare il fondo inumano ed impersonale[4] della soggettività e lo fa, da psicoanalista, percorrendo la via dell’inconscio. Restando in ascolto dell’inconscio dei suoi analizzanti sdraiati sul lettino in 5, Rue de Lille, Lacan riesuma così a suo modo, dal suo millenario oblio, la questione che si pone al di là del cogito e che ci ingiunge di ripensare l’uomo, la sua surreale sostanza, la sua posizione nel mondo, il suo rapporto con la storia (sia collettiva che singolare) e la sua pensabilità, la questione – per essere più precisi – dell’Essere.
“L’essere dell’uomo”, dice Lacan in una lezione di questo quattordicesimo seminario – del quale si rischia di non capire nulla se prima non si è inquadrata, da un’angolazione grandangolare, l’altissima posta in gioco filosofica – “ha un nome” e “per scoprire questo nome, e quello che designa, basta uscire di casa un giorno, in campagna, per fare una passeggiata. Attraversando la strada si incontra un camping, e tutt’attorno al camping, a demarcarlo con un cerchio di scorie incontrerete quell’essere verworfen (rigettato, ndr) dell’uomo che riappare nel reale. Si chiama detrito”[5].
Ora: se la funzione del fantasma consiste precisamente, come abbiamo già detto, nell’ottundere il rapporto percettivo e fenomenologico del soggetto con il mondo affinché esso giunga all’essere dimidiato (scisso tra un versante conscio ed uno inconscio, come ben raffigurato dal suo mathema: $), ovvero al prezzo di vedere solo quello che vuole vedere, va da sé che l’essere dell’uomo in quanto detrito è ciò cheviene rigettato nell’inconscio perchéè esattamente quello che il soggetto non vuole vedere. Ed è proprio qui che risiede il nucleo, il cuore pulsante di tutta la disamina del fantasma e della sua logica condotta da Lacan nel seminario in questione.
Certo, non si faticherà a riconoscere come tutto questo ci riporti per l’ennesima volta a Freud, come tutto questo non consista in altro se non nel ritornareda una parte alla negazione freudiana[6] (vero e proprio punto archimedeo dello psichismo) e, dall’altra, a quel celebre breve articolo apparso nel 1917 in Imago[7], in cui il padre della psicanalisi sostiene che il progressivo sviluppo della conoscenza, in occidente, abbia avuto come sua diretta conseguenza l’umiliazione narcisistica dell’uomo (in quanto le tre ferite narcisistiche infertegli prima da Copernico, poi da Darwin e infine da Freud stesso lo hanno costretto a ridimensionare la sua supposta centralità nel cosmo, costringendolo a vedere proprio quello che non voleva vedere)…Ma che cos’è, in fondo, tutta l’opera di Lacan se non un perpetuo ritorno a Freud?
Lungi dal profilarsi come una mera riproposizione o rimasticatura dei temi freudiani, quel che compie Lacan nel suo percorso intellettuale, ed in modo eminente ne La logica del fanatasma, è una sorta di traduzione, di aggiornamento o di rivitalizzazione del testo originario. In questo seminario si rileva infatti, e con grande brio intellettuale, la mutua embricazione di psicanalisi e filosofia, si pongono l’ontologia e la questione dell’Essere al cuore della psiche umana e si cala il dibattito sulla soggettività, della sua emergenza e del suo sviluppo, entro precise coordinate storiche. Ne emerge così l’idea assolutamente originale (e destinata a sedurre generazioni di studiosi) per cui l’intreccio tra il pensiero, l’essere e l’inconscio sia governato da una ferrea logica, da una specifica ontologia che si sostiene sull’esclusione, sul rigetto della componente più scabrosa e ripugnante del soggetto stesso. E che questi, rampollo dell’epoca moderna ed imbevuto di umanesimo e civiltà, si rifiuti di accogliere proprio la verità metafisica che gli si impone, che gli si rivela in quanto egli vive in un’epoca segnata dalla predominanza di quello che Lacan chiama il discorso della scienza. Un discorso, quello del materialismo e del riduzionismo assurti a uniche fonti di verità, che ordina a chiunque giovi degli innegabili frutti prodotti dal progresso tecnico-scientifico di accettare, a mo’ di scotto, il proprio essere essenzialmente e senza riserve lo scarto, l’inutile avanzo di processi impersonali ed anonimi che, a guardarli bene, fanno convergere su di un orizzonte assolutamente insignificante tanto il destino del soggetto quanto quello del mondo intero. “L’orrore della relazione con la dimensione dell’inconscio”, dice Lacan a tal proposito, “è tale che […] tutto è permesso all’inconscio…tranne articolare dunque io sono”[8].
E così, forte della lezione heideggeriana sull’esito nichilistico della storia occidentale ed in aperta polemica con il concetto marxista di alienazione (“È chiaro che l’alienazione nel senso marxista non ha nulla a nulla in comune con ciò che, per essere precisi, non è altro che confusione”)[9], con la fenomenologia (abbagliata dal miraggio della Selbstbewusstein, l’autocoscienza) e con la filosofia esistenzialista di Sartre (al quale, avendo affermato in una celebre pièce teatrale che “l’inferno sono gli altri”, risponde con un sonoro: “Se l’inferno è da qualche parte, si trova in Io”[10]) Lacan si impegna a fornire qui gli strumenti concettuali utili a mostrare le dinamiche sottese alla quotidiana impostura che chiamiamo la nostra identità, ai raggiri che architettiamo per assicurarci le nostre (in)soddisfazioni e, in breve, ai fantasmi che ci burattinano. Gli stessi fantasmi, cioè, che occultano il segreto più inaccettabile, più osceno e scabroso della psicanalisi: la struttura sadica e masochistica che giace al fondo dell’animo umano[11] e che condanna ognuno di noi alla ricerca, spasmodica e vana, di soddisfazioni artificiali e sintetiche. Ed è proprio in questo corso, infatti, che Lacan porrà le fondamenta concettuali per la sua originalissima e pirotecnica critica alla società dei consumi, quell’assemblaggio frankensteiniano di Hegel, Freud e Marx che giunge a maturazione nei seminari degli anni successivi, in concomitanza con l’esplosione a Parigi della grande contestazione e quasi come in risposta agli attacchi mossi al suo indirizzo da Deleuze e Guattari nell’Antiedipo.
Per concludere queste brevi riflessioni che, lungi dal voler sintetizzare il contenuto de La logica del fantasma, si limitano a richiamarne alcuni snodi concettuali decisivi, vale la pena menzionare un paio di ragioni per cui crediamo che questo seminario, cronologicamente a dir poco datato, abbia ancora molto da dire e offra più di uno spunto utile per comprendere il presente in cui viviamo. Al lettore attento, infatti, non sfuggirà come due temi di stringente attualità, due veri e propri fantasmi del mondo contemporaneo, compaiano fugacemente, come lampi, in queste lezioni tenute nell’anno accademico 1966 – 1967 e ripubblicate oggi, a distanza di più di cinquant’anni. L’impressione a dir poco perturbante che accompagna la lettura di questi passi è quella di un Lacan redivivo che torna, come uno spettro, dal regno dei morti per indicarci l'assurdità e l’apparente infondatezza di due delle illusioni che infestano il mondo contemporaneo. Ci riferiamo alla negazione del dimorfismo sessuale, così come questa viene propugnata in alcuni circoli (sedicenti) intellettuali, e all’illusione che soggiace al culto tecnopagano dell’Intelligenza Artificiale.
Se nel primo caso è vero che il tema dell’orientamento sessuale e dell’identificazione con uno dei due sessi (“gender”, in quegli anni, non era una parola in uso) verrà sviluppato più a fondo nei seminari degli anni seguenti e che manchi, ne La logica del fantasma, un vero approfondimento in merito, è comunque interessante notare come Lacan si riferisca in una lezione di questo quattordicesimo seminario al dimorfismo sessuale come all’“idea infernale di Dio”[12]. E se è interessante notarlo è proprio perché oggi, a mezzo secolo di distanza, la negazione del dimorfismo sessuale avallata dai gender studies tradisce un evidente orrore, per riprendere le stesse parole di Lacan citate più sopra, della relazione con la dimensione dell’inconscio. Disconoscere la realtà della differenza sessuale in tutta la sua inemendabile ed inaggirabile evidenza, infatti, non può essere che una questione relativa alle fantasie, alle fantasticherie e ai fantasmi che circolano in certi ambenti accademici. Ambienti in cui la mera constatazione di un fatto elementare come la differenza biologica tra maschi e femmine viene sovrainvestita di significati politici ed è intesa, in sé, come qualcosa di inammissibile – di infernale, per l’appunto. Sarebbe interessante indagare il perché di questo rigetto, di questo palese ed irrazionale rifiuto (ververfung) del corpo, inteso nella sua più viva carnalità, come oggetto piccolo (a). Qui però ci limitiamo a sottolineare l'allarmante similitudine tra i personaggi interpretati da Nicole Kidman e Bruce Willis nei due film che abbiamo citato, i quali si rifiutano di accettare l’idea di essere morti, e chi nel nome di un’identità di genere (per altro in alcun modo oggettivabile…) si rifiuta di essere sessuato. Non c’è forse parallelismo più calzante che possa esemplificare, e nel modo più paradigmatico, quel che in psicanalisi si intende per fantasma.
Per quanto riguarda l’Intelligenza Artificiale, invece, in una delle prime lezioni Lacan riporta al suo uditorio le impressioni suscitategli dalla lettura di un articolo in cui veniva descritto uno dei primi, rudimentali chatbot. Il programma, prodotto dall’IBM, si chiamava Eliza ed è curioso notare come Lacan si riferisca, più che al meccanismo di questo dispositivo che ricombina dei significanti in un modo che ricorda vagamente il funzionamento dell’apparato psichico, all’effetto suggestionante prodotto dall’interazione con questa applicazione come ad una sorta di transfert. “Il punto”, dice Lacan, “non è che una macchina sia capace di dare risposte articolate semplicemente quando le si parla” perché quel che c’è di davvero interessante, nell’uso di questi marchingegni, è “che si rivela essere un gioco […] che mette in questione ciò che, per il fatto di ottenere tali risposte, può prodursi in chi parla alla macchina”[13]. In poche battute il lungimirante psichiatra parigino presagiva così quella che sarebbe stata, e solo in anni recenti, una vera e propria sbornia collettiva davvero poco giustificata sul piano razionale ma molto comprensibile se teniamo conto del fatto che i fantasmi, ancora, “vedono solo quello che vogliono vedere”. Per quanto sia dilettevole (e possa risultare in qualche occasione anche utile, è innegabile) interagire con dei motori di ricerca molto più avanzati di Google e dotati della capacità di rispondere in prima persona all’interlocutore, infatti, è necessario ammettere senza riserve che le aspettative affidate allo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale sono quantomeno malriposte. Il disorientamento che coglie chi crede davvero di avere a che fare con forme di coscienza artificiali, ad esempio, e che ha ingenerato ingiustificati timori dal retrogusto distopico-fantascientifico[14], non tiene conto del fatto che queste tecnologie che simulano la condotta di entità coscienti non sono in verità altro che simulacri, fantocci. Nessun rischio e nessuna reale minaccia esistenziale proviene davvero da questi programmi – i quali, per parte loro, non sono dotati di nessun tipo di intenzionalità e si limitano a riprodurre associazioni tra simboli che, se risultano funzionali, è solo perché sono state decretate statisticamente rilevanti dai loro programmatori…Se esiste un vero pericolo, insomma, e se c’è qualcosa che merita non senza ragione le nostre preoccupazioni apocalittiche, questo non è di certo l'immaginaria vendetta delle macchine divenute come per magia senzienti, ma è proprio la struttura primitiva e fondamentalmente superstiziosa della soggettività umana. A costituire oggi una reale minaccia esistenziale per la nostra specie, infatti, è soprattutto la nostra naturale proclività a credere nelle illusioni, alle chimere, e a proiettare sugli oggetti il contenuto rimosso della nostra volontà per celare la reale indifferenza del mondo nei nostri confronti…in altre parole: l’architettura fantasmatica dell’animo umano. La stessa che Lacan coglie sapientemente, in questo seminario, nei termini di un groviglio inestricabile tra pensiero, essere e inconscio.
Questo intreccio, questo imbroglio che avviluppa da una parte la storia della cultura umana e dall’altra l’evoluzione biologica (benché quest’ultima resti confinata al di fuori del discorso lacaniano, in quanto di psicologia evolutiva si comincerà a parlare solo negli anni settanta) alligna nelle profondità oscure del processo adattativo che ha condotto all’emergenza della psiche così come noi oggi la conosciamo. Gettare lo sguardo in questo abisso senza fondo di processi adattativi randomici, di gelidi meccanismi impersonali che hanno plasmato tanto il corpo quanto la mente dell’uomo nell’indifferenza più totale della natura e nel silenzio più agghiacciante dell’universo, infatti, è qualcosa che val bene un rigetto (ververfung) in quanto lì lumeggia un orrore dal quale siamo portati comprensibilmente, come i protagonisti di The others e Il sesto senso, a volgerci altrove. Ma di fronte a questo spettacolo raccapricciante ed insopportabile, letteralmente insimbolizzabile – ovvero l’orrore del Reale, a paragone del quale anche il film horror più spaventoso rischia di sembrare una barzelletta… – le scelte, sembra dirci Lacan, sono solo due: guardare dall’altra parte, e scegliere di continuare a vedere solo quello che vogliamo vedere, o fissare lo sguardo proprio su ciò che non vogliamo vedere. Il rapporto del soggetto con l’inconscio, ed il nostro destino di soggetti, dipende da questa decisione tra l’illusione e l’orrore. “L'inconscio” infatti, come ebbe a dire Lacan, “così fragile sul piano ontico, è etico...e comunque sia bisogna andarci dentro”[15].
Filippo Zambonini
Bibliografia:
Benvenuto S., La psicanalisi e il reale.“La negazione” di Freud, Orthotes, Napoli, 2015
Lacan J., Il seminario VII. L'etica della psicanalisi (1959 – 1960), Einaudi, Torino 2008
Lacan J., Il seminario VI. Il desiderio e la sua interpretazione (1958 – 1950), Einaudi, Torino 2015
Lacan, J. (2003). Seminario XI: I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi. Einaudi, Torino
Lacan J., Il seminario XIV. La logica del fantasma (1966 – 1967), Einaudi, Torino 2024 https://time.com/6898967/ai-extinction-national-security-risks-report/
S. Freud, Una difficoltà della psicoanalisi, in “Opere”, Bollati Boringhieri, Torino, 1976, vol. 8, pp. 657-644.
xxx
Note:
[1] Lacan J., Il seminario XIV. La logica del fantasma (1966 – 1967), Einaudi, Torino 2024
[2] Lacan J., Il seminario VI. Il desiderio e la sua interpretazione (1958 – 1950), Einaudi, Torino 2015
[3] Lacan J., Il seminario VII. L'etica della psicanalisi (1959 – 1960), Einaudi, Torino 2008
[4] Rimandiamo l’approfondimento di questi temi al numero di Philosophy Kitchen dedicato proprio al concetto di impersonale: https://philosophykitchen.com/2016/09/limpersonale-si-pensa-si-sente-si-crea-the-impersonal-it-is-thought-it-is-felt-it-is-created-2/
[5] J.Lacan, Il seminario XIV. La logica del fantasma (1966 – 1967), op. cit., p. 103
[6] Ci permettiamo a tal proposito di segnalare l’imprescindibile S. Benvenuto, La psicanalisi e il reale.“La negazione” di Freud, Orthotes, Napoli, 2015
[7] S. Freud, Una difficoltà della psicoanalisi, in “Opere”, Bollati Boringhieri, Torino, 1976, vol. 8, pp. 657-644.
[8] J. Lacan, Il Seminario XIV. La logica del fantasma. 1966 – 1967 , Einaudi, Torino 2024, p. 88
[9] Ivi p.137
[10] Ivi p. 136
[11] La struttura sadica e masochistica del soggetto lacaniano, sia detto per inciso e con una punta di ironia, è forse da leggersi come un pleonasmo e non risparmia in fondo davvero nessuno (anche se, ironia a parte, la vera lezione della psicanalisi consiste proprio nel porre in altissima considerazione il conflitto del soggetto contro sé stesso, colto in tutta la sua brutale gratuità, ed è precisamente in questo punto che converge tutta l’analisi dell’alienazione condotta ne La logica del fantasma). Basti pensare, a tal riguardo, che lo stesso redattore dei seminari di Lacan, il genero e testamentario Jacques Alain Miller, sta centellinando da anni e a dir poco sadicamente la pubblicazione di un’opera che a detta sua è già stata completamente stilata (tant’è che, com’è noto, se ne può trovare anche una versione completa in francese, benché a cura di un altro allievo di Lacan, su questo sito: http://staferla.free.fr), e mai come in questo seminario si rivela avaro di riferimenti e di dettagli la cui assenza rende ancor più ostica, se possibile, la lettura del testo. Nella prima parte, ad esempio, mancano due indicazioni bibliografiche che sono imprescindibili per capire quel che si intende in questo seminario per logica. A pagina 44 dell’edizione Einaudi la relazione di Miller di cui si parla è "La Sutura" (pubblicata in italiano in Cahiers pour l'analyse. Scritti scelti di analisi e teoria della scienza. Bollati Boringhieri, 1977), mentre a pagina 67 l'articolo che cita Lacan è "Le sens du mot « structure » en mathématiques", di Marc Barbut (reperibile solo in francese in Les temps modernes, n°246, nov. 1966). L’intervento di Roman Jakobson del primo febbraio 1967, invece, non è stato proprio trascritto, né vi sono riferimenti che permettano di rintracciarlo.
[12] Ivi p. 310
[13] Ivi p. 42, 43
[14] Ci limitiamo a segnalare, a titolo illustrativo, questo articolo del Time: https://time.com/6898967/ai-extinction-national-security-risks-report/
[15] Lacan, J. (2003). Seminario XI: I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi. Einaudi, Torino, p. 34, corsivo mio.
-
Lungo la via
ronzio di api
e i nostri passi
(F. Nun)
La prima parte di Waggle dances. Oscillazioni scodinzolanti si può leggere qui. Ciò che segue è un’intervista nata entro la cornice della residenza artistica “Merleau indiano_Filosofia per ambienti_” a Giovanni Impellizzieri, performer e dancemaker, e a Chiara Organtini, Project manager della Lavanderia a Vapore, luogo in cui il progetto è stato ospitato. L’intervista è di Emanuele Enria. Il progetto citato si iscrive nella ricerca di un incontro tra pratica filosofica e pratiche artistiche, innanzitutto quali pratiche corporee. Ringraziamo G. Impellizzieri e C. Organtini per essersi prestati all’intervista.
Che cos'è l'azione performativa?
Trisha Brown risponde in un’intervista: «La relazione sempre aperta tra regole ed espressione, stasi e dinamismo, vincolo e libertà. È un rovesciamento in cui il live precede e determina la coreografia».
Così in Dance Well la danza, l’eco del gesto che si fa parola, l’eco della parola che si fa gesto che trasuda il movimento del dialogo e della scrittura, determinano una coreografia. Confini, come margini su cui sostare. Limiti fisici che si trasformano in orizzonti, in uno spazio e un tempo altri a cui approdare. Situazione estrema del limite, quest’anno, come possibilità di lottare, creare, scuotere per scrivere col nostro proprio gesto uno spartito che definisca nuove traiettorie. Una composizione polifonica per stare al mondo, così veloce da non scorgere le differenze e così lenta da mostrare l’azione del gesto unico di ognuno. Libertà è non pensare? Il corpo pensa? La parola può danzare? La risposta: una nuova domanda, continua ricerca, continuo dialogare di corpi pensanti e pensieri danzanti. Riflessioni e flessioni fisiche che ci trasformano. Ricerca che si fa azione di resistenza all’abitudine, alla routine, che scardina pregiudizi, dove il possibile si realizza in forme di pensiero-corpo.
Seduti iniziamo a cercare la libertà, dov’è?
Portati dallo sguardo troviamo un appoggio per spiccare il volo; i piedi non sono d’accordo, ma con il cuore lo sforzo si fa più intenso. L’attrito tra pensiero, sentimento e volontà genera una risata liberatoria. Dalla sedia alla terra proviamo a seguire i fiori trasportati dall’aria, dalla terra al cielo i nostri fiori si incontrano. Che cos’è la libertà? Com’è la libertà?
«L’azione umana è soggetta a vari tipi di vincoli. Quello biologico: siamo membri di una specie animale e le nostre capacità emotive e intellettive sono tali in virtù della selezione naturale. Quello istituzionale/organizzativo: ognuno di noi si muove dentro spazi strutturati, con regole scritte e non scritte – laddove la più potente di tali realtà istituzionali è lo stato. Vi è infine il vincolo dato dalle norme morali. Quale spazio di manovra resta allora ai singoli, al fine di poter plasmare la propria esistenza in modo libero e autonomo? Tale spazio sorge e cresce dall’ascolto del desiderio, da un confronto con le proprie pulsioni – su questo terreno germoglia infatti non solo l’aspirazione al godimento e alla felicità, ma soprattutto la pulsione verso la libertà» (Leghissa, Il Vincolo e la Libertà).
(Bollettino Dance Well 25 aprile 2021) waggle dances
Il performer contemporaneo troverà l’appoggio per il nuovo balzo abitando la distanza con uno sguardo sempre sul prato, sul non previsto, sull’inciampo che prevede l’esposizione di una vulnerabilità. Dovrà praticare danze scondinzolanti, oscillazioni e un’attenzione fenomenologica verso i fenomeni come un tentativo di mettere in discussione la divisione stessa tra soggetto e oggetto, cioè come un tentativo di evidenziare la coemergenza di mente e mondo (Gallangher & Zhahavi, La mente fenomenologica. Filosofia della mente e scienze cognitive, Milano: Raffaello Cortina Editore). waggle dances
Sulla strada, mossa dalle domande sulla mia pratica e dalla tensione a immaginare nuovi intrecci tra pratica di danza e pratica di filosofia, incontro il lavoro dell’artista Giovanni Impellizzieri; un lavoro che nel suo procedere nella creazione, attraverso lo stratificarsi di pratiche riflessive e espressive già nel suo nominarsi Pratica Pratiche_Pratiche si interrogava su cosa sia danza, da dove si origini e che intendeva la coreografia come dispositivo di soggettivazione e de-soggettivazione, per generare ambienti e istruzioni per la pratica. Domande e procedure analoghe che guidavano anche il mio procedere nella pratica di filosofia e che ci hanno immessi in un processo di concatenamenti veloci tra visioni e concetti con il desiderio di osare un tentativo di ricerca di un Tra danza e filosofia che ha preso forma attraverso la residenza artistica MERLEAU INDIANO_filosofia per ambienti_ e che per me partiva dalla domanda Facciamo la stessa pratica?
Un’esperienza dalla quale ho provato con le parole a cogliere il nettare:
un evento di composizioni, un istante, un evento di pensiero che cercherà le parole per esprimere un nodo di concatenamenti, una possibile via di fuga.
Ripercorrere strade asfaltate per tracciare nuovi sentieri. Tuffarsi per andare a fondo nello spazio bianco. Tra utopie ed eterotopie pensare il futuro, essere archeologi nell’oscillazione perché lì sta la filosofia, dappertutto e da nessuna parte; sulla soglia del desiderio abitare la distanza come l’infanzia abita il mondo. Radicale meraviglia, tra curiosità e stupore, danzare il non sapere, disattendere il conosciuto. Farsi carne e ossa per tracciare linee di fuga, tra i millepiani del potere scavare con un ramo la conoscenza del possibile; fare di una pozzanghera un mare e nuotare la superficie; come oceano tra discorso e corpo domandare la meraviglia di uno spazio esteso per regalarci la cura di un tentativo di accordo, la cura del mondo tra visibile e invisibile. Sostare in una terra di mezzo dove immaginare il futuro, dove essere sempre ancora curiosi dell’esistere per agire nuove nascite ancora e ancora; con impegno e ostinazione pensare col corpo e con le cose per farsi ambiente. Piovono pollini, semi di esistenza che nascono germogli di un divenire animale, di un divenire donna per liberare l’umanità. waggle dances
Qui di seguito un’intervista di Emanuele Enria a Giovanni Impellizzieri e Chiara Organtini (Project manager della Lavanderia a Vapore). Sono punti di osservazione e azione legate al lavoro di residenza, che testimoniano di processi e pratiche in essere nello spazio del Terzo paesaggio. Luoghi e persone abitati nei miei voli di orientamento e raccolta.
Emanuele: Partecipando a una giornata della Residenza, ho osservato come tu abbia costruito una sorta di dispositivo da attraversare. C’erano stimoli vari, oggetti, suoni, libri, persino delle mini sequenze di esercizi di riscaldamento da ripetere. Ci racconti come hai concepito questo dispositivo e cosa ti aspettavi da questi stimoli? Waggle Dances
Giovanni Impellizzieri: Lo spazio della residenza è concepito come un ambiente di formazione e autoformazione per creare interazioni dal vivo dove la danza è vista come una forma di autonomia del vivente, una forma di intelligenza, di presenza, di intensità percepibile attraverso i corpi, di comportamento emergente; la coreografia, una forma di organizzazione di un certo materiale nello spazio e nel tempo. All’interno del dispositivo si indagano temi come percezione, immaginazione e potere connessi all’indagine sul movimento e la composizione istantanea mettendo in discussione le tecniche apprese dai mover attraverso le tecnologie del corpo, un discorso su tutte le operazioni necessarie per adattare le proprie strutture (cognitive e anatomiche) al tempo e allo spazio della danza da generare. A un allenamento intellettuale e somatico segue la trasmissione di pratiche corporee con lo scopo di sondare processi, sollecitare le possibilità espressive e adattive della materia corporea. Le pratiche si presentano come dei compiti da svolgere, istruzioni utili per fare emergere danze. La ricerca è sensibile verso la costruzione di paesaggi mediante il design e le relazioni tra corpi e ne indaga le potenzialità a partire da coordinate condivise quali tempo e spazio, propone una modalità di comporre in maniera estemporanea e promuove l’accettazione di ogni possibile azione come danza. Nel momento che precede l’azione danzante attraverso la trasmissione dei dati generativi, ci si chiede cosa so fino adesso? Le pratiche corporee condivise sono in primis pratiche dei saperi, ciascuna di esse sottende differenti attitudini, immaginari corporei, sollecitati a emergere attraverso l’adesione a un comportamento danzante in cui si attualizzano utopie concrete avvicinando anatomie reali ad anatomie fantastiche in un esercizio sperimentale di libertà. Foucault conclude il suo Utopie ed Eterotopie dicendo che ci piace tanto fare l’amore perché nell’amore il corpo è qui: noi diciamo che ci piace tanto danzare perché quando danziamo il nostro corpo è qui, o per meglio dire, noi siamo qui.
Il corpo archivia ciò che la danza disarchivia come quella virtù che ridefinisce corpi e relazioni: è in questa archeologia del presente che emergono le presenze.
Gli stimoli sollecitano in chi attraversa l’ambiente, sperimentando le pratiche, un ricoreografare il desiderio inscrivendolo in un processo in cui la sospensione del giudizio è necessaria per conoscere qui e ora ciò che ancora non si sa, danzando e generando imprevisti e jamais vu. Più che di aspettativa, parlerei di Speranza, speranza di essere nuovi attraverso un’esplorazione silenziosa dell’inatteso in cui fioriscono nuovi tentativi, slanci, sguardi, mondovisioni a partire dalla condivisione di un costruttivismo impregnato di valori plastici, eidetici, cromatici, sonori, etici, politici. È attraverso accordi muscolari che trasformiamo “io” in “noi”, è danzando che in un disegno del piacere apriamo, dispieghiamo, condividiamo forme, forme di esistenza come forme di presente, forme di possibilità di un futuro immaginato insieme. In questo tempo svincolato dal potere si colloca l’autonomo agire dove umano e post-umano coesistono aderendo ad una politica della gioia. waggle dances.
La danza, come la poesia, sfida il silenzio nel suo farsi scrittura che accarezza l’atmosfera. waggle dances
Il danzatore e il filosofo, credits Giovanni Impellizzieri.
Credo che filosofia e danza traccino un ambito comune di ricerca. Entrambe si chiedono, domandano, desiderano. Ed è proprio il desiderio a introdurre la comune dimensione corporea: entrambe non esistono senza i corpi che desiderano e che danzano. Non credo che la filosofia possa solo esprimersi a parole, del resto traduciamo λόγος, non solo come parola, discorso, ma anche come strumento del discorso, intelligenza. Il corpo è strumento del pensiero, la danza il suo discorso, un discorso che non necessita di parole. Pensare è parlare in silenzio, danzare è pensare in silenzio. Attraverso il fenomeno danzante si verifica un doppio scioglimento del pensiero nella carne e della carne nel pensiero, in questo divenire forma che la materia cangiante assume (chiamo forma la direzione della materia), la danza offre allo sguardo visioni, materializzazioni del pensiero. Se la filosofia è l’arte di formare, di inventare, di fabbricare concetti (Deleuze e Guattari), per analogia il corpo indica l’idea, il concetto, e il suo linguaggio è la danza, questo indica idee e crea concetti attraverso il movimento, allora la danza si fa filosofia. La mente sta al pensiero come il corpo al movimento. Ma il pensiero è esso stesso movimento che si emancipa e si rende manifesto, così come il movimento si emancipa, si stacca dal corpo talvolta manifestandosi in danza. Questo movimento in primis interno è il desiderio o conatus. Parafrasando Lyotard (Perché la filosofia è necessaria?) possiamo dire che la filosofia è necessaria perché è necessario il desiderio; la danza, che è iperfilosofia in quanto evidente materializzazione di concetti attraverso i corpi, è necessaria perché espressione del desiderio che si esprime attraverso le loro intenzioni, movimenti, direzioni, emozioni plastiche. Se il mondo si esprime attraverso eventi danzanti in cui accordi ritmici e muscolari fanno apparire, vibrare e sparire corpi, la fenomenologia diviene riflessione sulla danza. Ed ecco che il danzatore e il filosofo si mettono accanto per espandere il senso, farlo slittare, attraverso una erosione delle rive.
Emanuele: Da quali interrogativi e riflessioni partono gli operatori del settore per ridisegnare luoghi, tempi e spazi per ridefinire il concetto di residenza artistica? Come le linee drammaturgiche sono guidate dalle teorie filosofiche contemporanee?
Chiara Organtini: Il tema delle residenze incontra sguardi e istanze a cavallo di discipline: credo che i ritmi accelerati e le logiche produttive e accumulative del paradigma liberista siano alla base delle crepe del sistema del presente e informino desideri e bisogni di persone e artiste e artisti nel trovare alternative possibili. Le residenze in Lavanderia sono una risposta a questi desideri, uno spazio-tempo dilatato e dedicato alla ricerca, in cui far respirare la sperimentazione senza un approccio deterministico che spesso è imbuto alla possibilità creativa, un ventaglio in cui concentrarsi nel processo creativo tenendo allo stesso tempo l’attenzione al circostante, l’ascolto al contesto e alle persone con cui generare incontri. Non a caso c’è una postura sempre più obliqua delle ricerche che ospitiamo allo sconfinamento nello spazio esterno alla sala e tesa alle dinamiche collettive e collaborative.
Le residenze in Lavanderia assomigliano a un polmone: sono spazi di concentrazione in sala e intimità, in cui proteggere la vulnerabilità del processo in fieri, costantemente cadenzati da aperture allo spazio circostante, alle persone e energie che necessariamente informano lo stare. Waggle dances.
Si parla oggi, anche in reazione alla crisi del concetto di residenzialità su più fronti, di permanenze: momenti di presenza temporanei che tuttavia respirano pienamente la dimensione che abitano lasciando tracce, perché tutto è irrelato.
Nella linea drammaturgica, ma anche operativa, che abbiamo disegnato, la nozione di cura è infatti legata profondamente alla visione del pensiero eco-femminista, da Haraway a Maria Puig de la bellacasa volta a rivelare la tessitura profonda che connette tutte le forme del vivente. waggle dances
Una visione che non è solo poeticamente formulata, ma che ha la volontà politica di riequilibrare le asimmetrie nelle relazioni di potere del presente: da cui alcune delle scelte non solo tematiche, ma anche strategiche fatte con le residenze per dare spazio a voci non ancora nominate dalla narrazione dominante o volte a creare condizioni abilitanti per artisti e artisti precarizzati.
In questo continuo intreccio di riflessione e azione, di visione e politica, filosofia e arti performative sono tentacoli complementari di uno stesso corpo: le arti performative sono epifanie e pensieri incarnati e che nel proprio manifestarsi, nutrono e fanno slittare il pensiero filosofico stesso.Una circolarità quindi di pensiero e azione non più gerarchizzata dal dualismo occidentale: in questa rotondità per me subentra poi un terzo elemento che è l’immaginazione che rende possibile per le arti performative agire alternative possibili e mondi forse non ancora pensabili.
Gaia Giovine Proietti
-
Non siamo ancora stati salvati, vent’anni dopo
Recensioni / Aprile 2024La storia intellettuale è costellata di congiunture: ricorrenze – o meglio occorrenze – non necessariamente coincidenti con eventi cardine della vita di un autore, che invitano a prendere in esame il bilancio della sua eredità. Un’eredità, specialmente quella di coloro cui è stato assegnato l’oneroso epiteto di classici, che stimola al ripensamento, alla rilettura, alla messa all’opera dei concetti e – perché no? – al tradimento vivificante: come insegna il Nietzsche della prima Inattuale, critico del filisteismo còlto e di ogni comoda epigonalità, quale modo migliore per abitare in modo generativo un’opera se non «continuare a cercare» seguendone lo spirito «senza mai stancarsi in ciò» (Nietzsche 1991, p. 21)?
La riedizione, a vent’anni esatti dalla pubblicazione della prima traduzione italiana, del libro di Peter Sloterdijk Non siamo ancora stati salvati. Saggi dopo Heidegger (Tlon 2024) rappresenta, in un certo qual modo, un’occasione di questo genere. Il che non significa necessariamente azzardare pericolose definizioni come quella di «classico contemporaneo», per affibbiarla a un autore assai prolifico e soprattutto ancora in vita – né tantomeno deliberare sull’eredità di un pensiero ancora in corso che oltretutto si arricchisce, a un ritmo vertiginoso, di sempre nuovi contributi.
Questa riedizione rappresenta piuttosto il καιρός, il momento giusto per rilanciare la centralità di un’opera come Nicht Gerettet tanto all’interno della riflessione del suo autore, di cui rappresenta uno snodo vitale che consente di illuminare sia ciò che sta a monte sia ciò che sta a valle della sua pubblicazione, quanto all’interno del dibattito filosofico contemporaneo, rispetto al quale – almeno nella convinzione di chi scrive – la filosofia di Sloterdijk ha da offrire strumenti di un’efficace e irriverente vitalità.
Come afferma Antonio Lucci (2024, p. 427), curatore della presente riedizione e autore della postfazione – che permette di inquadrare con una precisione veramente chirurgica la posizione del testo entro la riflessione di Sloterdijk – l’attualità di Non siamo ancora stati salvati è l’«attualità di un libro ancora da pensare». Ma, anche, che dà ancora da pensare.
Pensare a che cosa? Rispondere a questa domanda non equivale soltanto a immergersi tra i dieci saggi che compongono il testo per osservare l’intrecciarsi del loro reciproco dialogo o ricostruire le oscillazioni, le continuità e discontinuità che li legano alla trama precedente e successiva delle opere di Sloterdijk. Ma anche a compiere, oltre queste due operazioni necessarie, una terza, non meno importante: prestare attenzione al gesto, alla postura e allo stile espressi nella sua prosa.
Se infatti la filosofia è un esercizio – come Sloterdijk stesso si è impegnato a mostrare – Non siamo ancora stati salvati è un esempio paradigmatico delle peculiarità di quello specifico esercizio filosofico che è il pensiero sloterdijkiano: talmente esemplare che potrebbe forse essere ritenuto il migliore viatico alla produzione dell’autore – da un punto di vista sia tematico, sia metodologico.
È qualcosa che la postfazione di Lucci, riportando l’attenzione sul saggio – curiosamente poco considerato – che Sloterdijk dedica ad Adorno e al lascito della Teoria critica, Che cos’è la solidarietà con la metafisica nell’attimo della sua caduta?, sottolinea in modo inequivocabile. Se la Teoria critica è andata incontro a una vecchiaia precoce, a una perdita di spinta indotta dai suoi vizi interni (l’arma della critica come residuo criptognostico e criptoteologico, brandita da un osservatore esterno, immacolato e provvisto di un implicito carisma messianico), l’unico modo di rivitalizzarla e di assicurarne la continuità coincide, secondo Sloterdijk, col sostituire allo sguardo della critica, ormai svuotato e incapace di presa sulla realtà, uno sguardo ironico e iperbolico, isomorfo al suo oggetto nonché irrimediabilmente interno ad esso. È dunque al prezzo di uno svuotamento radicale, di una trasvalutazione della Teoria Critica nella Teoria Iperbolica che Sloterdijk, a metà tra l’ironico e il polemico, può rivendicare – contro Habermas – l’eredità di Adorno. Operazione, questa, ascrivibile al parassitismo metodico che costituisce la cifra più propria della filosofia sloterdijkiana – un modo di praticare il pensiero che:
costituisce al contempo un modo nuovo di abitare i testi e un nuovo genere di critica, una critica di secondo ordine che oltre a stanare i gesti irriflessi e l’inerzia intellettuale delle ovvietà obbliganti (come dovrebbe fare forse ogni filosofia) contempla al contempo l’ipotesi che la critica stessa sia revocabile e non abbia ragione di proporsi come veicolo per verità ultime da illuminare, le quali ricadrebbero comunque entro i vincoli di una logica identitaria (Bonaiuti 2019, p. 106).
Tra le pagine di Non siamo ancora stati salvati il parassitismo di Sloterdijk si esprime, allora, nel tentativo di elaborare un «controcanone filosofico» (Lucci 2024, p. 438) composto da divinità falsamente ritenute minori: Luhmann come patrono di un’ironia terapeutica e civilizzatrice, Cioran revanscista disinteressato, Gotthard Günther quale fautore di un superamento dell’ontologia monovalente, per la quale soltanto l’essere è, e della sua logica bivalente, in direzione di una logica polivalente in cui, tra vero e falso, tertium datur.
Ma si dà soprattutto a vedere nel corpo a corpo con la filosofia di Heidegger cristallizzato fin nel sottotitolo, nel quale Sloterdijk dichiara di voler filosofare nach Heidegger: vale a dire secondo Heidegger, in continuità con lo spirito del suo pensiero, ma anche dopo Heidegger, con Heidegger e contro Heidegger – senza il timore di tradirne e superarne la lettera dove necessario, attraverso innesti e ibridazioni multidisciplinari che ne garantiscano la sopravvivenza.
Questa liberazione «dall’ipnosi del maestro» (Sloterdijk 2024, p. 9) pervade in senso trasversale ogni contributo della raccolta. L’iniziale critica alla miopia heideggeriana nei confronti della motilità orizzontale, veicolata dal saggio Caduta e svolta, è il sasso che Sloterdijk getta nello stagno – o nella palude? – dell’ontologia fondamentale. Il riverbero che esso produce si propaga infatti alla giustificazione di una possibile continuazione sferologica dell’analitica esistenziale, delineata in «Il Dasein ha una tendenza essenziale alla vicinanza» e portata a compimento – in grande stile – dalla trilogia Sfere, la quale mira a esplicitare l’Essere e spazio rimasto implicito in Essere e tempo. Ma anche della possibilità di superare la diffidenza heideggeriana verso ogni antropologia per mostrare, come Sloterdijk propone tra La domesticazione dell’essere e Regole per il parco umano, che gli esseri umani siano originariamente esseri-del-trasferimento, plasmati e prodotti dalla cultura e dalla tecnica. «Storicizzare la temporalità e antropologizzare il movimento» (p. 435), sono dunque le premesse necessarie tanto alla plausibilità del concetto di sfera, quanto a quello di antropotecnica, così come del tentativo di risignificare – in Alétheia o la miccia della verità – la concezione heideggeriana della verità in termini storico-antropologici, quale «storia della tecnica e della sua socializzazione» (Sloterdijk 2024, p. 306), movimento esperienziale collettivo e cumulativo.
Proprio in questo disvelamento emerge il trait d’union che lega tutti i capitoli del saggio: il manifestarsi del mostruoso. Categoria, ancora una volta, heideggeriana, in cui Sloterdijk si installa per svuotarla e risemantizzarla dal suo interno. Mostruoso, smisurato, è innanzitutto l’essere umano; o meglio, lo è il suo enorme potere autoplastico espresso nel rapporto circolare e retroattivo che si dà tra i meccanismi spontanei alla base del processo di antropogenesi – insulazione, liberazione dai limiti corporei, neotenia e trasposizione – e la loro prosecuzione antropotecnica, primaria e secondaria. Le antiche pratiche immuno-sferiche preistoriche, così come le forme storiche di «modellamento diretto dell’uomo attraverso una messa in forma civilizzante» (Sloterdijk 2024, p. 216) e la loro continuazione nelle più recenti biotecnologie di manipolazione genetica, sono espressione di quella costitutiva tecnicità dell'umano, la cui natura è la cultura, che fa della comprensione sloterdijkiana del fenomeno homo sapiens una forma di filosofia della tecnica (Ferreira de Barros, Pavanini, Lemmens p. 2023). Dall’amigdala acheuleana al “taglio” e alla “ricucitura” del codice genetico; dal lancio di una pietra alle più astratte prestazioni concettuali – non sembra esserci, per Sloterdijk, soluzione di continuità.
Mostruosa è anche e soprattutto la modernità, intesa da Sloterdijk – si veda il titolo dell’ottavo saggio – come L’ora del crimine mostruoso: un crimine del quale siamo tutti inevitabilmente complici, la smisuratezza del quale non può essere descritta ma soltanto confessata, né tradotta in teoria ma soltanto fatta oggetto di «proiezioni iperboliche» (Sloterdijk 2024, p. 400). Una dismisura che si dà a vedere tanto a livello spaziale, nell’esplosione della globalizzazione europea, quanto a livello temporale, nella sincronizzazione della vita in un eterno presente post-storico, così come – e in modo particolare – a livello materiale, nell’arte e nella tecnica quale espressione della potenza poietica e autopoietica dell’essere umano; detto altrimenti, di ciò che l’uomo può fare. Rispetto a ciò, Sloterdijk propone di considerare una giustificazione filosofica dell’artificiale, corroborata dalla logica cibernetica di Günther, da leggersi in parallelo a quanto scritto nel saggio appena precedente, il settimo della raccolta, intitolato L’offesa delle macchine.
Proprio su questo punto è possibile misurare tutta l’attualità di un libro come Non siamo ancora stati salvati, che è ancora da pensare e che, si diceva, dà ancora da pensare. La prima edizione tedesca risale al 2001 e i saggi raccolti in essa sono stati elaborati da Sloterdijk tra il 1989 e i primi anni duemila: la temperie culturale e i suoi temi di riferimento, oggi, sono certo cambiati. Alcuni filoni di riflessione, fra tutti l’ossessione per una presunta fine della storia, sono stati smentiti da un brusco risveglio alla brutalità del reale. Tuttavia se, come sembra anche soltanto da un’analisi superficiale dello Zeitgeist contemporaneo, ci troviamo nel bel mezzo dell’epoca dell’Intelligenza Artificiale, non è forse passando attraverso la meditazione sloterdijkiana sul mostruoso contenuta in queste pagine che è possibile affrontare la questione a partire da un punto di vista né irrazionalmente tecnofobo, né acriticamente tecnofilo?
A partire da Sloterdijk si può infatti comprendere come l’avanzare dell’artificiale, che si tratti dello scalpore suscitato dallo sviluppo di biotecniche di clonazione, di progressi nel campo della robotica, o ancora dell’incremento dell’efficacia di sistemi algoritmici di Machine Learning, non costituisca affatto l’ennesima ferita narcisistica per l’essere umano. Né tantomeno una minaccia alla supposta umanità dell’uomo. L’offesa delle macchine è infatti soltanto apparente, radicata nell’antico pregiudizio metafisico che non vede alternativa possibile alle coppie oppositive vivente-non vivente, soggetto-oggetto, materia-spirito, natura-artificio; laddove l’artificiale rappresenta un terzo termine che sarà comprensibile soltanto a seguito di una riforma, in senso polivalente, della logica e dell’ontologia [1]. Senza contare che, seguendo la «fantasia filosofica» sloterdijkiana (2024, p. 165), l’umano stesso, lungi dal corrispondere a una qualche essenza astorica e immutabile, è piuttosto il prodotto di una lunghissima storia, sempre aperta e contingente, all’incrocio tra evoluzione naturale e sviluppo culturale, tra antropogenesi e antropotecnica.
L’attualità di Non siamo stati salvati non si esaurisce però nel tentativo di una giustificazione filosofica dell’artificiale: la sua rilevanza, è anche una rilevanza politica. Se infatti le pratiche di ottimizzazione algoritmica possono essere concepite come antropotecniche, che in quanto tali implicano un «potere di selezione» e una qualche forma di «custodia dell’uomo» e «suo allevamento», cioè una forma di potere, chi si occuperà di «prendere in mano attivamente il gioco» e formulare in futuro un «codice delle antropotecniche» (pp. 348-349)? E sarà sufficiente una trasformazione della (allo)tecnica in omeotecnica, non padronale e co-operativa, a garantire «l’emergenza di una cultura della ragione postparanaoide» (p. 244)?
Quello dell’Intelligenza Artificiale è un orizzonte confuso e in costante evoluzione, di cui non è ancora possibile comprendere appieno la portata. Che abbiano ragione coloro che (Landgrebe, Smith 2023) sostengono l’impossibilità, per i limiti intrinseci alle capacità di modellizzazione matematica predittiva applicata ai sistemi complessi, di un’IA generale che eguagli o superi le prestazioni umane, o che l’abbiano gli ambasciatori di un’ipotetica superintelligenza, una cosa è certa: come scrive Sloterdijk (2024, p. 177), «è finita l’epoca in cui gli uomini pensavano di potersi sottrarre alle responsabilità del mostruoso; poiché ora sono diventati i tecnici del mostruoso» – a fronte di ciò, non sarà certo un dio a poterci salvare.
di Luca Valsecchi
Note
[1] Facendo leva sull’ontologia emergente dalla cibernetica come «teoria e prassi delle macchine intelligenti» e dalla biologia come «studio delle unità sistema-ambiente» (232), Sloterdijk invita a identificare la terzietà degli artifici nel polo impersonale dell’informazione, situato a metà tra soggetto e oggetto, spirito e materia. Perciò: «dalla frase “c’è informazione” dipendono frasi come: “Ci sono sistemi, ci sono memorie, ci sono culture, c’è l’intelligenza artificiale”» (233). In quest’ottica ogni posizione antitecnologica altro non sarebbe che una forma di ressentiment, una resistenza residuale alla decomposizione della metafisica. A proposito dell’ontologia cibernetica e della sua non-modernità si veda ad esempio: Pickering, A. (2010). The Cybernetic Brain. Sketches of Another Future, The University of Chicago Press: Chicago-London.
Bibliografia
Bonaiuti, G. (2019). Lo spettro sfinito. Note sul parassitismo metodico di Peter Sloterdijk. Mimesis: Milano-Udine.
Ferreira de Barros, M., Pavanini, M., Lemmens, P. (2023). Peter Sloterdijk’s Philosophy of Technology: From Anthropogenesis to the Anthropocene. Technophany: A Journal for Philosophy and Technology, 1(2), 84–123.
Landgrebe, J. & Smith, B. (2023). Why Machines Will Never Rule the World. Artificial Intelligence without Fear, Routledge: New York.
Lucci, A. (2024). Portare Heidegger all’estremo. Peter Sloterdijk tra antropologia e Teoria Iperbolica. In Sloterdijk, P. Non siamo ancora stati salvati. Saggi dopo Heidegger (427-446). Tlon: Roma.
Nietzsche, F. (1991). David Strauss. L’uomo di fede e lo scrittore. Trad. it. di S. Giametta. Adelphi: Milano.
Sloterdijk, P. (2024). Non siamo ancora stati salvati. Saggi dopo Heidegger. A cura di Antonio Lucci. Tlon: Roma.
-
Maurice Merleau-Ponty: l’apparire del senso
Recensioni / Febbraio 2024Se, solitamente, le frasi scelte ad epigrafe di una monografia servono più a ringraziare qualcuno di caro o a restituire il senso più generale del testo che ci si approccia a leggere, le parole tratte da Nietzsche con cui Taddio dà il via al suo nuovo lavoro su Merleau-Ponty - Maurice Merleau-Ponty. L'apparire del senso - sono invece programmatiche e ci offrono un ottimo punto di inizio per analizzare il contenuto del libro. Dalla Nascita della tragedia Taddio estrapola questo passaggio essenziale: “Solo come fenomeno estetico l’esistenza e il mondo sono eternamente giustificati”. Il termine per noi fondamentale è “estetico”, che utilizzeremo (secondo l’accezione che a breve chiariremo) per leggere tutto il lavoro di Taddio. Com’è noto la parola può essere interpretata e usata in più modi, sia per indicare la filosofia dell’arte, sia - sfruttando la radice greca del termine - per includere il campo di indagine che analizza la dinamica tramite cui le cose ci appaiono, ovvero la fenomenologia. “Estetico” è il senso stesso della presenza dei fenomeni, che manifestandosi chiamano in causa il nostro sistema percettivo. In Nietzsche, tuttavia, il termine viene utilizzato in una terza accezione, per indicare un nuovo modo di interpretare la realtà senza il bisogno né di dividerla in due parti (fenomeno e noumeno) né di giudicarla a partire da degli assiomi eterni (il bene e il male). Tutto si gioca sul piano dell’apparire, del fenomeno, della pellicola che stimola i nostri sensi, e tutto – di conseguenza – si gioca e trova spazio unicamente sul piano dell’esperienza, che come tale è assoluta e illimitata e non può venire spartita in verità e illusioni. In questo senso, Nietzsche ci propone una lettura della natura del reale come effetto di superficie, come puro gioco di forme, o, per dirla altrimenti, ci permette di pensare a un significato ontologico del termine estetica.
Ed è proprio questa accezione radicale del concetto di estetico che permette di cogliere la tesi sostenuta dal libro di Taddio. Il quale, pur riconoscendo l’importanza delle arti e della pittura (quindi del primo significato del termine) nel pensiero di Merleau-Ponty, e pur dichiarando di voler «riscoprire il pensiero del filosofo come luogo ove far vibrare in modo inedito le corde della fenomenologia» (p. 13), ovvero rimanendo fedeli al secondo significato della parola “estetica”, propone una versione ontologica del pensiero di questo maestro del Novecento basandosi sugli ultimi scritti – incompleti e postumi – che questi ci ha lasciato. Il risultato è che Merleau-Ponty ci viene offerto in una veste classica e insolita al tempo stesso, perché se da un lato ne viene evidenziata la matrice già ampiamente studiata dalla letteratura secondaria di continuatore e critico della fenomenologia di Husserl, nonché di grande esperto di arte e letteratura, dall’altro il testo di Taddio lo installa su una prospettiva ontologica radicale da cui è possibile trarre degli spunti per trascinare gli strumenti classici merleau-pontiani in territori nuovi, come quelli della trasformazione digitale che stiamo tutti vivendo. Il libro, quindi, si pone come obiettivo quello di ripercorrere le vie più note del pensiero di Merleau-Ponty, ma di farlo secondo un orientamento differente e apertamente ontologico, utilizzando le pagine di Merleau-Ponty come i prolegomeni a un’ontologia delle relazioni pure di cui nel corso del libro viene, non a caso, delineato il profilo.
I primi cinque capitoli mettono in chiaro tutti gli elementi fondamentali per comprendere la portata generale del pensiero di Merleau-Ponty. Taddio costruisce un dialogo tra l’arte, la filosofia e le scienze così come Merleau-Ponty stesso ha inteso fare, ovvero intrecciandole tra loro in un movimento perpetuo ed ermeneutico che impedisca, da un lato, un irrigidimento soffocante in categorie troppo vincolanti (per la scienza) e, dall’altro, la ricaduta in un solipsismo esasperato e relativizzante (per la filosofia). Merleau-Ponty è stato in grado di proporre un movimento per cui l’arte accorre a sfumare i contorni della scienza moderna, mentre il linguaggio delle scienze (contemporanee) serve alla filosofia e, in particolare, alla fenomenologia, come ricettacolo di esempi, prove e dimostrazioni utili per ancorare la riflessione teoretica a un fondamento stabile. Merleau-Ponty ha però un indubbio bersaglio polemico, che Taddio chiarisce sin dalle prime pagine del libro: non la scienza in generale, ma la scienza moderna che ha poi trovato in Cartesio la sua nobilitazione filosofica. La modernità ha infatti prodotto un’interpretazione algebrica, geometrizzante e standardizzata della realtà, organizzandola – sul piano scientifico – all’interno di due contenitori assoluti e neutrali (lo spazio e il tempo) dentro cui ogni singolarità e specificità scompaiono, mentre – sul piano della filosofia – dividendo l’oggetto percepito dal soggetto percipiente come se fossero due mondi e sostanze distinte. Come Taddio riassume, «con l’inizio della modernità, possiamo assegnare alla scienza sperimentale il compito di indagare la realtà sottostante l’esperienza» (p. 26, corsivo nostro); in altre parole, con la modernità si configura una distinzione tra ciò che è percepito e chi percepisce, e tra ciò che i sensi offrono e ciò che le cose realmente sono al di là, o al di sotto, di questi. Riassumendo, possiamo dire che la modernità installa sulle precedenti categorie greche la distinzione tra ciò che è apparente e ciò che è reale, conferendo a questi due poli non soltanto un carattere distintivo, ma marcatamente rivale. Il risultato è che il mondo dei sensi viene derubricato a un ruolo passivo o scarsamente rilevante dal punto di vista teoretico, non possedendo mai in sé la propria stessa verità.
Per uscire da questa impasse costruita dalla complicità tra la filosofia e un sapere matematico-geometrizzante, Merleau-Ponty si rivolge all’arte: è l’arte che «ci conduce alle cose stesse. Per Merleau-Ponty i pittori e, più in generale, gli artisti hanno in effetti qualcosa da insegnare ai filosofi: innanzitutto, spiegano come guardare il mondo e le cose» (p. 19). L’arte pittorica, in particolare quella di Cézanne, è lo strumento per eccezione con cui Merleau-Ponty si imbarca nell’impresa di rieducare lo sguardo a non essere esclusivamente un occhio contemplativo che sbircia il mondo dal riparo di un guscio privilegiato e chiuso (la soggettività). La pittura, infatti, insegna all’uomo contemporaneo ad analizzare lo spazio che lo circonda come un mondo in divenire attraversato da «forze invisibili-visibili che agiscono nel campo fenomenico» (p. 20). L’arte è ciò che permette di ritornare alle cose stesse perché è ciò che permette la riscoperta di quell’intrinseco scambio dinamico e attivo che da sempre coinvolge chi percepisce e la cosa che viene percepita; uno scambio in cui il soggetto non è un punto privilegiato, ma è il nodo di una relazione più originaria e “orizzontale” con gli altri elementi che costituiscono l’esperienza. L’arte è dunque, in conclusione, secondo Merleau-Ponty, la cura alla modernità perché dissolve le gerarchie tra un sopra e un sotto, tra un alto e un basso, e restituisce all’esperienza lo statuto di una dinamica relazionale tra diversi livelli costantemente implicati gli uni negli altri, tra cui quelli del soggetto e dell’oggetto. La fenomenologia deve quindi partire da qui: da una dose di anti-modernità che le permetta di superare la distinzione tra apparenza e realtà e di divenire una scienza delle relazioni percettive pure.
In questo senso è chiaro che il bersaglio polemico di Merleau-Ponty non è la scienza tout court, bensì quello specifico sapere tecnico-organizzativo che si trova riassunto nel termine “modernità”. Questo dettaglio è, a nostro avviso, il contributo principale del libro di Taddio, che permette di lasciarsi alle spalle un’immagine antiquata del filosofo francese e ci porta a pensare con lui un rapporto nuovo, più ampio e solidale, sebbene non per questo meno critico, tra scienza, filosofia e arte. I capitoli che vanno dal sesto al sedicesimo sono infatti dedicati da Taddio a dimostrare quanto Merleu-Ponty fosse influenzato e apprezzasse le scienze a lui contemporanee, in particolar modo la Psicologia della Gestalt. Analizzando l’illusione di Müller-Lyer, di Zöllner, l’esperimento di Ternus e il movimento stroboscopico di Wertheimer, Taddio ci mostra non soltanto quanto la psicologia della Gestalt e una fenomenologia ad essa ispirata possano introdurci a un mondo fatto di costanti relazioni reciproche tra le parti, ma anche come Merleau-Ponty conoscesse a fondo queste teorie e che, proprio a partire dai loro risultati, formulò l’idea di una fenomenologia intesa come l’approccio più efficace per « indicare una via alternativa sia alla tradizione “empirista” sia a quella “intellettualista”» (p. 107). La fenomenologia intesa da Merleau-Ponty permette quindi di scappare sia dalle trappole di un riduzionismo spicciolo e “moderno” degli enti a cose, sia dal rischio – anche questo squisitamente moderno – di precipitare in un solipsismo in cui è il soggetto l’unico perno che garantisce l’oggettività e il senso del mondo. Questa mossa merleau-pontiana ha due effetti importanti. Il primo è quello di predisporre un’idea innovativa, che Taddio sembra condividere, di fenomenologia, la quale separandosi in parte dal solco husserliano si caratterizza per un movimento doppio: è sia la scienza delle essenze, ma è anche «quel metodo che ci consente di ricondurre le essenze al piano dell’esistenza, ovvero a quel piano che ci permette di comprendere il senso stesso dell’uomo e del mondo» (p. 74). In altre parole, per Merleau-Ponty la fenomenologia «non fonda il proprio sapere su essenze (eidos) concepite come modelli eterni e immutabili», perché questo rischierebbe di rimettere in campo tutte le “storture moderne” che Merleau-Ponty stesso vuole superare, in primis l’idea che ci sia una realtà più vera e oggettiva di quella che costituisce la nostra esperienza. Ne consegue che il principio epistemologico per il quale esisterebbe un velo tra apparenza e realtà, oppure una differenza ontologica tra un mondo superiore e un mondo inferiore, non è più applicabile. Piuttosto, in maniera profondamente nietzscheana, secondo questa “nuova” fenomenologia ogni «trascendenza si genera nell’immanenza» (p. 75), ovvero ogni diverso livello della realtà si genera dentro e a partire dalla realtà stessa; inclusi il soggetto e l’oggetto. Per mostrare questo punto, Taddio fa un esempio a nostro avviso efficace utilizzando il gioco degli scacchi (p. 155). Negli scacchi, le regole d’azione non sono tutte equivalenti, ma ottengono un senso preciso all’interno della partita specifica che si sta giocando: muovere un alfiere invece che il cavallo, in questa partita, assume un senso differente che farlo in un’altra, dove ci sono altre disposizioni dei pezzi nello spazio. Ne consegue che non esiste La Partita Perfetta, bensì una griglia di senso che si concretizza e muta nella dinamica composta dalle mosse possibili, dai movimenti scelti e dalla disposizione dei pezzi. In altre parole, «non esiste un modello atemporale e trascendente» (p. 155): è l’immanenza costituita da relazioni tra parti a concretizzare le proprie strutture durante il suo stesso svolgersi.
Avevamo detto, però, che le conseguenze di questo approccio erano due. Questa nuova idea di fenomenologia si trova, infatti, ad avere un alleato forse insperato in un pensatore che, pochi decenni prima rispetto a Merleau-Ponty, aveva già tentato di superare la distinzione tra intellettualismo e empirismo, formulando un concetto specifico. Il pensatore è Henri Bergson, che nel capitolo IV di Materia e Memoria introduce il concetto di virtuale per proporre un’ontologia immanente alle forme stesse (che lui chiama «immagini») che costituiscono la nostra esperienza, senza però far sì né che queste forme siano pensate come prestabilite da modelli già inscritti nel virtuale (ovvero non sono delle mere possibilità che concretizzano delle essenze già note) né, tantomeno, senza che il virtuale si riduca esclusivamente alle forme stesse in cui si attualizza, cosa che provocherebbe un arrestarsi del movimento del divenire per esaustione. Il virtuale di Bergson è il nuovo termine ontologico capace di sostituire l’ontologia essenzialistica di Cartesio, ovvero di compiere un passo radicalmente anti-moderno, come Manuel DeLanda (un realista, come Taddio stesso si dichiara essere nel corso del libro) ha ampiamente dimostrato nel suo Scienza intensiva e filosofia del virtuale, ricostruendo l’importanza di questo concetto nel pensiero di un altro filosofo francese assimilabile per certi versi a Merleau-Ponty stesso, ovvero Gilles Deleuze . Il virtuale, in altre parole, è l’idea che la realtà sia costitutivamente un flusso di divenire che si auto-genera e auto-struttura in un equilibrio semi-permanente, meta-stabile, e secondo cui il «mondo emerge con le proprietà fenomeniche che conosciamo nell’esperienza immediata» (p. 163) senza il bisogno di convocare un principio trascendente o esterno. Nietzscheanamente, non serve andare oltre la realtà creando un’apparenza da superare: il piano dell’esperienza immediata è sufficiente a spiegare, anche scientificamente, se stesso. Leggere dunque Merleau-Ponty secondo questa prospettiva permette di inserirlo in un contesto più ampio interno alla storia della filosofia francese contemporanea, in un arco che va da Bergson, Simondon, Thom, e corre fino a Deleuze.
Da questo quadro Taddio trae alcuni fondamenti epistemologici per una nuova fenomenologia delle relazioni basata sulle intuizioni di Merleau-Ponty, dove è possibile pensare a mondi distinti che però restano allacciati dallo stesso e unico piano di realtà. La filosofia e l’arte indagano il senso che questa configurazione delle cose si trova continuamente a generare, mentre la scienza studia e analizza il fondamento stesso della realtà in cui i mondi si trovano, col risultato che arte, scienza e filosofia (intesa, principalmente, come fenomenologia) si trovano a collaborare senza rivalità e senza sovrapposizioni in un unico piano ontologico che costantemente produce senso e costantemente si svolge e differenzia. La prospettiva ontologica del virtuale, che secondo Taddio Merleau-Ponty ha cominciato a delineare soprattutto a partire dagli ultimi scritti e dalle lezioni tenute al Collège de France dedicate al concetto di natura, può, alleggerita dal penso di una dualità insanabile tra soggetto e oggetto, aiutarci a descrivere ciò che oggi sta accadendo. In particolare, il libro propone un’analisi poco scontata dell’evoluzione tecnologica che i nostri corpi e le nostre società stanno subendo, invitando a considerare il digitale non come una mera illusione, una falsa realtà, un’apparenza, ma come un mondo interno alla realtà dentro cui stanno emergendo nuove strutture, come tali né negative né positive di principio. Solamente se analizzate senza dicotomie pregiudiziali (artificiale/naturale, umano/animale, falso/vero), quindi attraverso le lenti di questa fenomenologia “eretica” pensata da e a partire da Merleau-Ponty, le rivoluzioni in cui ci troviamo immersi si offrono nelle loro logiche di base, da cui poi è possibile prendere delle decisioni politiche accorte e efficaci. Il Merleau-Ponty di Taddio è un pensatore realista, anti-moderno ma non per questo anti-scientifico: un fenomenologo dell’immanenza che la sua morte avvenuta a soli cinquantatré anni, nel 1951, non ha forse permesso di vedere chiaramente.
Andrea Colombo
Bibliografia
Bergson, H. Materia e Memoria. Saggio sulla relazione tra il corpo e lo spirito, Laterza, Roma-Bari, 2014.
DeLanda, M. Scienza intensiva e filosofia virtuale, Meltemi, Milano, 2022.
Nietzsche, F. La nascita della tragedia, Adelphi, Milano, 1972.
-
Leggere… o peggio. Il Seminario XIX di Jacques Lacan
Recensioni / Novembre 2023“L’uno non è nato ieri, ma è nato a proposito di due cose completamente differenti, a proposito di un certo uso degli strumenti di misura e, contemporaneamente, a proposito di qualcosa che non c’entrava niente, ossia la funzione dell’individuo.” J. Lacan,“Leggere… o peggio." Il Seminario XIX, 1971 – 1972”, Einaudi, Torino, 2020, p. 154 "Leggere… o peggio."
Con la pubblicazione di Leggere…o peggio. Il Seminario XIX di Jacques Lacan, volume collettaneo curato magistralmente dal giovane filosofo Marco Ferrari, la casa editrice Galaad prosegue nell'impresa di scolastica e certosina delucidazione dei seminari tenuti dal poliedrico psicanalista francese per più di vent’anni a Parigi, dal 1953 fino a poco prima della sua morte. In questi seminari, trascritti dall’allievo-testamentario-genero Jacques Alain Miller, sono infatti condensati ancor meglio che negli Scritti [1] tanto il sapere quanto il metodo che definiscono la pratica psicoanalitica ad orientamento lacaniano e la loro frequentazione permette di osservarne direttamente, come in un cantiere, il work in progress teoretico. Ma, com’è noto, leggere Lacan e accompagnare in itinere lo sviluppo delle sue folgoranti intuizioni, il suo perdersi nei vicoli ciechi della ragione ed il suo riemergere infine vittorioso dai flutti di quel fiume acheronte che già per Freud era da considerarsi metafora eminente dell’inconscio non è cosa facile, anzi. E così, assieme al precedente volume curato da Chiara Massari e dedicato al seminario XVI [2], questo pregiato testo della collana chiamata per l’appunto “Leggere Lacan” può ben fungere da bussola, o da mappa, per chi voglia provare ad orientarsi nella fase più complessa ed oscura, la più tarda dal punto di visto cronologico, del suo insegnamento.
L’enigmatico titolo del seminario XIX, “…o peggio” (in francese: …ou pire), con quei tre puntini di sospensione seguiti da un’apparentemente ingiustificata formula peggiorativa, lascia infatti già presagire quelle che saranno le continue allusioni, le ambiguità e le aporie che accompagnano, sincopandone il passo, gli inciampi dialettici, le contorsioni logiche e le funamboliche misture di biologia, linguistica e filosofia di cui questo seminario, tra i più difficili, è letteralmente infarcito. E così, per consentire un accesso facilitato ai molteplici temi lì trattati (il rapporto della psicanalisi con la sessualità, della sessualità con la metafisica, l’inesistenza del rapporto sessuale e la logica dei processi inconsci…per citarne solo alcuni), il curatore Marco Ferrari ha deciso di chiamare a raccolta uno stuolo di filosofi e psicanalisti che si sono occupati, ognuno singolarmente o in coppia, di una o al massimo due lezioni del seminario in questione. Il risultato è un concerto ermeneutico polifonico che non esaurisce, non congela il testo di Lacan in una serie di interpretazioni definitive e statiche, ma anzi amplifica il contenuto già di per sé ricchissimo di “…o peggio” nella misura in cui, per l’appunto, ne offre diversi scorci, diversi punti di vista anche tra loro contradditori.
Il primo intervento è firmato da Silvia Lippi, psicanalista bolognese che esercita a Parigi, e offre una rilettura queer della psicanalisi freudiana e lacaniana che pone un particolare accento sulle identità trans. L’autrice muove dall’assunto per cui “secondo Lacan ci sono e ci saranno sempre due sessi” [3], ma visto che “come sostiene giustamente Judith Butler, è il discorso che determina la differenza sessuale” [4] allora si deve ammettere, anzitutto, che “pensare che un uomo debba avere il pene e la donna una vagina è una convenzione sociale e come tutte le norme non ha valore universale” [5] e, in secondo luogo, che la psicanalisi debba essere mondata dalle sue tare fallogocentriche. Il testo, che si propone di interpretare le prime due lezioni di “…o peggio” in cui viene sviscerato il tema del fallo (simbolizzato da Lacan con il simbolo phi: Φ) e degli effetti che questi ha sulla logica soggettiva (un tema a dir poco centrale per la disciplina psicanalitica) potrebbe fungere benissimo da manifesto per una psicanalisi queer all’italiana [6] e non mancherà certamente di entusiasmare chi è impegnato nella battaglia per la liberazione del desiderio – sia anche nelle già liberalissime, lussuriose e ultrapermissive società occidentali. Certo, il rischio di queste letture inclusive e queer che sembrano riscuotere oggi molto successo risiede paradossalmente nel fatto che sottoscrivere le posizioni di Butler, e confondere il sesso con il genere, può portare ad abbandonare una forma di (supposto) riduzionismo biologista in favore di un’altra (questa volta senz'altro riduzionista…): quella del costruttivismo sociale radicale. Sacrificare una visione in cui biologia e cultura concorrono, anche se in modo giocoforza asimmetrico, a definire l’identità di soggetti liberi di autodeterminarsi entro i confini dettati, oltre che dalla cultura, anche dalla fisicità e dalla materialità del corpo in favore di una concezione marcatamente costruttivista (secondo cui il sesso altro non è che un indice, un’etichetta assegnata dal biopotere medicale da intendersi sempre, comunque ed inesorabilmente in termini oppressivi) come quella promossa da Judith Butler potrebbe, infatti, rivelarsi un operazione che non solo non aiuta nessuna minoranza ad emanciparsi ma, anzi, corre il rischio di minare la credibilità di queste stesse battaglie…come si suol dire: dalla padella alla brace. Senza contare, poi, che non è Lacan a credere che i sessi siano due: quanti e quali sarebbero precisamente gli altri sessi e quale branca della scienza dovrebbe supportare quest’idea? [7] Leggere… o peggio.
Nel secondo capitolo il filosofo Felice Cimatti azzarda un felice parallelismo tra godimento femminile e postumano. Seguendo il solco tracciato da Lacan e senza cercare di forzarne o di travisarne il testo, l’autore cerca di sbrogliare il nodo che lega come in un unico groviglio il godimento di
LaDonna, la castrazione ed il celebre tema metafisico dell’Uno, che Lacan riprende storpiandolo nella formula Yadl’un (C’è dell’uno):“Quindi il Yadl’un è la condizione, affatto singolare, in cui si viene a trovare un essere umano che sia passato attraverso l’universalità della castrazione senza esserne completamente schiacciato. Ma siccome per Lacan è umano solo chi è individuato da Φx, allora il “c’è dell’uno” si colloca in qualche modo al di là dell’umano”
Cimatti mostra chiaramente come per Lacan sia
LaDonna la figura che incarna al meglio lo statuto singolare ed irriducibile che contraddistingue quegli individui che hanno assunto una postura esistenziale tale da permettere un superamento della castrazione (anch’essa simbolizzata nell’algebra lacaniana dal simbolo Φ), ovvero gli individui che nelle intenzioni degli psicanalisti hanno conquistato questa posizione perché hanno portato a termine un’analisi. Ciò a cui agogna l’analizzante, infatti, per gli psicanalisti lacaniani non è tanto il raggiungimento di una non meglio specificata sanità mentale o, peggio ancora, il ritorno ad una mitologica e stereotipica “normalita” ma, all’opposto, la possibilità di “superare il linguaggio […] rimanendo però nel linguaggio” [8], ovvero la chance di bypassare “la logica della definizione e quindi dell’imposizione” [9] che costituisce, fuori di metafora, il vero senso della castrazione. Se “la posizione femminile sfugge alla condanna di tutti i viventi che si trovano invece intrappolati nel desiderio dell’Altro” [10], allora, è proprio perché lungi dal profilarsi come un riduzionista fallogocentrico, Lacan concepisce la femminilità come ciò che incarna uno stile (che nel seminario dedicato al godimento femminile, Ancora [11], troverà il suo riferimento illustre nell’esperienza mistica di Santa Teresa, di Ildegarda di Bingen o di San Tommaso, che donna di certo non era…) tipico di chi riesce ad assumere su di sé la strutturale incompletezza ontologica della realtà senza per questo farsi annichilire da essa [12]. Che le donne si trovino facilitate, rispetto agli uomini, in questo gioco in cui in ballo vi è niente poco di meno che la soggettivazione è un fatto che Lacan da per scontato al punto da orientare tutta la sua tecnica analitica nel verso di uno spossessamento, di un abbandono che ricordano dappresso una sorta di femminilizzazione del soggetto. Tant’è che come osserva puntualmente Cimatti da quella tecnica postumana che è l’analisi ci si aspettano risultati postumani nella misura in cui ciò che si paventa è una trasformazione corporea che però, quasi magicamente, non ricorre a nessun tipo di intervento chirurgico:“Il corpo che esce dall’analisi è allora un corpo che ha assunto la posizione femminile (questo vuol dire che può assumere questa posizione anche un uomo e che non è affatto detto che tutte le donne siano capaci di assumerla). La posizione femminile è quella di un corpo capace di un godimento non fallico, ossia fuori castrazione, e quindi anche fuori dal controllo dell’Io” [13]
In ballo, in un’analisi, c’è infatti proprio la possibilità di andare a maneggiare l’articolazione logica della soggettività dell’analizzante ovvero la struttura psichica che altro non è se non quel che per millenni è stato chiamato “l’anima” – ed il cui sapore metafisico è ripreso da Lacan proprio mediante la formula “C’è dell’uno” che ritorna, lungo tutto l’arco del seminario “…o peggio”, con l’insistenza di una goccia cinese. Ma l’inesausta ripetizione di questo adagio, come a voler motteggiare la millenaria riflessione filosofica sull’Uno (quell’ἕν – hen – che da Parmenide a Schelling, passando per Plotino e Spinoza, allude alla possibilità di conchiudere la totalità dei fenomeni in un’unità concettuale che sintetizza l’infinito ed il finito nell’apprensione metafisica dell’Assoluto), fa da contrappunto ad un altro mantra del lacanismo ortodosso, il ben più celebre “non esiste rapporto sessuale” (il n’y a pas de rapport sexuel) e si pone rispetto a questo come una sorta di integrazione o, meglio, di polo dialettico capace di generare una tensione concettuale decisamente prolifica. Come mostrano bene l’intervento in tandem di Pierpaolo Cesaroni e Mavie Loda ed il seguente, quello della psicanalista Stefania Napolitano, infatti, il fatto che Lacan tra gli anni sessanta e settanta si sia dedicato ad una rilettura della tradizione logica e metafisica occidentale è da intendersi come il mastodontico tentativo di rifondare le premesse teoriche della psicanalisi sulle impasse, sulle aporie e sui fallimenti che hanno punteggiato la storia della filosofia e che sembrano riproporsi, come in controluce, nel vissuto degli analizzanti. L’interesse per i quantificatori aristotelici, per la logica formale e per la riflessione metafisica sull’essenza che negli anni di “… o peggio” acquistano via via sempre più centralità, e che soggiace alle formalizzazioni matematiche della vita psichica come i quattro discorsi o la tavola della sessuazione, indica per l’appunto un luogo di pulsazione centrale nell’economia dell’insegnamento lacaniano, il luogo dell’intersezione, dell’incrocio tra la filosofia e la psicanalisi. E “C’è dell’uno”, la formula ottenuta dalla copula del verbo essere con il sostantivo che allude ad una mitica unità tra l’uomo e il mondo, di questa intersezione è un po' il condensato, il significante che indicherebbe – come già ricordato nell’esergo di questa recensione – il rapporto tra “un certo uso degli strumenti di misura” così come questi vengono codificati nella storia della cultura occidentale “e […] qualcosa che non c’entrava niente, ossia la funzione dell’individuo”. E così dalle parole proferite dai pazienti sul lettino degli psicanalisti, in breve, trasparirebbero come su scala ridotta, sul piano soggettivo e singolare, le stesse aporie e lo stesso smarrimento che per millenni hanno animato quell’avventura del pensiero che passa sotto il nome di filosofia, gli stessi crucci metafisici, le stesse tensioni verso un Assoluto tanto irraggiungibile (con il quale non esiste il rapporto) quanto allettante e che la psicanalisi ha interpretato come il fantasma, la copertura immaginaria e simbolica della piena soddisfazione libidica. Quando Cesaroni e Loda scrivono, ad esempio, che:
“…fin dall’inizio del suo insegnamento, Lacan insiste sull’errore di considerare la comunicazione come un passaggio lineare di messaggi. “Non è questo” non si trova tra domanda e offerta, consiste nella loro distanza, non loro non essere uguali né corrispondenti” [14]
quello a cui i riferiscono è allora l’interdipendenza, la reciprocità intrinseca tanto del fatto che “non c’è rapporto sessuale” quanto del fatto che “c’è dell’uno”: l’assenza dell’uno implica la presenza dell’altro ed il continuo fallire la ricerca di una risposta definitiva sul piano filosofico e di una soddisfazione completa su quello psicologico è proprio ciò che anima, sia dal punto di vista della storia collettiva (o storia della filosofia) che di quella soggettiva, l’infinito articolarsi della catena significante, lo scorrimento metonimico del desiderio e quindi il ritorno inevitabile, benchè parziale, della jouissance...Come a dire che il fallimento connaturato ad ogni forma di comunicazione (quel che potremmo intendere come il pane della psicanalisi, ma anche come il presupposto ultimo della millenaria ruminazione che passa sotto il nome di filosofia) reca con sé le tracce, le impronte e gli indizi che permettono agli analisti di raccapezzarsi nella loro pratica: orientarsi attorno ad un punto di impossibilità (“Non c’è rapporto sessuale”) ed interpretare le modalità attraverso cui la soddisfazione così inizialmente impedita ritorna in modalità surrogate e parziali (“C’è dell’uno”) sarebbero così gli estremi, i veri e propri Scilla e Cariddi per la direzione della cura nella clinica psicanalitica.
Certo, una volta appurato tutto questo rimane inevasa la questione del perché alla donna, o al femminile piuttosto che al maschile, sia riservato un accesso privilegiato a quel che Lacan definisce godimento mistico, così affine e simile al godimento dell’Uno che c’è, e che è l’unica alternativa all’inesistenza del rapporto sessuale. Ad occuparsi di questo annoso problema è Federico Leoni in un testo molto ispirato in cui dimostra, attraverso un sapiente uso della metafora, come la postura del femminile per Lacan si ponga al di là della logica fallica ossia al di là delle contrapposizioni dialettiche che istituiscono ogni tipo di macchinazione e di manipolazione razionali del mondo, essendo queste pratiche invischiate nell’oscillazione dialettica del significato, dei suoi limiti e della sua assenza (ragion per cui sia il fallo che la castrazione sono simbolizzati, come abbiamo già ricordato, dal significante Φ).
LaDonna starebbe allora nell’economia generale della psicanalisi lacaniana come il supporto stesso, la condizione di possibilità stessa della ragione che svanisce e diviene inaccessibile ogni qual volta la ragione stessa viene applicata:“..la questione del femminile è appunto la questione del supporto, o se preferiamo, la questione del supporto è la questione del femminile. In questo caso, il non-rapporto non si impone come un abisso che separa il maschile dal femminile intesi come una mela e una pesca, si impone semmai come un abisso che separa la mela e la pesca dal cesto in cui stanno, o dallo scaffale su cui sono appoggiate”
Com’è noto, infatti, sin dall’articolo “La significanza del fallo” [15] per Lacan il Φ è il significante che conferisce significato ad ogni altro significante, e porsi al di là della castrazione (che del significato ne indica per l’appunto il limite) non significa necessariamente ricadere in un mondo privo di senso ma, piuttosto, raggiungere una postura soggettiva collocata al di là della sua sfibrante ricerca, dell’inseguimento del significato come problema maniacale e assillante – un al di là che ne costituisce paradossalmente la premessa, la condizione di possibilità. Quando Lacan parla di
LaDonna parla infatti proprio di questo: di un’attitudine soggettiva che sappia sottrarsi alla caccia ossessiva e maniacale dell’Assoluto, di un’inclinazione teorica e metafisica priva della smania di quell’Uno che ha tenuto occupati per millenni i filosofi e in nome del quale sono state riempite (da uomini, non a caso…) intere biblioteche di trattati e manuali: come se si trattasse di un esercizio o di uno stile, per l’appunto, teso a sovvertire e a mettere a soqquadro il mondo così come questo è stato pensato per millenni nei termini squisitamente utilitaristici e strumentali dagli uomini. Quale colpo di scena, allora, e soprattutto per chi taccia Lacan di fallogocentrismo, ritrovare nel femminile (e segnatamente nelle figure che meglio ne esemplificano l’orientamento mistico come le già citate Ildegarda di Bingen o Santa Teresa, figure da sempre marginalizzate quando non addirittura escluse nella storia della filosofia…) un modello o un paradigma innovativo per intendere la filosofia stessa?In continuità con questi temi e sempre a proposito dell’annosa questione del rapporto tra psicanalisi, mistica e filosofia ritorna anche lo psicanalista Ettore Perrella nel suo intervento che mette a fuoco l’interesse nutrito da Lacan per la dimensione sapienziale tipica delle forme più antiche di conoscenza:
“Lacan aveva fatto di tutto per aprire l’esoterismo della saggezza a un insegnamento che, pur non volendosi universitario, aveva finito per rivolgersi a centinaia di persone. […] E il più grande tentativo di Lacan di aprire alla scienza l’esoterismo delle scuole di saggezza fu, proprio negli anni in cui teneva il seminario …o peggio, la proposta della passe” [16]
La femminilizzazione come esito di una psicanalisi, la mistica e lo stile esistenziale de
LaDonna allora non sono che esempi paradigmatici che illustrano, ognuno a modo loro e ognuno con sfumature diverse, quel che Lacan intendeva come obiettivo o fine della pratica analitica: sono figure o concetti che recano con sé una forma di incompletezza ontologica radicale rispetto alla quale si rende necessario quel che la passe dovrebbe riuscire a ratificare, ovvero l’avvento di una “posizione etica individuale coerente con le esigenze pratiche della formazione” [17]. Detto altrimenti: per evitare la riduzione accademica e burocratica della psicanalisi e per scongiurare quel che sarebbe poi avvenuto comunque, nonostante tutto (ovvero la rimasticatura libresca e nozionistica della sua opera) Lacan avrebbe tratto dalle antiche scuole sapienziali oltre che l’afflato metafisico che traspira dalla sua originale reinterpretazione dell’Uno anche la passione – assolutamente incompatibile con qualsiasi etica utilitaristica disponibile nelle società capitaliste – per l’ingaggio morale, per la scelta individuale e per la centralità dell’esperienza etica. Ed è qui che, finalmente, le opache e cerebrali elucubrazioni di Lacan sull’Uno condotte nel seminario “…o peggio” acquistano il loro proprio vigore e si rivelano in tutta la loro ammaliante, stringente attualità.Il godimento che vi è in ballo quando si evoca il “C’è dell’uno” lacaniano, infatti, è quel tipo di godimento incontrollato e coatto che si qualifica come ripetizione involontaria e che, nella reiterazione dello stesso, esibisce come in controluce la struttura del soggetto che vi si trova implicato e che così vi si scopre, per l’appunto, fatalmente assoggettato. Miller ne sottolinea esemplarmente il carattere coercitivo quando ricorda che, nell’ultima fase del suo insegnamento, Lacan passa da una concezione di ciò che anima gli individui che all’inizio è intesa alla stregua di “un’insondabile decisione dell’essere” ma poi, dopo la svolta di cui “…o peggio” testimonia gli avanzamenti critici, è descritta come un “insondabile decisione dell’Altro” [18], ovvero come effetto forzoso e incontrollato dell’ordine simbolico, come una successione di significanti che si ripetono automaticamente e che quasi meccanicamente fanno godere il corpo. È quel “godimento assoluto, quello prodotto dall’incidenza del significante sul corpo, che fa del corpo un corpo (di) godimento, cioè un corpo fissato in un’alterazione di sé, in uno sfasamento di sé” [19] di cui parlano il curatore del volume, Marco Ferrari, e l’analista Alex Pagliardini nel loro intervento in coppia che chiude il volume – e che in un certo senso condensa i risultati dei loro due ricchissimi interventi individuali tesi ad offrire una lettura davvero rischiaratrice dell’algebra lacaniana.
Come porci, quindi, di fronte a questo strapotere dell’automatismo simbolico e come reagire d’innanzi a questa tanto scabrosa quanto fondamentale caratteristica della psiche umana scrutata da Lacan negli anni settanta, quasi a preconizzare l’avvento della nostra odierna società turboconsumista? Come opporsi a questo godimento uniano, a questo godimento autistico che, anche grazie alla diffusione di dispositivi che letteralmente incollano lo sguardo di ogni-uno alla parata infinta del significante, ha assunto oggi una portata tale da risultare difficilmente circoscrivibile in quanto interessa fenomeni tutt’affatto eterogenei (dal doom scrolling alle più gregarie manifestazioni di piazza condotte nel nome di ideali posticci, passando per gli hikikomori e per la riduzione del discorso politico a mera passerella identitaria), come a voler sancire la diffusione ormai capillare di soggettività richiuse su sé stesse, che hanno come loro unico orizzonte l’Altro della ripetizione significante? Posto che non esistono, al di là dei richiami populisti che provengono sia da destra che da sinistra, risposte univoche a queste domande e una volta appurato con sconforto lo stato in cui riversa la realtà sociale, può essere utile anche solo – ma forse è già molto… – ritornare umilmente a frequentare i classici, a Freud, ritornare a Lacan. E ritornare a leggere Lacan non tanto con l’intento di elaborare nuove teorie o di rinnovare nominalmente, formalmente, la psicanalisi o la filosofia ma per assumere su di sé, singolarmente ed in modo giocoforza unico, quello stesso godimento dell’Uno per rivoltarlo contro sé stesso attraverso “un’operazione che riporta l’insopportabile al suo posto” [20]. Solo così è possibile rendere urgente, inaggirabile e inderogabile l’azione, la decisione insondabile che arricchisce il reale scabro e desertico con qualcosa di inedito, di singolare. È questo infatti il limite critico della scienza, incapace com’è di valicare i suoi scopi descrittivi, che la mistica ed il femminile secondo Lacan dovrebbero riuscire a scardinare ed è questa, in breve, la grande lezione etica della psicanalisi:
“Forse solo una considerazione epistemologica della scienza, se riuscisse ad allargarne il concetto fino ad includervi anche la psicanalisi, e quindi l’etica, potrebbe rendere il contributo di Freud e di Lacan centrale non solo nella storia della psicanalisi, ma in una teoria della formazione” [21]. "Leggere… o peggio."
Filippo Zambonini
Note:
[1] Lacan, Scritti, 2 Voll, Einaudi, Torino, 1974
[2] Chiara Massari, “Leggere…Da un Altro all’altro. Il Seminario XVI di Jacques Lacan”, Galaad Edizioni, 2021
[3] Marco Ferrari, “Leggere…o peggio. Il Seminario XIX di Jacques Lacan”, Galaad Edizioni, 2023, p. 55
[4] Ivi., p. 53
[5] Ivi., p. 54
[6] Il riferimento qui è a Fabrice Bourlez, Queer Psicanalisi. Clinica minore e decostruzione del genere, Mimesis, Milano – Udine, 2022
[7] A tal riguardo rimando a questo illuminante saggio di Richard Dawkins: https://areomagazine.com/2022/01/05/race-is-a-spectrum-sex-is-pretty-damn-binary/
[8] Marco Ferrari, “Leggere…o peggio. Il Seminario XIX di Jacques Lacan”, op.cit., p. 74
[9] Ibidem.
[10] Ivi, 75
[11] Jacques Lacan, Il Seminario XX. Ancora, Einaudi, Torino, 2011
[12] Lacan scrive
LaDonna barrandone l’articolo proprio in modo da ricordare lo statuto di negatività radicale che Heidegger attribuisce all’Esserci (Dasein) alla fine di “Essere e Tempo”, dove per indicare che “l’Essere” (Sein) dell’Esserci non è esso stesso un Essere – e quindi irriducibile a qualsivoglia ontologia – si ricorre all’espediente tipografico “Essere”(Sein).[13] Ivi, 76
[14] P. 97
[15] Lacan, J, La significazione del fallo: Die Bedeutung des Phallus, in Scritti, op. cit.
[16] Pp. 194 - 195
[17] P. 200
[18] Jacques Alain Miller, Cause et consentement, corso inedito del 1997 – 1998, lezione del 2 Dicembre 1987
[19] P. 211
[20] P. 244
[21] P. 204
Bibliografia:
Fabrice Bourlez, Queer Psicanalisi. Clinica minore e decostruzione del genere, Mimesis, Milano – Udine, 2022
Richard Dawkins: https://areomagazine.com/2022/01/05/race-is-a-spectrum-sex-is-pretty-damn-binary/
Marco Ferrari, “Leggere…o peggio. Il Seminario XIX di Jacques Lacan”, Galaad Edizioni, 2023
Jacques Lacan, “… o peggio. Il Seminario XIX, 1971 – 1972”, Einaudi, Torino, 2020
Jaqcues Lacan, Il Seminario XX. Ancora, Einaudi, Torino, 2011
Jacques Lacan, Scritti (2 voll.), Einaudi, Torino, 1974
Chiara Massari, “Leggere…Da un Altro all’altro. Il Seminario XVI di Jacques Lacan”, Galaad Edizioni, 2021
-
«Girare in cerchio». Furio Jesi e l’enciclopedia del mito
Recensioni / Novembre 2023Sfogliando gli indici del Vocabulaire des Institutions Indo-Européennes di Benveniste, ci si imbatte in una circostanza singolare. Tra i vocaboli che il grande linguista prende in esame, «nel vasto tesoro delle corrispondenze acquisite», per ripercorrere a ritroso la genealogia delle istituzioni indoeuropee, la parola mythos non compare affatto. Chi ricercasse l’uso originale, ricavato per comparazione dalle fonti, di mythos, rimarrebbe dunque inevitabilmente deluso. Che mythos non presenti ricorrenze significative nel Vocabulaire, potrebbe, però, alludere a una circostanza ben più decisiva, tale da investire la storia delle religioni, l’antropologia, la filologia, la linguistica, e, in ultima analisi, lo stesso statuto epistemico delle scienze umane. Si tratta, cioè, del dubbio circa l’esistenza dell’oggetto «mito», a cui la parola mythos non cessa tuttavia di rimandare.
È proprio da questa considerazione che, quattro anni dopo l’uscita del Vocabulaire, prendeva le mosse Furio Jesi (1941-1980) in Mito, pubblicato per la prima volta nel 1973 nell’Enciclopedia Filosofica Isedi. Il libro, ristampato nel 1980 da Mondadori e nel 2008 da Aragno, è ora disponibile nella nuova edizione Quodlibet (2023) curata da Andrea Cavalletti, corredato dal saggio finora inedito La nascita dello spazio-tempo. Tale edizione si colloca in una fase indubbiamente cruciale della ricezione dell’opera di Jesi. Se, nel 2011, un interprete autorevole del pensiero jesiano come Enrico Manera annunciava una Jesi-reinassance, segnata da un rinnovato interesse perlopiù circoscritto all’Italia, oggi pare di assistere a una seconda reinassance jesiana, stavolta estesa al mondo editoriale e accademico francese, tedesco e, soprattutto, anglofono.
In effetti, Mito di Jesi si apre con l’indagine degli usi omerici di mythos che Benveniste, nel Vocabulaire, aveva omesso. In Omero, mythos significa qualcosa come «decisione», «congiura», «progetto» esistenziale e «sentenza» divina. Il campo semantico del termine include, cioè, ciò che Benveniste avrebbe chiamato gli usi performativi del linguaggio e che Jesi, in singolare consonanza con le riflessioni che Northrop Frye andava maturando in quegli anni (e che Jesi, però, probabilmente non conosceva), chiama «parola efficace» (p. 24). In Omero, però, mythos può essere «parola efficace» anzitutto perché è, insieme, «astuzia presente» e «evocazione dei tempi passati», paradossale coincidenza di «oggi» e «tempi antichi» nell’istante dove «il passato anticipa e consacra, fa vero, il presente».
È il tardo conio della parola mythología a scandire, per Jesi, uno stadio decisivo nella genealogia del lemma mythos, che coincide con una crisi epocale nella storia della cultura europea. In un processo che affonda le sue radici nella crisi dell’epos antico, ma che trova in Platone il suo più alto punto di maturazione, mythos e lógos si dispongono ai poli opposti di un campo semantico che procede da un minimo a un massimo di performatività: mythos assume il significato di un «puro raccontare […] non obbligatorio» (p. 20); mentre lógos diviene parola persuasiva, vincolante in quanto vera, efficace.
A partire dalla Grecia classica, dunque, il mythos è consegnato alla scienza e alla politica europee anzitutto come significante vuoto, simulacro di una «parola efficace» ormai resa ineffettuale e, insieme, fantoccio, straw-man contro cui la ragione non cesserà di scagliarsi, proiettandovi, al tempo stesso, i propri demoni e, paradossalmente, le proprie nostalgie. È la designazione stessa della parola «mito» a vacillare, nel sempre rinnovato tentativo di ancorarsi alla spettrale realtà di un oggetto – il mito – che è sempre «già e non più accessibile» (p. 46). In questo senso – così suona la tesi fondamentale di Jesi – la moderna scienza del mito non può che configurarsi come paradossale «scienza di ciò che non c’è» (p. 94).

Giovanni Battista Piranesi: La Grande ruota (1761)
M. Johnston, Open Access Image from the Davison Art Center, Wesleyan UniversityChe cos’è il mito? – Mito di Jesi ruota, appunto, attorno a questa domanda. In effetti, il suo tratto più caratteristico è proprio di non cessare di «girare in cerchio» (p. 120) intorno all’oggetto-mito. A giudicare dal sommario, Mito si presenta in tutto e per tutto come una introduzione allo studio del mito e delle sue interpretazioni in età moderna. Di fatto, Jesi, dopo aver individuato nella «crisi nei confronti dell’accesso moderno alla mitologia» (p. 47) il punto di insorgenza della «scienza del mito» – che va dunque situato in epoca post-rinascimentale, dal momento che «il primo umanesimo e la cultura del Rinascimento […] ”vissero” o credettero di vivere» il mito (p. 33) –, traccia un percorso che, dai primi decenni del XIX secolo, attraversa la teorizzazione illuministica (Charles François Dupuis) e romantica del mito (Buttmann, K.O. Müller, Creuzer, Bachofen), si snoda attraverso lo storicismo (Wilamowitz) e l’etnologia e le scienze antropologiche del XX sec. (Malinowski, Lévy-Strauss, Dumézil), approdando alla singolare sintesi della teoria junghiana degli archetipi con il modello morfologico di Propp, che costituisce la proposta teorica dello stesso Jesi.
Eppure il senso di tale itinerario si chiarisce soltanto alla luce dell’avvertenza che Jesi pone all’inizio della Prefazione. «Codesto libro – scrive Jesi – non è una sistematica breve storia della “scienza del mito”, né un’introduzione ad essa. È piuttosto un tentativo di circoscrivere il concetto di mito mediante una tecnica di “composizione” critica di dati e dottrine, fatti reagire tra loro, il cui modello metodologico si trova nella formula del conoscere per citazioni […]. Oggetto di codesto libro è il concetto di mito nell’ambito di una enciclopedia» (p. 11). In questo senso, Jesi prese alla lettera la sfida che Mario Antonelli gli pose proponendogli di scrivere Mito per la collana Enciclopedia Filosofica della Isedi. Che l’oggetto-mito possa essere accostato soltanto con uno stile di pensiero enciclopedico, cioè attraverso una enkýklios paideîa, una vera e propria «educazione circolare», in grado di tenersi costantemente equidistante dal nucleo che potrebbe (o non potrebbe) essere occupato dal mito, ciò costituisce precisamente l’ipotesi centrale della teoria della «macchina mitologica» che Jesi andava elaborando in quegli anni, e che trova in Mito una delle sue verifiche più cogenti.
Tale ipotetico nucleo è infatti, per Jesi, il sito di un paradosso che non può essere sciolto sul terreno della scienza, ma soltanto su quello della politica. In effetti, tale paradosso si articola storicamente nel decisivo aut aut che Jesi coglie in filigrana nello sviluppo della moderna scienza del mito. Alla domanda: Qual è il compito epistemologico del mitologo?, essa può rispondere soltanto articolando e riproponendo sempre di nuovo l’ alternativa secca tra accettazione e spiegazione dei materiali mitologici: con «la consapevolezza che lo studio deve in ultima istanza promuovere l’accettazione della mitologia, il “bere alla sorgente” (secondo le parole di Kerényi), oppure con la consapevolezza che lo studio deve trovare compimento nella spiegazione delle ragioni per cui il materiale mitologico si è plasmato in determinate forme» (p. 65).
È questa spaccatura a segnare irrimediabilmente la mitologia moderna. Anzitutto istituendo i due poli attorno a cui essa incessantemente oscilla: la fede o la non-fede nell’esistenza del mito inteso come sostanza autonoma – motore efficiente che, generando e assemblando senza posa i materiali mitologici, plasmerebbe lo spazio politico e l’ordine del discorso. In questa prospettiva, la vicenda storica della «scienza del mito» coincide con una verifica costante ciò che Jesi chiama «la qualità ideologica della scelta di affermare o negare la sostanza del mito». È così che la questione intorno alla presunta essenza del mito si trasforma nella domanda sulla sua esistenza: C’è o non c’è qualcosa come il mito tra le pareti della macchina mitologica? È il mito un semplice focus imaginarius, un centro ipotetico proiettato da una circolazione di materiali culturali, scientifici e ideologici che si sosterrebbe in ultima analisi sull’umano? O, viceversa, l’umano non è che un veicolo attraverso cui una sostanza extra-umana si esprime, configurando quei materiali in un mondo sostenuto soltanto dallo spettrale rimando al suo insondabile fondamento?
Tali questioni segnalano indubbiamente il profondo legame tra Jesi e la Mythos-Debatte degli anni Settanta in Germania da un lato, e, dall’altro, la sua affinità elettiva con autori come Derrida, che, poco più di un anno prima dell’uscita di Mito, aveva pubblicato su «Poétique» La mythologie blanche. Il gesto più caratteristico di Jesi è, forse, di lasciare sine conditione alla politica l’ultima parola sulle ipotesi della scienza del mito. Certo, la politica gioca un ruolo essenziale in un Blumenberg, un Marquard o un Derrida. Eppure, che la politica coincida con il piano ultimativo di verifica della mitologia, con il giudizio di ultima istanza sulla teoria, è una posizione che, in quegli anni, è stata formulata con chiarezza pari a Jesi soltanto da un autore come Jacob Taubes. Non a caso, fu proprio Taubes, in polemica con i mitologi e i teorici della cultura che ruotavano attorno a «Poetik und Hermeneutik», a denunciare con toni tipicamente jesiani il capovolgimento della mitologia di Eliade, Kerényi, Lévy-Strauss in una vera e propria mitografia («Comune a tutti – scrive Taubes – resta il fatto che essi danno una spiegazione mitica del mito e non mirano a un punto archimedico esterno alla situazione mitica; insomma producono un “mito della mitologia”»).
Una menzione particolare merita, poi, l’ambiguo (non-)rapporto tra Jesi e la storia delle religioni italiana. In effetti, nemmeno una pagina, in Mito, è dedicata a Raffaele Pettazzoni, Angelo Brelich o Ernesto De Martino. Circostanza tanto più sorprendente in quanto non solo Jesi, nella seconda metà degli anni Cinquanta, si accostò alla questione del mito proprio attraverso le pubblicazioni della celebre «Collana viola» di Einaudi, diretta da Pavese e dallo stesso De Martino, ma soprattutto perché la dicotomia tra accettazione e spiegazione, che, in Mito, scandisce la vicenda della mitologia moderna, ricalca da vicino la tensione metodologica tra fenomenologia e storicismo che, per il tramite di Pettazzoni, diventerà un tratto caratteristico della storia delle religioni in Italia.
Ma ancora più curioso è il silenzio che Jesi riserva a un autore come Brelich, che, da Gli eroi greci (1959) a Paides (1969), aveva individuato nel kerényiano rinnovamento dell’umanesimo il compito politico dello studio storico-religioso della civiltà greca e dei suoi miti. Fu proprio tale visione del ruolo politico dell’intellettuale a determinare la partecipazione di Brelich (come di Jesi) al Sessantotto italiano («La vicenda – scriveva Brelich in Verità e scienza – non mi avrebbe potuto trovare più pronto e aperto. Ero tra i primi docenti a parteggiare, senza esitazione e perfino […] in forma insolitamente attiva, per gli studenti che smascheravano “irrispettosamente” gli atteggiamenti delle autorità accademiche […], le loro connivenze con gli interessi della reazione»). In questa luce, il mancato confronto tra Jesi e la scuola italiana appare, in Mito, come una lacuna ambigua, un’omissione carica di tutta l’eloquenza del non-detto.
Ma torniamo ora, in conclusione, alla tesi di Jesi e al meccanismo epistemologico-testuale di Mito. Se, come suona la classica tesi di Adorno, il mito è anzitutto il sempre-uguale, la scienza del mito, vittima e al tempo stesso artefice dell’eterno ritorno della domanda sull’esistenza del mito, si fa essa stessa mitopoietica. Di fronte a questa circostanza, Jesi risponde con un risoluto nichilismo metodologico. «Nell’ambito della “storia del mito” – egli dichiara – l’unica scienza oggi possibile è la storia della storiografia» (p. 46), cioè uno studio degli approcci moderni al mito che sia in grado di cogliere la loro tensione dialettica. Tale nichilismo non coincide, però, con una professione di assoluto nominalismo. È vero che il passaggio dal greco mythos al «mito» delle lingue moderne non può essere in nessun caso legittimo. Eppure, non si può nemmeno affermare la non-esistenza in via di principio di un referente di «mito». Occorre piuttosto, secondo Jesi, spostare l’asse della questione: dall’esistenza all’uso, dalla metafisica alla pragmatica, dall’epistemologia alla politica.
Che cos’è il mito? – è dunque, precisamente, la domanda a cui Jesi non dà risposta. Anzitutto, perché accoglierla equivarrebbe a rientrare nella casistica che si snoda lungo l’intero itinerario moderno della scienza del mito. In secondo luogo, perché la stessa formulazione della domanda è il trucco con cui la macchina mitologica esercita il suo fascino su manipolati e manipolatori, vittime e carnefici, illusi e illusionisti. È l’allusiva strizzata d’occhio con cui la macchina si ammanta di un’aura di suggestione e ci invita a lasciarci sedurre dal suo sguardo di Medusa: «Non badate tanto al mio modo di funzionare, quanto alla mia essenza» (p. 123). Girare in cerchio, enciclopedizzare, come fa Jesi in Mito, significa allora seguire con sobrietà i movimenti, le filiazioni, le disarticolazioni e riarticolazioni della macchina, sposando una strategia di resistenza genuinamente politica.
Lorenzo Mizzau
Bibliografia
Benveniste, E. (1969). Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee. ed. it. a cura di M. Liborio. 2 voll. Torino 2001: Einaudi.
Carchia, G. (1997). Elaborazione della fine. Mito, gnosi, modernità. in id. L’amore del pensiero. Macerata 2000: Quodlibet.
Derrida, J. (1971). La mitologia bianca. in Id., Margini della filosofia. ed. it. a cura di M. Iofrida, Torino 1997: Einaudi.
Frye, N. (1982). Il grande codice. La Bibbia e la letteratura. ed. it. a cura di G. Rizzoni. Torino 1986: Einaudi.
Jesi, F. (1973). Lettura del Bateau ivre di Rimbaud in Id. Il tempo della festa. a cura di A. Cavalletti. Roma 2014: Nottetempo.
Jesi, F. (2023). Mito. a cura di A. Cavalletti. Macerata: Quodlibet.
Manera, E. (2012). Furio Jesi. Mito, violenza, memoria. Roma: Carocci.
Sarpi, P. (2013). Prefazione. in A. Brelich. Paides e parthenoi. a cura di A. Alessandri e C. Cremonesi. Roma: Editori Riuniti.
Spineto, N. (2023). Gli studi di storia delle religioni. Firenze: Le Monnier.
Taubes, J. (1954). Dal culto alla cultura, in Messianismo e cultura. cit.
Taubes, J. (1983). Sulla congiuntura del politeismo, in Messianismo e cultura. Saggi di politica, teologia e storia. ed. it. a cura di E. Stimilli. Milano 2001: Garzanti.
-
L’inconscio e il trascendentale. Saggi tra filosofia e psicoanalisi di Giovanni Leghissa (Orthotes, 2023) è a suo modo e a dispetto delle apparenze un libro di metafisica: a percorrere e collegare i cinque testi che lo compongono è infatti il tema filosofico per eccellenza, quello della fondazione. Che ne è, oggi, del gesto della fondazione? È ancora possibile effettuarlo, ossia – nei termini dell’autore – dominare, con sguardo “totale”, l’enciclopedia dei saperi? La risposta di Leghissa, che si muove nel solco della fenomenologia husserliana (seppur riveduta e corretta), è naturalmente negativa: le risorse che il sapere filosofico ha da sempre dispiegato per dare un fondamento in senso logico, ontologico e percettologico (p. 109) alla realtà non possono se non essere interne al sistema indagato. Con buona pace delle pretese – in fondo teologiche – che ancora animavano i pensatori sistematici del XIX secolo, Leghissa sostiene come sia costitutivamente impossibile reclamare uno sguardo “da fuori”, fondando dall’esterno ciò nella cui costruzione siamo inevitabilmente coinvolti (p. 20). Si tratta di un definitivo congedo dalla filosofia (p. 22), in favore di saperi scientifici e umanistici più attrezzati in quanto circoscritti e controllabili? Al contrario: se la filosofia, pur accogliendo in sé l’impossibilità della fondazione, intende riguadagnare la pretesa di porsi quale sapere critico universale, in grado di mettere in questione ciò che non si indaga poiché ritenuto ovvio tanto nei suoi stessi confronti quanto rispetto a ciò che le è esterno, bisognerà procedere a una sua riforma, che investa nel profondo i suoi principali operatori.
È innanzitutto l’ormai classica distinzione tra empirico e trascendentale a dover essere rimodulata (p. 113). Mantenere una netta separazione tra questi due ambiti, quasi che spontaneamente ciò che percepiamo con i sensi possa riapparire intatto nelle più alte sfere della concettualità – o che, all’inverso, le forme ideali separate riescano ad aderire perfettamente all’esperienza sensibile – significa condannare il pensiero al vicolo cieco di un dualismo che non riuscirà mai a riunire adeguatamente ciò che ha separato. Seguendo la lezione dello schematismo kantiano e la sua successiva penetrazione all’interno del pensiero di Husserl (p. 113), Leghissa mostra come operazioni sintetiche capaci di prefigurare la costruzione dell’idealità siano già attive all’interno della sensibilità e come, di conseguenza, la stessa concettualità non sussista mai in piena purezza, ma risulti sempre coalescente con una componente di natura empirica (p. 116). Nozioni husserliane quali quelle di sintesi passiva (p. 113), di ritenzione (p. 114) e di mondo della vita (p. 136) vanno così intese secondo Leghissa in un senso non duale, molto vicino – si potrebbe aggiungere – alle riflessioni di Gilles Deleuze sulla natura filosofica dell’immanenza, tale per cui ciò che costituisce la condizione trascendentale (ad esempio la nozione di triangolo) risulta effettivamente esistente soltanto nella sua concreta apparizione empirica (ossia il triangolo disegnato).
Allo stesso tempo – e conseguentemente – sarà l’altrettanto originaria distinzione tra mythos e logos a dover essere rimessa in questione: il gesto inaugurale – di nuovo: fondativo – con cui la filosofia ha preteso onorare la propria vocazione razionale, prendendo al contempo le distanze dalle narrazioni proprie dell’orizzonte mitico è infatti, ancora una volta, un’operazione inservibile (p. 118). Come ha sapientemente mostrato Jacques Derrida, è a rigore impossibile istituire una distinzione definitiva tra concetto e metafora, proprio perché questa stessa distinzione non sembra prestarsi a un’analisi di tipo concettuale: a mancare è il concetto filosofico della metafora, la “metafora della metafora” (p. 123). A una più accurata ricognizione risulta dunque chiaro non solo come – idea già maturata per esempio nel pensiero di Bergson – le metafore possano fornire un concreto ausilio allo sviluppo del pensiero filosofico, ma anche come i principali operatori filosofici risultino indecidibili (p. 128), ossia non posizionabili completamente né da parte metaforica né da parte concettuale (com’è significativamente il caso della Lebenswelt husserliana).
L’embricazione costitutiva tra empirico e trascendentale quanto quella tra concetto e metafora conduce così Leghissa a riflettere sul significato e il portato del gesto filosofico. In primo luogo esso dovrà da un lato porsi sotto il segno della decostruzione (p. 128): la filosofia dovrà muoversi in quel groviglio di concetti e metafore che caratterizza l’insieme dei saperi, con l’obiettivo critico di chiarire e mostrare gli aspetti mitici all’opera nella razionalità e quelli razionali agenti all’interno dei mitologemi. In secondo luogo, essa, nel riconoscere i propri costitutivi limiti, dovrà allearsi con un altro sapere ibrido per eccellenza, ossia la psicoanalisi che, sull’asse Freud-Lacan, ha per sua propria natura fatto i conti con l’impossibilità di una fondazione ultima. Secondo Leghissa la psicoanalisi freudiana – soprattutto nella sua versione lacaniana, “linguistica” e strutturale – nell’interrogare da vicino la nozione di inconscio, può istituirsi quale “macchia cieca” della filosofia, ossia riuscire da un lato nell’intento di rendere visibili quelle sue operazioni interne (p. 11) che le restano per sua natura precluse e, dall’altro, di attutire la sua ineludibile volontà – di natura in fondo mitica – di “fare uno”, ossia di ridurre l’intero campo del reale a puro concetto (p. 144).
Sono però forse le incursioni nell’antropologia filosofica, condotte a partire dal pensiero di Hans Blumenberg, a dare alla prospettiva di Leghissa particolare originalità, schivando gli esiti spesso sterili che incontrano oggi gli epigoni di Husserl e Derrida. Le rimodulazioni del rapporto tra empirico e trascendentale, così come la pratica filosofica della decostruzione e la possibile alleanza con la psicoanalisi trovano quale presupposto una precisa ipotesi antropologica – in fondo già nietzscheana – che vede nell’essere umano “un animale che, per superare oggettive deficienze adattive […] si concede il lusso di creare artefatti anche piuttosto elaborati” (p. 134). L’esigenza umana di costruire un linguaggio attraverso cui raccontar storie per “dominare” il reale costituisce lo sfondo – una sorta di mondo della vita riletto però in chiave antropologica – a partire dal quale l’avventura anche “teoretica” di Homo sapiens può essere posta. Si comprende allora in maniera più chiara il ripetuto appello a combattere quella purezza che il filosofico ha da sempre riservato per sé: si veda, a titolo di esempio, l’analisi storico-teologica che Leghissa consacra alla nozione plotiniana di Uno, svelandone implicazioni ed esigenze, e capace di mostrare come tale concetto/metafora non emerga alla stregua di un prestito calato dall’empireo, ma si realizzi e diventi concretamente operativo attraverso la compresenza e l’evoluzione di differenti “figure” (pp. 128-133).
È proprio a partire da qui, ossia dalla capacità di mostrare la natura impura del concetto e la conseguente presenza di ampi tassi di mythos nel cuore stesso della razionalità filosofica che si situa la proposta “politica” che emerge dal testo: l’attività di critica filosofica, in pieno accordo con l’esplicita rivendicazione di un’eredità illuminista, deve essere al tempo stesso produttrice di emancipazione. Leghissa riflette lungamente – attraverso le intuizioni di Freud sul rapporto tra io e massa e quelle di Lacan intorno al nome del padre – sulla natura “fantasmatica” della relazione che l’uomo instaura costantemente con la realtà: tanto nell’esperienza dell’innamoramento (p. 82), quanto nel rapporto con la legge e con gli altri (p. 88) è ogni volta in atto un meccanismo emotivo di identificazione che conduce l’individuo a una rinuncia all’attività individuale in favore di un comportamento stereotipato (pp. 28-50; pp. 62-63; pp. 88-98). Se è vero che tale meccanismo di identificazione è imprescindibile per la crescita dell’essere umano e di esso è dunque impossibile liberarsi completamente, la presa di consapevolezza conseguente alle attività di una filosofia psicoanalitica (o di una psicoanalisi filosofica) potrà quantomeno indurre il soggetto a un rapporto più sorvegliato nei confronti del reale.
A partire da queste considerazioni, si sarebbe tentati di assegnare alla psicoanalisi una funzione politica emancipatrice, ma è l’autore stesso a metterci in guardia: proporre un freudismo o un lacanismo massimalista e rivoluzionario (nei tanto esempi in cui oggi si declina) significa misconoscere il pessimismo antropologico che da sempre ha animato il discorso psicoanalitico, per il quale “le pulsioni aggressive degli uomini non sono in alcun modo eliminabili” (p. 77). Al di là dei confini di questo pessimismo, ossia al di là del nesso tra desiderio e fantasma, e in ottica esplicitamente utopistica, è forse meglio guardare – sembra confessarci Leghissa – alle preziosissime indicazioni fornite dal Marchese de Sade nella sua opera (pp. 99-108). Sganciando la pulsione sessuale dal desiderio – quale autore in fondo meno erotico? – Sade sembra immaginare una società senza fantasmi, ossia pienamente egualitaria, la quale da un lato è in grado di mostrare la completa arbitrarietà delle norme sociali in quanto tali (p. 107) e dall’altro scommette su cosa può significare una libertà “assoluta” incarnata da soggetti completamente sovrani (p. 108).
Di fronte alla proposta teorico-politica proposta da Leghissa si potrebbero tuttavia avanzare alcune obiezioni relative al ruolo che in essa viene ad assumere la filosofia. Seguendo alcuni nuclei argomentativi pare che questa ne esca notevolmente ridimensionata: all’interno del progetto enciclopedico – cui essa non prende di fatto parte – le resterebbe in eredità soltanto un compito di natura fenomenologico-descrittiva (p. 22), peraltro in un contesto in cui i saperi sono oggi perfettamente in grado di autolegittimarsi (certo, con una dose più o meno massiccia di artifici retorici), respingendo con successo ogni intrusione nel proprio ambito di indagine. Se si seguono altri passaggi emerge invece la posizione opposta, per cui sull’impresa filosofica pare gravare un carico che è forse al di là delle sue reali capacità e competenze: da un lato questa dovrebbe sapersi riparametrare a puntello critico capace di sondare i presupposti inindagati dell’intero campo dei saperi (p. 139) e, dall’altro, una volta posta la sua alleanza con la psicanalisi, parrebbe vocata allo sforzo quasi ossimorico di tenere insieme il riconoscimento del bisogno umano di rassicurazioni identificative al valore emancipativo che una “mitologia della ragione” potrà indurre (p. 145). Insomma, la filosofia sembra alternativamente destinata o al congedo dall’enciclopedia dei saperi o a un potenziamento ipertrofico della sua stessa presenza.
Al netto di queste considerazioni, L’inconscio e il trascendentale si presenta come una raccolta di saggi ricca di stimoli non soltanto teorici, nella quale si tenta un decisivo collegamento tra la riflessione metafisica sulla natura del gesto filosofico e l’indagine delle caratteristiche proprie dell’essere umano e del suo modo di abitare la realtà, la storia e le istituzioni. Leghissa si dimostra così in grado di maneggiare, accompagnandola con rigore argomentativo, quell’arte della “distanza” – quel voler afferrare la natura intima del reale senza voler coincidere completamente con esso – che è in fondo il senso stesso dell’impresa filosofica.
Giulio Piatti
-
Il riconoscimento naturalizzato di Lucio Cortella
Recensioni / Settembre 2023Pochi concetti nel pensiero sociale e politico contemporaneo hanno suscitato un interesse così diffuso come il concetto di riconoscimento. Gran parte del suo fascino sembra derivare dal fatto che si basa su un'esperienza famigliare a tutti, vale a dire l'esperienza di dipendere dagli altri nella propria relazione con sé stessi, nel bene e nel male. Questa esperienza può assumere molte forme. Essere ignorati ad una festa da chi ci ha visto ci mette a disagio, ricevere elogi da un collega per un lavoro ci fa sentire orgogliosi, essere sottoposti a controlli approfonditi ad una frontiera ci fa dubitare di quanto siamo benvenuti nel paese dove andiamo. Esempi come questi illustrano che gli altri sono coinvolti nel plasmare le nostre vite e le nostre percezioni attraverso il modo in cui ci vedono e ci trattano. È proprio su questa connessione tra sé e altro che si è aperta una profonda riflessione. L'attuale interesse per il riconoscimento - un concetto che può essere trovato nelle opere di una varietà di pensatori, ma che è, almeno nella tradizione della filosofia europea, più comunemente associato a Hegel è in gran parte dovuto agli interventi teorici di Charles Taylor e Axel Honneth all'inizio degli anni '90. Taylor coniò l'espressione “la politica del riconoscimento” nel contesto dei dibattiti sul multiculturalismo come strumento per affrontare il tema della valorizzazione della differenza culturale, ma fu soprattutto Honneth che con Lotta per il riconoscimento (1992) fece un lavoro di recuperò dell'idea della lotta per il riconoscimento come concetto centrale per una rinnovata teoria critica post-adorniana che fosse in grado di dare un senso alle motivazioni morali della lotta sociale. Il concetto di riconoscimento rapidamente acquisì importanza nella filosofia sociale e politica, lo testimonia un corpus letterario in continua crescita.
La grande sfida affidata a quelle riflessioni consisteva nel tentativo di uscire dalle secche della dissoluzione del soggetto che il linguistic turn, in tutte le varianti novecentesche, aveva imposto e che conducevano a forme di decostruzione e a teorie del potere che avevano trasformato il soggetto nella marionetta eterodiretta da discorsi o poteri impersonali. Axel Honneth senza ricadere nel monismo soggettivista che da Cartesio a Kant aveva caratterizzato la modernità, si mantiene fedele al paradigma intersoggettivo postmetafisico riportando i temi della costituzione del soggetto al centro della filosofia contemporanea. Non trascurando, anzi assumendo le critiche al soggetto che si sono sviluppate da molteplici tradizioni filosofiche contemporanee, Honneth ritiene si possa ripensare l’autonomia stessa del soggetto a partire dalla sua costituzione intersoggettiva. A differenza del tema del “dono” che nei medesimi anni veniva utilizzato per svolgere lo stesso ruolo anti-liquidatorio del soggetto, il riconoscimento è stato un principio assolutamente più efficace e longevo che ha avuto varianti ed applicazioni differenti. In questa prospettiva va letto l’ultimo testo di Lucio Cortella Ethos del riconoscimento (Laterza, 2023): certamente non, semplicemente, la ricostruzione di un dibattito che dalla pubblicazione del testo di Honneth ha preso il via, quanto il rilancio e l’oltrepassamento di quella prospettiva in una chiave più radicale. Il passo oltre Honneth parte dal confronto con lo stesso Hegel che è l’ispiratore della teoria del riconoscimento honnethiano. Cortella, come Honneth, considera il merito filosofico principale di Hegel nell’aver compreso che il rapporto con sè stessi che si esprime nell’autocoscienza è possibile solo in quanto si costituisce come rapporto ad altri, rapporto che va inteso come un’interazione mediata da un processo di reciproco riconoscimento. Questo recupero di Hegel è in sintonia con una serie di riflessioni che, a partire dagli anni ’70, hanno consentito l’abbandono definitivo delle tesi riflessiviste dell’autocoscienza che da Cartesio a venire in avanti hanno rappresentato l’identità come il prodotto di un soggetto che si identifica come oggetto del proprio pensiero. Che il soggetto che si pone davanti a sé stesso in una sorta di auto-endoscopia possa costituire il significato dell’autocoscienza era già stato profondamente contestato per esempio da pensatori come Ernst Tugendath o Dieter Henrich i quali mostravano la contraddizione di un io che rivolgendosi a se stesso in un atto di autoriflessione deve presupporre ciò che costituisce il risultato di quest’atto.
Secondo Cortella, Hegel pensa il riconoscimento come condizione inaggirabile dell’autocoscienza e quindi dell’identità individuale, ma forzando Hegel stesso, Cortella definisce il riconoscimento come condizione trascendentale – in senso kantiano – dell’autocoscienza. “Originario non è dunque il soggetto, ma la relazione. Ora essendo tale relazione condizione di possibilità della nostra autocoscienza e della nostra conoscenza degli oggetti in esso si ripresenta il senso e la funzione del trascendentale” (Ethos del riconoscimento p.56). Si tratta di un trascendentale depurato dal carattere soggettivistico di Kant, per cui tale presupposto non risulta più interno al soggetto, ma fuori di esso. Come noto l’assolutizzazione che ne farà Hegel, comprometterà fino alla seconda metà del ‘900 la nozione di trascendentale che sarà recuperato sul piano del linguaggio e della sua dimensione pragmatica in modo decisivo da Karl-Otto Apel e da Jurgen Habermas. Se Honneth, nella propria teoria del riconoscimento si tiene lontano da questa soluzione, Lucio Cortella si colloca decisamente su questo terreno, un terreno in cui la caratterizzazione dei soggetti empirici costituiti naturalmente e posti in contesti storici ne impedisce la definizione nel senso di un apriori trascendente l’empirico. È una impostazione di trascendentale che Cortella definisce “minimale” e che indica l’impossibilità di aggiramento. Risuona in questa argomentazione del filosofo veneziano la lezione di un suo maestro, Emanuele Severino, che si rifaceva all’elenchos aristotelico per chiarire la forma dell’inaggirabilità del principio di non contraddizione. Tuttavia la radicalità di Cortella pare andare oltre nel senso che nonostante il fastidio e il fatto che Lucio Cortella si premuri di non menzionarlo, quello che si delinea in Ethos del riconoscimento è una sorta di definizione ontologica del riconoscimento: quando sostiene che la relazione di riconoscimento precede i soggetti e di fatto li costituisce è facile dire che si tratta di questo tipo di argomentazione. Di fatto Cortella cercando di smarcarsi da questo tipo di vocabolario sostiene che è presente all’origine una logica del riconoscimento la quale analogamente alla fenomenologia del dialogo illustrata da Gadamer “gioca” i partner della relazione conducendoli nel rapporto reciproco. Il riconoscimento non è dunque un prodotto che si forma tra un io e un altro io, ma si impone tra i due dall’esterno come un terzo che conduce alla relazione, è una struttura oggettiva che si palesa nel logos che determina il funzionamento del rapporto tra soggetti. Le pagine che illustrano questa dinamica sono di assoluto spessore e in fondo sebbene mai esplicitate nei testi hegeliani, quando Cortella mostra che si tratta di una sorta di “medio” che si impone tra le parti che le conduce al riconoscimento reciproco, esse ben si confanno all’autore della Fenomenologia dello spirito. Questa logica che ha un carattere trascendentale tuttavia per Cortella possiede – ecco un'altra variante decisiva rispetto alla versione honnethiana di riconoscimento – una base naturale. C’è già stato, in tempi recenti, un altro filosofo italiano che ha accostato la logica del riconoscimento alle basi naturali dell’individuo: Paolo Virno. In Saggio sulla negazione (2013) Virno mette alla prova la figura del riconoscimento hegeliano con la scoperta dei cosiddetti “neuroni-specchio” avvenuta anni dopo la pubblicazione del testo di Honneth. Virno si pone la domanda di come si possa parlare di attribuzione o negazione di riconoscimento fra soggetti se esiste, come dimostra la scoperta dei neuroni-specchio, un riconoscimento fra umani che precede qualsiasi processo di consapevole riconoscimento. La soluzione di Virno non compromette la dinamica hegeliana, ma la rimette in gioco ad un secondo livello. Secondo Virno esiste un “livello base” della socialità ancorato alla neurofisiologia. Egli afferma che il linguaggio può retroagire distruttivamente sullo “spazio noi-centrico” minandone la compattezza. Cosa significa non riconoscere il proprio simile? L’esempio è quello del vecchio ebreo consumato dalla fame e dell’ufficiale nazista che pur sapendo cosa prova il suo simile grazie alla “simulazione incarnata”, è in grado di disattivare quell’empatia generata dai neuroni-specchio. L’ufficiale può arrivare a trattare il vecchio ebreo come un non-uomo. Imputare il mancato riconoscimento tra umani a ragioni storiche, culturali, politiche appare troppo comodo e deresponsabilizzante, la situazione è più tragica. Nessuno nega il peso della dimensione politico-culturale: è importante però mettere a fuoco le basi biologiche di questa dimensione. L’ufficiale nazista può non riconoscere il vecchio ebreo perché la socialità dei sapiens non è fornita soltanto dai neuroni a specchio, ma anche dal linguaggio che ammette la negazione degli stati di fatto. “Se i neuroni-specchio agiscono nel suddetto modo, gli atteggiamenti proposizionali autorizzano invece a mettere da parte e a contraddire la rappresentazione dell’altro come persona simile a noi. La sospensione del consentire neurale è legata alla più rilavante prerogativa del linguaggio”. A questo punto vale la pena chiedersi se questa urgenza di verificare la tenuta del riconoscimento alle sollecitazioni provenienti dalle scienze naturali in qualche modo non costituisca uno dei tratti di una ipotetica variante italiana della teoria del riconoscimento. Cortella fa riferimento agli studi di George Herbert Mead e a quelli più recenti dello psicologo e neuroscienziato americano Michael Tomasello i quali, in maniera diversa, condividono lo sforzo di mostrare la genesi e la filogenesi intrecciata di comportamento comunicativo e comportamento cooperativo in direzione di un apprendimento reciproco delle altre persone e della posizione altrui. Il tentativo inedito di coniugare il quadro trascendentale ad una base naturale è la vera scommessa messa in campo da Cortella per gettare le basi di un recupero della soggettività in un quadro di intersoggettività originaria salvandola dalla deriva decostruzionista.
La costitutiva originarietà dell’Annerkennung non si ferma alla dimensione della soggettività, ma significa l’anteriorità dello stesso anche all’Erkennen. Così come non è immaginabile una soggettività che preceda il riconoscimento, allo stesso modo l’oggettività del mondo è irraggiungibile al di fuori di un rapporto tra soggetti che si riconoscono e che si riferiscono collettivamente a quel mondo. Questa ipotesi assolutamente fuori dalla teoria del riconoscimento di Honneth è dovuta, a detta di Cortella, al fatto che l’impostazione del successore di Habermas alla direzione della Scuola di Francoforte rimane troppo concentrata sulle opere jenesi di Hegel non approfondendo sufficientemente la logica del riconoscimento che si evolve lungo tutta la Fenomenologia dello Spirito a partire dalla dialettica servitore/padrone nel capitolo IV dell’opera del 1807. Le pagine della dialettica servitore/padrone delineano in modo “aurorale” la dinamica che percorrerà il testo, ma trovano in quella figura il loro fallimento che invece raggiungerà un esito positivo soltanto a partire dal capitolo VI. Come scrive Cortella, in quel confronto i due soggetti non pervengono ad un riconoscimento reciproco, per raggiungere quello stadio si dovrà passare attraverso una serie di esperienze che metterà la coscienza a confronto con il mondo esterno e con altri soggetti e che gli permetterà di uscire dal particolarismo in cui è collocata. È la nuova forma di oggettività che si raggiunge a partire dalla fine del V capitolo della Fenomenologia e che si espliciterà nella prima parte del VI capitolo. “L’oggettività delle nostre conoscenze è il risultato di un processo di riconoscimento nel quale una prospettiva soggettiva – passata attraverso il vaglio degli altri soggetti coinvolti e completata dal contributo di tutti – è stata riconosciuta come oggettiva”— (Ethos del riconoscimento pag 41). Il valore trascendentale del riconoscimento intersoggettivo assume la valenza delle categorie dell’analitica trascendentale della Critica della Ragion Pura per la conoscenza oggettiva che nella proposta kantiana consentivano l’upgrading delle sensazioni soggettive.
La principale differenza rispetto alla proposta honnethiana è che quest’ultima rimane collocata su di un piano genetico-descrittivo nella misura in cui pur mostrando come si vadano a formare le aspettative morali e il senso morale attraverso il riconoscimento e le sfere del riconoscimento storicamente determinate, manca, a detta di Cortella, il fondamento della normatività del riconoscimento ovvero perché il mancato riconoscimento costituisca un atto immorale. Per Cortella il merito di Honneth di mostrare la ricca articolazione delle forme del riconoscimento gli consente di uscire dalle secche del formalismo astratto di tanta etica contemporanea, tuttavia esplicitarne il funzionamento nei termini di una piena costituzione soggettiva non risolve la necessità – che è evidentemente estraneo ad Honneth – di una argomentazione giustificativa. Il tentativo di Cortella è di muoversi tra la Scilla della deriva assolutizzante del riconoscimento che compie Hegel nel corso della Fenomenologia dello Spirito e la Cariddi del proceduralismo di Habermas costituito da un ipotetico confronto di argomentanti il cui esito è una morale separata da qualsiasi dimensione etica relegata a collezione di “vite buone” e concetti di bene. Se per quanto riguarda Hegel si tratta di fare salva la figura del riconoscimento prima della sua assolutizzazione nello Spirito Assoluto, per quanto riguarda Habermas significa mostrare che in realtà l’autore dell’Etica del discorso nell’ipotizzare “la situazione discorsiva ideale” ha bisogno di fare implicitamente riferimento ad una normatività pre-morale fatta di rapporti vitali, “entro i quali ha la sua fissa dimora” (Etica del Discorso pag 111). Cortella intende Ethos al di là degli usi e costumi, la intende come “dimora”, dimensione originaria in cui gli umani vivono e in cui sono collocati. È il terreno in cui crescono le nostre relazioni che come tali precedono qualsiasi “dover essere”. Il riferimento ad Aristotele è chiaro, così come è chiara la presenza di Aristotele in tutta la riflessione di Cortella. Il suo testo si apre citando la celebre definizione dell’uomo come animale politico, Zoon Politikon ed in fondo si può dire che tutto il lavoro è percorso dall’ aspirazioni di ridefinire quel concetto aristotelico nel quadro della contemporaneità. Il tentativo di coniugare la naturalità del legame fra gli umani e l’inaggirabilità del carattere normativo di quel legame va in quella direzione. Detto in altri termini si tratta per Cortella di superare la necessità kantiana di postulare due regni distinti per stabilire da una parte la verità delle proposizioni oggettive e dall’altra la giustezza delle norme morali. Ciò è possibile mostrando la compatibilità della nostra esperienza morale e della nostra natura biologica. Se ha ragione Kant nel mostrare che non è rinvenibile la libertà nel campo della necessità oggettiva, si tratta allora, anziché rivendicare un regno sovrasensibile della libertà, mostrare come essa sia il “risultato di un processo intersoggettivo e sociale che muove da basi e facoltà naturali. La soggettività non è qualcosa di innato, ma il risultato di un processo costitutivo. Allo stesso modo dobbiamo trattare il problema della libertà”. Sono fatte fuori, in questo modo, tutte le teorie della liberta originaria ovvero quelle impostazioni che ritengono che l’essere umana nasca dotato di libertà e che il rapporto con gli altri, nelle forme politiche che le società si danno, significa quanta libertà venga ceduta, quanta tutelata, quanta negoziata. È l’altro che mi mette in condizione di essere libero. La logica del riconoscimento è quello di una reciproca dipendenza che consente ad un io di essere autonomo nella misura in cui l’altro soggetto che lo riconosce come autonomo conferisce ad esso il medesimo statuto di autonomia. Riconoscimento e riconoscenza si richiamano vicendevolmente perché io sono in debito con l’altro per ciò che egli mi attribuisce nello stesso modo in cui questo altro è in debito con me perché lo riconosco. Quest’economia di riconoscimento/riconoscenza è la base su cui nasce un senso morale, ma anche un principio di “vulnerabilità normativa” perché qualora non si realizzi questo scambio ovvero non venga attribuito un riconoscimento, si genera verso chi è misconosciuto un sentimento di sofferenza, umiliazione e disistima verso sé stessi. Il riconoscimento ovvero la condizione di reciproca attribuzione di autonomia vale per gli individui, ma anche per i gruppi sociali; spesso sono il frutto di conflitto e lotta per raggiungere una parità di posizione al di là delle forme di sopruso o paternalismo. La novità di Ethos del riconoscimento di Cortella, che lo rende un testo che spicca tra quelli della vasta produzione filosofica sul tema del riconoscimento, è il tentativo, riuscito, di mostrare come i contenuti morali di libertà e responsabilità abbiano una base naturale senza bisogno di far ricorso a nessun ordine sovrasensibile, ma anche di mostrare come questa naturalità produca un ordine più che naturale, perché in grado di superare gli impulsi di mera conservazione ed utilità, fino a prodursi in cultura. Da questo punto di vista, Cortella, come altri studiosi della scuola veneziana, pensiamo ad Italo Testa, ipotizzano una sorta di ‘riconoscimento naturale’ che diventa elemento chiave dell’epistemologia e dell’ontologia sociale. Ciò in forte sintonia con quella Koiné contemporanea delle scienze umane e sociali che da fronti disciplinari molto diversi guarda oltre la stretta separazione naturale/culturale. La peculiarità del testo di Lucio Cortella è quello di mostrare il superamento di questa dicotomia utilizzando gli strumenti concettuali della tradizione filosofica e tratteggiando un modello teorico che può offrire soluzioni ai problemi in cui incorrono altri pensatori del riconoscimento da Honneth a Ricoeur, da Taylor a Brandom.
Massimo Fiorio
Bibliografia
L. Cortella Ethos del riconoscimento, Laterza, Bari-Roma, 2023
J. Habermas Etica del Discorso Laterza, Bari-Roma 1985
G.W. F. Hegel La Fenomenologia dello spirito, Bompiani, Milano, 2000
A. Honneth Lotta per il riconoscimento Il Saggiatore, Milano, 2002
C. Taylor Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento. Feltrinelli, Milano, 1998
-
“Quando l’Agnello aprì il quarto sigillo, udii la voce del quarto essere vivente che diceva: “Vieni”. Ed ecco, mi apparve un cavallo verdastro. Colui che lo cavalcava si chiamava Morte e gli veniva dietro l’Inferno.”
Apocalisse (6, 7-8)
Nell’Apocalisse la fine del mondo è rappresentata come un’epocale resa dei conti tra il bene e il male, tra il dio dei cristiani e il suo acerrimo nemico, Satana, che emerge dal mare sotto forma di immonda bestia cornuta e getta nello scompiglio più totale l’umanità prima di essere sconfitto da un angelo salvatore e rigettato negli abissi dove resterà incatenato per mille anni. L’epico scontro con il quale si conclude la Bibbia inoltre è annunciato dall’avvento di quattro figure misteriose, i quattro cavalieri dell’apocalisse che per millenni hanno infestato gli incubi e l’immaginario occidentale al punto da saturarne l’universo iconografico: dalle xilografie di Dürer alla musica heavy metal (basti pensare al brano The four Horseman dei Metallica) fino al riferimento subliminale presente nelle prime, memorabili scene di Terminator 2: il giorno del giudizio, in cui si vede una giostra sulla quale bruciano quattro cavalli che hanno gli stessi colori di quelli immaginati dall’apostolo Giovanni. Secondo l’interpretazione allegorica del testo invalsa sino ad oggi, infatti, ogni dettaglio numerico, lessicale e cromatico presente nel libro dell’Apocalisse dovrebbe avere un significato esoterico e così il cavallo bianco starebbe a simboleggiare la guerra poiché chi lo cavalca brandisce un arco, quello rosso sangue sarebbe la metafora della violenza umana, quello nero rappresenterebbe la morte ed il cavallo verdastro (spesso raffigurato con tinte che ricordano la carne in putrefazione) sarebbe l’effige della peste e della malattia. E se l’avvento stesso dei quattro cavalieri è da intendersi come un’infausta allegoria dell’incipiente giudizio universale è perché per millenni l’umanità è stata veramente afflitta da guerre, carestie, violenze e pestilenze che hanno lasciato pronosticare la fine imminente di tutte le cose.
Ora, se è vero che grazie allo sviluppo scientifico e alle innovazioni tecnologiche l’umanità è riuscita ad affrancarsi, o quantomeno a mettersi al riparo, dai poderosi colpi sferzati da quei mali che per millenni hanno falcidiato e svilito la vita umana su questo pianeta è anche vero che, se volessimo riscriverlo oggi, al passo dell’Apocalisse in questione dovremmo aggiungere almeno una nuova figura.
All’emblematico corteo di sciagure che l’umanità è destinata a fronteggiare da sempre, e che segnalano come oscuri presagi una catastrofe incombente, manca infatti il riferimento figurativo a quella nuova e nefasta condizione mentale che connota il nostro vissuto quotidiano. Questo si scopre oggi afflitto da una condizione storicamente inedita di assoluto disorientamento cognitivo e di totale mancanza di punti di riferimento, sia simbolici che ideologici, frammista ad una patologica dipendenza da news (vere o fake che siano) e da stimoli percettivi filtrati attraverso gli schermi di tablet e telefonini. Il flagello che ammorba l’epoca contemporanea potremmo allora immaginarlo, in continuità con la lisergica visione giovannea, come un cavallo pixelato montato da un cavaliere che regge in mano un cellulare mentre è intento a twittare un articolo in cui si dimostra, ad esempio, che la terra in realtà è piatta. E se è vero che quest’immagine esula dalle capacità immaginifiche dell’apostolo Giovanni, è altrettanto indubbio che la comparsa di un tale spauracchio oggi si profila come una vera e propria piaga che nulla ha da invidiare alle altre (fame, guerra, pestilenza e malattia) e come il segno inequivocabile di una catastrofe sociale tanto inevitabile quanto imminente.
Nel suo ultimo saggio dal titolo Apocalypse Cognitive, Gérald Bronner (professore di sociologia all’Université Paris-Diderot e membro del rinomato Institut Universitaire de France) scandaglia con salacia, eclettismo e con grande rigore scientifico le ragioni che hanno condotto la nostra specie a smarrirsi nel vicolo cieco della distrazione permanente, nella palude dell’infotainment e nel baratro cognitivo che, se da una parte non lascia pronosticare nulla di buono per quanto riguarda il futuro della nostra specie, dall’altra offre quantomeno la possibilità di gettare uno sguardo inedito sui moventi ultimi e sugli apriori psicologici della natura umana. Il lavoro di Bronner infatti è da sempre incentrato sullo studio dei fenomeni sociali e culturali a partire dalla prospettiva offerta dalla sociologia cognitiva. Nei suoi libri si analizzano, con una particolare attenzione posta all’analisi statistica e quantitativa dei fenomeni presi in esame, tanto i meccanismi psicologici che presiedono alla formazione delle credenze collettive (Bronner 2006) quanto quelli che inducono a forme di radicalizzazione ideologica (Bronner 2012), tanto la naturale proclività umana a commettere grossolani errori di valutazione (Bronner 2015) quanto il costo sociale e politico, per le democrazie occidentali, della disinformazione e della credulità (Bronner 2016). Apocalypse Cognitive costituisce a tal riguardo una sorta di ricapitolazione e di rilancio dell’intera opera del sociologo francese, è un lavoro figlio di una lunga e ponderata gestazione intellettuale e suscita un particolare interesse per chi si occupa di filosofia. L’autore, infatti, oltre ad esaminare la problematica relazione che sussiste tra lo sviluppo tecnologico e l’evoluzione della mente umana, solleva questioni relative al senso della storia, al ruolo dell’intellettuale nel mondo contemporaneo e al concetto stesso di “verità”, intesa nel suo senso eminente di “disvelamento” e di “rivelazione”.
L’assunto principale dal quale muove Bronner consiste nel prendere atto che «la situazione inedita di cui siamo testimoni è quella relativa all’incontro tra il nostro cervello ancestrale e la concorrenza generalizzata degli oggetti di contemplazione mentale associata ad una liberazione, fino ad ora impensabile, del tempo cerebrale a disposizione» (p. 21). In altre parole secondo l’autore il mondo in cui viviamo sarebbe contraddistinto da una sorta di collisione tra da una parte l’attività psichica (finalmente liberata, grazie allo sviluppo tecnico e all’evoluzione della civiltà, da quegli oneri che per millenni hanno gravato tanto sulla disponibilità quantitativa quanto sulle modalità qualitative d’impiego dell’attenzione) e dall’altra la cornucopia di oggetti virtuali offerti dall’esplosione incontrollata del mercato cognitivo. Con questa formula ci si riferisce a quel bazaar globale di nozioni, idee e concetti le cui origini sono tracciabili all’incirca con l’invenzione della carta stampata, ma rispetto al quale l’impulso più determinante è stato dato, in anni recenti, dall’avvento e dalla diffusione di internet. In Apocalypse Cognitive i meccanismi squisitamente economici sottesi alla ricerca di un equilibrio tra la domanda e l’offerta all’interno del suddetto mercato vengono interpretati, in modo assai originale, come un vero e proprio esperimento sociopsicologico su scala globale. Il punto di equilibrio che ne risulta lascia emergere, come vedremo, uno specifico profilo antropologico.
Ogni secondo vengono prodotti nel mondo ventinovemila Gigabyte di informazione. Nel 2017 sono stati inviati, in media, duecentocinquantatremila messaggi al secondo e nello stesso lasso di tempo su Google venivano effettuate sessantamila ricerche sui temi più disparati. I numeri relativi alla quantità di informazione che la nostra civiltà globale produce e consuma sono sconcertanti (basti pensare, ad esempio, al fatto che il novanta percento delle informazioni disponibili in questo momento al mondo è stato prodotto negli ultimi due anni…) (p. 97) – ma a cosa servono precisamente tutti questi dati?
Anche se Homo Sapiens fosse genuinamente intenzionato a capire il mondo che lo circonda, infatti, dovrebbe comunque fare i conti con quei meccanismi ancestrali che regolano, inibendola e stornandola alla bisogna, la sua attenzione.
Ad esempio, se nel bel mezzo di una festa siamo immersi nel chiacchiericcio che rende indistinguibile ogni conversazione e qualcuno nella sala pronuncia il nostro nome ecco che, come per magia, questo si staglia sullo sfondo del brusio. Certo, è la prova più evidente che il cervello umano è stato plasmato dalla selezione naturale per prediligere ogni stimolo inerente a ciò che che ci riguarda. Ma questo fenomeno, studiato per la prima volta nel 1953 e definito “effetto pop up”, (p. 94) se da una parte ci permette di disporre immediatamente delle informazioni di cui abbiamo più urgentemente bisogno, dall’altra limita inevitabilmente il nostro accesso alla realtà nella misura in cui rigetta tutto ciò che non pertiene al nostro interesse personale. E la perversa alleanza che è venuta a crearsi in anni recenti tra questi meccanismi modellati dall’evoluzione e quella tecnologia che, oltre a facilitare le nostre ricerche su internet anticipa, prevedendole, le nostre preferenze, è tale da suscitare qualche legittimo timore dal retrogusto apocalittico. I “tunnel attenzionali” nei quali l’evoluzione ci ha condotti lungo il tortuoso sentiero dell’adattamento trovano infatti nella struttura algoritmica dei motori di ricerca uno strumento il cui utilizzo spesso amplifica a dismisura le convinzioni degli utenti che se ne servono. In fondo è come se quella preziosa risorsa che è la nostra attenzione confluisse, per ristagnarvi all’infinito, in virtuali casse di risonanza per ogni tipo di credenza, anche per le più ottuse e irragionevoli. Non solo risulta così impossibile fuoriuscire dal loop autocatalitico di superstizioni infondate: il rischio è quello di alimentare forme di ignoranza collettiva, di causare catastrofiche diffusioni di notizie fasulle e di nutrire i bias cognitivi proprio attraverso le modalità dalle quali ci si aspetterebbe il contrario. Ma la nostra attenzione può essere deviata e sussunta in altri modi.
Nella cacofonia informazionale costituita da tutto ciò che circola in modo assolutamente deregolamentato all’interno del mercato cognitivo si stagliano infatti, al di là di questi vicoli ciechi, alcuni elementi dotati di un intrinseco vantaggio concorrenziale. Non a caso l’umanità intera ammira attonita ogni anno centrotrentasei miliardi di video hard che corrispondono a ben un terzo dei filmati attualmente visionabili su internet. La somma totale del tempo immolato da tutti gli utenti del mondo alla visione di materiale pornografico annualmente ammonta a seicentonovantaduemila anni, mentre ne servirebbero solo centosessantanove ad un solo individuo (senza calcolare le pause fisiologiche come dormire e mangiare) per guardare tutti i filmati proposti solo da PornHub, (pp. 103-104) il primo sito al mondo nel settore. Anche in questo caso, certo, è perfettamente comprensibile leggere il fenomeno in questione come una continuazione, magari imprevista da un punto di vista strettamente naturale, degli automatismi comportamentali che presiedono alla riproduzione nella misura in cui la sessualità gioca un ruolo cruciale nella perpetuazione della vita. Quel che stupisce e che merita l’attenzione dell’indagine sociopsicologica di Bronner è semmai la smodata quantità di tempo, energie e risorse che ogni anno letteralmente evapora tra le mani di un’umanità avvinta nelle grinfie della masturbazione compulsiva.
Oltre al sesso, poi, nel cocktail globale di stimoli offerti sul mercato cognitivo c’è almeno un altro ingrediente che risalta in modo deciso: la paura. Ne più né meno dello zucchero o della cocaina, ogni informazione finalizzata ad allertarci riguardo a qualsiasi tipo di pericolo crea in noi dipendenza. È così difficile resistere allo stimolo del terrore che nel 2016 il quaranta per cento degli articoli letti su internet aveva come suo contenuto principale un evento cruento (incidenti stradali, morti improvvise, cataclismi naturali) (p. 116). Nel 2014 il sito d’informazione russo CityReporter è stato addirittura al centro di un involontario esperimento sociopsicologico teso a capire se per un giornale deciso a pubblicare solo notizie positive fosse possibile sopravvivere nel mercato editoriale: dopo poche settimane il crollo del settanta percento dei lettori ha obbligato la redazione ad una repentina retromarcia. Il direttore del giornale ha commentato l’esperienza con questi toni amareggiati: «Noi abbiamo cercato di pubblicare notizie positive, e pensavamo di averle trovate. Ma forse nessuno ne ha bisogno: è questo il problema» (pp. 201-202). E come nel caso della pornografia e dei tunnel attenzionali, anche quando si tratta di spiegare l’appetibilità suscitata dalla paura Bronner ricorre alla teoria dell’evoluzione, ponendo l’accento sugli inaspettati sentieri verso cui è stata condotta la vita nel suo sforzo di adattarsi ad un ambiente sempre meno naturale e via via più virtuale:
«C’è qui in ballo una logica preistorica. Questa logica radicata nella nostra biologia ha avuto la sua utilità evolutiva, ma provoca degli effetti collaterali nelle nuove condizioni storiche generate dall’esplosione del mercato cognitivo. Il rischio più evidente nel quale incappiamo è quello di consacrare le nostre risorse per delle lotte contro dei pericoli infondati o di costruire delle gerarchie di pericoli fondamentalmente arbitrarie» (p. 117)
Tutti gli esempi qui riportati indicano anzitutto come «la captazione della nostra attenzione, che è una merce limitata, molto spesso non obbedisce alla qualità dell’informazione scambiata ma piuttosto alla soddisfazione mentale che essa induce» (p. 215) e dimostrano anche come i moventi ultimi di questi mercanteggiamenti facciano capo ad una serie di bisogni innati che non trovano di che soddisfarsi. E se da una parte questo disorientamento rende palese la condizione di fondamentale incompletezza ontologica in cui riversa la psiche umana, dall’altra esprime, al negativo, le preferenze che indicano un particolare, connaturato interesse per alcuni oggetti e non per altri. Se «nel mondo contemporaneo, certi elementi fondamentali della nostra natura mentale sono presi in carica più facilmente dall’offerta» (pp. 164-165) è perché allora, evidentemente, la mano invisibile che regola il mercato cognitivo è mossa da una volontà sulla quale il sesso, la paura e le informazioni riferite al proprio sé esercitano una sorta di fascino irresistibile, e questo è il vero e proprio oggetto di studio di Apocalypse Cognitive.
Bronner presenta infatti un’analisi che si serve delle indagini quantitative offerte dalla statistica, dei dati raccolti dalle rilevazioni informatiche e dei risultati sperimentali in più di un secolo di indagini psicologiche, come di una sorta di setaccio che rileva il peculiare vantaggio concorrenziale di tutti i prodotti offerti dal mercato cognitivo – e questi, come per riflesso, offrono preziosi spunti per inedite ed originali riflessioni antropologiche. Scandagliando le fluttuazioni di questa compravendita dell’attenzione è infatti possibile (seguendo modalità non dissimili da quelle che nel mondo del marketing vengono definite customer profiling) azzardare una sorta di analisi incrociata che a ritroso offre un’immagine piuttosto verace del soggetto economico che agisce dietro a questi scambi. E così, forte di un solido impianto bibliografico che spazia da Bernard Stiegler ad Antonio Damasio, dalle neuroscienze fino alle rilevazioni prodotte da multinazionali come Youtube e Google, e attraverso una fitta rete di riferimenti alla cronaca e agli episodi di Black Mirror, l’autore di Apocalypse Cognitive avanza una tesi solenne, una sorta di diagnosi epocale relativa al nucleo scabroso e abietto che pulsa al cuore della nostra natura.
E il profilo dell’umanità che si intravede tra le pagine del libro è lo stesso, verrebbe da dire, di quel soggetto che vediamo riflesso negli schermi opachi di quei telefonini che assorbono implacabilmente, giorno dopo giorno e sempre di più, il nostro prezioso capitale attenzionale:
«Il mondo contemporaneo, così come viene dispiegato dalla deregolamentazione del mercato cognitivo, offre una rivelazione – ovvero un’apocalisse – fondamentale per comprendere sia la nostra natura che i rischi che ci attendono. Questa deregolamentazione ha come sua conseguenza primaria la fluidificazione generale tra la domanda e l’offerta, in particolare per quanto riguarda il mercato cognitivo, e questa coincidenza tra l’una e l’altra non fa apparire né più né meno che le grandi invarianti specie specifiche dell’umanità. La rivelazione, allora, è relativa a quella che definirei un’antropologia non ingenua. Il fatto che il nostro cervello sia recettivo rispetto ad ogni informazione egoriferita, agonistica, legata in qualche modo alla sessualità o alla paura, per esempio, disegna un profilo piuttosto verace di Homo sapiens. La deregolamentazione del mercato cognitivo attualizza in un certo senso quello che esisteva solo sotto forma di possibilità. Nei tempi lunghi della storia queste potenzialità sono state limitate da ogni sorta di regolamentazioni e di impedimenti: censura, interdetti religiosi, ostacoli geografici, limiti informazionali, forme di paternalismo più o meno permissive…Oggi, grazie alla deregolamentazione del mercato cognitivo, l’offerta e la domanda si accordano al meglio – e al peggio – e ci permettono di scrutare da vicino l’immagine di noi stessi». (pp. 191-192)
Lungi dal configurarsi quale semplice avvisaglia della fine del mondo o come il mero epilogo della plurimillenaria avventura del genere umano, l’apocalisse di cui ci parla Bronner va intesa allora nel senso etimologico più proprio all’etimo greco: ἀποκάλυψις (apokálypsis), ovvero “rivelazione”. Il termine ha un significato drammaticamente prossimo a quello di ἀλήθεια (aletheia), comunemente tradotto con “verità” ma che può essere meglio reso come “lo stato del non essere nascosto; lo stato dell'essere rivelato”, e com’è noto fu Martin Heidegger a dedicare più di una pagina alla questione di quale verità sarebbe stata disvelata all’uomo dallo sviluppo tecnologico (Heidegger 1991). Ma Heidegger, così attento ai movimenti tortuosi del disvelamento, si muoveva a sua volta sul solco teoretico tracciato da Immanuel Kant. Nella sua Critica della ragion pura, (Kant 1997) il titanico filosofo di Köningsberg si era posto come obiettivo proprio l’indagine relativa alle condizioni di possibilità della conoscenza che precedono ogni esperienza empirica e che, non potendo essere raggiunte dai sensi, devono essere descritte da un'analisi critica svolta dalla sola ragione. E siccome lo scopo che accomuna Kant e Bronner sembra proprio essere quello di voler rivelare, seppur con metodi e strumenti concettuali differenti, la verità che in fondo pertiene alle “grandi invarianti specie specifiche dell’umanità”, noi non possiamo che accogliere le recenti osservazioni condotte in Apocalypse Cognitive se non come una sorta di continuazione alla o di compendio della filosofia trascendentale. Il parallelismo, al contrario di come può sembrare a tutta prima e nonostante il fatto che Kant non figuri tra i riferimenti di Bronner, non è affatto forzato. Infatti, se Kant cercava di estrarre per via squisitamente speculativa dalle fonti della ragion pura (in quanto scevra da ogni contaminazione empirica) le forme intellettuali che regolano, limitano e lavorano a priori ogni pensiero, per Bronner al contrario la scommessa della sociologia cognitiva consiste proprio nell’individuare il sostrato impuro dell’animo umano: quella dimensione che plasma a nostra insaputa le nostre performance cognitive ma che può essere approcciata solo a posteriori.
Ma la dialettica tra purezza e impurità, che ci permette di leggere Apocalypse Cognitive come una vera e propria Critica della Ragion Impura, può essere interpretata anche in senso lato, più letterale: se infatti l’analitica trascendentale risultante dalla speculazione filosofica kantiana elicita quanto di più razionale e puro l’animo umano disponga (i concetti, le categorie ed i principi) l’indagine promossa da Apocalypse Cognitive rivela al contrario i funzionamenti atavici che regolano tutto quello spettro della cognizione umana filosoficamente spurio, istintuale e irriducibile all’intelletto. La dipendenza dai vari bias di conferma, la viscosa attrazione esercitata dal sesso e dalla paura, così come la zavorra mentale costituita dalla strutturale incompletezza ontologica della natura umana, sono infatti caratteristiche precipue ed inemendabili di questa natura, vere e proprie strutture trascendentali che fungono da contrappeso a tutto l'equipaggiamento razionale individuato da Kant, e che contribuiscono così a restituire un’immagine di Homo Sapiens più realistica, meno astratta e intellettualistica.
Un’immagine più respingente e scabrosa di quella tanto in voga presso quegli ambienti intellettuali nei quali fermentano teorie critiche alla moda e vengono prodotte analisi sociali intellettualmente seducenti, ma in cui è diffuso, nelle parole dell’autore, un approccio “antropologicamente ingenuo”. Quando Bronner afferma, ad esempio, che «non ci sono forze sociali misteriose e potenti che orientano il comportamento degli individui, come si crede quando si pratica della sociologia ingenua, ma micro-anticipazioni che producono effetti collettivi involontari, benché prevedibili» (p. 214), sembra allora riferirsi alla disinvoltura con cui molti degli intellettuali di oggi sono portati ad accanirsi contro il saracino dell’assoggettamento sistemico – sia esso incarnato dal capitalismo, dal neoliberalismo o da quella cangiante chimera dalla discutibile credibilità che è l’eterocispatriarcato…
Gli strali polemici del libro sono infatti indirizzati a tutti quegli autori stregati dalla militanza e inebriati dall’attivismo che, anteponendo le loro schematiche concezioni del mondo all’esperienza diretta dei fatti più elementari, rimangono vittima di una concezione parziale, romantica e idealista tanto delle scienze sociali quanto della politica:
«Piuttosto che degli esseri eteronomi sballottati dalle malvage intenzioni di un misterioso sistema di dominazione, gli individui sono spesso degli attori che tentano strategicamente di conciliare i loro interessi materiali e simbolici. A volte dissimulano nei loro discorsi delle virtù che sono disposti a sottoscrivere a giorni alterni. Alcuni tra loro, certo, lo fanno solo per ipocrisia ma non è il caso di generalizzare sposando una tesi così misantropa. Basta ricordarsi dell’esistenza di quei conflitti che risiedono al cuore stesso del nostro cervello. La soluzione a questi conflitti, spesso, è tributaria di quelle soddisfazioni a breve termine rispetto alle quali siamo disposti ad indulgere e che ci illudono di risolvere problemi a lungo termine» (pp. 291-292).
L’invito a valutare la portata di “quei conflitti che risiedono al cuore stesso del nostro cervello” quindi va letto come un’esortazione di stringente attualità indirizzata tanto ai fruitori quanto ai produttori dei manufatti virtuali in vendita sugli scaffali del mercato dell’informazione. E la rivelazione cognitiva epocale che descrive Bronner, come sarà ormai chiaro, riguarda proprio la carsica rilevanza culturale e politica dei funzionamenti inconsci che governano il rapporto tra informazione, consumo e soddisfazione e che allignano nel profondo della psiche umana, da dove preferiremmo distogliere lo sguardo. Apocalypse Cognitive costringe al contrario il lettore a scrutare nei meandri di questa rivelazione come se si trattasse di fissare gli occhi della testa di Medusa (la stessa che, dipinta dal Caravaggio, campeggia non a caso sulla copertina del libro…) il cui potere, secondo il mito, era quello di pietrificare chiunque l’avesse guardata.
È infatti solo vincendo le resistenze mentali nei confronti di quelle verità scomode che fanno capo ad una “antropologia non ingenua” che è possibile oggi assolvere seriamente al ruolo dell’intellettuale. E al contrario di quanto affermato da Thomas Jefferson, secondo cui “solo l’errore necessita di un aiuto da parte del governo, la verità si difende da sola” (p. 216), Bronner sostiene che la verità nel mondo in cui viviamo non si difenderà affatto da sola ma, anzi, avrà bisogno dello sforzo di studiosi, giornalisti e ricercatori capaci di discernere il vero dal falso, e il plausibile dall'irragionevole, in un contesto di assoluta anarchia informazionale. Il lavoro intellettuale, oggi, non può dunque prescindere dal dovere di riconoscere l’ombra lunga che le strutture psichiche ancestrali proiettano nel bailamme indifferenziato del mercato cognitivo. E al fine di scongiurare la deriva identitaria del dibattito politico, per limitare la circolazione incontrollata di idee ingannevoli e per imparare a muoversi con disinvoltura in quella “battaglia di narrazioni” (p. 312ss) che imperversa nell’agone multimediale della società globale informatizzata, l’autore di Apocalypse Cognitive consiglia saggiamente che imparare a resistere allo sguardo pietrificante della verità, prima ancora che a difenderla, è un compito duro ma inevitabile.
Filippo Zambonini
Bibliografia:
Bronner G, Vie et mort des croyances collectives, Hermann Editeurs des sciences et des arts, Paris 2006
Bronner G, Il pensiero estremo. Come si diventa fanatici, Il Mulino, Bologna 2012
Bronner G., L’empire de l’erreur. Éléments de sociologie cognitive, PUF, Paris 2015
Bronner G, La democrazia dei creduloni, Aracne, Roma 2016
Bronner G, Apocalypse Cognitive, PUF, Paris 2021
Heidegger M., La questione della tecnica, in Saggi e Discorsi, a cura di Gianni Vattimo, Mursia, Milano 1991
-
Sloterdijk Suite: gestire la riduzione
Recensioni / Luglio 2023È esperienza comune tra i lettori di Sloterdijk rimanere perplessi davanti alla decina di pagine che conclude il suo capolavoro del 2009, Devi cambiare la tua vita. Dopo un lungo percorso, in pieno stile sloterdijkiano, tra i meandri della vita incentrata sull’esercizio, e dopo aver gettato uno sguardo – attraverso le lenti dell’antropotecnologia generale – sul paesaggio incredibilmente vasto delle discipline, nonché dopo aver seguito le sue linee di sviluppo interne, nell’arco che connette storicamente gli esercizi degli antichi a quelli dei moderni e al loro fallimento, ci si trova, come si suol dire, «con un pugno di mosche in mano». Tutto ciò che Sloterdijk offre, nella parte che si vorrebbe più propositiva del suo lavoro, è l’abbozzo di un’etica della co-immunità, mediante la quale soltanto l’umanità potrebbe finalmente diventare – da mero flatus vocis – un concetto politico, all’ombra inquietante della Grande Catastrofe ambientale e globale, nuovo attrattore di energie antropotecniche in grado di far risuonare ancora una volta la voce dell’imperativo metanoico assoluto e indicare così una rinnovata direzione alle tensioni verticali. Ma delle «regole monastiche» di questa macrostruttura immunitaria globale, le quali dovranno indurre a nuove secessioni e al costituirsi di una nuova civiltà antropotecnica, nulla ci viene detto se non che «vanno redatte ora o mai più» (Sloterdijk 2010, 556). Qual è dunque, viene spontaneo chiedersi, il valore pratico, concretamente applicabile – e perciò possibilmente politico – del pensiero antropotecnico sloterdijkiano?
È a questa stessa perplessità che sembra rispondere il saggio di Eleonora de Conciliis, Sloterdijk Suite. Espansione e riduzione dell’umano (Meltemi, 2023). La sua pubblicazione arricchisce il panorama della – crescente – ricezione italiana della filosofia di Sloterdijk, e lo fa con un intento teoretico ben preciso. L’obiettivo dichiarato dell’autrice, infatti, è quello di «sprofondare» dentro l’opera del filosofo di Karlsruhe, paragonata a un enorme dispositivo narrativo immersivo o anche a un’installazione di arte contemporanea à la Eliasson, piuttosto che tentare vanamente di «rincorrerlo» nel suo forsennato gettito di pubblicazioni, per adottare quello che è forse l’approccio più produttivo all’opera di un autore ancora vivente e così instancabilmente fecondo. Se Sloterdijk stesso è un raffinato parassita della tradizione filosofica – senza alcuna accezione spregiativa del termine: un parassita metodico nel senso indicato da Bonaiuti (2019) –, la cui opera è la smisurata espansione rizomatica, in ponderosi volumi qualificabili essi stessi come ospiti di questo magmatico germinare, di alcune fondamentali intuizioni poste sul finire degli anni ’90, è opportuno allora, ritiene de Conciliis, impegnarci a nostra volta a parassitarlo (2023, 22-24). Un simile gesto, quantomai lontano dal tradursi in un saggio monografico o in un’impossibile ricostruzione esaustiva delle fonti che la informano, è affine allo spirito antiaccademico e irriverente, nonché ironico – di quella quarta ironia a cui de Conciliis dedica il primo capitolo del saggio –, che anima l’opera di Sloterdijk e può tradursi nella libertà teoretica di lavorare a partire da Sloterdijk, con Sloterdijk ma anche oltre e contro Sloterdijk, mimando la postura che egli stesso ha adottato nei confronti di Heidegger (Sloterdijk 2004). Vale a dire: soffermarsi su alcuni aspetti particolari della sua riflessione, approfondirli ed espanderli, al prezzo di tralasciarne e ridurne degli altri.
Ed è proprio a partire dal nesso inscindibile tra espansione e riduzione che si muove il saggio di de Conciliis – sia a livello metodologico, per il quale ridurre Sloterdijk equivale a «disincantarsi, o meglio […] disintossicarsi dalla sua melodia» (de Conciliis 2023, 29), sia a livello teorico, ravvisando nel legame tra espansione e riduzione dell’umano una chiave fondamentale per leggere l’opera del filosofo di Karlsruhe in modo proficuo. Detto altrimenti, per allucinare mediante i potenti mezzi di quell’esercizio di riduzione espansiva che è la filosofia una strada concreta che conduca agli esercizi per il futuro, nella quale oltre a una necessaria riduzione antropotecnica di homo sapiens, si giunga anche a una riduzione autoironica del filosofo e del suo esercizio di morte apparente nel pensiero «a format di istruzioni tecniche miranti a una concreta, pragmatica rarefazione dell’umano» (2023, 46).
Come in una suite barocca, dove a un’allemanda segue un corrente e a una sarabanda una giga, de Conciliis ci conduce in un viaggio nell’alternanza tra queste «due facce di un unico movimento spazio-temporale» (2023, 51), nel quale la riduzione può essere intesa come un’inevitabile conseguenza della precedente espansione.
La ricerca si concentra infatti attorno a due assi tematici, che costituiscono poi l’ossatura del libro. Da un lato, a partire dalla sintesi di prospettiva sferologica e riflessioni sul nesso antropogenesi-antropotecnica, de Conciliis ricostruisce un affresco della mostruosa e affascinante epopea dell’espansione psico-spaziale dell’umano, permessa dall’iniziale auto-domesticazione antropotecnica. Essa dà luogo a una vera e propria pulsazione storica dal carattere immunitario: se l’uomo è tale, dentro e fuori l’utero, quale abitatore di spazi interni nei quali soltanto può prosperare, il movimento dell’antropogenesi sferica coincide con un ridursi a un «dentro» in cui ci si espande (materialmente e psichicamente) per imparare così ad avventurarsi nel «fuori». Movimento che si regge in gran parte sul quarto dei meccanismi antropogenici individuati da Sloterdijk: quello della trasposizione (Übertragung), concepibile tanto, come sottolinea de Conciliis, nei termini di un tentativo di ridurre simbolicamente il fuori al dentro, avvicinando così l’estraneo, quanto assimilabile a uno sforzo di trasferire il dentro nel fuori reale, in un gesto a tutti gli effetti ek-statico. Si tratta quindi del percorso che dall’insulazione nelle sfere animate dei gruppi umani originari – le orde – conduce all’attuale saturazione del mondo, risultato della terza globalizzazione che ha condotto la Terra a essere risucchiata in uno spazio interno del capitale (im Weltinnenraum des Kapitals), nel quale è palese «sia l’assenza di un “fuori”, che l’infestazione del “dentro”» (de Conciliis 2023, 192).
È a questa vertiginosa e ormai insostenibile espansione che consegue, sempre meno remota, la possibilità di una battuta d’arresto, di un contraccolpo violento che si darebbe nella forma di una riduzione catastrofica e incontrollata – lo spettro angosciante dell’estinzione della specie. A questo stesso fantasma si contrappone, d’altra parte, la seconda linea tematica del saggio di de Conciliis, ossia il dichiarato tentativo, a partire da Sloterdijk, di individuare un’altra forma di riduzione dell’umano che sia in grado di disinnescare le conseguenze della catastrofe ecosistemica, operando, mediante nuove e più opportune antropotecniche «una radicale riformattazione del sistema umano» (2023, 74).
Il libro di de Conciliis mostra qui quelli che sono forse, riassumendo al massimo una trattazione così ricca e concentrata, i suoi due più grandi meriti. Sfuggire, da un lato, alla retorica della catastrofe propria di un certo milieu «onto-ecologista», che vedrebbe nella riduzione violenta dell’umano l’unica via per chiudere i conti con l’Antropocene; proporre, dall’altro, a partire da Sloterdijk, una posizione politico-pedagogica radicale, che sappia condurre a una nuova antropogenesi in formato ridotto, a contrarre l’umano «in modo storicamente avvertito» (2023, 26).
Che una nuova ominazione sia possibile non è un’idea così inusitata, ma deriva da ciò che de Conciliis sottolinea magistralmente come «storicità dell’antropogenesi» (2023, 75-105), vale a dire la radicale contingenza dell’antropogenesi stessa, legata a quella forma di conservazione e superamento delle sue condizioni di possibilità (i quattro meccanismi antropogenici individuati da Sloterdijk e i loro complementi sferologici) che sono le antropotecniche. Esse, in quanto modalità psicofisiche di trasmissione intersoggettiva di pratiche «con cui i gruppi umani hanno preso “in mano” da soli la propria formazione simbolica e disciplinare» (Sloterdijk 2004, 159), possono retroagire sull’antropogenesi, espandendo o riducendo, aumentando o contraendo l’umano, nonché lo spazio e il peso eco-sistemico dello stesso. Aver posto così chiaramente l’accento sul carattere estremamente fluido e sulla delimitazione quantomai labile – contingente – del confine tra antropogenesi e antropotecniche è del resto il terzo indiscutibile merito del saggio di de Conciliis.
Tuttavia, se questa ne è la premessa teorica, come pensare in pratica, tale riduzione? Dichiarare l’equivalenza di umano e non-umano non è sufficiente, come non basta tentare di uscire dall’ontologia classica mediante una Object Oriented Ontology. Bisogna abbandonare – ridurre –, suggerisce de Conciliis, la tensione timotica e acrobatica condensata da Sloterdijk nelle «antropotecniche terziarie» (Lucci 2014), risultato della svolta antropotecnica racchiusa in Devi cambiare la tua vita, per tornare invece alle antropotecniche secondarie e al loro sviluppo omeotecnico, già circoscritte dal filosofo di Karlsruhe nei discussi interventi sul finire degli anni ’90, «come culmine storico dell’auto-domesticazione dei sapiens e passaggio a una nuova fase dell’antropogenesi» (de Conciliis 2023, 220-21). Abbandono la cui esigenza era già stata prospettata da de Conciliis (2020) in un precedente contributo.
La posta in gioco è quella di generare una nuova micro-umanità, a tal punto ridotta e resiliente da poter abitare nelle inedite condizioni dell’età neo-paleolitica prossima ventura, previa una riflessione sulla decrescita «in chiave problematicamente psicotecnica» per interrogarsi «sul modo in cui andrebbe inculcato nelle menti dei sapiens il “cambio di paradigma” auspicato dai teorici della decrescita» (2023, 74).
Si rintraccia qui il contributo più audace del saggio, che potrebbe anche essere definito un lungo commento all’esortazione sloterdijkiana a inaugurare un nuovo ciclo di secessioni «per far uscire nuovamente gli uomini, non più dal mondo, bensì dall’ottusità» (Sloterdijk 2010, 543). Se è vero infatti che la forma di civiltà scaturita dalla rivoluzione neolitica, con le sue antropotecniche inibenti, è ormai da tempo in crisi, espansa fino a scoppiare in una miriade schiumosa e instabile di bolle e di users al contempo frenetici e apatici, nonché sempre più infantili e incapaci di esplicitazione – e di critica –, la cui condizione esageratamente neotenica è esacerbata dalla digitalizzazione, intesa da de Conciliis come quinto nuovo meccanismo antropogenico, immaginare «esercizi per il futuro (per renderlo possibile, oltre che immaginabile)» (2023, 229) significa al contempo contrastare l’indebolimento psico-cognitivo della specie – correlato riduttivo dell’espansione – e ridurre le sue catastrofiche potenzialità espansive. Immaginare una riduzione, insomma, che consenta di perpetuare, attenuandone l’impronta ecologica, la fioritura psichica e tecnologica – introtopica – dell’umano, senza cadere in un «primitivismo naïf».
Ecco allora la ricetta di quella che de Conciliis definisce curiosamente – ma non troppo, se si considera il fondamentale capitolo Lusso neotenico e allomaternità, con la sua riflessione sul materno e sulle sue protesi nel contesto di una metamorfosi (post-)umana – «modifica ginotecnica dell’antropogenesi» (229): una graduale decrescita biologica che si esplichi mediante un pianificato e tutt’altro che distopico decremento demografico, unito a un incremento della resistenza psicofisica a situazioni di stress, nonché un rimpicciolimento, passante per vie pedagogiche, del verticalismo esasperato di homo sapiens. Ancora: una sdivinizzazione del web come premessa del suo uso intelligente, come nuova rete connettiva e «chiave mediale» dell’allenamento della comunità idioritmica – il richiamo è a Barthes – dei «ridotti»…l’elenco potrebbe anche continuare, e si potrebbe discutere sull’opportunità o meno dei singoli provvedimenti da adottare. Soffermandosi, per esempio, sulla domanda inaggirabile: come pensare l’esercizio – se è davvero possibile – rinunciando alla dimensione acrobatico-differenziale? Una cosa, tuttavia, è certa. Come afferma de Conciliis, se una riduzione è necessaria, essa non andrebbe certo subita, ma, al contrario, antropotecnicamente gestita.
Luca Valsecchi
Bibliografia
Bonaiuti, G. (2019). Lo spettro sfinito. Note sul parassitismo metodico di Peter Sloterdijk. Milano: Mimesis.
de Conciliis, E. (2020). Miglioramento umano? Sloterdijk e il problema della differenza. In M. Pavanini (a cura di), Lo spazio dell’umano. Saggi dopo Sloterdijk (127-152). Pompei: Kaiak.
de Conciliis, E. (2023). Sloterdijk Suite. Espansione e riduzione dell’umano. Milano: Meltemi.
Lucci, A. (2014). Un’acrobatica del pensiero. La filosofia dell’esercizio di Peter Sloterdijk. Roma: Aracne.
Sloterdijk, P. (2004). Non siamo ancora stati salvati. Saggi dopo Heidegger. Milano: Bompiani.
Sloterdijk, P. (2010). Devi cambiare la tua vita. Sull’antropotecnica. Milano: Raffaello Cortina.
-
«Ce n’est plus d’une libération universalisante que l’homme a besoin, mais d’une médiation», scriverà Gilbert Simondon nel 1958 a proposito dell’ideale enciclopedico della cibernetica, cogliendone appieno lo spirito. Questo ideale enciclopedico si accompagnava a una dichiarata volontà di rinnovamento delle categorie filosofiche e di superamento di molte dicotomie metafisiche. È il carattere spettrale e disseminato della cibernetica, il suo insistere negli interstizi dell’enciclopedia, che ci ha spinto a dedicarle questo numero con l’obiettivo di cartografare i luoghi del sapere in cui possono ravvisarsi le tracce lasciate dalla cibernetica, seguirne le piste, ricostruirne le trame, farne emergere i modi d’essere, interrogarne l’eredità e l’attualità.

«Ce n’est plus d’une libération universalisante que l’homme a besoin, mais d’une médiation», Gilbert Simondon (1958) would write, concerning the encyclopedic ideal embraced by cybernetics. This encyclopedic inspiration went hand in hand with an explicit desire for renewal of philosophical categories and with the will of overtaking metaphysics’ dichotomies. It is the spectral and disseminated character of cybernetics, its insistence in the interstices of the encyclopaedia, that has led us to devote this issue to it, with the aim of mapping the places of knowledge in which the traces left by cybernetics can be discerned, following its trails, reconstructing its plots, bringing out its modes of being, questioning its legacy and relevance.
A cura di Luca Fabbris e Alberto Giustiniano
Scarica PDF
English version
DOI: https://doi.org/10.13135/2385-1945/18.2023
Pubblicato: marzo 2023
Indice
EDITORIALE
Luca Fabbris, Alberto Giustiniano - Cibernetica. Prospettive sul pensiero sistemico [PDF It]
I. CIBERNETICA. L'EVENTO E I SUOI ANTEFATTI
Arantzazu Saratxaga Arregi - A Reconstruction of Epistemological Foundations of Cybernetics. The First Steps in Epistemologies of Complexity [PDF En]
Marco Ferrari - La cibernetica prima della cibernetica. Filosofia, scienza e tecnica in Norbert Wiener (1914-1943) [PDF It]
Francesco Vitali Rosati - L’officina cosmica. Biosfera, organizzazione, ecologia nel pensiero pre-cibernetico russo [PDF It]
II. LE AVVENTURE DELL'INFORMAZIONE
Francesca Sunseri - “Ciberneretica” simondoniana [PDF It]
Niccolò Monti - The Unmeaning Machine. Cybernetics from Semiotics to AI [PDF En]
Luciano Boi - I diversi livelli di informazione e comunicazione nel mondo vivente e la costruzione del significato [PDF It]
III. L'USO DEI SISTEMI
Robin Asby - On The Framing of Systems and Cybernetic Models [PDF En]
Paolo Capriati - Autopoiesi dei sistemi politici: il caso Cybersyn [PDF It]
Saverio Macrì - Arte e interattività: per un’estetica dei sistemi [PDF It]
IV. OGGETTI, MACCHINE, MEDIA
Luca Fabbris - Cibernetica orientata all’oggetto. L’oggettivismo radicale di Ranulph Glanville [PDF It]
Gregorio Tenti - Tecnoplastia. Note sulla poiesi macchinica [PDF It]
Giancarlo Corsi - Sociologia dei mezzi di comunicazione. Considerazioni per una teoria generale [PDF It]
V. TESTIMONIANZE E MATERIALI
Settimo Termini - All’ombra di nuove scienze in fiore. Lo strano caso della cibernetica con uno sguardo all’Italia degli anni Sessanta [PDF It]
Il glossario del Biological Computer Laboratory [PDF It]
-
Il libro di Silvia Caprioglio Panizza The Ethics of Attention. Engaging the Real with Iris Murdoch and Simone Weil (2022) ci fa innanzitutto interrogare sulle nostre modalità di interazione col mondo. Secondo l'autrice, esiste un modo di relazionarsi "bene" con la realtà, e questo modo passa inevitabilmente attraverso l'attenzione, un concetto a cui sia Simone Weil che Iris Murdoch hanno dedicato un posto d’onore all’interno delle loro riflessioni sulla morale. Il libro ha molti meriti: in primo luogo, rilancia la centralità dell'attenzione in campo morale entrando in un dialogo dinamico e affascinante con Murdoch e Weil, il quale viene arricchito ulteriormente da rimandi alla letteratura psicologica contemporanea, nonché a concetti appartenenti alla tradizione del Buddismo zen. In secondo luogo, offre un'esplorazione avvincente e scrupolosa del ruolo che l'attenzione può svolgere quando si tratta di destreggiarsi tra questioni etiche attuali e oltremodo scomode, come la maniera in cui trattiamo gli animali e i venditori ambulanti. Il fil rouge che connette i capitoli è una sorta di magnetismo della verità, della realtà così com'è indipendentemente da noi e dalle nostre preoccupazioni; nel prendere sul serio questo magnetismo, il libro di Caprioglio Panizza è allo stesso tempo stimolante dal punto di vista teorico ed estremamente pratico. Iris Murdoch e Simone Weil.
Il capitolo 1 fornisce una definizione generale di attenzione e introduce, attraverso le concezioni divergenti di Weil e Murdoch, il fatto che per partecipare alla realtà, dobbiamo in qualche modo uscire di scena e lasciare che essa si riveli da sola. I capitoli 2 e 3 affrontano le tensioni che sorgono quando ci si concentra sul ruolo del sé nell'attenzione e le considerano attraverso due possibili percorsi: la visione addomesticata (“The Tame View”, capitolo 2), secondo cui l'attenzione risulta incompatibile solo con alcune parti del sé, e la visione radicale (“The Radical View”, capitolo 3), secondo cui l'attenzione è incompatibile con il sé tout court. Il capitolo 4 affronta ancora un'altra tensione, quella della conoscenza di sé: sembra che sia necessario concentrarsi su noi stessi per capire se stiamo partecipando correttamente, ma, allo stesso tempo, il "guardarsi dentro" risulta incompatibile con l'attenzione. Infine, i capitoli 5 e 6 difendono la seguente tesi: l'attenzione è necessaria per la percezione morale e sufficiente per la motivazione e per l'azione.
Innanzitutto, che cos'è l'attenzione? L'autrice la presenta come una sorta di impegno nei confronti della realtà che si assume l’individuo nel momento in cui percepisce, o in qualche modo accetta il magnetismo della verità (24). L'elemento di "ricerca della verità" è ciò che rende l'attenzione una capacità morale, in quanto ci permette di vedere la verità e di agire su di essa; dunque, se vogliamo essere "buoni" agenti morali, dobbiamo essere agenti morali attenti. Questo requisito normativo si presenta in due dimensioni, le quali vengono esplorate da Caprioglio Panizza seguendo una distinzione su due "assi": l'asse verticale riguarda la presenza o l'assenza di attenzione, dove il requisito normativo è quello di prestare attenzione invece di mantenere un atteggiamento distratto o di fantasticheria nei confronti della realtà. L'asse orizzontale riguarda, dall’altra parte, gli oggetti dell'attenzione e il requisito normativo è quello di prestare attenzione a quelli "giusti" (le altre persone, particolari oggetti del mondo, la natura), poiché ciò a cui prestiamo attenzione dà forma ai nostri pensieri e alle nostre azioni (alla nostra "coscienza", Murdoch MGM 167). Nel capitolo 1 ci vengono presentati, inoltre, punti in comune e divergenze tra Murdoch e Weil. La ricerca della verità è un elemento cruciale per entrambe le filosofe, che pongono il Bene/Dio come ciò che in ultima analisi guida l'attenzione verso l'eros, ma ci si rende presto conto che esse hanno idee alquanto diverse in merito a ciò che è richiesto all'agente per partecipare correttamente alla realtà; la presenza o l'assenza di attenzione assume due forme distinte, con le quali l'autrice si confronta esaustivamente nei capitoli successivi.
Nel famoso esempio di M&D, in cui lo sguardo ri-orientato di M è proprio ciò che le permette di vedere realmente D, vi è un momento in cui M mette da parte se stessa per concentrarsi su D. I capitoli 2 e 3 esplorano la relazione tra attenzione e sé; in particolare, tra l'attenzione e, rispettivamente, le idee del sé di Murdoch (cap. 2) e di Weil (cap. 3). Iris Murdoch, pur essendo attratta dalla presa di posizione radicale di Weil, lavora con una concezione del sé che è sostanziale – per cui esiste una cosa, il sé, che può essere migliorata – e che trova un certo grado di unità nel sé morale. Dato l’elemento di ricerca della verità, l'attenzione diventa quindi ciò che permette all'agente morale di progredire moralmente; punto cruciale, diventa ciò che permette all’agente morale di progredire attraverso il proprio sé, non nonostante il proprio sé. Il capitolo 2 esplora il percorso di Murdoch attraverso quella che Caprioglio Panizza chiama "la visione addomesticata", poiché non cerca di eliminare il sé, ma piuttosto di sopprimere (o addomesticare) alcune parti di esso. Secondo questa visione, vi è solo una parte del sé che risulta problematica, quella dell'ego, ovverosia la parte che spinge a concentrarsi sulle proprie preoccupazioni e che impedisce di guardare il mondo con uno sguardo che sia indipendente da esse. In questo senso, il mettersi da parte di M è inteso come un ri-orientare lo sguardo; un distoglierlo dalle preoccupazioni del proprio sé (l’ego) per andarlo a posare esclusivamente su D, per amare D vedendo D come una realtà indipendente da M. L'autrice ci guida nel notare come in entrambe le concezioni del sé di Murdoch e di Weil sia più o meno implicita la presenza di un'illusione; nel caso di Murdoch, si tratta dell’illusione dell'egocentrismo, nel caso di Weil, dell’illusione del sé in quanto entità separata dal mondo. Essere buoni agenti morali, in entrambi i casi, richiede di superare tali illusioni.
Il capitolo 3 inizia con tre preoccupazioni che l'autrice solleva riguardo alla visione addomesticata: la prima è che, secondo questa visione, l'attenzione non è pienamente raggiunta, poiché nel momento in cui il sé è ancora presente, allora l'oggetto non può essere del tutto presente. La seconda è che, pensando a una parte del sé come "cattiva", si potrebbe andare a scatenare una battaglia interiore che finirebbe solo per rafforzare la parte egocentrica del sé, rivolgendo la direzione dell’attenzione verso l'interno (il sé) anziché verso l'esterno (ciò che è indipendente dal sé). La terza preoccupazione è che, in modo analogo, assumendo che l'attenzione sia ciò che ci permette di migliorare noi stessi, potremmo finire per rendere il nostro sé ancora una volta oggetto di attenzione. A questo punto è difficile resistere davanti alla possibilità che vede, nell’attenzione, un sé del tutto assente. Caprioglio Panizza chiama questa possibilità la "visione radicale", rifacendosi alla concezione di Weil che vede il sé come un'interferenza con la realtà che non fa che alimentare la nostra separazione da essa, qualcosa di cui sbarazzarsi tout court se vogliamo essere fedeli alla spinta verso la verità propria dell’attenzione. "Vedere un paesaggio così com'è quando io non ci sono" (GG 42, in Caprioglio Panizza 91) afferma Weil, citata dall'autrice, per descrivere l'azione di partecipare al mondo con una concezione vuota di sé. L’azione richiesta non si configura come una "soppressione", né come una "rimozione", quanto piuttosto come un atto di "de-creazione" (93). Ma come possiamo metterlo in atto? Come possiamo vedere il paesaggio come se non fossimo noi a vederlo? Come possiamo toglierci di mezzo per permetterci di vedere la realtà così com'è? Queste domande, per quanto legittime, sono figlie dell’illusione della separazione, ovverosia dell’illusione di credere che nel momento in cui concentro la mia attenzione sul paesaggio, vi siano due entità distinte: me stessa (da sopprimere) e il paesaggio. In realtà non vi è alcuna separazione; io e il paesaggio non siamo due entità distinte. In questo senso, la "de-creazione" implica prendere coscienza del fatto che il sé non è mai veramente esistito (92). Alla fine del capitolo, Caprioglio Panizza introduce il Buddhismo Zen come un possibile modo per comprendere che cosa implica il partecipare al mondo senza sé, e la risposta è sorprendente, diametralmente opposta a quella che si potrebbe aspettare. La filosofia Zen non richiede che, prima di tutto, si debba sopprimere il proprio io per poi, improvvisamente, vedere la realtà così com’è; piuttosto, afferma che è attraverso l'esperienza della non-dualità che possiamo sperimentare l'assenza dell'io. Quando siamo finalmente in questo stato di unità, quando possiamo finalmente vedere che, in realtà, non vi è proprio nulla da sopprimere perché la linea di demarcazione tra noi e il mondo era del tutto fittizia in primo luogo, solo allora staremo sperimentando l'attenzione. Questo parallelo con il Buddhismo Zen risulta estremamente utile poiché, seppur le metafisiche di Weil e dello Zen non coincidano, vi è significativa sovrapposizione fenomenologica tra le due concezioni di attenzione; nelle parole dell’autrice, "non sono soppressa, ma unita" (99), e questa è un'esperienza che è propria di entrambe le letture.
Sebbene Caprioglio Panizza sia esplicita nel manifestare sintonia con la soluzione radicale di Weil, il resto del libro si concentra principalmente sull’opzione moderata di Murdoch, la quale dà origine alla seguente tensione: come vi può essere compatibilità tra attenzione e consapevolezza di sé (capitolo 4)? M si rende conto che la sua percezione di D era sbagliata; ergo, vi è un momento in cui M deve per forza aver raggiunto una certa consapevolezza riguardo questa percezione distorta ("fammi guardare di nuovo"). Dunque, in un certo senso, sembra che la consapevolezza di sé, o la conoscenza del sé illusorio, sia in qualche modo necessaria per l'attenzione, poiché, altrimenti, non potremmo renderci conto di eventuali errori percettivi. Tuttavia, se l'attenzione si configura come l'atto di lasciare che la realtà si manifesti indipendentemente da noi, allora che spazio vi può essere per un tipo di conoscenza che inevitabilmente mette di nuovo il sé al centro di tutto? Potremmo dire che M si rende conto che la sua visione di D è distorta in quanto, dopo aver orientato l'attenzione su se stessa attraverso un atto di introspezione, si accorge di essere una persona con un certo tipo di schemi mentali, possibilmente da mitigare; tutto ciò riguarderebbe nuovamente M. La soluzione sembra essere quella di guardare i propri accadimenti interiori sia nel loro contesto (non solo ciò che sta accadendo, ma anche da dove potrebbe provenire) sia "dall'esterno", cioè attraverso le lenti degli altri. L'obiettivo di un'autoconoscenza non egocentrica non ha, dunque, a che fare con il tipo di io morale che sono ("sto agendo bene?"), ma piuttosto con ciò che potrebbe ostacolare l'attenzione. Questo, tuttavia, solleva un'altra tensione: alcuni degli stati mentali che hanno un impatto sulla nostra visione morale sono "privati", non accessibili "dall'esterno", quindi o siamo gli unici ad avere accesso esclusivo a questi stati mentali moralmente rilevanti, oppure, seguendo la lettura Murdochiana di Wittgenstein, dobbiamo lasciare le cose come stanno, poiché non vi sono categorie logiche attraverso le quali possiamo renderle pubbliche; il loro significato si perde se cerchiamo di metterle in parole. Caprioglio Panizza si confronta sia con Murdoch che con Wittgenstein, e difende un resoconto della vita interiore che è logicamente indipendente da quella esterna (alla Murdoch), ma che è anche trasparente al di là delle credenze/bias (alla Wittgenstein). Tornando all'esempio di M e D, vi è un aspetto privato moralmente rilevante della vita interiore di M che solo M può capire (comprensione “dall’interno”); ma vi è anche un elemento di trasparenza che permette a M di capire cosa le sta succedendo al di là delle sue credenze su D (comprensione “dall’esterno”). L'attenzione di M è concentrata su D e questo le permette di vedere quali forme ha assunto il suo concentrarsi su D. Questo è ciò che Caprioglio Panizza definisce "conoscenza di sé impegnata" (engaged self-knowledge, 125), ossia l'elemento dell'attenzione che ci permette di percepire come stiamo percependo, in virtù del fatto che ci preoccupiamo di percepire correttamente la realtà di un altro. L'elemento non egocentrico è preservato dal fatto che quando guardo come sto percependo, la conoscenza che ottengo dipende dall'oggetto della percezione, non da me. Io voglio vedere bene l’altro; non, io voglio vedere bene l’altro. L’enfasi è essenziale.
Infine, i capitoli 5 e 6 si concentrano sull'attenzione in quanto modellatrice della percezione (cap. 5), della motivazione e delle possibilità di azione (cap. 6). Per esplorare i nostri atteggiamenti errati nei confronti della realtà e come l'attenzione possa ri-orientarli al meglio, Caprioglio Panizza si concentra sull'esempio della sofferenza animale: "l'attenzione alla sofferenza degli [...] animali consente la percezione morale, che a sua volta ci motiva ad agire" (131). Quando assistiamo alla sofferenza proviamo disagio e distogliamo lo sguardo; ma se siamo veramente attenti, allora percepiamo che ciò che vediamo ci chiede qualcosa a cui sentiamo di dover rispondere. A questo punto ci si potrebbe domandare se l'attenzione non possa essere semplicemente un altro modo per indicare istanze di "empatia". L'autrice individua due modalità di partecipazione alla realtà che sono moralmente problematiche e che esemplificano la distinzione tra attenzione ed empatia: "spesso, quando vediamo la sofferenza, distogliamo lo sguardo proprio perché proviamo empatia: ci sentiamo male e vogliamo che questa sensazione cessi, quindi smettiamo di guardare" (155, enfasi mia). Tornando a Murdoch, nei casi in cui si distoglie lo sguardo, è l'ego che prende il sopravvento: stiamo soffrendo, quindi smettiamo di guardare. Inoltre, "percepire la sofferenza può dare origine non all'empatia, ma al godimento" (155; istanze di “sadismo quotidiano”, 158, o di “attenzione sadica”, 159). In questi casi, l'ego prende ancora una volta il sopravvento: noi stiamo godendo. L'empatia, quindi, è legata al modo in cui percepiamo l'altro, è vero, ma non tutti i casi di percezione dell’altro sono anche casi di attenzione. Se la percezione parziale o errata della sofferenza può generare il distogliere dello sguardo o atti di sadismo, la percezione attenta, invece, genera atti che intendono fermare quella sofferenza. Alla fine, Caprioglio Panizza suggerisce che questo è possibile perché l'attenzione "ci permette di vedere alcune possibilità che altrimenti non vedremmo" (161); nel momento in cui guardiamo l'animale sofferente non come se fosse carne, ma come se fosse la creatura vivente che è, vediamo la possibilità per quella creatura di non soffrire. L'animale che soffre appare, ora, soccorribile; la sofferenza stessa, eliminabile. Il suffisso "-abile" indica una affordance, una sorta di chiamata all’azione presente nella situazione. Una sofferenza posso vederla come "ferm-abile" o “evit-abile” solo nel momento in cui mi sto veramente concentrando sulla creatura che soffre. Nel pratico, nel momento in cui vedo l'animale come "carne", allora l'affordance a cui rispondo è "mangiabile"; si tratterebbe di un’istanza di cecità nei confronti della sofferenza e, dunque, di una percezione errata. Sebbene l'autrice sia tornata alla visione addomesticata nel suggerire come l'attenzione plasmi la nostra visione e le nostre azioni, il libro si conclude con una nota Weiliana: la realtà ci pone delle richieste (affordances) e, se siamo agenti morali attenti in modo corretto, non possiamo che obbedire ad esse.
Come abbiamo visto, nell'affrontare questioni e tensioni che emergono nel corso del libro, l'autrice si concentra su quello che identifica come l'approccio meno radicale, quello Murdochiano, che vede l'attenzione come compatibile con alcune parti del sé e, in generale, che configura le azioni moralmente buone come derivanti dall'attenzione sviluppata attraverso l'agente - cioè attraverso la formazione della sua visione morale - e non nonostante l'agente. Tuttavia, Caprioglio Panizza è chiara nell'affermare la sua vicinanza filosofica alla visione radicale, sebbene la consideri come una possibilità solo nel capitolo 3. Credo che questa scelta abbia a che fare con il messaggio generale del libro: l'attenzione è cruciale per la morale, ma è anche difficile da sostenere. Ci chiede di guardare veramente situazioni che ci possono mettere a disagio e di starci dentro, senza distogliere lo sguardo. La visione addomesticata rende tutto questo digeribile, mettendoci davanti al fatto che nonostante sia indubbiamente difficile, possiamo farlo senza dover rinunciare a ciò che è a noi tanto caro: il nostro sé. D'altra parte, l’autrice sembra suggerire che la storia potrebbe non finire qui. Vi è molto altro da scoprire se, come lei, ci sentiamo attratte dall’approccio radicale di Weil; forse, in particolare, attratte dall'intuizione che partecipare alla realtà è, sì, difficile, ma se smettessimo di pensarci come entità separate tra loro e orbitanti intorno a loro stesse, guardare il paesaggio morale in quanto paesaggio indipendente da noi potrebbe, in realtà, riuscire molto più naturale di quanto crediamo.
Matilde Liberti
Bibliografia
Caprioglio Panizza, S. (2022) The Ethics of Attention: Engaging the Real with Iris Murdoch and Simone Weil, London and New York, Routledge.
Murdoch, I. (1992) Metaphysics as a Guide to Morals [MGM], London, Penguin.
Weil, S. (2002) Gravity and Grace [GG], trans. Emma Crawford and Mario von der Ruhr. London and New York, Routledge.
-
Una teoria critica dell’Antropocene
Recensioni / Giugno 2023Antropocene è il nome che la comunità scientifica – in maniera non del tutto unanime e non ancora formalizzata – ha voluto assegnare alla nuova epoca geologica della storia della Terra, nella quale «l’attività umana ha alterato irreversibilmente le dinamiche geologiche terrestri» (Zalasiewicz et. al., 2021). Originariamente il problema relativo alla definizione dell’Antropocene aveva natura metodologica (Ellis, 2018), ovvero era noto all’interno della comunità scientifica che l’impatto umano sul pianeta stesse provocando alterazioni strutturali del sistema Terra. Ma come renderne conto attraverso un’unica prospettiva, integrando cioè entro un unico quadro l’immensa mole di dati relativi a ciò, provenienti dalle diverse discipline coinvolte? Quanto è accaduto è che le questioni concernenti l’Antropocene legate alle scienze naturali, questioni di natura anzitutto epistemologica, si sono progressivamente trasformate ed estese al di fuori di queste ultime per catalizzare infine buona parte dei discorsi attuali relativi alla crisi ecologica.
Anche le scienze umane, e la filosofia in particolare, sono state recettive di questo nuovo, si potrebbe dire, evento concettuale, o, com’è stato chiamato, “cambio di paradigma” (Ellis, 2018) e ad oggi la letteratura filosofica che ha visto e vede nell’Antropocene l’occasione per reimpostare questioni teoretiche e pratiche, per – speculativamente e praticamente –, “cambiare rotta” è decisamente nutrita. Nutrita, ma per molti versi ancora in fase di definizione, manchevole cioè di un quadro concettuale unitario entro il quale inserirsi e trovare ordine.
Il saggio di Paolo Missiroli, Teoria critica dell’Antropocene. Vivere dopo la Terra, vivere nella Terra (Mimesis, 2022) s’inserisce in questo contesto e cerca di dare un ordine alle molteplici prospettive sull’Antropocene sviluppatesi nel corso di almeno quindici anni di dibattito.
L’obbiettivo del saggio è duplice. Da un lato, presentare un quadro del dibattito interno alle scienze umane, senza risparmiarsi dettagliate incursioni in quello scientifico, rispetto al concetto di Antropocene. Dall’altro, articolare una proposta teorica capace di mostrare le contraddizioni interne a un certo modo di interpretare l’Antropocene, inserirsi nella faglia aperta da questa disamina, indicarne un possibile, e alternativo, sviluppo pratico-teoretico. Quest’ultima operazione, al centro del saggio, prende il nome di “critica”.
L’idea di Missiroli (con Marcuse) è che critica sia sinonimo di trasformabilità. Criticabile è solo ciò che può essere modificato ovvero «ciò che è esito di un processo storico determinato» (p. 23). Ma, se si critica è per aprire una linea di fuga verso uno stato di cose, verso un presente diverso dal nostro, delineando un’alternativa possibile ad esso. Questo processo seguirebbe quindi un doppio movimento: dapprima, di ricognizione dei presupposti che soggiacciono a un certo discorso o a una certa teoria; poi, di analisi delle sue contraddizioni in vista dell’elaborazione di un orizzonte pratico-teorico alternativo ad esso. Tale suddivisione – che segna, così ci sembra, l’inestricabilità di ontologia e politica nella riflessione di Missiroli – segue a grandi linee la scansione del volume.
Il primo capitolo (L’Antropocene prometeico), infatti, si sofferma sui presupposti impliciti ad una certa modalità d’intendere il concetto di Antropocene, che Missiroli chiama “discorso prometeico sull’Antropocene” (DPA). Scrive Missiroli: «[Il] discorso prometeico identifica l’Antropocene come l’epoca di un dominio pieno e incontrastato dell’umanità, intesa come un tutto indistinto, sul pianeta Terra, ormai ridotto a oggetto manovrabile e integralmente gestibile. Il suo esito pratico politico consiste soprattutto nella proposta della geoingegneria» (p. 32). Questo discorso riposa su tre assunti: una specifica immagine dell’umano, una specifica immagine del tempo, una specifica immagine della Terra – tre assi, questi appena citati, che si potrebbero definire, semplificando molto, antropologico, naturale e storico.
Il primo asse è il più fondamentale, perché informa di sé anche i restanti due. L’uomo del DPA è, per utilizzare le parole dell’esponente più celebre di questo paradigma, Yuval Noval Harari, un “serial killer ecologico”, un essere la cui azione corrisponde alla negazione, ovvero alla distruzione, della natura. L’uomo (che è, sottolinea Missiroli, l’Uomo – un’unità astratta pensata come un tutto indistinto) agisce, anche simbolicamente (dando cioè senso alle cose), come un demiurgo che plasma a suo piacimento la realtà naturale che si trova di fronte, creando da essa l’ambiente della propria esistenza. Egli, per essenza, e quindi come se ciò fosse iscritto nel suo stesso destino, come se sin dal suo apparire sulla Terra fosse destinato all’Antropocene – egli, si diceva può tutto. E nella misura in cui può tutto, l’Antropocene stesso viene a profilarsi negli scritti dei teorici che implicanontra il DPA, come l’epoca della gestione tecnica integrale del pianeta Terra; ovvero, come l’epoca della geoingegneria.
L’idea che l’attuale crisi ecologica possa essere risolta tramite l’impiego di strutture ingegneristiche capaci di creare un meccanismo globale di rifrazione dai raggi solari, di stoccare Co2 al di sotto della crosta terrestre e così via sono, a parte subiecti, il riflesso di questa immagine come scrive Missiroli «negativista» dell’umano, mentre a parte obiecti – ecco il secondo asse – la conseguenza di una visione ben precisa dello spazio come «compatto e oggettivabile» e, perciò, della Terra come «piatta, svuotata di ogni profondità e da ogni resistenza». Questa concezione di uno spazio “alla mano” si traduce praticamente (e politicamente) nell’idea che la Terra – o meglio, il “Globo”, questa sfera blu ben visibile nella sua interezza – costituisce una sorta di navicella di cui l’uomo possiede i comandi, e dunque il controllo. «Il Globo, come immagine prestata ai discorsi sull’Antropocene, serve comunemente come dispositivo di riduzione della complessità della Terra al servizio di prospettive che affidano all’uomo il compito di gestire un pianeta ridotto a una sfera infinitamente manipolabile» (p. 49).
Il terzo asse concerne la visione della temporalità, e dunque della storia, che deriva dai presupposti antropologici e naturali propri al DPA. Se è vero che l’Antropocene è un evento inevitabile nella storia dell’umanità, che l’uomo con la scoperta del fuoco stava già avanzando in direzione della crisi ecologica, allora entro questo quadro il futuro costituisce qualcosa di già inscritto nel presente. Il tempo è pensato come una linea, una freccia, che si muove univocamente in direzione di un(a) fine che trascende la Terra, che si porta, come recita il sottotitolo del libro, dopo di essa. Infatti, questo futuro prospettato dal DPA sarà capace di svincolarsi e liberarsi dalla presenza-ostacolo della Terra stessa – e ciò sia che si parli, come accade sovente oggi, di “catastrofe” o “collasso”, sia che si parli, come fa l’ecomodernismo, di controllo integrale del pianeta: in entrambi i casi, uno rovescio dell’altro, la prospettiva è quella di un post, di una cesura, tragica o gloriosa, capace di proiettarci entro un orizzonte totalmente altro.
Il discorso sul Capitalocene, analizzato nel secondo capitolo del saggio (Geologia del capitale), costituisce una parziale alternativa al DAP. Il concetto di Capitalocene ha conosciuto negli ultimi anni una vasta diffusione all’interno delle humanities, coagulando in sé, nelle intenzioni degli autori che hanno per primi cominciato ad impiegarlo, la critica principale, ma variegata nelle sue forme interne, che si muove all’Antropocene: quella di non costituire tanto il prodotto dell’Uomo generalmente inteso, quanto piuttosto l’esito del modo di produzione capitalistico. Come scrive Missiroli il Capitalocene «nasce per contrastare il discorso prometeico» (p. 66) ovvero de-naturalizzarne i presupposti. Anche in questo caso, il fine è anzitutto critico: sganciando le narrazioni naturalistiche sull’Antropocene dalla prospettiva destinale che le accomuna, se ne rintraccia l’origine storica, e dunque storicamente determinata, alla base di tale epoca geologica. Jason Moore è forse l’esponente più noto della teoria del Capitalocene, e il nome sul quale l’analisi di Missiroli si sofferma. Secondo Moore, che rielabora in ciò la lezione della scuola dei sistemi-mondo, il capitalismo funziona come un’ecologia-mondo, ossia un sistema complesso che organizza la natura in funzione del profitto. Il capitale necessita di una “natura a buon mercato”, ovvero immediatamente disponibile e a basso costo per avviare i cicli di accumulazione. Dunque non ci sono, da una parte, la natura, e dall’altro, il capitale, che si appropria della natura – ma, questo è il presupposto ontologico della teoria di Moore – una relazione creativa, storica e dialettica tra, nonché dentro, le nature umana ed extra-umana – una relazione che Moore chiama oikeios. Al suo grado zero, la realtà è una rete di relazioni – Moore parla di “rete della vita” – che si concretizzano in forme storicamente determinate, ma in divenire, che si trasformano. La natura è dunque il prodotto del capitalismo stesso, che plasma una parte di realtà al fine di trarne profitto. D’altra parte, il capitalismo è “dentro” quella che Moore definisce appunto “rete della vita”, il sistema di relazioni umano-e-non-umano nel quale esso si appropria e plasma l’ecosistema.
È rispetto a questo punto che, secondo Missiroli, la teoria del Capitalocene presenta alcune criticità. Anzitutto, l’autore ritiene scorretta la pretesa di Moore di sostituire il concetto geologico di Antropocene con quello storico-filosofico di Capitalocene. Anche concedendo a Moore l’impianto teorico che sostiene il paradigma dell’ecologia-mondo, dal punto di vista storico-geologico esso non regge all’analisi dei dati stratigrafici, i quali dicono che i passaggi d’epoca nella storia terrestre devono essere identificati a partire da evidenti (e sincroniche) alterazioni del sistema Terra. Ora, nota Missiroli, «nessuna rottura significativa è stata riportata, sulla scala stratigrafica, all’altezza della metà del XV secolo» (p. 84) – che rappresenta il momento in cui, secondo Moore, sarebbe cominciato il Capitalocene. Sussiste dunque una sorta di discrasia tra i piani del discorso, che Moore confonde: ciò che nomina l’Antropocene “scientifico” non è ciò che nomina il Capitalocene, ovvero la causa di un’epoca geologica.
Ma c’è di più. La critica più profonda di Missiroli riguarda infatti il modo in cui Moore articola il rapporto tra crisi del modo di produzione e crisi ecologica. «Per Moore – scrive Missiroli – le due cose sono assolutamente identiche, la crisi dell’ecologia-mondo capitalistica è la crisi ecologica, e viceversa (p. 87)». Nella prospettiva di Moore, la questione ecologica coincide interamente con gli effetti del capitalismo, motivo per cui non c’è, nota Missiroli, «alcuna naturalità, alcuna realtà esteriore al sistema capitalista» (p. 88). Si tratta di un problema che, anche a parere di chi scrive, segna nella sua struttura teorica il discorso sul Capitalocene, e più in generale le prospettive (specialmente di matrice postumanista) che riducono la questione dell’Antropocene a quella del capitalismo. Se il limite naturale-materiale, ossia ciò che determina storicamente le forme assunte dall’ecologia-mondo, è interno al capitalismo stesso e il mondo naturale un suo prodotto, come può il capitalismo appropriarsi di qualcosa che non è distinto da esso? Se natura e capitalismo non stanno uno di fronte all’altro come prospettato dal nemico (teorico) dei nemici – il cartesianesimo, e con esso il dualismo tra natura e cultura – non c’è modo di pensare la relazione di appropriazione nel senso di uno sfruttamento verso qualcosa di esterno. All’estremo, è come se il sistema-mondo capitalistico si appropriasse di se stesso.
Per questo motivo, pur necessaria nella sua operazione di de-naturalizzazione della congiuntura bio-geo-logica attuale, la teoria del Capitalocene non è sufficiente a costituire una teoria critica dell’Antropocene. Essa risolve la questione sul piano dell’origine storica (l’Antropocene in quanto prodotto del Capitale) senza preoccuparsi di analizzare le «contraddizioni interne alla nostra condizione storico-naturale» (p. 90). Tali contraddizioni, spiega Missiroli, vanno rilevata nella faglia che si apre tra il modo in cui gli esseri umani riproducono la loro vita nel mondo, e l’organizzazione storico-naturale oggi dominante (che comprende, non ci sono dubbi, il modo di produzione capitalistico). Manca, in altri termini, il criterio (p. 25) della critica ovvero il contatto tra la de-naturalizzazione del presente e l’analisi delle modalità d’esistenza umane che collidono con la congiuntura.
L’Antropocene – questo il cardine dell’argomentazione di Missiroli così come sviluppata nel terzo capitolo del libro (Vivere nella Terra) – rivela una condizione: la condizione «terrestre» (p. 94), propria di qualsiasi essere umano. L’operazione teoretica messa in atto da Missiroli consiste nel recuperare e rielaborare la proposta di pensatori e pensatrici che, in maniera più o meno sotterranea, rovesciano le premesse del DAP. L’Antropocene, da questa prospettiva, non è l’epoca dell’umano, ma l’epoca della Terra, o meglio, l’epoca in cui all’umano si manifesta la propria appartenenza terrestre. Ciò, più concretamente, significa che l’Antropocene lungi dal conferire preminenza assoluta all’attività dell’umano ne decentra la posizione rispetto alla storia profonda, al deep time che, viceversa, costituisce – con le condizioni bio-geologiche che ha prodotto, essenziali allo sviluppo della vita – la sua condizione di possibilità. Come ha mostrato Dipesh Chakrabarty, è solo perché la storia della Terra si è svolta nel modo in cui si è svolta che si è aperta la possibilità per, dapprima, la storia – biologica – della vita umana, e, poi, la storia dell’industrializzazione. Ciò implica che anche il capitalismo si alimenta della e sulla Terra, cioè in un certo senso ne dipende. Nessuno di questi segmenti storici è riducibile agli altri, ed anzi essi vanno pensati nella loro coesistenza, nel loro intreccio e nella loro convergenza: l’Antropocene è l’epoca in cui si mostra la collisione di queste temporalità diverse. Di conseguenza, è solo entro il campo aperto dalla storia geologica che l’azione umana si rende possibile, e che, per questo motivo, la dimensione del geologico resta «inappropriabile» (p. 119) rispetto all’azione umana - la quale, scrive Missiroli, è “espressione” della Terra. Raccogliendo intuizioni di Bruno Latour e Donna Haraway, ma facendole reagire con alcuni concetti provenienti dalla filosofia di Maurice Merleau-Ponty – a cui l’impianto teorico di Missiroli è molto vicino – l’autore giunge a sostenere che l’umano non coincide con la Terra, né la trascende, ma è ad essa imminente. È quest’ultimo uno dei punti più originali del libro di Missiroli: imminente, scrive l’autore, «è ciò che si sporge su altro, ciò che sta dietro a qualcos’altro non corrispondendovi in alcun modo, ma al contempo non abbandonandolo mai» (p. 97). Così, dire che l’umano sta in un rapporto d’imminenza con la Terra, o la storia con la natura, significa dire che Terra e natura sono presenze operanti al fondo dell’umano e della storia, ma non si esauriscono nell’umano e nella storia: al contrario, ne istituiscono la differenza che rimane vincolata alla propria appartenenza geologico-naturale.
L’immagine della Terra offerta dal DAP viene in questo modo ribaltata. La Terra non coincide con l’oggetto – il Globo – del DAP, uno spazio piatto orizzontale e, per impiegare un concetto heideggeriano, vorhanden, alla mano, ma detiene una sua autonomia complessa, una sua oscurità, una sua profondità. Missoroli interpreta in questo senso i risultati più recenti proveniente dalle Scienze del Sistema Terra, che hanno dimostrato come la Terra rappresenti un sistema dinamico in cui la vita gioca una parte fondamentale nel mantenimento dell’equilibrio complessivo; un sistema dinamico regolato da cicli di retroazione non prevedibili e incerti. «La Terra ha una certa profondità, cioè, appunto, non è mai del tutto data allo sguardo di un soggetto […]. Ha una certa potenza di agire che, nell’Antropocene, viene esperita su scala planetaria» (p. 116). Profondità, verticalità, oscurità, invisibilità: la Terra – si potrebbe dire contro Hegel – ha un interno; ed è alla luce di ciò che Missiroli può criticare, mostrandone l’inconsistenza, la proposta della geoingegneria, la quale, considerando la Terra come un puro oggetto, trascura esattamente questa sua “profondità”. Ma ciò d’altro canto non significa che l’azione dell’uomo sia totalmente soggiogata alla potenza della Terra. Piuttosto, anche l’azione umana va pensata entro la rete complessa naturale-terrestre con la quale, di nuovo, sta in un rapporto di imminenza. Si tratta di concepire un margine di passività all’interno della prassi, un peso che opera in essa senza coincidervi, un suolo al fondo delle nostre azioni: «la Terra e la vita umana e non umana stanno tra loro in una relazione di imminenza: la prima è cioè l’orizzonte attivo e insuperabile della seconda, ciò che la attraversa senza coincidere con essa» (p. 122).
È solo a questo punto che diviene possibile abbozzare il profilo di una teoria critica dell’Antropocene. Anzitutto l’Antropocene, quale concetto di matrice geologica, va mantenuto come tale all’interno delle discussioni più teoretiche. Poi, è necessario abbandonare l’ipotesi che si possa – come spesso è stato detto – “uscire” dall’Antropocene: in quanto evento nella storia della Terra che istituisce un campo di possibilità bio-geo-logiche, le trasformazioni apportare al sistema Terra che ne determinano le caratteristiche «non possono essere semplicemente rimosse» (p. 126). Più concretamente: i ghiacciai continueranno a sciogliersi, la temperatura globale a salire. Pensare che queste trasformazioni siano reversibili, significherebbe, da un lato, schiacciare le diverse scale temporali l’una sull’altra, dall’altro, ribadire la centralità prometeica dell’umano che tutto il discorso di Missiroli tenta di ribaltare. Ecco perché Missiroli giunge a scrivere che «per ogni vivente, oggi, la Terra è l’Antropocene» (p. 128; corsivo nel testo), ovvero l’azione umana è vincolata ad un ambito di possibilità determinato anzitutto dall’epoca in cui ci troviamo. Solo riconoscendo questo ambito di possibilità come l’esito non necessario – ossia non legato ad un’essenza umana negatrice – di un intreccio complesso di storie, è possibile rendere il presente trasformabile. La condizione bio-geo-logica istituita dall’Antropocene costituisce dunque il criterio che permette di preparare un’ecologia politica – sulla quale si arresta il libro di Missiroli, che vede nel movimento della decrescita un primo passo politico-teorico in questa direzione – che prenda in carico la realtà e l’autonomia della Terra quale ambito di possibilità per l’azione umana. Tale prospettiva non solo ambisce a conservare e ristabilire l’equilibrio tra gli umani nell’Antropocene, ma anche tra umani e non-umani, istituendo – e non creando –, lo spazio per il conflitto e dunque per la decisione politica.
Concludendo, questa ”ontologia critica di noi stessi” messa in campo da Missiroli, che rappresenta solo una prima, importante tappa verso la costruzione – necessariamente multidisciplinare e collettiva – di un paradigma adatto alla presente congiuntura geo-storica, costituisce più di una semplice introduzione alla problematica dell’Antropocene. Essa rappresenta un esempio di dialogo riuscito tra la filosofia e le più recenti questioni, anche specialistiche, sollevate dalle scienze naturali, un dialogo che ha evidenti ricadute sia teoriche che pratiche e che prelude ad un lavoro ancora tutto da fare. Restano alcune questioni problematiche su cui riflettere ulteriormente (ad esempio, la distinzione fra concetto e oggetto “Antropocene”, che a parere di chi scrive non è così netta come sembra a Missiroli). Questioni che, tuttavia, non sono certo decisive rispetto alla concretezza di Teoria critica dell’Antropocene – forse riassumibile riprendendo le parole di una scrittrice italiana vicina per sensibilità e intuizioni a tali questioni, Anna Maria Ortese: «E che cos’è, questa Natura? Bene o male? Che cosa attende? Essa soffre, è chiaro… bisogna aiutarla. È ciò possibile, senza morire davanti all’Eterno?» (Ortese, 1986; p. 81).
Giovanni Fava
Bibliografia
Ellis, E. C. (2018), Anthropocene. A very short intruduction, Oxford Univ. Press, Oxford.
Ortese, A. M. (1986), L’iguana, Adelphi, Milano.
Zalasiewicz, J., Waters, C. N., Williams, M., Summerhayes, C. P, (eds.) (2021), The Anthropocene as a geological time unit. A guide to the Scientific Evidence and Current Debate, Cambridge Univ. Press, Cambridge. -
L’immaginazione delle esperienze
Recensioni / Maggio 2023Dopo aver intrapreso una carriera come geografo, poi come funzionario pubblico sulla scala locale, poi come attivista politico, Alan Taylor si è avvicinato alla musica soltanto verso la metà della sua vita e da allora ha conseguito un dottorato di ricerca sul tema dell’immaginazione musicale. È inoltre un musicista dall’attività vivace: conduce due ensemble, si esibisce regolarmente e dirige il Festival musicale di Herne Hill. Questo percorso eterogeneo e multiforme gli permette di adottare una prospettiva molto particolare sui temi dell’invenzione musicale e della creazione artistica collettiva, realtà che l’autore conosce per averne fatto l’esperienza diretta, al di là della riflessione teorica.
In The Imagination of Experiences, Taylor comincia con l’esaminare il mito del genio, concepito in questo contesto come un’ideologia capace di influenzare sia il pubblico sia i musicisti. Si tratta di un retaggio dell’epoca romantica, quando figure come Liszt o Chopin, ma anche, retrospettivamente, Mozart o Beethoven, furono erette come paradigmi del creatore solitario, capace di produrre senza sforzo grandi opere d’arte, eccezionale nell’intelligenza e nel talento (Berstein, 1998, pp. 59-81). Taylor sottolinea come certi aspetti del modo in cui funziona l’immaginazione possono indurre gli artisti a credere che le loro idee scaturiscano esclusivamente dalla loro mente, e a iscriversi quindi in una concezione della creazione che deriva direttamente dal topos del genio romantico. Tuttavia, l’intenzione dell’autore è di prendere in contropiede questa tendenza, evidenziando che la pratica compositiva è spesso collaborativa e non corrisponde affatto all’idealizzazione del creatore solitario. Inoltre, un corollario di questa illusione è che la musica d’arte occidentale sia concepita come una raccolta di opere singolari ed irriducibili, figlie proprio di un processo di creazione inconoscibile poiché legato alla mente eccezionale di un personaggio geniale (Kanga, 2014, p. 155). Anche questo aspetto è contestato da Taylor, che osserva come esso sia legato a un momento specifico della storia della musica, e che non si possa quindi applicarlo tale e quale alla musica di altri periodi, senza contare che non corrisponde davvero alla realtà empirica della musica eseguita.
Una volta presa posizione in questo senso, Taylor illustra tre caratteristiche principali del processo immaginativo (p. 25): 1) le idee emergono dalle interazioni tra le numerose influenze assorbite dall’individuo, e sono quindi naturalmente complesse; 2) l’immaginazione dipende e viene provocata dal coinvolgimento con la società e con l’ambiente circostante; 3) le idee appaiono nella mente cosciente come dal nulla, dopo una riflessione nel subconscio. Questa terza caratteristica è dunque la ragione della persistenza del mito del genio romantico, che trova così riscontro nell’esperienza creativa individuale. Per quanto riguarda invece la seconda caratteristica, la sua manifestazione più elementare è l’interazione con i mezzi e gli oggetti fisici necessari all’attività musicale, che si tratti di immaginarli per comporre o di usarli per suonare. In questo contesto, scrive Taylor, l’immaginazione è inestricabilmente legata al corpo (p. 38), secondo il quadro proposto da Marc Leman (2008): partendo dal presupposto che il corpo svolge un ruolo centrale in tutte le attività musicali e basando il suo approccio su un’ipotesi di relazione tra l’esperienza della percezione musicale e la materia sonora, questi sostiene che il corpo umano è un intermediario capace di trasferire il suono fisico a un livello mentale e, invertendo il processo, di trasferire la rappresentazione mentale in forma materiale.
Taylor distingue inoltre tra due attività immaginative separate: il sopravvenire di un’idea e la scelta di una collocazione o di un uso per quest’idea (p. 44). Si può quindi rilevare una differenza tra un momento generativo e un momento valutativo nel processo di immaginazione.
Dopo aver descritto la natura dell’immaginazione creativa, l’autore presenta poi la questione della collaborazione artistica e della condivisione del lavoro immaginativo, e più precisamente di come sia possibile condividere il processo di elaborazione subconscia per gli artisti che lavorano insieme (p. 54). Si fa dunque sensibile la necessità di una comunicazione efficace, nel riconoscimento dei limiti reciproci. Come si esprime il compositore statunitense John Adams: «La collaborazione artistica non è mai facile. […] Si tratta forse della cosa più dolorosa che due persone possano fare insieme» (2008, p. 220). In un tentativo di schematizzazione, Taylor suddivide le modalità cooperative possibili in una relazione di creazione artistica in due casi esemplari (p. 61): il primo, quando esiste un progetto o uno schema concordato, magari già prodotto in collaborazione, e i partner apportano i loro contributi in modo separato ma paritario; e, il secondo, quando i partner lavorano fianco a fianco sui loro contributi rispettivi, condividendo le decisioni man mano che procedono. Nel primo caso, si può parlare di cooperazione pre-pianificata, mentre per il secondo è più opportuno parlare di cooperazione interattiva. Questa distinzione non riguarda soltanto le circostanze della condivisione del lavoro immaginativo, ma anche il modo in cui questa viene vissuta. Inoltre, come si è detto, la condivisione del lavoro immaginativo dipende dalla capacità di comunicazione degli artisti coinvolti, e Taylor sottolinea il bisogno di un linguaggio conveniente per assicurare una comunicazione capace di produrre i risultati voluti (p. 67). Tuttavia, sarebbe erroneo presupporre che questo linguaggio debba essere di natura verbale: gli improvvisatori jazz comunicano attraverso l’ascolto e l’impiego di materiale musicale in un idioma familiare, e i ballerini possono comunicare attraverso il movimento.
In un secondo tempo, Taylor si interroga infine sui processi di creazione del significato musicale e l’immaginazione che viene quindi indagata in questo momento non è più quella del compositore, ma quella dell’ascoltatore. La prima preoccupazione dell’autore in questo frangente è la distinzione tra il significato musicale e l’emozione musicale (p. 76): quest’ultima sarebbe il senso di emozione o di significato non specificato e forse non precisabile provocato da un brano musicale, mentre il primo sarebbe invece il tentativo di verbalizzazione di questo senso. In effetti, la verbalizzazione è una fase necessaria per lo studio di quel senso non ancora determinato che Taylor identifica con l’emozione musicale e, se questa è forse condivisa tra ascoltatori diversi, è molto probabile che resoconti dettagliati delle impressioni prodotte dallo stesso brano possano differire drasticamente da un ascoltatore all’altro (cfr. Downey 1897, pp. 63-69; e Nattiez, 1990, pp. 244-246). L’autore riporta inoltre un’esperienza originale e interessante, in cui ha studiato la percezione da parte del pubblico di due dei suoi propri brani (2020). L’esperimento gli ha permesso di constatare che, sebbene il pubblico abbia descritto una varietà di significati più o meno collegati al carattere generale dei brani come era stato immaginato dal compositore, le loro risposte condividevano due caratteristiche: erano molto più elaborate rispetto allo stadio di elaborazione immaginativa a cui il compositore era giunto durante il processo creativo, e descrivevano comprensioni contrastanti dei brani. Per questa ragione, sembra più probabile che i membri del pubblico creino dei significati individuali a partire dalla loro esperienza della musica, piuttosto che decodificando dei significati che la musica comunicherebbe in maniera inequivocabile.
Anche nel caso dell’immaginazione ricettiva, e non creativa, il ruolo del corpo non è irrilevante (cfr. Juslin et al., 2011). Anzi, come viene evidenziato da Taylor, poiché la cognizione della musica dipende da meccanismi di reazione tra cervello e corpo, si può spiegare perché la musica è percepita come significativa in relazione all’esperienza pregressa. Infatti, il coinvolgimento corporeo porta a percepire delle somiglianze tra la musica e le esperienze anteriori che hanno provocato sensazioni simili, e a costruire quindi il significato della prima sulla base di analogie con queste ultime (pp. 89-90). Riassumendo, questo processo può essere razionalizzato in tre fasi (p. 95): 1) la musica viene ascoltata e le aree motorie e sensoriali del cervello registrano gli stimoli acustici e di movimento grazie a un meccanismo di reazione tra cervello e corpo; 2) le aree semantiche e cognitive del cervello sono convocate nel processo di creazione del senso; 3) qualsiasi senso di comprensione degli stimoli musicali deriverà dall’esperienza pregressa dell’ascoltatore. L’implicazione è quindi che il processo di percezione dei significati musicali attraverso l’analogia è probabilmente involontario, almeno in una certa misura.
In conclusione, in The Imagination of Experiences, Taylor asserisce dunque contro il mito del genio solitario che l’immaginazione musicale è una capacità posseduta da tutti, e si posiziona in questo senso nella scia di alcune ricerche recenti che sostengono l’universalità della musica in tutte le culture umane e il ruolo importante che questa avrebbe svolto da un punto di vista evolutivo (Mithen, 2005). Recentemente, per esempio, partendo dai Neanderthal e dai primi sapiens, il musicologo Gary Tomlinson ha descritto le conquiste incrementali che hanno gettato le basi di comportamenti musicali più prossimi ai tempi odierni, modificando la comunicazione e l’organizzazione delle società umane (2015). Tuttavia, tornando a The Imagination of Experiences, il fatto che l’immaginazione musicale sia radicata nel subconscio è un ostacolo rispetto alle possibilità di condivisione dei processi immaginativi quando gli artisti si trovano a lavorare insieme. Inoltre, un’altra conseguenza significativa di questa circostanza è che i significati musicali non sono comunicati direttamente dai compositori agli ascoltatori.
Lucia Pasini
Bibliografia
Adams, J. (2008). Hallelujah Junction. Composing an American Life. New York, NY: Faber and Faber.
Bernstein, S. (1998). Virtuosity of the Nineteenth Century: Performing Music and Language in Heine, Liszt and Baudelaire. Redwood City, CA: Stanford University Press.
Downey, J.E. (1897). A Musical Experiment. The American Journal of Psychology, 9 (1), 63-9.
Juslin, P.N., Liljeström, S., Västfjäll, D., Lundqvist, L.-O. (2011). How Does Music Evoke Emotions? Exploring the Underlying Mechanisms. In P.N. Juslin e J.A. Sloboda (a cura di), Handbook of Music and Emotion: Theory, Research, Applications (605-42). Oxford: Oxford University Press.
Kanga, Z.R. (2014). Inside the Collaborative Process: Realising New Works for Piano. Tesi di dottorato inedita, Royal Academy of Music, Londra, Regno Unito.
Leman, M. (2008). Embodied Music Cognition and Mediation Technology. Cambridge, MA: MIT Press.
Mithen, S. (2005). The Singing Neanderthals. The Origins of Music, Language, Mind and Body. Londra: Weidenfeld & Nicolson.
Nattiez, J.-J. (1990). Can One Speak of Narrativity in Music? Journal of the Royal Musical Association, 115, 240-57.
Taylor, A. (2020). Death of the Composer? Meaning Making from Musical Performance. Music & Practice, 6.Tomlinson, G. (2015). A Million Years of Music. The Emergence of Human Modernity. New York, NY: Zone Books.
-
«Perché alcuni acconsentono a subire la sofferenza, mentre altri acconsentono a infliggere tale sofferenza?» Lavoro e ingiustizia sociale.
L’ingranaggio siamo noi. Lavoro e banalizzazione dell’ingiustizia sociale, edito da Mimesis nel 2021, è la più recente traduzione italiana dell’opera Souffrance en France di Christophe Dejours, edita per la prima volta nel 1998, éditions du Seuil. L’autore, Christophe Dejours, è psichiatra e psicanalista, direttore dell’Insitut de Psychodynamique du Travail (IPDT) di Parigi: la sua ampia produzione sul tema del lavoro parte da ricerche sul campo nell’ambito della psicodinamica del lavoro, ma offre altresì importanti spunti alla riflessione filosofica sul tema, entrando in dialogo con la tradizione critica. Piuttosto noto e presente nel dibattito pubblico in Francia, Dejours risulta invece ancora poco conosciuto in Italia: fra i suoi volumi tradotti in italiano vi sono solo i due testi Lavoro vivo, traduzione di alcuni brani del secondo volume di Travail vivant, e Si può scegliere. Soffrire al lavoro non è una fatalità, traduzione di Le choix Souffrir au travail n’est pas une fatalité. La nuova edizione italiana de L’ingranaggio siamo noi risulta dunque di particolare importanza, in quanto riporta nel panorama italiano un testo che, a distanza di quasi vent’anni dalla sua prima edizione, può fornire ancora spunti fecondi sul mondo del lavoro contemporaneo. Lavoro e ingiustizia sociale
Il testo si articola a partire da una domanda, esplicitata nel primo capitolo del libro: come tollerare l’intollerabile? Ovvero, com’è possibile che si assista oggi non solo all’accettazione della sistematica sofferenza di alcuni, ma anche alla generazione di consenso di questi attorno agli stessi dispositivi che ne causano la sofferenza? Perché, per citare Dejours, la sofferenza non è più percepita come ingiustizia sociale?
Dejours affida al lavoro un ruolo centrale nella spiegazione del fenomeno: le sue indagini si concentrano infatti sulla sofferenza generata al lavoro. In L’ingranaggio siamo noi, l’oggetto della ricerca non sono più tanto i lavoratori operatori sul campo, come era invece in Travail, usure mentale, quanto i quadri collaboratori dei dirigenti d’azienda. L’autore si domanda infatti quali meccanismi dell’organizzazione del lavoro contemporanea siano in grado di coinvolgere a tal punto “brave persone” a collaborare attivamente alla generazione di sofferenza fra altri lavoratori.
Per costruire una risposta a tali quesiti, Dejours parte da considerazioni di psicodinamica del lavoro circa le strategie di difesa mobilitate dai lavoratori per far fronte alla sofferenza. Il legame tra sofferenza e lavoro può essere secondo Dejours di due tipi: da una parte vi è la sofferenza di coloro che non hanno un impiego, dall’altra vi è la sofferenza vissuta da coloro che lavorano, che può assumere forme diverse.
Un primo fattore che determina la difficoltà a reagire alla sofferenza e contribuisce ad aggravarla è la sua negazione, perpetrata secondo Dejours tanto dalle organizzazioni politiche e sindacali che dovrebbero prendersene carico, quanto dai lavoratori stessi che finiscono per delegittimare e non riconoscere la propria stessa sofferenza psichica. In uno scenario di crescente disoccupazione, la battaglia per diminuire la sofferenza a lavoro risulta essere appannaggio dei privilegiati che hanno un impiego, i quali vanno incontro a colpevolizzazione e vergogna di fronte a tutti coloro che sono invece esclusi dal lavoro stesso. A tali fenomeni di inibizione delle rivendicazioni si aggiunge la paura per la precarizzazione, lavorativa e dunque esistenziale, in cui vive la maggior parte dei lavoratori, che accresce l’individualismo e la solitudine.
Tale negazione è alla base nel fenomeno che Dejours chiama «distorsione comunicativa», concetto centrale nella riflessione dell’autore. Tale distorsione è dovuta, secondo l’autore, allo scarto fra due diverse descrizioni del lavoro: quella manageriale e quella soggettiva dei lavoratori. Quest’ultima rende conto del reale del lavoro, ovvero il confronto con gli inevitabili imprevisti a cui tutti i lavoratori devono far fronte nelle loro attività quotidiane, in cui sono mobilitate risorse soggettive di creatività e ingegno non previste dall’attività prescritta. Al contrario, la descrizione manageriale del lavoro prevede secondo Dejours una sistematica e strategica distorsione comunicativa che concorre all’occultamento della sofferenza fra i lavoratori e alla collaborazione zelante dei quadri: la narrazione del lavoro a partire solo dai risultati e non dalle attività che li producono, l’enfasi sui successi e l’omissione di errori e fallimenti diffondono un’immagine che non corrisponde alla realtà (come sintetizzato da Dejours con la descrizione dei dispositivi di dominio manageriale della «valutazione individualizzata delle prestazioni» e dello «standard di qualità totale»).
La distorsione è realizzata grazie all’attiva cooperazione dei quadri: è a questo punto che Dejours introduce un’analisi della specifica forma di sofferenza che affligge questa categoria di lavoratori. Dalle inchieste condotte da Dejours emerge infatti la loro difficile posizione psicologica: costretti a compiere azioni inique con i propri subordinati, «dei quali si finge di ignorare la sofferenza, o con i propri colleghi, verso i quali, per conservare il posto o ottenere avanzamenti di carriera, si è costretti a essere sleali». La collaborazione attiva a tali azioni è possibile secondo Dejours in ragione di due diversi tipi di sofferenza, negata e dissimulata: da una parte vi è la paura di licenziamento e precarizzazione in caso di rifiuto, ma dall’altra vi è una vera e propria «“sofferenza etica”» determinata dall’essere costretti a «perdere la propria dignità» e a «tradire i propri ideali e valori». Per far fronte a questa specifica sofferenza, che non può essere espressa, i quadri mettono in atto strategie individuali e collettive di difesa che Dejours riconduce a un processo di razionalizzazione, intesa in questo caso in senso psichiatrico, come «una difesa psicologica che consiste nel dare a un vissuto, a un comportamento o a dei pensieri riconosciuti dal soggetto stesso come inverosimili (ma ai quali tuttavia egli non può rinunciare) una parvenza di giustificazione». La razionalizzazione si articola secondo l’autore in due processi psicologici: la «strategia collettiva di difesa del “cinismo virile”» e «l’ideologia difensiva del realismo economico». Con la prima l’autore fa riferimento al potere che il movente della virilità può esercitare nel giustificare agli occhi dei quadri scelte che causeranno sofferenza ai lavoratori (dai licenziamenti alla consapevole distorsione comunicativa) e nel creare dinamiche di gruppo a cui il singolo partecipa pur di non sentirsi escluso e di non perdere la propria identità. Dejours descrive a tal proposito veri e propri “rituali” per esorcizzare il rifiuto morale provato dai soggetti per le azioni compiute, come cene fra i quadri in cui dare pubblica dimostrazione di cinismo e disprezzo per le vittime. La seconda fa invece riferimento alla produzione di un discorso di giustificazione del “male necessario” in nome di «interessi sovra-individuali» di natura economica. Proprio la logica economica è al centro del processo di giustificazione e razionalizzazione: non vi è alcuna scelta da compiere, se non quella «tra sopravvivenza e disastro», per cui le scelte di management che comprendono tagli e menzogne, per quanto dolorose, sono inevitabili per salvare l’azienda. È proprio questa narrazione a fare da sfondo al cinismo virile che caratterizza le strategie collettive di difesa dalla sofferenza etica dei quadri.
È a questo punto che Dejours introduce l’interessante analogia fra il processo di razionalizzazione messo in atto a lavoro e il concetto di “banalità del male” di Hannah Arendt, riprendendo la figura di Eichmann. L’autore francese non è l’unico a fornire nuove interpretazioni del concetto di “banalità del male” di Arendt. Altre letture fanno tuttavia riferimento alla «routinizzazione del male» o alla «normalità del male», mentre Dejours attribuisce un significato diverso alla “banalizzazione del male”, in cui il lavoro gioca un ruolo cardine. La deresponsabilizzazione cui si appella Eichmann, in nome di conformismo e obbedienza, è interpretato da Dejours come una strategia difensiva analoga a quella messa in atto dai quadri nel tentativo di proteggersi dalla sofferenza etica e dalla minaccia di «precarizzazione e di esclusione sociale». È così che l’autore finisce per definire la banalizzazione del male come «il processo tramite il quale un comportamento eccezionale, abitualmente inibito dall’azione o dal comportamento della maggioranza, possa essere eretto a norma di condotta, addirittura valore».
L’aspetto di notevole interesse del testo risiede proprio nella complessa analisi psicologica, sociale e politica condotta dall’autore, in cui il lavoro ricopre un ruolo centrale. L’organizzazione manageriale del lavoro in un sistema sempre più tendente al neoliberismo genera infatti precarietà e paura, sofferenza che viene sistematicamente negata. La novità dell’analisi proposta da Dejours risiede nel sottolineare come i quadri stessi, complici del funzionamento dell’organizzazione, siano vittime di un sistema che li costringe al diniego e al misconoscimento della loro sofferenza etica, di fronte alla quale l’unica strada percorribile è innescare strategie di difesa che rafforzano e reiterano non solo la sofferenza subita da altri lavoratori, ma anche l’adesione dei quadri stessi al sistema che ne è causa. Proprio per questo Dejours ritiene possibile ricorrere al concetto di La Boétie di «servitù volontaria», nominata esplicitamente nella Prefazione all’edizione del 2008: «La mia indagine sulla servitù volontaria nel sistema neoliberista rivela che la maggioranza delle persone può essere arruolata al servizio di un sistema del quale pure disapprova profondamente i metodi. E mostra […] che tale mobilitazione può essere ottenuta senza l’uso della forza». Sull’utilizzo della categoria di servitù volontaria in questa chiave non mancano ulteriori spunti.
Una simile interpretazione è ancora feconda per tentare di comprendere il perpetuarsi di fenomeni di ingiustizia sociale che generano disuguaglianza e sofferenza e la difficoltà per molti movimenti a organizzare una forza sociale che promuova una visione alternativa in grado di aggregare consenso. Le indagini di Dejours suggeriscono di spostare l’attenzione sul ruolo centrale svolto dal lavoro nell’adesione alla narrazione dominante, tema sempre più in secondo piano nel dibattito politico, nella convinzione che «se la pubblicazione di quest’analisi è utile, è perché può servire a […] coloro che vogliono pensare non soltanto la resistenza, ma soprattutto delle alternative a quest’evoluzione».
Martina Fang Lu
Bibliografia
H. Arendt, La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme, Feltrinelli, Milano 1964.
S. Benhabib, Hannah Arendt and the Redemptive Power of Narrative, in «Social Research», n°57, 1990.
C. Dejours, Travail, usure mentale. Essai de psychopatologie du travail, Bayard Éditions, 2015 (1980).
C. Dejours, Le facteur humain, PUF, Paris 2018 (1995).
C. Dejours, L’ingranaggio siamo noi. Lavoro e banalizzazione dell’ingiustizia sociale, Mimesis, Milano 2021 (1998).
C. Dejours, Travail Vivant (vol. 1: Sexualité et travail, vol.2: Travail et émancipation), Payot, Paris 2013 (2009).
C. Dejours, Si può scegliere. Soffrire al lavoro non è una fatalità, Moretti & Vitali, Bergamo 2021 (2015).
C. Dejours, J.-P. Deranty, E. Renault e N. H. Smith, The Return of Work in Critical Theory, Columbia University Press, New York 2018.
J.-P. Deranty, Travail et expérience de la domination dans le néolibéralisme contemporain, in «Actuel Marx», 49, 1, 2011, pp. 73-89.
E. Donaggio, Dissonanze del totalitarismo. Banalità del male o servitù volontaria?, in «Psicoterapie e scienze umane», n°2, 2013, pp. 239-254.
E. Donaggio, Souffrance en France en Italie, in « Travailler », 42, 2 2019, pp. 93-101.
C. Emmenegger, F. Gallino, D. Gorgone, Investire se stessi. Capitalismo e servitù volontaria, in E. Donaggio (a cura di), C'è ben altro. Criticare il capitalismo oggi, Mimesis, Milano, 2014, pp. 123-138.
C. Emmenegger, F. Gallino, D. Gorgone, Entre complicité et souffrance. Penser la servitude volontaire dans le monde du travail, in « Travailler », n°42, 2019, pp. 103-118.
S. Forti, I nuovi demoni. Ripensare oggi male e potere, Feltrinelli, Milano, 2012.
É. de La Boétie, Discorso della servitù volontaria, Feltrinelli, Milano 2014.
E. Renault, Souffrances sociales: Philosophie, psychologie et politique, la Découverte, Paris 2008.
E. Renault, Domination et pathologie sociale chez La Boétie, in « Cahiers La Boétie », 3, 2013, pp. 137-151.
-
La servitù volontaria dell’io soggiogato
Recensioni / Maggio 2023«Se il testo di La Boétie è incontestabilmente un testo politico, tuttavia affronta le relazioni di potere e di dominio sotto una prospettiva specifica, dal punto di vista dell’ombra proiettata dalla realtà sociale sul funzionamento mentale dei soggetti, per mettere in rilievo i danni identitari e narcisistici tipici della sofferenza sociale. Interroga anche, per converso, gli effetti sociali di questo funzionamento mentale, la sua capacità ad alimentare condotte di sottomissione e ad alimentare il sistema di dominio»
– T. Dagron, p. 380
Da qualche mese, sugli scaffali dedicati alla filosofia moderna e contemporanea della celebre libreria «Vrin» di Place de la Sorbonne a Parigi, è comparsa una sezione «La Boétie». Segnale dell’ottima salute di cui gode tanto il Discours de la servitude volontaire quanto il fenomeno che il suo autore definisce. Entrambi continuano a interessare studiosi, studiose e case editrici (tra le edizioni più recenti, questa in lingua spagnola è assai pregevole). Tra i volumi della sezione, spicca Le soi subjugué. Servitude volontaire et cliniques de l’aliénation (Librairie Philosophique J. Vrin, 2022, pp. 405) di Tristan Dagron, direttore di ricerca al CNRS di Lione.
Il nome di Dagron è legato a quello di La Boétie ormai da diverso tempo: suo è uno dei contributi che si trovano nell’edizione Vrin del Discours del 2002, che si proponeva come alternativa all’edizione Payot del 1975, a cura di Miguel Abensour e Marcel Gauchet. È sua anche l’introduzione al Discours della nuova edizione Vrin del 2012. Un’introduzione che merita di essere citata: Dagron vi sanziona la specificità della «riattualizzazione della nozione della servitù volontaria» (p. 18) avvenuta negli ultimi anni, quale strumento euristico adoperato da sociologia e psicologia per esplorare le forme di dominio nel mondo del lavoro (cfr. Dejours 2006).
Le soi subjugué prosegue le ricerche che Dagron ha avviato con Pensée et cliniques de l’identité. Descartes, Cervantès, Montaigne (Librairie Philosophique J. Vrin, 2019). La prospettiva adottata è la medesima: coniugare il lavoro di storico della filosofia con la psicoanalisi. Lo sguardo di Dagron sul Discours non è solo quello dello specialista in storia della filosofia; il suo spettro di domande e di interessi è rivolto verso «processi mentali che sono in fondo assai ordinari» (p. 16) e nutrito dell’approccio psicoanalitico di René Roussillon e dall’ambiente lionese (cfr. Roussillon, 1991). Narcisismo, identità, riflessività, alcuni dei termini chiave.
Se mai fosse necessario prevenire qualsiasi esitazione in merito a un simile approccio, la lettura di Dagron si tiene ben lontana da freudismi spiccioli o selvagge interpretazioni psicoanalitiche della vita degli autori. Il lettore, al massimo, potrà risentire un certo spaesamento a causa di un percorso argomentativo talvolta complesso, che si sposta rapidamente da discussioni storico-filosofiche a discussioni psicoanalitiche e che lascia implicite alcune definizioni tecniche. Questo non intacca la rilevanza de Le soi subjugué, nel contesto del rinnovato interesse per La Boétie degli ultimi due decenni.
Nel primo dei dieci capitoli del volume, Dagron si occupa, per l’appunto, mettere in luce l’attualità del Discours, in particolare rispetto alla tematica della cosiddetta «sofferenza sociale», quella forma specifica di sofferenza che deriva dall’effetto prodotto da determinate situazioni sociali sull’individuo (cfr. Renault 2008). Nel secondo capitolo, l’autore esplicita l’interesse del proprio approccio pluridisciplinare che propone d’integrare la prospettiva psicoanalitica sul narcisismo alla problematica dell’identità secondo i termini della psicologia sociale.
Conclusa questa sorta di preambolo, Dagron orienta gli altri capitoli sui temi canonici connessi al Discours: amicizia, libertà, memoria, abitudine, volontà e patto. Qui svolge un lavoro di analisi storico-filosofica per rendere conto del rapporto di La Boétie con autori quali Aristotele, Cicerone o Marsilio Ficino, o per confrontare la «servitù volontaria» con l’ethelodouleia del discorso di Pausania nel Simposio o, ancora, per ricostruire la psicologia della memoria di Avicenna, che è uno dei sostrati teorici del Discours. Tuttavia, la finalità di Le soi subjugué non si esaurisce in quest’ordine di discussioni.
L’obiettivo di Dagron, in effetti, è dimostrare che il Discours presenta «una ricca riflessione clinica sulla posta in gioco della socializzazione e della soggettivazione» (p. 383). Più esattamente, La Boétie offre «un bilancio della violenza sociale» e dei fenomeni che essa induce dal punto di vista delle capacità mentali e riflessive degli individui. Sicché, il vero e proprio asse su cui si articola Le soi subjugué è l’interesse per il Discours in quanto testo che concerne una «realtà clinica» assai precisa: la «disorganizzazione identitaria» della psiche individuale dalla società e le sue conseguenze sul giudizio d’attribuzione di ciò che suscita piacere e dispiacere.
Stando alla lettura de Le soi subjugué, la servitù volontaria indica non tanto una forma di governo quanto una relazione di dominio. Per descriverla, Dagron sembra voler adoperare il termine di «subjugation», ma non è chiaro a riguardo: l’espressione che dà il titolo al volume non è oggetto di una discussione specifica che la definisca. Alla voce «subjuguer», però, il dizionario Robert riporta: «mettere qualcuno nell’impossibilità di resistere, per ascendente, all’influenza che si ha su di lui». E tale pare essere la condizione dei servi volontari.
La celebre paradossalità della formula laboetiana della servitù volontaria (il dominio si sostiene sul decisivo e volontario contributo dei servi: allora perché, pur potendo smettere di servire, non lo fanno?) si riflette nell’insieme di caratteristiche che si rinvengono nell’interpretazione di Dagron: la servitù volontaria è tanto estorta e indotta quanto spontanea e non deliberata, cioè frutto di un’azione volontaria ma i cui moventi sono per lo più inconsci. Infatti, essa è un risultato che il tiranno ottiene dai sudditi e corrisponde a una «strategia di difesa, tra le altre possibili, che può essere mobilitata dalla psiche per far fronte all’impatto disorganizzatore della violenza sociale» (p. 96).
Questo è un dato fondamentale che va sottolineato: per Dagron la servitù volontaria non si spiega con una «sete di obbedienza» presente nei servi né indica una delle cause prime del dominio. È un adattamento difensivo che alimenta e mantiene il dominio che lo induce. In altri termini, occorre ricercare la servitù volontaria non a monte di dinamiche politico-sociali, in qualità di loro principio causale; al contrario, la servitù volontaria è un fenomeno che sta a valle, portato di un «mondo perseguitato dalla morte sociale e psichica» (p. 305).
Dagron si serve allora della psicoanalisi per sondare i «moventi interni, ma non per questo meno oscuri ed enigmatici» (p. 38) degli individui. Posto il narcisismo quale meccanismo di difesa dell’io dalle esperienze negative e di integrazione di queste ultime (cfr. Freud 1921 [1975]), alla vulnerabilità sociale corrisponde la «precarizzazione psichica» (p 63). La sottrazione di alcuni «oggetti sociali» (quali l’impiego, il reddito, e l’alloggio, secondo gli esempi proposti da Dagron) che l’individuo investe narcisisticamente, spinge l’individuo a un «tentativo, tanto strano quanto oneroso, di restaurazione narcisistica» (p. 49) che si configura come una «relazione addittiva» nei confronti dei «frammenti» di quegli oggetti che «tiranno sa bene come far scintillare» (p. 50). In questo modo si innesta il suo comportamento di sottomissione e di asservimento nei confronti di chi domina.
Questo è un altro aspetto dell’interpretazione di Dagron che va tenuto in considerazione: la servitù volontaria non è dovuta all’ignoranza, all’inganno o all’illusione dei servi. Al contrario, è la disillusione, cioè «il riconoscimento, in sé doloroso, della verità» (p. 50), a giocare un ruolo cruciale. Gli individui adottano la strategia di adattamento in cui consiste la servitù volontaria proprio in quanto consapevoli del pericolo dell’esclusione sociale della precarietà: a tal proposito non si sbagliano. Sono particolarmente interessanti le pagine in cui Dagron definisce la servitù volontaria come una condotta di «auto-inclusione» in una relazione di sottomissione e la confronta con la strategia della «auto-esclusione» di cui rinviene il modello in Diogene (cfr. pp. 305 e ss.).
Dunque, secondo la prospettiva che propone Dagron, il fulcro del Discours de la servitude volontaire si trova sul piano clinico: un’opzione interpretativa particolare (per un approccio per alcuni aspetti simile: cfr. Renault 2016) e non certo l’unica possibile (cfr. Provini, Rees, Vintenon 2016). In Le soi subjugué, però, Dagron non si spende in alcuna discussione polemica con altre interpretazioni del Discours. In particolare, risalta il totale silenzio su Miguel Abensour, il principale artefice della riscoperta di La Boétie negli anni Settanta e uno dei massimi interpreti del pensiero laboetiano (cfr. Abensour 2011). Palese è la distanza tra loro: per Dagron, La Boétie non fornirebbe «alcuna teoria filosofica del potere politico» (p. 127), laddove per Abensour La Boétie non fonda niente di meno che una nuova teoria del dominio (cfr. Abensour 2018).
Un confronto tra le loro interpretazioni del Discours eccede certamente i limiti di una recensione. Tuttavia, questo permette di rilevare un merito importante de Le soi subjugué, su cui vale la pena concludere. Con questo volume, Dagron consolida e contribuisce a definire un certo approccio alla questione della servitù volontaria e, pertanto, Le soi subjugué diventa un valido termine rispetto a cui confrontare le altre forme assunte dalla riattualizzazione del Discours de la servitude volontaire.
Bibliografia
Abensour, M. (2011). Per una filosofia politica critica (a cura di Pezzella, M.), Jaca Book, Milano.
Abensour, M. (2018). La Boétie prophète de la liberté, Sens & Tonka, Paris.
Dejours, C. (2006). Aliénation et clinique du travail, in «Actuel Marx », 39, pp. 123-144.
Freud, S. (1921). Psicologia delle masse e analisi dell’io, Bollati Boringhieri, Torino, 1975.
Provini, S., Rees, A., Vintenon, A. (dir.) (2016). Cahiers La Boétie. La parole de La Boétie : approches philosophiques, rhétoriques et littéraires, Classique Garnier, Paris
Renault, E. (2008). Souffrances sociales. Sociologie, psychologie et politique, La Découverte, Paris.
Renault, E. (2016). Domination et pathologie sociale chez La Boétie, in Gerbier, L. (dir.). Cahiers La Boétie. Lectures politiques de La Boétie, Classique Garnier, Paris, pp. 137-151.
Roussillon, R. (1991). Paradoxes et situations limites de la psychanalyse, P.U.F., Paris.
Armando Arata
-
PK#21 \ settembre 2024
a cura di Carlo Deregibus e Aurosa Alison
Siamo abituati a guardare alle forme dell’architettura come portatrici di significati. Quello tra forma e significato era un nesso così ovvio, così connaturato alla costruzione e alla realtà sociale, da rimanere perlopiù implicito, premessa a qualsiasi discorso e trattato. Valeva nell’architettura classica come in quella medievale, in quella egizia come in quella barocca, in quella moderna come, persino, in quella propriamente detta postmoderna. Solo in tempi relativamente recenti, quando il postmodernismo fa vacillare non tanto quel legame, quanto la la sua univocità, il significato diventa un problema per l’architettura. Da un lato, perché la missione del Moderno, così assoluta da polarizzare qualsiasi dibattito, si rivela alla prova del tempo quantomeno aleatoria. Dall’altro, perché si avvertono i primi sentori di quel cambiamento, fatto di globalizzazione e moltiplicazione del pensiero che diverrà travolgente nel nuovo millennio. Nasce cioè l’idea che la forma sia parte di un sistema di comunicazione di significati, più che la latrice di un univoco messaggio.
In questo contesto usciva in Italia, ormai 50 anni fa, Il significato in architettura, curato da Charles Jencks e Georges Baird e pubblicato a Londra cinque anni prima. Raccoglieva una quindicina di testi tra loro spesso in contrasto, editati e commentati, che indagavano il significato da vari punti di vista: secondo approcci semiotici o fenomenologici, con accenti teoretici od operativi, con critiche o proposte, i testi tracciano una storia del significato possibile. Tanto che proprio il contrasto, a volte violento ed esplicitamente sobillato dai curatori, diventa il tratto più distintivo del volume: un contrasto reso possibile dalla convinzione, vana, che fosse ancora possibile definire il rapporto tra significato e forme.
Cosa resta, cinquant’anni dopo, di quel dibattito? Poco, in effetti. Lungi dall’essere sparito dai radar degli architetti, in questi decenni il significato si è moltiplicato in rivoli talmente frammentati da non permettere più una geografia culturale precisa. Nuovi significati - la globalizzazione appunto, ma anche i temi dell’antropocene, della gentrification, delle ecologie, della resilienza, dei gender studies, e così via - offrono infinite possibilità di teorizzazione, sempre legate a pratiche tra loro distinte, separate e che non comunicano. Ma che si considerano tutte Architettura. È uno sfilacciamento riflesso anche dalle teorie sull’arte e dalla crescente distanza tra arte e mercato, tra significato e esperienza, tra percezione e comprensione. Eppure, continuiamo a progettare, a produrre e a criticare l’Architettura, continuamente attribuendo alle sue forme significati, e rivestendola di intenzioni e speranze.
Così, questo numero di PK esplora, una volta di più, questa sfuggente ma insieme ineludibile relazione tra significato e architettura. Lo fa secondo tre assunti metodologici. Il primo è che, lungi dall’essere scomparso, il significato oggi ecceda, e largamente, la forma, e dunque sia sempre e di nuovo possibile riscoprire e riprogettare la loro relazione: certo quel legame muta a velocità variabili, secondo sistemi diversi la cui reciproca irritazione produce cambiamenti spesso imprevedibili, ma tuttavia esiste. Il secondo è che le dimensioni teoretica e pratica dell’architettura non siano pensabili separatamente, se non come coppia oppositiva derridiana: il progetto dell’architettura deve essere sempre inteso nella sua dimensione performativa e secondo gli effetti che questo produce, e la distinzione tra progetto e progetto di architettura è ad essi strettamente quanto problematicamente legata. Il terzo è la dimensione sistemica dell’architettura, che deve essere intesa nelle sue condizioni socio-tecnico-economiche: questo vale sempre, storicamente, e oggi implica una relazione costitutiva con un pervasivo sistema neoliberale, un confronto con una dimensione produttiva che cancella le tensioni artigianali, e la modifica delle modalità di produzione del progetto che, circolarmente, ne stravolgono concezione e quindi significato. Le connessioni tra i tre assunti - ad esempio nella tensione tra agire individuale e dimensione sistemica, da cui emerge una valenza tattica e strategica del progetto - sono altrettanto decisive.
Le proposte possono affrontare il tema del significato in architettura da una prospettiva ontologica ed epistemologica, anche con una prospettiva storico-critica, oppure rientrare in uno dei quattro nuclei tematici qui enucleati, anche esplorandone connessioni e interrelazioni e trattandoli da diversi punti di vista - storico, teoretico, critico:
- Nuove forme del significato. I luoghi sono sempre stati collettori del senso di comunità, sia in senso simbolico sia in senso esperienziale. Come coordinare il continuo moltiplicarsi di forme di socializzazione reale e digitale (dal metaversale alla visual turn) con l'aspetto ontologico e reale della progettazione? Sulla scorta della retorica di una democratizzazione dei processi comunicativi, sociali e relazionali, è davvero possibile innestare un significato nello spazio pubblico, o questi progetti non fanno altro che illudere i partecipanti di farlo? È il processo, o il programma, a dare un significato a un’architettura in cui le forme non hanno rilevanza alcuna se non come trasposizione tecnica o, al contrario, l’architettura va considerata e trattata come un palinsesto che vive persino indifferentemente dagli usi, diventandone uno sfondo neutrale? Nel mezzo, un’infinita sfumatura di pratiche e approcci.
- Nuovi significati delle forme. Vorremmo riflettere su quei significati che più sembrano trasversali e sostanziali nell’impattare l’architettura. Il primo è ascrivibile al tema della sostenibilità: ad esempio, come superare pratiche estetizzanti e approcci puramente prestazionali e sviluppare una dimensione autenticamente ecologica del progettare? È un tema di norme, di cultura, di azioni, di tecniche, di approcci, di forme, di strategie, o ancora di altro tipo? Il secondo è il cosiddetto design for all, che raccoglie questioni pratiche - come l’accessibilità - e culturali - come l’urbanistica di genere - e che però, curiosamente, si sostanzia in limitazioni burocratiche variamente normate: quasi che il progetto non definisse, ontologicamente, i limiti di qualche libertà. Come superare questa visione, aggrappata a una logica di tutela dei gruppi di minoranza, per sviluppare il tema della libertà nel progetto e nelle forme?
- Resilienza dei significati. C’è Architettura e architettura. Gran parte dei progettisti nel mondo non si occupano di quelle rare opere “straordinarie” (auditorium, chiese, musei), cioè i tradizionali portatori di significati condivisi: bensì di ordinarie, comuni, quotidiane costruzioni. Non parliamo dell’ordinario sperimentale e d’élite esplorato dagli architetti di punta, ma proprio della pratica comune, di quel significato che nasce e si sostanzia in una continua variazione e ripetizione, nel real estate come negli slum. Spogliata dalle stratificazione semantiche dell’Architettura, resta cioè un’architettura: lontana dalle accademie e dalle pagine patinate, ma che traccia il nostro mondo. A livello ontologico e pratico, il progetto di questa architettura è diverso da quello di Architettura? E in che modo si evolve, ad esempio guardando all’ascesa impressionante dei software basati sull’Intelligenza Artificiale?
- Resilienza delle forme. Il costruito ha una immensa capacità resiliente. Certo, non sempre questa va d’accordo con gli usi, e i significati di quelle forme. Il caso italiano è emblematico, tra tensioni verso la rigenerazione e l’esigenza di tutela e conservazione del patrimonio. Casi come Palazzo dei Diamanti a Ferrara o lo stadio Meazza a Miano sono solo le evidenze mediatiche di un problema diffuso e in inevitabile crescita: lo scontro tra valori e significati diversi, che si sovrappongono nelle forme. La risposta è nella qualità del progetto? Oppure in quella del processo? È un problema di procedure e soggetti decisori, oppure di proposte e gestione? In che modo significati sempre più essenziali e inconciliabili - ad esempio la fruizione dei beni storici, la sicurezza in caso di sisma, il risparmio energetico, il costo degli interventi, vincoli antincendio, di accessibilità e così via - si intersecano nelle forme?
È nostra intenzione, in omaggio al tratto più distintivo de Il significato in architettura, promuovere una circolazione dei contributi tra gli autori prima della pubblicazione, in modo da raccogliere commenti specifici da parte di tutti gli autori e offrire una possibilità di controreplica ai commenti da parte degli autori stessi. Un dibattito interno al volume, unico quanto prezioso.
Bibliografia:
Ando, T., (1990), Complete Works, Taschen
Armando, A. & Durbiano, G. (2017). Teoria del progetto architettonico. Dai disegni agli effetti. Roma: Carocci.
Aureli P.V. (2008). The Project of Autonomy: Politics and Architecture Within and Against Capitalism. Hudson: Princeton Architectural Press.
Berlin, I. (1969). Four Essays on Liberty. Oxford: Oxford University Press
Booth C., Darke J. & Yeandle S. (edi) Changing Places: Women’s Lives in the City. London: Paul Chapman Publishing Ltd.
Boudon, R. (1984). La place du désordre. Critique des théories du changement sociale. Paris: Presses Universitaires de France.
Chia, R. & Holt, R. (2011). Strategy without Design: The Silent Efficacy of Indirect Action, Cambridge: Cambridge University Press.
Deregibus, C. (2016). Intention and Responsibility. Milano: IPOC.
Derrida, J. (2008). Adesso l’architettura. Milano: Scheiwiller, 2008.
Haraway, D. (1985). Manifesto for cyborgs: science, technology, and socialist feminism in the 1980s. Socialist Review, no. 80, 65-108.
Holl, S., Pallasmaa, J. & Perez-Gomez (2007). A. Questions of Perception: Phenomenology of Architecture. San Francisco: William K Stout Pub.
Jencks, C. & Baird, G. (ed) (1974). Il significato in architettura. Bari: Dedalo.
Jullien, F. (2004). A Treatise on Efficacy. Between Western and Chinese Thinking. Honolulu: University of Hawai Press.
Koolhaas, R. (1978). Delirious New York. A Retrospective Manifesto for Manhattan. New York: Oxford University Press.
Luhmann, N (2012). Introduction to Systems Theory. Cambridge: Polity Press.
Moneo, R. (1989). “The Solitude of Buildings”, A+U: architecture and urbanism, 227.
Norberg-Schulz, C. (1967). Intentions in Architecture. Cambridge & London: The MIT Press.
Norberg-Schulz, C. (1975). Meaning in Western Architecture. New York: Praeger Publisher.
Norberg-Schulz, C. (1979), Genius Loci. Paesaggio, Ambiente, Architettura. Milano: Electa.
Paci, E. (1961). Tempo e verità nella fenomenologia di Husserl. Roma-Bari: Laterza.
Paci, E. (1965). Relazioni e significati. Milano: Lampugnani Nigri.
Pallasmaa, J. (1996). The Eyes of the Skin. Architecture and the Senses. New York: John Wiley & Sons.
Pareyson, L. (1954). Estetica. Teoria della formatività. Torino: Edizioni di Filosofia.
Ponti, G. (1957). Amate l’architettura. Genova: Società Editrice Vitali e Ghianda (Quodlibet, 2022).
Preciado, P. B. (2020). Un appartamento su Urano. Cronache del transito. Roma: Fandango libri.
Preciado, P. B. (2022). Dysphoria Mundi, Paris: Grasset.
Rogers, E. N. (1958). Esperienza dell’architettura. Torino: Einaudi (Skira, 2002).
Rogers, E. N. (1961). Gli elementi del fenomeno architettonico. Roma-Bari: Laterza (Marinotti, 2006).
Rowe, C. (1994). The Architecture of Good Intentions. Towards a Possible Retrospect. London: Academy.
Vitali, W. (Ed.). Un'Agenda per le città. Nuove visioni per lo sviluppo urbano. Bologna: Il Mulino.
Ward, C. (1973). Anarchy in Action. London: Freedom Press.
Windhoff-Héritier, A. (1992). City of the Poor, City of the Rich: Politics and Policy in New York City. Berlin: de Gruyter.
Procedura:
Per partecipare alla call, inviare all'indirizzo redazione@philosophykitchen.com, entro il 16 luglio 2023, un abstract di massimo 4.000 caratteri, indicando il titolo della proposta, illustrando la strutturazione del contributo e i suoi contributi significativi, e inserendo una bibliografia nonché una breve biografia dell’autore o dell’autrice.
L'abstract dovrà essere redatto secondo i criteri scaricabili qui [Template Abstract], pena esclusione.
Le proposte verranno valutate dai curatori e dalla redazione. I contributi selezionati, che saranno sottoposti a double-blind peer review.
Lingue accettate: italiano, inglese, francese.
Calendario:
- 16 luglio 2023: consegna degli abstract
- 03 settembre 2023: comunicazione degli esiti
- 17 dicembre 2023: consegna dei contributi selezionati
- 03 luglio 2023: comunicazione degli esiti della selezione
- Primavera 2024: circolazione dei pezzi tra gli autori
- Settembre 2024: pubblicazione del volume
-
Filosofe di età moderna tra corpo e mente
Recensioni / Aprile 2023Nei libri di storia della filosofia è raro incontrare donne, con qualche sporadica eccezione confinata al Novecento (Hannah Arendt è forse l’esempio più emblematico); ciò non significa che non siano esistite filosofe nel corso della storia, ma piuttosto che esse non hanno trovato spazio nel canone storico-filosofico occidentale. Il pregiudizio secondo cui la filosofia non sarebbe fatta né per le donne né dalle donne trova un’efficace smentita nel volume Corpo Mente. Il dualismo e le filosofe di età moderna (enciclopediadelledonne.it 2022), che attraverso un’interessante rassegna di autrici e testi ha il merito di mettere in luce il contributo delle donne alla storia della filosofia in un periodo in cui tradizionalmente trovano spazio soltanto filosofi. Le quasi quattrocento pagine di quest’antologia, arricchita da puntuali presentazioni delle autrici e delle opere considerate, rappresentano un tassello importante di quel «lavoro di riscrittura della storia della filosofia sulla base di un canone più inclusivo rispetto a quello che ha prodotto le narrazioni tradizionali» (p. 11), iniziato alcuni decenni fa.
La scelta dei curatori è ricaduta su quattordici autrici vissute nel periodo compreso tra il XV e il XVIII secolo, di diversa provenienza, oltre che su un autore – François Poullain de la Barre – degno di attenzione in qualità di singolare precursore del femminismo. Molte di queste scrittrici sono oggi sostanzialmente dimenticate; eppure, i testi qui selezionati testimoniano una consapevole partecipazione ai dibattiti filosofici del tempo. Se la consueta esclusione delle donne dal canone storico-filosofico affonda senz’altro le sue radici in una questione culturale, per cui «alle donne per molti secoli è stato precluso l’accesso all’ampio strumentario di cui disponevano gli uomini, che avrebbe consentito loro di coltivare e affinare le doti intellettuali» (p. 13), tale innegabile svantaggio di partenza non ha impedito ad alcune di loro di sviluppare un proprio pensiero filosofico e di confrontarsi con i filosofi più autorevoli, come dimostrano le loro prese di posizione sul rapporto mente-corpo, cruciale nella filosofia di età moderna.
La prima parte del volume (Da Christine de Pizan a Camilla Erculiani), a cura di Sandra Plastina, si apre con Christine de Pizan, pioniera della scrittura femminile come professione, dell’irrompere del soggetto sulla scena letteraria e del protofemminismo francese. Nata a Venezia intorno al 1365 e trapiantata ben presto in Francia (dove il padre, medico e astrologo, era al servizio del re Carlo V), Christine de Pizan ha consacrato buona parte della sua ampia produzione letteraria, in prosa e in versi, alla questione dell’educazione femminile, interrogandosi anche sulle ragioni dell’esclusione delle donne dal campo della letteratura. Celebre per aver preso fermamente posizione nell’acceso dibattito sul Roman de la Rose, sfociato nella querelle des femmes che avrebbe continuato a infiammare gli animi per secoli, tra il 1404 e il 1405 scrisse il Livre de la cité des dames, incentrato sulla convinzione che nessun ambito dell’attività umana è per natura precluso alle donne.
L’opera è degna di attenzione per molte ragioni; in particolare, merita di essere sottolineato – sulla scia della curatrice – l’abbandono dell’espressione di ascendenza scolastica «nature de femme» a favore di «conditions de femme somme toute» («somma totale delle condizioni femminili», p. 26), che riconduce l’identità femminile all’esperienza e alla storia, lungi da ogni essenzialismo. Aiutata da Dama Ragione, la protagonista della Cité des dames prende coscienza dell’infondatezza dei giudizi di biasimo nei confronti delle donne che gli uomini disseminano copiosamente nei loro libri. Tali giudizi sono definiti contro ragione e contro natura; inoltre, Christine de Pizan non esita a fare appello alle Sacre Scritture per sostenere l’uguaglianza tra uomo e donna: «Dio fece addormentare Adamo e creò il corpo della donna da una delle sue costole, nel senso che gli doveva essere al fianco come compagna e non ai suoi piedi, come una serva, e che egli la doveva amare come la sua stessa carne» (p. 40).
I rapporti sociali generalmente conflittuali tra uomini e donne, con le loro inevitabili implicazioni sulla ricerca della propria identità da parte di queste ultime, sono centrali nell’opera dell’autrice patavina Giulia Bigolina (c. 1518 – c. 1569). Scritto intorno al 1556-1558, in prosa, Urania, nella quale si contiene l’amore d’una giovine di tal nome è «il primo romanzo scritto da una donna nella storia della letteratura italiana» (p. 45), ma è rimasto inedito fino ad anni recenti: una prima edizione, presto seguita da due traduzioni inglesi, è stata curata da Valeria Finucci nel 2002. Ben inserita nell’ambiente culturale del tempo, Giulia Bigolina mostra nel suo romanzo una notevole profondità psicologica e filosofica, nonché un’indubbia familiarità con la filosofia neoplatonica. Al di là dell’attenzione al tema amoroso, strettamente intrecciato a quello della bellezza dell’anima e del corpo, ampio spazio trova la riflessione sul posto delle donne nella cultura italiana rinascimentale, sulla necessità della loro educazione e sulle molte difficoltà che incontrano quando decidono di consacrarsi alla scrittura.
Un più spiccato interesse per questioni squisitamente filosofiche – e per il rapporto tra mente e corpo – si manifesta nell’opera di Luisa Oliva Sabuco de Nantes Barrera (1562 – c. 1622), autrice della Nueva filosofia della naturaleza de l’hombre (1587) in sette trattati. Mettendo abilmente a frutto gli studi di medicina, botanica e scienze naturali svolti con il padre, Sabuco ha elaborato una riflessione originale dal punto di vista sia della filosofia naturale sia della storia della medicina, senza esitare a prendere apertamente le distanze dal galenismo e dalla medicina a lei contemporanea, di cui critica l’inefficacia. Ai suoi occhi, l’essere umano è un’unica entità psico-fisica e l’alterazione della relazione armoniosa tra il corpo e la psiche – spesso frutto delle passioni – è causa della malattia, della follia e, nei casi più estremi, della morte. L’interpretazione della malattia in chiave psicosomatica – così come la proposta di servirsi della musica come terapia – sono particolarmente innovative. D’altronde l’autrice, nella lettera dedicatoria a Filippo II, non esitò a rivendicare con orgoglio il valore della propria opera, presentandola come necessaria perché «migliora il mondo in molti modi» (p. 98).
Lungi dall’assumere così apertamente la propria autorialità, molte scrittrici nel corso dei secoli hanno cercato di tenersi al riparo dall’esposizione pubblica ricorrendo all’anonimato o a uno pseudonimo. È questo il caso di Modesta Pozzo, vissuta a Venezia tra il 1555 e il 1592 e nota come Moderata Fonte, «una spiritosa trascrizione letteraria, nonché versione eufonica, del vero nome dell’autrice, che faceva pensare a un “modesto pozzo”» (p. 119). Autrice di diverse opere e ben inserita negli ambienti culturali veneziani, Moderata Fonte è oggi ricordata soprattutto per il dialogo Il merito delle donne, pubblicato postumo nel 1600, nel contesto della polemica suscitata dall’opera di Giuseppe Passi I donneschi diffetti. Nel dialogo, prima presa di posizione sulla questione femminile da parte di una donna nell’Italia di fine Cinquecento, l’autrice si avvale di argomentazioni paradossali per confutare la tesi della maggior eccellenza dell’uomo, insistendo sul ruolo fondamentale dell’educazione ai fini dell’emancipazione femminile.
Già da questi primi esempi emergono con forza alcune costanti: la difficoltà per le donne di prendere pubblicamente la parola, l’inadeguatezza della loro educazione, il tentativo di rivendicare la propria parità (talvolta anche la propria superiorità) rispetto agli uomini. Sulla sponda orientale dell’Adriatico, precisamente a Ragusa (odierna Dubrovnik) a farsene portavoce è Marija Ivan Gundulić, o Maria Ivan Gondola. Nella sua sola opera superstite, la lettera di dedica ai Discorsi (1584) scritti dal marito Nicolò Vito di Gozze, ella prese le difese della poetessa Cvijeta Zuzorić e, più in generale, delle donne e delle loro capacità intellettuali, attraverso un curioso rovesciamento del paradigma aristotelico. A suo avviso, infatti, proprio per la mollezza del loro temperamento (a cui solitamente si attribuiva la loro subalternità intellettuale), le donne avrebbero una maggior predisposizione a occuparsi di questioni filosofiche e scientifiche.
La stessa fiducia nelle doti intellettuali femminili si ritrova in Camilla Gregetta Erculiani, «l’unica donna italiana nel XVI secolo a pubblicare un libro di filosofia naturale» (p. 165). Questa speziale padovana, nelle Lettere di Philosophia naturale (1584), dichiarava espressamente di voler «far conoscere al mondo, che noi siamo atte a tutte le scientie, come gli huomini» (p. 166). Lei stessa scrisse di filosofia naturale in volgare, elaborando un’originale teoria sul diluvio universale (attribuito a cause naturali) e ipotizzando la possibilità della generazione spontanea degli uomini in seguito a catastrofi naturali. Sospettata di eresia e interrogata dall’Inquisizione, si difese sostenendo la piena legittimità della sua riflessione, che non riguardava il piano teologico, bensì si limitava a quello puramente filosofico.

Meister der 'Cité des Dames' (Wikimedia) L’attiva partecipazione delle donne al dibattito filosofico del loro tempo, anche attraverso il dialogo epistolare con i suoi principali esponenti, emerge ancora più nettamente nella seconda parte del volume (Da Lucrezia Marinella a Catharine Cockburn), a cura di Emilio Maria de Tommaso. In particolare, si rivela cruciale il sostegno di familiari di sesso maschile (si tratti del padre, di un fratello o del marito) per colmare lo svantaggio educativo legato alla condizione femminile e avere l’opportunità di assecondare le proprie aspirazioni. Proprio grazie a un ambiente familiare intellettualmente vivace, Lucrezia Marinella (1571 – 1653) poté dedicarsi alla scrittura e farsi apprezzare nella Venezia del tempo. Ella fu tra coloro che reagirono ai Donneschi diffetti di Passi, dimostrando, nel suo saggio Le nobiltà et eccellenze delle donne (1600), l’erroneità delle conclusioni dell’avversario fino a sostenere la superiorità ontologica, fisiologica e morale della donna, in cui ravvisa l’immagine più nobile della divinità. A tal fine riprende – come già Christine de Pizan – il racconto della Genesi, sulla base del quale «suggerisce che l’uomo sia funzionale alla generazione del corpo femminile, nella misura in cui fornisce la degna materia della produzione della donna» (p. 189).
Marie Le Jars de Gournay (1565 – 1645), nota per il suo stretto legame con Michel de Montaigne, che la considerava la propria figlia spirituale, riprese nei suoi scritti Egalité des hommes et des femmes e Grief des dames le tematiche tipiche della querelle des femmes, esprimendo la convinzione che la disuguaglianza tra uomini e donne non sia biologica ma culturale; «la sua idea filosoficamente più forte, che opera in filigrana negli scritti egualitari, è la neutralità della mente, ossia la sua mancanza di connotazione di genere» (p. 211). L’idea che la mente non abbia sesso è centrale anche nella riflessione di François Poullain (o Poulain) de la Barre (1647 – 1723), filosofo di impostazione cartesiana che in ben tre opere (De l’éducation des dames, De l’égalité des deux sexes, De l’excellence des hommes) denunciò con fermezza l’assurdità dei diffusi pregiudizi nei confronti delle donne. Proprio una donna, Elisabetta di Boemia, discusse alcuni degli aspetti più controversi della filosofia cartesiana – in particolare l’annosa questione dell’interazione tra anima e corpo – in un avvincente carteggio con il suo autore, inducendolo a precisare meglio la propria posizione nel saggio Le passioni dell’anima.
In ambito anglosassone, Anne Finch Conway (1631 – 1679) fu aiutata a coltivare le proprie ambizioni intellettuali prima dal fratello, poi dal marito. Fu allieva – inizialmente per via epistolare – di Henry More, esponente di spicco del platonismo di Cambridge, da cui prese tuttavia le distanze in merito al rapporto tra corpo e spirito. Fautrice di una tripartizione ontologica (Dio, Cristo, le creature, distinti perché diversamente esposti al cambiamento), elabora una nozione di corpo piuttosto originale, sia rispetto al maestro sia rispetto all’ontologia cartesiana, di cui rifiuta il dualismo. Il medico Franciscus Mercurius von Helmont, che la introdusse al cabalismo e al quaccherismo, alla sua morte fece stampare i Principia philosophiae antiquissimae et recentissimae de Deo, Christo et Creatura id est de materia et spiritu in genere (1690), redatti sulla base di un taccuino su cui Lady Conway aveva annotato a matita le proprie riflessioni filosofiche.
La familiarità con l’ambiente del platonismo di Cambridge, a cui il padre Ralph Cudworth apparteneva, si ritrova in Damaris Cudworth Masham (1659 – 1708). Ella intrattenne intensi scambi intellettuali con John Norris, ma anche con Leibniz (di cui criticò il sistema dell’armonia prestabilita) e Locke, con cui condivise una lunga e solida amicizia. Proprio a Locke alcuni attribuirono erroneamente la sua prima opera, pubblicata anonima nel 1696 e intitolata Discourse Concerning the Love of God. Nella sua seconda opera filosofica, Occasional Thoughts in Reference to a Vertuous or Christian Life (1705), Lady Masham prese posizione sulla condizione femminile, attribuendo alle donne un ruolo centrale in ambito educativo e mettendo in luce l’assurdità di non istruirle adeguatamente. La filosofia di Locke influenzò significativamente anche Mary Astell (1666 – 1731), considerata la prima femminista inglese. Non si tratta tuttavia di un’accettazione acritica, come dimostra The Christian Religion, as Profess’d by a Daughter of the Church of England (1705), in cui l’ipotesi lockiana della materia pensante è messa in discussione. Una sintesi dei fondamenti dell’epistemologia lockiana e di alcuni elementi del platonismo di Cambridge trova spazio, infine, nell’opera di Catharine Trotter Cockburn (1679 – 1749), che pubblicò vari scritti in forma anonima, tra cui Remarks upon the Principles and Reasonings of Dr. Rutherforth’s Essays on the Nature and Obligations of Virtue (1747).
La ricca panoramica di testi e autrici di cui si è cercato di dare un’idea in queste pagine (che vorrebbero essere soprattutto un invito a una più approfondita esplorazione) dimostra efficacemente che anche le donne si sono occupate di filosofia, malgrado circostanze poco favorevoli al loro fiorire intellettuale e contrariamente a quanto si tende a pensare sulla base della lettura dei manuali canonici di storia della filosofia. Il contributo delle donne alla storia delle idee europea merita perciò di essere riscoperto e rivalutato; in questa prospettiva, come ha sottolineato Nuria Sanchez nella sua Postfazione, il presente volume rappresenta una «pubblicazione di grandissima utilità per avvicinare studenti e studentesse a opere di donne intellettuali quasi sconosciute nei programmi didattici abituali» (p. 376). Ciò vale anche per un pubblico più ampio: Sandra Plastina ed Emilio Maria de Tommaso, curando questo libro nell’ambito del pregevole progetto enciclopediadelledonne.it, hanno reso accessibili a qualsiasi lettore interessato – non soltanto, dunque, a studenti o specialisti – testi a lungo trascurati. Disseppellirli dall’oblio a cui sono stati ingiustamente condannati, permettendo loro di essere conosciuti e apprezzati, sembra il modo migliore per iniziare a restituire alle donne quel posto nella storia della filosofia che per secoli è stato loro negato.
di Debora Sicco
-
La scrittura sensibile. Proust e Merleau-Ponty
Recensioni / Febbraio 2023Nel film Magnifica presenza (Fandango, Faros Film) del regista turco Ferzan Özpetek, il giovane Pietro (Elio Giordano), vive un’esperienza singolare. Egli si accorge infatti, col tempo, di soggiornare in un appartamento infestato da fantasmi. Le misteriose entità, dapprima sfuggenti e timorose, trovano in Pietro un confidente, una figura amica, un tenero protettore. Lo stesso Pietro, che tra gli spiriti incontra Luca, vede in quest’uomo l’espressione più genuina ed autentica del sentimento amoroso, il candore delle prime volte. Sia Pietro che i membri della ‘compagnia Apollonio’ scoprono così un altro modo di vivere, di abitare il tempo, insieme, un tempo ‘ritrovato’, ben distante dalla mera cronologia, dal riepilogo del record quotidiano. I fantasmi che popolano la casa di Pietro non sono infatti ‘invenzioni’, per dirla con Bioy Casares. Non sono nemmeno il frutto di proiezioni sinistre, di spaventose allucinazioni. Lo svolgimento del film mostra che anche Pietro, come i suoi coinquilini, deve perdersi per poi ritrovarsi, per rivedersi, in senso autentico. Rivedere opinioni, correggere i propri giudizi su cose e persone: anche Pietro è un fantasma. Proprio di questa rettifica, di questa rilettura consta l’essenza più segreta della Ricerca.
Di Proust filosofo e della sua relazione con la fenomenologia merleau-pontyana si è scritto molto, nel corso negli anni passati. All’interno del vasto panorama offerto da questi studi, la recente pubblicazione del testo di Franck Robert va ad occupare una posizione di sicuro rilievo, e questo per più di una ragione. In primissimo luogo a colpire è l’ampiezza e la profondità, fisica e tematica, del volume in questione: composto da tredici capitoli (Proust philosophe; Percevoir, le rapport sensible au monde; De l’art; Modernité de Proust; Littérature et réalité; L’homme et l’œuvre; Art et vie; Le style; Vérité et institution; Approche phénoménologique. Temps et subjectivité; Le temps sensible; Écriture et vérité ed Ouvertures)che si dispongono su oltre quattrocentocinquanta pagine di testo, il lavoro di Robert rappresenta, a mia personale conoscenza, lo studio ad oggi più completo dedicato specificamente al confronto tra l’opera di Proust ed il pensiero di Merleau-Ponty, quest’ultimo da sempre affascinato, per confessione del filosofo stesso, dalla prosa dello scrittore e dalla sua ricchissima eredità concettuale. Un ulteriore e pregevole aspetto formale che mi preme rimarcare, in apertura, è la presenza constante, nell’argomentazione di Robert, di richiami teorici e testuali al corso merleau-pontyano Le problème de la parole, tenutosi al Collège de France tra gli anni 1953 e 1954, recentissimamente edito in lingua francese (Métis Presses, 2020, di questo testo mi permetto di segnalare una mia recensione pubblicata in «Studi di Estetica. Italian Journal of Aesthetics», vol. 19, 2021, pp. 237-242). Questa peculiarità, questa scelta speculativa, rappresenta senza dubbio un elemento meritorio e di originalità del già di per sé ricco lavoro di Robert.
La tesi fondamentale del libro è l’affermazione della centralità del ruolo della scrittura al cuore dell’esperienza sensibile. La scrittura non è slegata dalla pratica percettiva, anzi: ne è elemento costitutivo, compimento essenziale, sublimazione. Grazie alla scrittura l’uomo può ritrovare il senso autentico del tempo e dello spazio: tornando sui suoi passi, ripercorrendo a ritroso il cammino della conoscenza, ritrovandosi. Si tratta di un’opinione sostenuta sia da Proust che da Merleau-Ponty, sebbene sia stata comprovata in campi e discipline affatto diverse. Sia lo scrittore che il filosofo, però, hanno fatto della scrittura una vocazione, un mestiere, un modo di vivere ed interpretare il mondo e la propria epoca. Per entrambi la scrittura si spinge, si inoltra dove la percezione sensibile, la nostra prima e fondamentale porta d’accesso al mondo percepito, non può arrivare. Ma perché quest’insufficienza? Cosa serve a giustificare la sua comparsa della ‘grafia’, il suo richiamo, la sua fantasmagoria? Quale logica comanda la dimenticanza, e quale ancoraggio impone, in senso contrario, il percorso, la rotta del ricordo? Robert tenta di rispondere in questo testo a tali domande.
La scrittura, lungi dall’essere banale, sterile, ripetizione del senso, ne sancisce invece la ‘raccolta’, la ‘fissazione’, l’istituzione che non è, però, da intendersi quale esercizio di una qualsivoglia facoltà intellettuale, superiore, di ‘sorvolo’. La scrittura, dice Robert, «apre su di un’universalità che non presuppone, ma che, viceversa, inaugura» (p. 16). Tale affermazione prescrive la primarietà dell’espressione sull’espresso, della comunicazione sul contenuto della comunicazione stessa, facendo allusione ad un’universalità che non può – più – essere quella del concetto (p. 433). La parola non deve essere compresa come «esercizio del concetto, ma rivolta verso l’intersezione dei mezzi espressivi di una pienezza che essi delimitano [qu’ils jalonnent] ma che non contengono», recita Il problema della parola (p. 420; Merleau-Ponty 2020, 143).

Henri Michaux - Untitled (1959) (Flickr: Pedro Ribeiro Simões) Per mezzo dell’espediente letterario proustiano, «la verità che si rivela al narratore nelle reminiscenze della sensazione e nella scrittura – dice Robert – non è un accesso ritrovato a un mondo di idee che l'esperienza sensibile avrebbe coperto, poiché le arti che aprono la strada a questa verità, che abbozzano ciò che la letteratura realizzerà in altro modo, attraverso la scrittura, sono proprio le arti meno concettuali, più vicine al sensibile» (ibid.). Non è la filosofia che conduce alla filosofia, dice Robert, il sapere non si nutre di sapere, autenticamente, in modo univoco, ma è la ‘non-filosofia’, l’esperienza concreta, vissuta, ad indicare la via per il suo superamento non concettuale, laterale. L’intera opera di Proust, sostiene Robert facendo parlare le pagine Merleau-Ponty, può essere intesa allora come un tentativo di rovesciamento del platonismo, dell’idealismo cartesiano e delle sue derive teoreticamente più pericolose. Citando nuovamente Il problema della parola, in questo caso, «l’idea non precede l’espressione, ma è l’espressione ad essere responsabile dell’avvento dell’idea» (p. 108; Merleau-Ponty 2020, 160).
L’ambizioso compito della scrittura, e con essa del linguaggio letterario, è quello di restituire «la modalità di apparizione del mondo sensibile» (p. 221). E proprio «restituendo questo mondo vissuto, pre-nozionale, è possibile effettuare il passaggio all’idea: ovvero, è possibile costruire un ‘equivalente spirituale’ dell’esistenza» (Merleau-Ponty 2020, 178-179). Dunque, ‘spirituale’ ed ‘ intellettuale’ non sono termini coincidenti. Soprattutto, scrive Merleau-Ponty, «le essenze vere – e non quelle intellettuali – si trovano esclusivamente attraverso il chiaroscuro del vissuto, che noi provvediamo a costruire attraverso la nostra vita» (ibid.). La ‘modernità’ proustiana, la sua ‘ricerca’e la sua successiva realizzazione, sta, per Merleau-Ponty, nella sua capacità di rompere con la complicità idealistica con la conoscenza di ‘sorvolo’, la quale «sostituirebbe alle cose allo stato nascente l’idea delle cose», approdando alla dimensione più propria di ricerca dell’«idea sensibile» (p. 419). Quest’indagine si alimenta della proliferazione di «significati nascenti» (p. 435), designati dal criterio della «denominazione» (Merleau-Ponty 2020, pp. 153, 181-182; cfr. Merleau-Ponty 1996, pp. 106-108) e del suo eventuale capovolgimento ‘algoritmico’, – del quale il pittore Elstir è daimon proustiano né A l’ombre des jeunes filles en fleurs, così come, a ben vedere, lo è della reversibilità carnale merleau-pontyana – ovvero di quella logica del rinvio che, nella letteratura latu sensu, consentirebbe alla verità di raggiungere quell’universalità dettata da una progressiva ed inesauribile crescita «laterale» (Merleau-Ponty 2013), contributiva ed intersoggettiva.
Di questo consta la sintesi, passiva, delle ‘cose’ che la prosa di Proust sarebbe in grado di raccogliere, di riunire: la sintesi «risiede – allora – nel modo in cui il corpo riceve il mondo, nella capacità di tracciarvi delle linee che costituiscono un senso, degli assi che il soggetto segue, e che accompagna nel suo modo di abitare il mondo» (p. 435). Menzionando indirettamente il lavoro di Jacques Garelli, la ‘ricerca’ si occupa della raccolta del «logos del mondo estetico (…) delle idee prime che sono sensibili perché, all’interno del sensibile stesso, ne tracciano il senso pur senza apparirvi esteriormente» (ibid.).
Già, ma perché – come anticipato – si continua a parlare insistentemente, nelle pagine di Robert, di raccolta, di recupero del senso? Cosa è andato perduto nella delicata transizione tra percezione ed espressione, seguendo questa volta l’itinerario storico e teorico dell’opera merleau-pontyana? Cosa è andato ‘storto’? La replica a queste domande, sebbene ponderata e testualmente fondata, non può che risultare ambigua. A pagina 255, Robert sostiene che « [m]entre nell'opera di Proust la scrittura ha origine nella perdita, è una ricerca di un significato sepolto nell'esperienza del narratore, una raccolta e uno svelamento del passato, una ricerca di un senso della vita perduta, una vita superiore a qualsiasi vita vissuta, nell'opera di Stendhal la scrittura è identica alla vita stessa, un progetto di esistenza sempre già superato da questa stessa esistenza, un eccesso, un'apertura su un futuro che si inventa mentre si realizza, un'avventura». È una prima risposta, di primo acchito soddisfacente: vi sono molti modi di vivere, di interpretare, e quindi di scrivere il mondo circostante.
Ciò che, a mio parere, Merleau-Ponty individua ed apprezza nell’opera proustiana, ed è un aspetto che Robert coglie appieno, è il ruolo positivo della dimenticanza, dell’oblio, della capacità di allontanarsi dal mondo senza perderlo mai dal personale ‘orizzonte ermeneutico’, direbbe Collot, senza perderlo mai del tutto di vista. Per Proust ogni opera, ogni sforzo, mira ad «accogliere e a raccogliere l’esperienza», attraverso una «conquista differita e sospesa del senso dei fenomeni», la quale si attua per mezzo del «ritorno incessante al concreto, al sensibile» (p. 36). Secondo Proust, e a parere di Merleau-Ponty, l’esperienza, l’erranza avventurosa e, segnatamente, l’errore, la maldestrezza, è necessaria al fine di raggiungere la verità (p. 39). Questo punto è cruciale: il narratore non sarebbe tale senza la distanza, senza la contrarietà, senza la trascendenza che lo allontana da persone e cose, come l’istituzione del sentimento amoroso e la gelosia provata per Albertine nel corso su Istituzione e passività attestano con chiarezza. È come dire che sbagliando si impara o che il viaggio conta almeno quanto la destinazione, il che è condivisibile, detto anche in modo triviale.

Maurice Merleau-Ponty (Wikimedia)La posta in gioco è altissima. Non si tratta più solo, a ben vedere, di riconoscere il proprio favore ad un modo di raccontare le cose, ad un determinato tipo di restituzione degli eventi: ciò che si ridiscute, in queste pagine, è nientemeno che lo statuto dell’idealità, della razionalità, dell’epistemologia platonico-aristotelica che tradizionalmente sostiene l’architettura del pensiero occidentale.
Cercando di riassumere, queste sono le domande che ci si pongono, nuovamente: che tipo di relazione c'è tra l'eternità e la temporalità? La temporalità è un fatto primitivo o derivato? Può qualcosa essere ‘eterno’ e ‘temporale’ allo stesso tempo? Può qualcosa di originariamente ‘temporale’ assurgere al rango di essere ‘eterno’? Intuitivamente, ciò che è temporale può durare ‘per sempre’. Ciò che dura può essere ‘sempiterno’, ma è ancora situato ‘nel tempo’, in quanto radicato in una cornice strettamente temporale, chiariranno le lezioni di Merleau-Ponty su L’origine della geometria husserliano. Ciononostante, a quanto pare, per conferire all'azione temporale un valore autentico, positivo, abbiamo bisogno di una nuova definizione di memoria e di oblio, superando la lezione dello schiavo del Menone.
Nell’ontologia di Merleau-Ponty, «l'oblio ha la priorità» sul ricordo, perché «senza oblio non sarebbe possibile alcun ricordo» (Waldenfels, Calandrella 2000, 114). Dimenticare significa in un certo senso lasciare andare qualcosa, rinunciare al pieno possesso intellettuale del mondo, per conservarlo in altro modo. Il mondo sfugge perché il flusso del tempo influisce sulle capacità del soggetto vivente di trattenere tutte le possibili esperienze che passano, che scorrono, che si confondono l’una nell’altra. Il soggetto a cui pensa Merleau-Ponty non detiene più le prerogative di una coscienza assoluta poiché rivela un'apertura naturale, una disposizione ad accogliere il divenire del tempo e quindi a concedere «una sorta di passività» (Morris 2018, 86). Contestando il concetto di «ritenzione» di Husserl, Merleau-Ponty rimprovera a questi di non aver ammesso con sufficiente chiarezza che la memoria «implica l'oblio», afferma Gallagher (2005, 107).
Questo è un punto essenziale, poiché Merleau-Ponty non può sostenere il fatto che l'oblio possa essere concepito come «un passaggio nel nulla, – come ha fatto il tedesco – (...) ma – al contrario, – un modo di essere a... nell'allontanarsi da...» (Merleau-Ponty 1964, 250). Riprendendo le parole di Gallagher, «l'oblio permette la possibilità dell'intenzionalità; è il necessario rovescio dell'intenzionalità. Se l'intenzionalità è intesa come differenziazione, uno scarto, l'oblio è indifferenziazione» (2005, 107). Nell'ontologia di Merleau-Ponty, nulla è completamente perso, dal momento che nulla è assolutamente guadagnato, acquisito una volta per tutte. La presenza o l'assenza effettiva dell'uomo in questo mondo, la sua presa su di esso è, a ben vedere, solo una questione di variazione tra un modo di agire consapevole, intenzionale, e una modalità involontaria e inconsapevole di indifferenza vitale, un abbassamento, una regressione in qualche modo controllata.
La ritenzione è l'inarrestabile «affondamento graduale» della percezione presente, come hanno sottolineato Waldenfels e Giuliani (2019, 50), ma essa non comporta un eventuale, sciagurato naufragio della memoria. Conservare qualcosa significa invero non lasciar andare, trattenere ciò che l'oblio disperderebbe. Il processo di dimenticanza, proseguono i due studiosi, è «l'inverso dell'attenzione e, in quanto impercettibile, appartiene alla percezione stessa» (ibid.). La ritenzione entra in gioco in qualsiasi momento, poiché l'oblio vero e proprio «inizia ora» (ibid.), nel ‘tutto’ che è ‘ogni’, corrisponde cioè all'ineliminabile lato oscuro della percezione, di ogni atto percettivo. Ma come funziona questo processo di allontanamento? Come può Merleau-Ponty sostenere che la dimenticanza non porta alla completa, diciamo, cancellazione del ricordo, della presenza? Infine, come può il filosofo francese salvare l’essere dal nulla, dall’irrecuperabile?
Ecco che allora l’erranza proustiana insegna propriamente a Merleau-Ponty che è il corpo a custodire i segreti della memoria, ad esserne lo scrigno del tempo il cui sigillo può essere divelto solo a determinate condizioni, che non sono quelle dettate dalle logiche dell’intelletto. L’esperienza principe che testimonia la sussistenza, sotterranea, silenziosa, di questa memoria di permanenza, è offerta già dalle primissime pagine proustiane della Ricerca, dedicate alla descrizione del processo di addormentamento e di risveglio dal sonno del narratore. È la «descrizione del risveglio – dice Robert – e la scoperta della continuità tra il mio essere ed il mondo, che consentono di pensare la memoria del corpo» (p. 372). Questo lungo passo della Ricerca è commentato da Robert all’interno del capitolo Le temps sensible, collocato verso la conclusione del libro, e che ne rappresenta, a parere dello scrivente, uno degli estratti più vividi e riusciti circa l’analisi della comunanza tra i due intellettuali.
Nelle pagine proustiane, Merleau-Ponty coglie infatti quell’onirismo, quell’elemento immaginario, simbolico, proiettivo e retrospettivo, quella poesia o ‘poetica’ della coscienza, quell’affaiblissement dello spirito che stava cercando, quell’«indice» (Merleau-Ponty 1945, 479) che segnala un problema, che, filologicamente, lo interessava già dal 1945: mi riferisco all’attività nella passività, ai movimenti avversi e pur inerenti alla vita stessa, il chiaroscuro che, come detto, costruiamo giorno per giorno (e notte per notte). Quella peculiare azione-passione che è l’addomentarsi, l’‘endormissement’ è la migliore prova, illustra Robert, che una coscienza può perdersi e ritrovarsi «rimanendo se stessa», che essa non è mai pienamente presenza à sé, e che il sogno non incarna l’assenza di ogni coscienza» (p. 366). Al contrario, il sonno, come la veglia, incarna «un modo in cui il corpo dispone per incontrare il mondo» (ibid.).
Assodata la virtualità del sonno, quella cavità che è una possibilità interna all’essere, perché la coscienza «scivola, senza una transizione chiara, nel sonno» (p. 367), altrettanto importante appare il risveglio, nel quale il corpo effettivamente si ‘ritrova’. In Proust, «il tempo ritrovato (…) si delinea innanzitutto nel modo in cui il corpo conserva la memoria del passato (...) il corpo – prosegue Robert – è innanzitutto ciò che riceve, che raccoglie il mondo, ciò che è sensibile al mondo; in esso, nel sonno, come nella vita percettiva, si radica un senso che non proviene dall'attività della coscienza di veglia» (p. 366). Il corpo è un qualcuno, è colui che mantiene e salvaguarda il legame con il cosmo, il tempo e lo spazio. Proprio come Merleau-Ponty, anche Sartre si è cimentato nell’analisi del sonno proustiano, insistendo però grandemente – e colpevolmente, rimarca Robert – «sull’immobilità del corpo, sull’annullamento di ogni motricità e l’abbandono di ogni fascinazione dei pensieri» (p. 370).
È un versante interpretativo che Merleau-Ponty non condivide, e che si impegna a confutare proprio sulla base della lettera proustiana. L’immobilità ipnotica cui pensa Proust, dice Robert leggendo Merleau-Ponty, ricalca infatti di una soppressione diversa, che non è concepita come degradazione, diminuzione della vita della veglia. Nel sonno, si vive in un altro modo, secondo rinnovate coordinate etologiche: l’immobilità è infatti «una possibilità del corpo che si relaziona a delle possibilità altre rispetto alla motricità» (ibid.) e che non è affare di coscienza. Nel sonno, il corpo si ritrova: nel riassorbimento letargico, il dormiente ri-scopre, potremmo dire, la ‘religione’ ed il culto primitivo di un passato carnale dal carattere enigmatico, una liturgia per la quale l’ancoraggio alla profondità, alla stasi del riposo personifica già, forse curiosamente, le virtualità di un progetto, una specifica «iniziazione cinetica» (p. 67), l’attributo di un «movimento imminente» (Merleau-Ponty 2020, 139).
L’esperienza di Pietro perciò si ‘scrive’, si ‘raccoglie’. Nel sonno, nel sogno, in questa dimensione non meglio precisata dell’immaginario, la ‘compagnia Apollonio’ rivive, e Pietro con lei: le sue vicende riecheggiano per i muri dell’appartamento, le voci dei suoi protagonisti lo accompagnano nelle vicissitudini quotidiane, ed il recupero, la raccolta del senso, ‘ritrovato’, la sera, ha il sapore dolce dell’intimità, dell’appuntamento. L’auspicio è che la ricerca possa, in futuro, concentrarsi su quest’ambiguità teorica, quest’anfibolia interna alla vita cosciente, rappresentata dalla dualità sonno-veglia, un aspetto che il libro di Robert ha messo in mostra con singolare fulgore.
di Riccardo Valenti
Bibliografia
Opere merleau-pontyane
M. Merleau-Ponty (1945). Phénoménologie de la perception, Paris, PUF
M. Merleau-Ponty (1964). Le visible et l’invisible. Suivi de Notes de travail, Paris, Gallimard
M. Merleau-Ponty (1996). Sens et non-sens, Paris, Gallimard
M. Merleau-Ponty (2013). Recherches sur l’usage littéraire du langage. Cours au Collège de France. Notes 1953, Genève, Métis Presses,
M. Merleau-Ponty (2020), Le problème de la parole. Cours au Collège de France. Notes, 1953-1954, Genève, Métis Presses
Bibliografia secondaria
S. Gallagher (2005) «Disrupting Seriality. Merleau-Ponty, Lyotard, and Post-Husserlean Temporality», in L. Hass; D. Olkowski (ed.), Rereading Merleau-Ponty. Essays Beyond the Continental-Analytic Divide, New York, Humanity Books
D. Morris (2018). Merleau-Ponty’s Developmental Ontology, Evanston, Northwestern University Press
B. Waldenfels; D. Calandrella (2000), Time Lag: Motifs for a Phenomenology of Time, in «Research on Phenomenology», vol. 30, Leiden, Brill
B. Waldenfels; R. Giuliani (2019) «Vortex of Time: Merleau-Ponty on Temporality», in E. Alloa; F. Chouraqui; R. Kaushik (ed.), Merleau-Ponty and Contemporary Philosophy, Albany, Suny
-
Il danzatore performer nell’epoca contemporanea
Filosofia e danza / Febbraio 2023...Da loro impara il saggio Allora lo zoppo salterà come un cervo
che deve a questo mondo aver paura (Isaia, 35:6)
del tumulto e del moto;
d'un ombra che passa ebbro, poi per sempre
sconta l'uomo il castigo
d'aver voluto muoversi
(Charles Baudelaire, I Gufi)
Dovevano disporre di una tavolozza di colori, di gesti e di emozioni ancora in costruzione, i primi membri della comunità che corsero a imprimere la sensazione di un salto. E poi, era stata una prima volta o già la ripetizione di una ripetizione di quel gesto che li portò a trascriverlo sulla parete? Forse il bisogno (psico) fisico di addomesticarlo guardandolo in faccia, di rilasciare quell'energia furente che dava l'uscita per la caccia? Il tentativo di fermare quel momento, l'attimo in cui la corsa diventava uno slancio, una sospensione, un salto, e trasferirlo poi da un corpo a una superficie. Ma che sensazione provarono in quel momento? Il cuore doveva battere all'impazzata, il respiro pulsante, i muscoli eccitati nell'atto di sentire il proprio corpo che “imparava” le distanze infilandosi tra altri corpi animali, lungo corridoi di tronchi d'albero, gettandolo poi in una rincorsa dentro spazi aperti. Forse era a quel punto che arrivava il salto. Un momento privilegiato di sospensione, che staccava per un attimo i piedi da terra. Ci sono voluti millenni e vari cambi di tecnologie, fino alla poetica cronofotografia di Étienne-Jules Marey (non a caso fisiologo e cardiologo, prima di tutto), e Eadweard Muybridge, per raccontare fino in fondo quale meravigliosa complessità esista dentro quel movimento. Ma ciò che mi interessa di più è immaginare cosa provarono in quel momento quei primi saltatori/cacciatori: era già un esercizio estetico? Un intermezzo tra un passo e l'altro, in cui la testa percepì l'ebbrezza di sentirsi ancora più in alto, le gambe il desiderio di distendersi ancor di più per raggiungere un punto lontano, mentre il soggetto stesso si osservava agendo?
La danza classica riuscirà a tradurre quel momento, millenni dopo, in uno dei suoi passi più sublimi, il grand jeté. Puro slancio nello spazio, privo ormai di ogni azione di caccia se non il mantenere la forza e la grazia del corpo del danzatore/danzatrice in aria per attraversarlo.
C'è un momento magico dentro ogni salto che facciamo. I bambini lo sanno bene, così come i danzatori, gli atleti, le persone felici. Ognuno prepara quel momento a modo suo. Perché quando siamo felici viene quasi spontaneo saltellare, lanciare il proprio corpo in aria, godersi quel momento di sospensione che assomiglia alla traccia che rilascia una stella cometa. Coda di cometa, così la chiamava Husserl: continuo presente che si porta dietro una coda di cometa di ritenzioni che gli aderiscono strettamente. Come un vestito.
Quando siamo rimasti chiusi nelle nostre case durante i mesi più complessi del Covid, nel 2020, è avvenuto qualcosa di inaspettato. Danzatori, performer, filosofi si sono collegati on line per condividere le proprie pratiche. Si trattava di allenare una resistenza. Di re-imparare a vivere il nostro quotidiano all'interno di quelle che erano le nostre abitudini più prossime, ovvero le mura di casa nostra. Per alcuni, erano mura quasi sconosciute, per altri mura soffocanti. E così ci siamo collegati, in tanti, tra luoghi e mondi vicini e lontani.
Durante una pratica online di Dance Well, progetto di danza che coinvolge anche persone con il Parkinson, ho chiesto a tutti i partecipanti di saltare. Di fare o immaginare un salto. Quasi tutti ci trovavamo davanti a una finestra. O davanti a un muro. Attorniati da una piantina. Era una richiesta che avevamo fatto insieme a Gaia Giovine, un'ape operaia della filosofia, come ama definirsi, Elena Cavallo e Lucia Guarino, danzatrici.
Ha preso così forma questa restituzione, letta dalla voce di Stefania Ressico.
Per raccontare quali siano i tratti del pittore della vita contemporanea, Charles Baudelaire evoca una figura singolare, che si firma solo con le iniziali, C.G. Ciò che interessa al signor G, è la pura osservazione di quel che gli accade intorno. Il modo di muoversi delle persone, i loro tratti, abitudini, quei piccoli cambiamenti che intercorrono tra uno spazio e l'altro, tra un luogo e l'altro. (Nel linguaggio della danza è ciò che ha a che fare con la coreografia: ovvero, un certo modo di muoversi nello spazio e nel tempo).
Per questo, per definirlo, Baudelaire usa la parola cosmopolita, uomo di mondo, anziché artista. Perché tutto il mondo gli appartiene, lo incuriosisce. Ma ha bisogno di un'altra immagine ancora, e questa gli viene dal celebre racconto di E. A. Poe, L'uomo della folla.
E' la storia di una convalescenza. Dietro il vetro di un caffè, troviamo un convalescente che, riprendendo le proprie energie, osserva curioso e avido di vita il muoversi della folla. Tutto attira la sua attenzione, ed è come se si accorgesse per la prima volta di ogni dettaglio. A tal punto che, a un certo punto, si getta fuori dal caffè per inseguire uno sconosciuto. All'interno di questo profilo che Baudelaire va disegnando compaiono parole prettamente fisiologiche e poetiche: la convalescenza è come un ritorno all'infanzia. Il convalescente possiede in sommo grado, come il bambino, la facoltà di interessarsi alle cose. Vede tutto in forma di novità. Di più. Ciò che lo rende così contemporaneo è quella scossa nervosa, più o meno intensa, che si ripercuote sin nel cervelletto. Possiede una sorta di infanzia ritrovata per un atto di volontà. Con quell'occhio fisso e animalmente estatico dei bambini di fronte al nuovo.
Per definirlo ancor di più Baudelaire azzarda altre due parole. E' dunque un dandy? Non proprio. Un filosofo? Forse, se riesce a fare i conti con l'istinto metafisico della categoria. E' certamente un flâneur, ma non lo dice. Quasi due secoli dopo, potremmo aggiungere anche un'altra possibilità. E' forse un danzatore? Un performer? Un coreografo?
Così come potremmo aggiungere altre parole e sensazioni, “digerite” dai Situazionisti dal 1957: psicogeografia, spirito di scoperta, disorientamento dei riflessi abituali. Cartografia rinnovata. Détournement. Deriva.
Quando il sociologo Chombart d Lauwe nel suo studio su: Paris et l'agglomération parisienne, metteva in luce la quasi immutabilità del percorso quotidiano di un cittadino medio, a cominciare dalla vita di uno studente, il cui percorso si riduceva a un triangolo di dimensioni ridotte, senza fughe, i cui tre vertici erano: l'Ecole des Sciences Politiques, il domicilio della ragazza e quello del suo professore di pianoforte, non dava drammaticamente ragione a Baudelaire, ai Situazionisti, circa il bisogno di rinnovare i sensi? Di re-interrogarli dentro le loro abitudini quotidiane?
Forse non tutti sanno che è proprio quello che da decenni la danza e la performance stanno provando a fare.
Immaginate di prendere 8 danzatori, diceva il grande coreografo Merce Cunningham, per spiegare che cosa era la complessità che la danza moderna stava portando dentro il Novecento. Dunque, prendete 8 danzatori e incominciate a creare una situazione in cui ciascuno si comporta come un solista. Immediatamente, rispetto al tradizionale corpo di ballo che si muove insieme, vi accorgerete che state già creando un tipo diverso di complessità. Ora, ritornate per un attimo al tradizionale corpo di ballo con 16 danzatori che si muovono insieme e simmetricamente a destra e a sinistra della scena. E vi accorgerete con che facilità e letizia il vostro sguardo li seguirà da un lato all'altro. Ora, provate a introdurre una piccola modifica: una serie di 8 danzatori andrà a destra e un'altra serie di 8 a sinistra; ciascuno dei due gruppi inizierà poi a eseguire dei movimenti diversi dall'altro gruppo. Vedete che la situazione incomincia a farsi più imprevedibile. Aggiungiamo un'ulteriore complessità. Degli 8 danzatori a destra, 4 inizieranno a fare certi movimenti, e i rimanenti 4 altri. E così di seguito anche sul lato destro. Potete intuire fin dove ci si può spingere: ognuno dei 16 danzatori inizia a sviluppare una propria serie di movimenti. State entrando in un grado di complessità differente. Ma, sopratutto, sottolinea, state aprendo il campo a una gamma di possibilità tutte da esplorare. Non finisce qui, insiste Cunningham. Perché il meraviglioso balletto classico ragiona in termini di prospettiva di scena, orientata frontalmente davanti allo spettatore. Cosa succede, invece, domanda Cunningham, se ogni punto dello spazio diventa egualmente interessante? Che si rompe quel codice secondo cui il centro, la piazza potremmo dire in termini architettonici, ma anche politici e sociali, è il punto più importante. Pensiamoci bene, a che cosa tutto ciò comporta: ancora adesso, dopo un'elezione politica, all'interno dello sviluppo economico di una città, osserviamo il centro e la periferia. Ma cosa succede se tutti i punti, se tutte le parti diventano egualmente importanti da esplorare? Benvenuti dentro la grande complessità con cui si interfaccia la danza contemporanea.
Guardavamo fuori dalla finestra per cercare continuamente idee. Osservavamo le persone muoversi, camminare. Chi sono questi flâneurs, che parlano ancora così nel 1960? Un gruppo di coreografi, artisti visuali, danzatori, compositori, filmakers, riunitisi negli spazi della Judson Memorial Church, una congregazione Protestante presente a New York nel Greenwich Village, per una serie di workshops in cui indagano cosa sia la danza. E lo fanno a partire dai movimenti della vita di tutti i giorni: camminare, cadere, correre, alzarsi, rotolare, saltare. Eseguire delle piccole sequenze. Giocare. Sembrano i requisiti immaginati da Baudelaire per il pittore della vita contemporanea. Molti dei loro nomi costituiscono la storia della danza fino ai giorni nostri: Trisha Brown, John Cage, Lucinda Childs (leone d'oro a Venezia nel 2017), Merce Cunningham, Simone Forti, Steve Paxton (leone d'oro alla carriera a Venezia nel 2014), Yvonne Rainer, Robert Rauschenberg.
Passando davanti a una scuola elementare, per esempio la Tommaseo di piazza Cavour a Torino, può capitare di imbattersi in un pavimento disegnato dagli stessi bambini, in cui compare una sorta di scacchiera composta da palline allineate dello stesso colore disposte su 4 file: ogni fila ha un colore, giallo, verde, rosso, blu. Ogni fila è composta di 6 palline allineate dello stesso colore. Si tratta di un gioco in cui le regole sono dettate da una voce che “comanda” degli atteggiamenti: appoggia la mano destra su tale pallina, quella sinistra su un'altra, il piede destro su quella di quel colore. E così via. Dentro la scacchiera ci stanno almeno due persone che eseguono i comandi. Gradualmente i loro corpi si trovano a esplorare le posizioni più contorte e impossibili. E, allo stesso tempo, a trovarsi attorcigliati, intrecciati tra di loro.
Il gioco si chiama Twister ed è stato inventato e brevettato nel 1966 negli Stati Uniti, all'interno di uno di quei tanti cosiddetti brainstorming aziendali che da una cosa ne generano un'altra. Reyn Guyer, stava infatti cercando un'idea per promuovere una scatola di lucido da scarpe quando ebbe un'altra idea: un nuovo gioco di gruppo, da giocarsi non sul tavolo ma direttamente sul pavimento. Una sorta di scacchiera in cui le pedine sono i corpi stessi delle persone. Da quel che ne sapeva, non esisteva alcun gioco brevettato in cui i corpi delle persone agissero direttamente da pedine.
Ne fece dunque il prototipo e lo sperimentò con i suoi collaboratori. Ma, mancando di esperienza in quel settore, fece chiamare due esperti del settore: Charles Foley e l'artista Neil Rabens. Rabens propose di aggiungere nelle regole del gioco il fatto di appoggiare anche le mani, e non solo i piedi; mentre Foley propose di inserire 6 cerchi dello stesso colore per ogni fila distribuite su 4 file, in modo che gradualmente i giocatori finissero intrecciati tra loro per muoversi. Il gioco all'inizio prese il nome di Pretzel. Alcuni membri dello staff avevano però dei dubbi: il gioco, su degli adulti, poteva risultare un po' troppo compromettente, specialmente se a giocare erano un uomo e una donna, che si sarebbero trovati attorcigliati tra di loro. E, nel caso la donna avesse una gonna, addirittura con l'uomo che rischiava di finire sotto la sua gonna! Ma vinse la fiducia nell'idea e fu messa in produzione. Ma con un altro nome, Twister. E una frase che lo promuoveva: The Game That Ties You Up in Knots. Il gioco che ti intreccia in nodi.
I timori espressi da alcuni sembrarono all'inizio dargli ragione. I rivenditori, infatti, mostravano un certo imbarazzo nel promuovere, sopratutto sotto le Festività, un gioco che creava una forte promiscuità tra i corpi. E così si valutò l'ipotesi di toglierlo dal mercato.
Ma, prima di farlo, tentarono l'ultima chance. La possibilità di presentare il gioco all'interno della celebre trasmissione americana della NBC's“Tonight Show. La puntata andò in onda il 3 maggio del 1966 e il conduttore Johhny Carson si trovò a giocare a Twister con l'attrice Eva Gabor, famosissima all'epoca.
Il risultato fu un'esplosione di gioia e sensualità, i loro corpi si trovarono intrecciati e in posizioni atipiche esattamente come prevedevano le “regole” del gioco. Che, in realtà, non facevano altro che stimolare delle posizioni e posture diverse dall'ordinario. Facile prevedere il seguito. Da quel giorno la richiesta di Twister invase tutti i negozi.
Se osserviamo il tutto con decenni di distanza, ci accorgiamo subito di un fatto. Che ancora una volta hanno vinto i bambini. Il gioco è presente, per loro, davanti alle scuole, negli spazi adepti al gioco dei parchi. Talvolta è addirittura improvvisato. Come un piccolo détournement. Ma mai, vediamo un adulto giocarvi. Troppo scomode e diverse dall'abituale sono le posizioni da esplorare. Quel finire sotto, strisciare, aggrapparsi, provare ad articolare le gambe e le braccia su 4 direzioni diverse, come farebbero certi personaggi di Beckett, è troppo insensato, troppo buffo.
Nei parchi, negli spazi aperti, che sono il grande teatro della vita contemporanea, gli adulti sono quasi sempre seri e misurano tutto: la corsa, i passi percorsi, saltano solo per allenare i muscoli delle loro gambe, salgono e scendono da una panchina ripetendo il copione di un esercizio da fare. La coda della cometa è scomparsa. Ha vinto il ticchettio impeccabile della lancetta dell'orologio. La misurazione. Non esiste gioco, esplorazione, camminate inusuali, cadute, girare su se stessi. E se gli si dicesse che anche questi sono gli ingredienti di una pratica di danza con cui si costruisce una ricerca, una coreografia, forse sarebbe l'unico momento in cui li vedremmo sorridere.
Traducendo il De Rerum Natura di Lucrezio, il poeta Milo De Angelis osservava come uno scrittore, e un poeta in particolare, non scrive ciò che sa, ma comincia a saperlo scrivendo. E lo stesso avviene con una traduzione. Non traduciamo ciò che sappiamo, ma cominciamo a saperlo traducendo.
Quale è la legge “segreta” che sta dietro le nostre abitudini, comportamenti, azioni? E' all'interno di questi spazi, di queste griglie “invisibili” che si sono rifatte le pratiche di danza spuntate in mille modi dal nostro presente per interrogare quel che il corpo fa ogni giorno: ovvero, mettersi in movimento, anche quando sta fermo, come milioni di persone fanno quotidianamente nelle ore lavorative. Che coreografia sta abitando il nostro presente? Ce lo chiedeva già la grande Trisha Brown decenni fa. Ecco il tipo di domanda che proveremo continuamente a porci. Lanciando quasi una sfida e uno stimolo. Un'ulteriore domanda, in realtà. E se dentro quell'albero di genealogie così necessarie per interrogare il nostro presente che filosofi come Giovanni Leghissa ci propongono, fosse necessario provare a rispondere ogni volta attraverso una pratica? Attraverso l'esplorazione di una coreografia, che altro non è se non il rapporto che avviene tra i corpi all'interno dello spazio e del tempo che abitano?
I piedi, i nostri piedi, tornano così a cercare. Prima erano punte, sublime spazio metafisico di distanza tra cielo e terra. Finché, riaffondando dentro il selciato, hanno accettato anche il dialogo con l'orizzontalità, con le cadute, i rotolamenti. Da li, stanno re-imparando a saltare. Al danzatore, al flaneur, al filosofo, al poeta, ai botanici, agli scienziati, agli agricoltori è richiesto questo aspetto mutante di peso, di pressione, di tocco. Questo esercizio di spazio che, tra le persone, prende la forma di una comunità. Tra alberi e piante, e noi, la forma di un nuovo tempo, nuovo perché così antico, un tempo vegetale.
In questo la danza, il movimento tornano ad essere un esercizio filosofico che parte da dove tutto era cominciato: da una domanda.
Ed è quello che proverò a fare, insieme a Gaia Giovine, nelle prossime puntate.
di Emanuele Enria
-
Heidegger e l’inizio della filosofia occidentale
Recensioni / Febbraio 2023All’interno del pensiero di Heidegger, indubbiamente, quello relativo alla Kehre è sempre stato oggetto delle più numerose critiche, in particolare relativamente ad un ritorno – dai tratti considerati spesso esoterici – al pensiero dei primi pensatori, i presocratici. La recente traduzione italiana del xxxv volume della Gesamtausgabe, intitolata L’inizio della filosofia occidentale. Interpretazioni di Anassimandro e Parmenide, edita da Adelphi nel 2022, per molti versi, permette un diverso approccio. Innanzitutto, il corso del 1932 su Parmenide ed Anassimandro si colloca in una posizione importante all’interno del Denkweg heideggeriano: è subito successivo ad alcuni importanti testi che segnano il passaggio al pensiero della Kehre; soprattutto, nei due anni precedenti, Heidegger scrisse la conferenza del 1930 Dell’essenza della verità (Heidegger 1987, pp. 133-57) da cui poi trasse il corso dell’anno successivo (Heidegger 1997). Ma il testo è anche precedente a quello del 1935, Introduzione alla metafisica (Heidegger 2014a), il quale rappresentava finora la prima e decisiva presa in considerazione del pensiero pre-platonico, in particolare di Parmenide ed Eraclito. Prima di questo testo, come nota il curatore all’edizione italiana (Heidegger 2022, p. 14) i riferimenti sono brevi e sporadici, risalenti principalmente ad un corso del 1922 (Heidegger 2005a, pp. 209-31) e ad uno del 1926 (Heidegger 2000, pp. 137-46; 331-33). Se il pensiero heideggeriano fino al 1927, con Essere e Tempo, si muove nei riguardi della filosofia antica principalmente seguendo le orme di Aristotele (Volpi 2010), e se la Kehre inizia a partire dal 1930 in direzione dell’ἀλήθεια ( Heidegger 1987, pp. 133-157) con la critica alla dottrina platonica (Heidegger 1987, pp. 184-192), in L’inizio della filosofia occidentale Heidegger mostra l’aspetto più prettamente positivo della Destruktion della storia dell’ontologia (Heidegger 2005b, pp. 33-40), aprendosi per la prima volta ed in maniera decisiva al pensiero di Parmenide e Anassimandro, che ritorneranno spesso nei testi successivi.
Il testo consta di tre parti di cui la prima e la terza consistono nelle interpretazioni puntuali rispettivamente di Anassimandro e Parmenide, mentre l’esegesi svolta nella sezione centrale, di natura più ampia, offre la prospettiva da cui inquadrare le altre due. Della lettura di Anassimandro – qui interpretato per la prima volta –, ciò che risulta particolarmente interessante è la trattazione più ampia e piana dei frammenti rispetto al Detto di Anassimandro, comparso solo nel 1946, contenuto in Holzwege (Heidegger 2014b, pp. 379-441). In quest’ultimo testo, infatti, Heidegger si concentra solamente sulla parte centrale del frammento – «κατὰ τὸ χρεών· διδόναι γὰρ αὐτὰ δίκην καὶ τίσιν ἀλλήλοις τῆς ἀδικίας» (A 1 DK) – ritenendo le altre non affidabili (pp. 402-3); in L’inizio della filosofia occidentale il commento è completo (Heidegger 2022, p. 32), aprendo interessanti possibilità di confronto tra i due testi. Nel Detto di Anassimandro l’intero lavoro ermeneutico ottiene una propria dimensione nella traduzione di “τὸ χρεών” – «il primissimo nome per il pensato ἐόν degli ἐόντα» (p. 429) – in Brauch, pensando attraverso di esso l’Evento, la dinamica che rapporta l’Essere e l’uomo. Nel nostro testo, invece, la parte su Anassimandro si conclude sull’ultima parte tràdita del frammento, quindi sul concetto greco di χρόνος, un tempo che «non è per nulla solo la cornice dell’ordine della successione» (Heidegger 2022, p. 48) – ossia il risultato di una comprensione dell’essere a partire dalla sua sostanzialità semplicemente-presente – ma al contrario come ciò che è capace di «assegnare di volta in volta all’essere la sua “sistemazione” (Taxe)» (p. 51), cioè l’essere dell’ente. Questo aspetto rimanda all’ultimo termine analizzato del pensatore di Mileto, “τὸ ἄπειρον”, che – in un interessante utilizzo della semantica del Riß (pp. 58-64) centrale nell’Origine dell’opera d’arte (Heidegger 2014b, pp. 5-89) – riconduce alla dinamica della differenza ontologica, «la più originaria che in assoluto possa darsi» (Heidegger 2022, p. 64).
La parte dedicata a Parmenide, la terza, assume un ruolo ancora più importante per quando riguarda i successivi sviluppi del pensiero heideggeriano: rispetto agli altri due “pensatori iniziali”, Eraclito e Anassimandro, Parmenide è sicuramente quello che avrà una rilevanza maggiore, sia per numero di testi dedicatigli, sia per la sua presenza in quelli più teoreticamente decisivi, tutti incentrati principalmente sul frammento «τὸ γὰρ αὐτὸ νοεῖν ἐστίν τε καὶ εἶναι» (fr. 3 DK), tramite cui Heidegger tenterà di illuminare la co-appartenenza di essere e pensiero (Heidegger, 2009; 2014c pp. 158-75; 1999). Ciò che risulta interessante della parte dedicata a Parmenide è che qui Heidegger traduce e commenta tutti i frammenti superstiti del poema del filosofo di Elea, elaborando una struttura interpretativa che, seppur guidata dalle necessità di un corso universitario, colpisce per la complessità e il respiro ampio, elementi che nelle interpretazioni successive rimarranno in ombra. Di fronte all’impossibilità di un riassunto esaustivo di questa parte, che si mostrerebbe incapace di offrire l’esperienza di un tale lavoro, risulta più proficuo illuminare alcuni aspetti centrali. In particolare, il lavoro si muove inizialmente a partire da quella che Heidegger chiama «la tesi originaria» (Heidegger 2022, p. 208) di Parmenide – appunto il fr. 3 – già in queste pagine esplicitamente interpretata alla luce della reciproca co-appartenenza di essere e pensiero (pp. 224-5). Questo aspetto, quasi trent’anni dopo, assumerà una centralità fondamentale, in quanto riletto alla luce dell’Evento e alla sua connessione con il Ge-stell (Heidegger 2009, pp. 27-51). Oltre a questo primo aspetto, centrale come si è potuto vedere, per comprendere la genesi di alcuni dei concetti centrali dei testi dell’ultimo Heidegger, meriterebbero ulteriori analisi – qui impossibili da approfondire ma tuttavia importanti da rilevare – le due seguenti tesi che Heidegger evince dal testo: quella “essenziale”, secondo cui «l’essere è assolutamente non-nullo» (pp. 203-4); ed infine quella “temporale”, per cui l’essere, senza «parlare di atemporalità o di eternità […] sta in relazione con il presente, e solo con esso» (p. 207). Il tentativo che si prospetta in queste pagine sarà proprio quello di comprendere il legame reciproco tra queste tesi, attraverso un’analisi che culminerà nella problematizzazione dei concetti di presente e presenza, Gegenwart e Anwesenheit, i quali necessiteranno, come si è mostrato con Anassimandro, di un confronto con la temporalità. Che l’obbiettivo teorico di Heidegger sia quello di sottrarre Parmenide alla tradizionale interpretazione che lo vede come il sostenitore di un’ontologia statica ed immobile, risulta chiaro, oltre che dallo sviluppo delle tre tesi, soprattutto da un ulteriore aspetto che vale la pena di approfondire brevemente. Come appare nelle annotazioni redatte per la preparazione del corso (p. 310) Heidegger sottolinea molto spesso il legame tra ἀλήθεια e δόξα, anch’esso aspetto che non ricomparirà nei lavori successivi. Nonostante nel testo la dea intimi a Parmenide di evitare la via dell’opinione a favore di una verità fuori dal tempo, Heidegger rilegge i passi alla luce di una «coappartenenza essenziale» (p. 153) dei due termini: «chi vuole comprendere concettualmente la verità deve comprendere la non-verità, non può eluderla, bensì accogliere entrambe nel loro più intimo confronto reciproco» (p. 152). Tale è esattamente la dinamica che Heidegger cercherà di chiarire con il termine ἀ-λήθεια, dis-velamento. L’importanza di Parmenide dunque si mostra soprattutto in quest’ultimo passaggio: «la via di Parmenide conduce fuori all’Aperto, in quel Libero dove si libera anzitutto e per la prima volta l’intera antiteticità di verità e non-verità» (p. 153).
Ciò mostra come la lettura dei presocratici – seppure nell’aspetto didattico di un primo passo – rappresenti non solo una continuazione, come affermato in precedenza, del progetto mai smentito della Destruktion, ma altresì un approfondimento del problema della verità su cui si innesta la Kehre, tema la cui importanza veniva già sottolineata in Essere e tempo – in particolare nel paragrafo 44, il quale non a caso si apre con Parmenide – insieme alla necessità di un ritorno al pensiero pre-platonico (Heidegger 2005b, pp. 258-77). L’inizio della filosofia occidentale inoltre, proprio per il suo carattere di inizio, contiene un’ulteriore parte, quella intermedia, qui lasciata volutamente per ultima, che affronta in maniera esplicita numerose delle aporie e problematiche in seguito riconosciute in questo ritorno agli inizi. In fondo, questo tentativo di ritorno all’inizio, ha spesso suscitato il seguente interrogativo: «non si tratta forse di dogmi calati dall’alto, capricci di un incontrollabile arbitrio […]?» (p. 67). Come Heidegger stesso aggiunge poi: «due millenni e mezzo non si possono certo saltare semplicemente tenendo un corso universitario» (p. 68). L’idea di un restauro dell’origine e di un culto dell’autentico – seppur molto presenti nella critica (Adorno 2016) – non sono mai stati lo scopo del pensiero di Heidegger: «l’accesso all’“inizio” ci rimane sbarrato […]. Non v’è arte dell’interpretazione che ci consenta di superare l’abisso dei millenni» (p. 70) o, come ripeterà pochi anni dopo a riprova dell’importanza di questo aspetto: «sottrazione di un mondo e dissoluzione di un mondo non sono mai reversibili» (Heidegger 2014b, p. 34). Il tentativo di pensare la storia dell’essere non si riduce ad una storia del suo allontanarsi da un’origine piena, disponibile, a cui bisognerebbe fare ritorno attraverso pochi frammenti di un pensatore di cui ciò che abbiamo «è poco, e quel poco è incompleto» (Heidegger 2022, p. 32), bensì sta nella sfida rischiosa, che il testo incarna in pieno, di riscoprire nuove strade per il pensare, un pensare «non dell’uomo in assoluto e in generale – che non c’è mai e in nessun luogo» (Heidegger 2022, p. 89), bensì quello di un’esistenza concreta, storica, che prende le mosse sempre Aus der Erfahrung des Denkens (Heidegger 1986), dall’esperienza del pensiero.
di Pietro Prunotto
BIBLIOGRAFIA
Adorno, T.W. (2016). Il gergo dell’autenticità. Sull’ideologia tedesca. Trad. it. di P. Lauro. Torino: Bollati Boringhieri.
Heidegger, M. (1986). Aus der Erfahrung des Denkens. Stuttgart: Neske.
Id. (1987). Segnavia. A cura di F. Volpi. Milano: Adelphi.
Id. (1997). L’essenza della verità. Sul mito della caverna e sul «Teeteto» di Platone. A cura di F. Volpi e H. Mörchen. Milano: Adelphi.
Id. (1999). Parmenide. A cura di F. Volpi. Milano: Adelphi.
Id. (2000). I concetti fondamentali della filosofia antica. A cura di F. Volpi. Milano: Adelphi.
Id. (2005a). Phänomenologische Interpretationen ausgewählter Abhandlungen des Aristoteles zu Ontologie und Logik, in Gesamtausgabe (LXII). A cura di G. Neumann. Frankfurt a.M.: Klostermann.
Id. (2005b). Essere e Tempo. A cura di F. Volpi. Milano: Longanesi.
Id. (2009). Identità e differenza. A cura di G. Gurisatti. Milano: Adelphi.
Id. (2014a). Introduzione alla metafisica. A cura di G. Vattimo. Milano: Ugo Mursia.
Id. (2014b). Holzwege. Sentieri erranti nella selva. A cura di V. Cicero. Milano: Bompiani.
Id. (2014c). Saggi e discorsi. A cura di G. Vattimo. Milano: Ugo Mursia.
Id. (2022). L’inizio della filosofia occidentale. Interpretazione di Anassimandro e Parmenide. A cura di P. Trawny e G. Gurisatti. Milano: Adelphi.
Volpi, F. (2010). Heidegger e Aristotele. Roma-Bari: Laterza.
-
Vita e potenza. Marco Aurelio, Spinoza, Nietzsche
Recensioni / Novembre 2022Scopo dichiarato dell’ultima opera di Rossella Fabbrichesi, Vita e potenza. Marco Aurelio, Spinoza, Nietzsche (Cortina 2022), non è tanto una ricostruzione storiograficamente rigorosa quanto la delineazione (e la messa in atto di un pensare-con) di un canone filosofico alternativo a quello, maggioritario, che ha tradizionalmente separato la filosofia dalla pratica di vita. Proprio questa impostazione rende il lavoro meno disponibile a essere recensito e più atto – in una compulsione al pensare, e dunque al vivere, che è tra i maggiori pregi del libro – a suscitare ulteriori interpretanti che spazino sull’uso delle sue idee.
I tre nomi che corredano il titolo e che scandiscono il succedersi dei capitoli – Marco Aurelio (adottato come simbolo dello stile di pensiero stoico), Spinoza e Nietzsche – infondono a questo rimando un carattere marcatamente etico: non si tratta di ottenere qualche conoscenza filologica, ma di saper incorporare una certa comprensione della verità, di «dare uno stile» al proprio pensiero e quindi alla propria vita, nella convinzione – trasudante già dalle pagine del lavoro precedente di Fabbrichesi, Cosa si fa quando si fa filosofia? (Cortina 2017), ma qui portata a tema e sviluppata attraverso il confronto con le sue radici più autentiche – dell’inseparabilità di filosofia ed ethos. La pratica filosofica è intesa come askesis, esercizio al servizio della vita. Con un termine foucaultiano che ricorre in queste pagine, la filosofia è prima di tutto etopoietica. In due passi che sintetizzano efficacemente il tono generale del pensiero di Fabbrichesi: «il fine della vita, la massima felicità (eu-daimonia), è lavorare a costruirsi un carattere (ethos), riconoscendo, affermando, volendo ciò che in esso è destinato (il proprio daimon)» (p. 21); «La filosofia come modo di vita orienta dunque verso uno strenuo lavoro di rimodellazione del sé, una trasformazione che sappia creare soggetti non più assoggettabili, soggetti che sappiano disporre dei dispositivi che normalmente li incatenano» (p. 58).
Del suo maestro, Carlo Sini, l’autrice mantiene l’idea che il rapporto col mondo consista in una ripetizione e modulazione a partire da qualcosa che ereditiamo e che ci dà forma in maniera essenziale: non è il pensiero a essere nella nostra testa, siamo noi a essere nel pensiero. A questa consapevolezza, Fabbrichesi affianca però la lezione di una tradizione filosofica che – sulla scorta di intermediari ermeneutici come Hadot, Foucault e Deleuze – sottolinea il ruolo che la potenza può ricoprire nel superamento della dicotomia tradizionale tra soggetto e assoggettamento, polo, il secondo, sul quale Sini tende ancora ad ancorarsi. Il concetto di potenza è ciò che rende l’agente non solo soggetto alle pratiche, ma anche, in una misura che si tratta di scoprire volta per volta, soggetto delle pratiche, che possono essere modificate, progressivamente e con un duro esercizio, proprio perché esse hanno bisogno di passare attraverso l’agente per perpetuare la propria realtà. Pratica non è più solo l’insieme di dispositivi nel quale siamo immersi, ma un compito che può riarrangiare questo stesso campo. La potenza è qualcosa che innanzitutto troviamo come dato, su cui dobbiamo lavorare, che infine raggiungiamo in maniera nuova.
Il cuore teoretico del libro potrebbe essere localizzato in una rilettura etica della massima pragmatica di Peirce, pensatore cui Fabbrichesi ha dedicato i suoi primi anni di studio: stando a Peirce, un’entità (un’idea) è identica a quell’insieme di effetti condizionali che possiamo immaginare seguano dalla sua esistenza (dalla sua assunzione). Leggere eticamente questa massima significa prescrivere che questa somma condizionale di effetti (che, con la mediazione di Spinoza, divengono piuttosto affetti) venga spostata nella direzione che più si accorda a un aumento di potenza dell’entità considerata. Ciò significa che, Peirce con Spinoza, il conatus curvato verso l’habitus, la potenza diventa il dispositivo ontologico fondamentale, sostituendo la forma come il concetto definente le entità nel modo più profondo, in un rovesciamento, silenzioso ma totale, del modo di pensare maggioritario (quello di matrice aristotelica) all’interno della tradizione occidentale. Il «pragmatismo raffinato» (pp. 42, 103) che l’autrice ascrive agli autori di questo canone è un pragmatismo etico, che mira all’esercizio delle nostre possibilità vitali più profonde. L’idea non è più un generale, come in Peirce, ma un’essenza singolare e vitale, la cui determinazione, rimandata a «una visione intrecciata a una pratica» (p. 120), va intesa meno in termini descrittivi che di sperimentazione e scoperta. Un’etologia che è inseparabile da una trasformazione, che riguarda non «un’essenza pensata come avviluppata in possibilità inespresse, riferita a un generale universale cui conformarsi, ma […] un’essenza che non è che singolarizzazione in un’espressione costantemente attiva e in via di definizione» (p. 111). Si tratta, con le parole dell’autrice, di «trasformare gli affetti passivi in affetti attivi, ampliare le zone di dominio, anzitutto su di sé, ordinare gli spazi passionali dove fluttuiamo in un mare di oscurità e ambiguità» (p. 82).
Dal punto di vista storiografico, il grande spostamento individuato da Fabbrichesi riguarda il nodo problematico che si forma tra la dialettica libertà-necessità – gli autori di riferimento, come noto, tendono a vedere la prima come consentimento alla seconda – e la gestione delle passioni. La tendenza, di cui Fabbrichesi mostra tutta la bontà nonché una sorta di inevitabilità evolutiva, sta nello scivolamento dalla recisione stoica delle passioni, viste con tinte quasi tumorali come un intralcio alla conformazione al logos, alla via spinoziana della selezione, tra le passioni, di quelle che sono atte ad aumentare la nostra potenza. Dalla battaglia quale modello di rapporto al mondo si passa alla danza; dall’imperturbabilità quale fine ultimo della pratica filosofica si passa alla gioia. Lo spostamento è del massimo peso teoretico per quanto riguarda l’immagine della libertà che ne emerge. Il paradigma stoico – ben reso dall’immagine aureliana della «cittadella interiore», che Fabbrichesi evoca spesso insieme a Hadot – vedeva l’animo umano come qualcosa che, pur partecipando della corporeità universale, restava in qualche modo separato da essa: proprio nell’identità tra separazione (imperturbabilità) e conformazione stava l’ideale del saggio stoico, il suo consentire al fatalismo cosmico. Da questo punto di vista, i sostenitori del fatalismo e quelli del libero arbitrio di matrice cristiana mostrano la stessa ingenuità nel ritenere l’agente in qualche modo un’eccezione rispetto al resto del cosmo, pur in due direzioni opposte: i secondi assegnano un’agency completa al soggetto proprio come i primi lo privano di ogni possibilità fuori da quella di acconsentire a un divenire di matrice esterna. La teoria stoica, mai sviluppata con rigore, dei «confatali» puntava già nella direzione che poi sarebbe stata sviluppata da Spinoza: proprio perché l’agente non è un’eccezione rispetto al resto del cosmo, esso non è del tutto libero, ma è una parte di quella libertà cosmica che forma la necessità individuale, e può pertanto interferire, curvare, selezionare: come spiega Fabbrichesi, «nel senso etimologico del termine, de-cisione è taglio, una selezione» (p. 47). L’agente non è una cittadella che deve tagliarsi fuori dal mondo esterno; esso è piuttosto una membrana che può filtrare una concatenazione di eventi, che vengono così a dipendere, in una misura e solo se questi sarà in grado di rendersi «causa adeguata», anche da lui. Per Spinoza, non si tratterà per nulla di «non farsi toccare»: «gli Stoici operano attraverso una sospensione del rapporto difettivo con il mondo, Spinoza attraverso un’immersione totalmente affettiva in esso» (p. 116). L’individuo, lo sottolineerà efficacemente Deleuze, non ha rapporti, ma è esso stesso un avviluppo di rapporti; la gioia individuale, come spiega Fabbrichesi, va intesa allo stesso tempo come una forma di «autoerotismo» dell’unica sostanza, come il mondo che guarda se stesso compiaciuto (p. 121). La ragione non può lavorare in assenza di un supporto emotivo – meglio ancora, come vedrà Nietzsche, la ragione non ha valore che quello che le deriva dall’essere «l’affetto più potente» (p. 54). È questa con-fatalità a rendere il paradigma dell’imperturbabilità ancora in qualche modo un fraintendimento rispetto a quello della gioia; conclude Fabrichesi, mostrando quanto indistricabilmente vadano concepiti agente e mondo: «Vi è un intreccio avviluppante di decisioni che vengono consapevolmente operate e di esseri che strenuamente decisi ad agire. Ma l’essere decisi affonda le radici in una serie di concatenamenti che non si possono conoscere, se non cogliendo l’invito della filosofia a divenire saggi» (p. 48).
Ricomposta l’estraneità di facciata tra ragione e affetto, la potenza acquisisce il ruolo di autentico sostrato, se di sostrato si può ancora parlare, del diventa ciò che sei: l’indagine di Fabbrichesi potrebbe intendersi anche come una grande riflessione attorno a questo precetto dal carattere storicamente problematico, caratterizzato da una ricchezza semantica che appare inesauribile da ogni trattazione unilaterale. Tra i grandi meriti di Fabbrichesi v’è anche quello di lasciar emergere a turno, attraverso i tre capitoli del libro, le accezioni che esso può assumere, e che serve sempre tenere presenti con uno sguardo sinottico, per riequilibrare le problematiche di un uso del linguaggio ricalcato su un’esistenza diacronica, che non può che tradire un pensiero che cerca di cogliere il punto di vista dell’eterno (la scienza intuitiva, l’eterno ritorno). Prolungando le linee tracciate da Fabbrichesi, potremmo analizzare questa concettualità inviluppata scomponendola in quattro fattori problematici, quattro fonti classiche di equivocità che non sono in realtà che i diversi aspetti di quest’unica natura solo apparentemente antinomica del precetto.
Primo: l’autrice richiama spesso alla necessità, scoperta dagli stoici, di «imparare a vivere secondo natura» (pp. 24, 173), di scoprire nella fondamentale consonanza col cosmo la nostra potenza più propria. Quello che, così formulato, potrebbe apparire come un grido quasi reazionario è in realtà il più radicale e materialista dei punti di vista, il più lontano da un appello meramente normativo a una supposta natura cui adeguarsi coattamente. Seguire la natura è anche seguire la propria natura, è affermare la superiore originalità della physis immanente rispetto a un nomos spesso imposto, l’anteriorità della potenza sulla forma; è affermare il diritto dell’esistente, anche di quello singolare, in rapporto a ogni ideale estrinseco, poiché non c’è ideale che quello immanente al singolo esistente. Il nietzschiano «diventa ciò che sei» significa proprio, al di là di ogni «dover essere», elevare a potenza questa physis che troviamo come data.
Secondo: può essere una preoccupazione legittima che questa prospettiva appaia come una giustificazione dell’irresponsabilità. In un libro recente (Sulla viltà, Einaudi 2021), Peppino Ortoleva si domanda ad esempio se davvero si possano mettere sullo stesso piano Don Abbondio, che non fa che realizzare la propria natura di pavido, e personaggi come Fra Cristoforo e l’Innominato, la cui grandezza starebbe proprio nell’andare contro se stessi, dominando il proprio temperamento quasi criminale. A sua volta, il precetto di ripetere potenziata la propria essenza prima non deve trasformarsi in un nuovo asserto normativo che impedisca il lavoro su di sé e la trasformazione, e anzi l’intero percorso filosofico tracciato da Fabbrichesi tende nella direzione inversa. Ciò che sentiamo come più autenticamente nostro può spesso non coincidere con la nostra potenza, ciò che possiamo non è sempre identico ai nostri abiti immediati. Il «cammino del consentimento», come lo chiama Paul Ricoeur nella sua Filosofia della volontà, a condizioni che non abbiamo scelto, come il nostro carattere, l’inconscio, le condizioni biologiche, è un cammino che può essere completato, persino deviato, accogliendo influenze esterne e metabolizzandole affettivamente. L’amor fati è inseparabile da una «trasvalutazione degli affetti» (p. 171), e il «ciò che sei», lungi dall’essere dato dall’inizio e una volta per tutte, comprende anche tutte quelle cose che abbiamo reso nostre.
Terzo: anche così, sembra impossibile appianare del tutto la tensione tra il punto di vista dell’accettazione piena – la prospettiva stoica, l’amor fati nietzschiano – e quella del divenire gioioso – la gioia di Spinoza, la volontà di potenza, che sembra in qualche modo incitare alla lotta per il miglioramento delle condizioni vitali. Amor fati non significa solo acconsentire a tutto quanto ci accade; significa altresì, e forse soprattutto, dare forma a un destino che possiamo amare. Come recita un meraviglioso aforisma postumo di Nietzsche citato dall’autrice, l’eterno ritorno non insegna che a «vivere in modo tale che tu debba desiderare di rivivere» (p. 174). Gli stoici certo insegnano a non «digrignare i denti» contro quanto il destino ci riserva, ma altrettanto «contro natura» sarebbe forzare noi stessi all’accettazione di tutto quanto viene da fuori. Il consentimento è sempre trasformazione del consentito; il suo vero significato è ben reso da Fabbrichesi: «Rassegnarsi, nel senso etimologico di ri-assegnarsi: fare sì che il destino divenga una destinazione desiderata, assunta, guadagnata come un proprio movimento libero […] Libertà diviene allora sinonimo di potenza: capacità di conoscere e ri-conoscere ciò che accade» (p. 46).
Quarto: l’intero lavoro di Fabbrichesi si lascia consapevolmente attraversare da un grido lanciato da Spinoza ed esaltato dalla lettura deleuziana: non sappiamo cosa può un corpo. Ogni singolo affetto è determinato da una rete relazionale così complessa che nessuna mente finita potrebbe prevederne con esattezza l’esito. Da qui l’imperativo di non dire in anticipo – in termini deleuziani, non giudicare, ma lasciar esistere, vale a dire sperimentare. È questo corredo a privare il «diventa ciò che sei»di ogni contenuto normativo determinato, convertendolo piuttosto in una disposizione alla creazione di un essere nella cui realizzazione il nostro carattere possa scoprire la gioia. Non c’è modo di sapere ciò che siamo se non attraverso una lunga e rischiosa sperimentazione. Cos’era la follia di Nietzsche se non l’estremo amor fati applicato a questa sperimentazione? Cosa sono i richiami di Deleuze alla necessaria prudenza richiesta dalla sperimentazione, se non un orrore ammirato al pensiero di una vita piena che, come quella di Nietzsche, è stata dilaniata dal coraggio di un’assenza di misura? Il concetto di limite invocato da Fabbrichesi attraverso Deleuze serve proprio a questo scopo: la potenza è un tendere che deve contenersi un passo prima del proprio disfacimento, è sprigionamento di forze ma anche mantenimento di un’organizzazione minimale che ne assicuri il funzionamento coordinato. Non un rigido «limite-cornice», ma un «limite-tensione» (pp. 113-4) che col giusto lavoro può sempre essere spostato un passo più in là. L’esercizio spirituale è sempre un bilanciamento di forze centrifughe o espansive, espressive di potenza, e di forze centripete e contenitive che danno forma a un nucleo che fa da aggancio sempre metamorfico agli accidenti del mondo e del carattere.
Tutte queste difficoltà vengono insomma dalla necessità di cogliere il precetto sinotticamente, sia dal punto di vista temporale e umano, che da quello dell’eternità, dal punto di vista dell’esercizio che si dispiega e di quello dell’essere. La stessa essenziale duplicità si ritrova nel concetto di vita, altro polo della diade che fa da protagonista al libro. Esso si identifica da una parte come il flusso, impersonale e in questo senso atemporale, che definisce la potenza. Ma vita è anche la vita vissuta, ad un livello non riducibile a quello meramente personale o impersonale – una vita, diceva Deleuze –, e che acquisisce definitezza attraverso le pagine di una scrittura ancorata allo stesso svolgimento narrativo del vissuto. L’ultimo capitolo del libro è fondamentale alla comprensione complessiva del lavoro non solo in quanto ai contenuti, ma per la sua stessa forma: proprio l’approccio biografico a Nietzsche – o meglio, a «Friedrich» – eleva a potenza l’identificazione della filosofia con la sua pratica. Di Nietzsche, Fabbrichesi non presenta la dottrina o la teoria, ma «la potenza pratica di lavoro su di sé» (p. 127) con cui egli annullò la differenza tra la sua vita attuale, perlopiù derelitta e impotente, e la realizzazione della sua potenza più propria. Un divenire-Friedrich (avrebbe detto Deleuze), dell’autrice quanto del lettore, viene messo in atto attraverso le vicende e le lettere, in particolare quelle relative al tormentato rapporto con Lou Salomé. Pochi pensatori esemplificano quanto Nietzsche la solidarietà tra vita e pensiero evidenziata da una tradizione che da Diogene Laerzio va fino a Sini; se questa solidarietà si integra tanto bene al tono più ermeneutico-testuale dei primi due capitoli, è soprattutto perché Nietzsche mostra quanto la scrittura della propria vita possa configurarsi anch’essa come un esercizio volto all’aumento della potenza. Fabbrichesi suggerisce anzi che solo tramite tale esercizio Nietzsche fu capace di vedere la grandezza insita nella propria esistenza. L’auto-bio-grafia come askesis consiste, si potrebbe dire, nel saper cogliere gli eventi marchiati dal proprio nome, finanche gli eventi più tragici e sciagurati, da quel punto di vista che permette di vederli come tasselli del compimento di un destino. La «grande salute» non è uno stato, ma quel punto di vista dal quale la malattia si può narrare come identica alla salute, la sventura come identica alla realizzazione di sé, la disperazione più profonda alla gioia più alta. Potremmo parlare, facendo confluire Nietzsche, Peirce e Sini nella lente di Fabbrichesi, di un interpretante auto-bio-grafico finale, della scoperta di quel punto vitale che permetta una risignificazione integrale degli eventi come passi sul cammino della potenza di una vita.
Vita e potenza è anzitutto – lo prospetta la stessa autrice rifacendosi nelle prime pagine a Rachel Bespaloff – un incontro in forma di libro. Il suo pensare-con gli stoici, con Spinoza e Nietzsche è un generatore di ulteriori compulsioni a con-pensare – e ciò significa, seguendo l’equazione tra pensiero e vita, che il percorso tracciato da Fabbrichesi attraverso il suo canone di autori diventa anche un’esperienza vitale trasformativa. La contagiosità dell’urgenza personale espressa dal libro fa sì che lettura ed esercizio vengano a coincidere. Si tratta già di un aumento di potenza.
di Christian Frigerio
-
Non è certo facile restituire la complessità e la densità del volume di Maurice Merleau-Ponty, Il mondo sensibile e il mondo dell’espressione (Mimesis 2021), recentemente tradotto e curato per il pubblico italiano da Anna Caterina Dalmasso, senza dubbio una delle studiose più autorevoli del pensiero del filosofo francese (suo l’importante saggio di Introduzione, pp. 17-52). Non è facile innanzitutto per la stessa natura di questo (non) libro, che raccoglie il materiale del filosofo prodotto in vista del suo primo corso al Collège de France dell’a.a. 1952-53. Il volume contiene tanto l’effettivo materiale utilizzato dal filosofo nelle sue esposizioni orali, quanto appunti che ne ampliano e approfondiscono l’orizzonte teoretico.
L’opportunità per il pubblico italiano di studiare e apprezzare il pensiero di Merleau-Ponty svolto al Collège si amplia così, dopo la traduzione di altri corsi avvenuta a cavallo tra la fine del secolo scorso e l’inizio del millennio: La nature (Seuil, 1995, tr. it. Cortina, 1996) e Notes de Cours 1959-1961 (Gallimard, 1996; tr. it. Cortina, 2003). Quello che qui discuteremo è stato pubblicato nel 2011 dall’editore svizzero MētisPresses[1] sotto la direzione scientifica di E. de Saint Aubert e di S. Kristensen e la traduzione italiana permette di accedere a un materiale teorico molto fecondo, sia per chi si occupa direttamente di Merleau-Ponty sia per chi sia interessato al pensiero francese del Novecento. In queste quattordici lezioni, infatti, si anticipano o si sviluppano in modi originali piste che attraversano, carsicamente a volte, altre in superficie, una tradizione di pensiero gravida ancora oggi di ampi sviluppi teorici. Lungi dall’essere una pubblicazione per soli addetti ai lavori, questo volume può essere di grande aiuto a chi volesse comprendere meglio alcuni intrecci - sia detto solo a titolo di esempio non esaustivo — tra Gestaltpsychologie e filosofia dell’esistenza, tra bergsonismo e fenomenologia, nonché — come segnala la Prefazione di Mauro Carbone (pp. 9-16) foriera di stimolanti riflessioni sull’arte e l’estetica. Insomma, pur non essendo di facile accesso — e tuttavia l’ottimo lavoro di Dalmasso aiuta chi non fosse specialista — il volume non potrà che trovare interesse in molti ambiti degli studi filosofici contemporanei.
Qui ci proponiamo di tracciare una possibile via d’accesso in questo universo filosofico ancora da esplorare anche da parte di chi, da molti anni, vi si dedica con studio attento. Come ogni pista d’accesso, non ne impedisce di altre e non può essere pienamente esaustiva della ricchezza contenuta nelle quasi trecento pagine del volume. Tuttavia, può essere utile a meglio orientarvisi. Come segnala la curatrice, il volume ha il merito di offrire «un punto di vista privilegiato» (p. 17) sul back-office della produzione di Merleau-Ponty, un vero e proprio laboratorio artigianale di concetti situato al fondo del lavoro pubblicato in vita dall’autore.
A differenza degli altri corsi già tradotti per il lettore italiano, la peculiarità de Il mondo sensibile e il mondo dell’espressione consiste nel fatto che esso ci mostra un Merleau-Ponty sul punto di farsi, che non è più quello della Fenomenologia della percezione e non è ancora quello de Le avventure della dialettica, un Merleau-Ponty per così dire “intermedio”, in divenire (Lanfredini 2011): «Le note del corso del ’53 — continua Dalmasso — offrono un insieme di argomentazioni e di fonti in grado di gettare luce su alcuni punti più oscuri o anelli mancanti della riflessione merleau-pontiana successiva» (p. 18). Insomma, il corpus magmatico di questo volume permette, a chi voglia avventurarvisi, di «cogliere “un filosofo al lavoro” e di “accompagnare Merleau-Ponty” nel farsi del suo lavoro» (p. 20). Una vera e propria avventura filosofica che permette al lettore di oggi di risemantizzare molte antinomie che nel nostro presente appaiono ovvi se non addirittura vetusti. Del resto, non siamo noi oggi figli di quella temperie culturale che genericamente potremmo definire post-moderna e che ha fatto della lotta al manicheismo dualistico la sua pars destruens ? È un pensiero non dualistico, senza per questo, vedremo, rinunciare alla duplicità, quello che l’autore — che ovviamente di post-moderno non sapeva nulla — prova a mettere in forma, e che noi abbiamo occasione di studiare proprio nell’atto del suo generarsi.
Mondo sensibile e mondo dell’espressione definiscono un’antinomia che trova le proprie radici, a voler estremizzare, quanto meno nella distinzione platonica tra mondo ideale e mondo sensibile. Se si volessero fissare delle tappe a noi più vicine — come sempre troppo semplicistiche, ma utili a orientarsi — sensibile ed espressione rimandando alle distinzioni moderne di Descartes (quella tra materia estesa e pensiero inesteso) e di Kant (mondo sensibile della natura e mondo intelligibile dei valori) generalizzabile nella distinzione del pensiero antropologico tra natura e cultura (Lévi-Strauss 1969 pp. 39-52; Descola 2005). Già dunque nel tema stesso delle lezioni contenute in questo volume si comprende lo sforzo teorico che le sottende, un lavoro filosofico e fenomenologico che chiama in causa le principali architravi del nostro sensus communis moderno.
Potrebbe essere utile contestualizzare brevemente queste note di corso (si rimanda all’introduzionedella curatrice per i dettagli). L’anno accademico, come detto, è il 1952-53 ed è l’esordio di Merleau-Ponty al Collège de France, dopo che ha già tenuto il suo Elogio della filosofia nella lezione inaugurale (Merleau-Ponty, 2008) e mentre sta aprendo il cammino che lo consacra ai livelli più alti della cultura e della filosofia francese e forse mondiale. Non sono anni facili, gli anni Cinquanta, sia a livello storico (sono gli anni della guerra fredda, delle prime notizie in occidente del regime staliniano, della guerra di Corea, ecc.) sia a livello personale (Merleau-Ponty ha in cantiere La prosa del mondo che resterà incompiuto, sta rivedendo le sue posizioni rispetto all’URSS espresse in Umanismo e terrore del 1948, ma, soprattutto, sta per rompere il grande sodalizio filosofico e affettivo con J.-P. Sartre). Sul piano scientifico ha qualche sassolino nelle scarpe dopo la conferenza del 1946 presso la Société de philosophie dal titolo Il primato della percezione e le sue conseguenze filosofiche (Merleau-Ponty2004) nella quale presentava davanti a un pubblico composto dalle migliori menti filosofiche del tempo i risultati conseguiti con Fenomenologia della percezione. Amici e colleghi (Hyppolite, Bréhier, Lachièze-Rey per citarne alcuni) accolgono in maniera polemica e critica la tesi di fondo di quel libro accusandolo in alcuni casi di sensismo e positivismo. La sensazione di non essere stato compreso si radica nel filosofo e sette anni dopo è proprio da quella discussione che, con certosina attenzione, riparte (p. 61). Il primato della percezione diventa un punto di partenza ottimale per penetrare nel fitto bosco del sensibile e dell’espressione.
Sin dalla prima lezione, quasi un brevissimo compendio di Fenomenologia della percezione, emerge il tema cruciale con un gusto programmatico. Si tratta, cioè, di pensare l’unità del mondo percepito tale che questa unione non sia la “sintesi determinante”, la sintesi intellettuale, cioè, di una molteplicità sensoriale di stimoli empirici. L’unità cercata nella sua opera principale (ma anche in La struttura del comportamento del 1942) non era una sintesi del giudizio, ma di ordine “percettivo”. Si può dunque capire come qui emergano molte ambiguità che il filosofo dovrà in qualche modo dipanare.
Primato della percezione non significa postulare l’esistenza delle cose fuori di me o la corrispondenza oggettiva di mondo e conoscenza né di opporre a una filosofia intellettualista un empirismo sensista à la Hume, bensì di «fare una teoria concreta dello spirito» (p. 59). Il primato della percezione non postula «un primato del sensoriale, del dato naturale» (p. 60), ma è ricerca di un piano originario che non sia né empirico né trascendentale in cui il sensibile e l’espressione possano divenire indiscernibili: è lo statuto stesso della fenomenologia a modificarsi con questo primato. Fenomenologia della percezione non sta ad indicare solo che è possibile trattare la percezione come “noema”, ma che nel farlo si segue il divenire della percezione nel suo stesso attuarsi, ossia che la percezione indica un piano ontologico intermedio tra l’essere oggettivo e l’essere soggettivo. Si può trattare fenomenologicamente la percezione solo se essa non è né l’oggetto di un sapere né il soggetto della sensazione. È questo né né a non essere stato compreso alla Société nel ’46 (pp. 61-62). Il punto è che la percezione non rimanda solo al mondo del sensibile, ma implica anche un carattere espressivo: «Intenderemo qui per espressione o espressività la proprietà che ha un fenomeno, per la sua organizzazione interna, di farne conoscere un altro che non è dato o che non è mai stato dato. […] È in questo […] senso che la percezione è espressione, espressione del mondo» (pp. 62-63).
Fare una fenomenologia della percezione è studiare il farsi del mondo, una fenomenologia che acquista sempre più caratteristiche “hegeliane” (Vuillerod, 2018) risemantizzando il concetto di coscienza. Se c’è percezione, infatti, non è detto che vi sia necessariamente soggetto (nel senso del Cogito trascendentale che accompagna ogni io empirico), ma vi è senz’altro coscienza, che non è il pieno possesso di sé che la tradizione cartesiana e kantiana ci ha consegnato. La coscienza percettiva non è esterna alle cose, si situa tra di esse, ma non è cosa estesa tra cose estese: essa si fa negli scarti, nelle differenze (cromatiche, uditive, sensibili…) tra le cose, è trans-individuale (Ruyer 2018; Simondon 2011), passività creativa (Ménasé 2003). A differenza di quella trascendentale, essa «non ha a che fare con valori […], ma con esseri esistenti» (p. 64). Potremmo dire, cioè, che attraverso il primato della percezione Merleau-Ponty intraveda la possibilità di emancipare la coscienza percettiva dalla sovranità dell’intelletto dell’estetica trascendentale e di riscoprire nella materialità il suo proprio valore/valere.
L’espressività della percezione — il suo “primato” — è dunque ontogenetico, essa non è la facoltà inferiore della coscienza — come all’origine dell’estetica riteneva, ad esempio, A.G. Baumgarten (1993: 41) — ma la sua espressione “sensibile”, è «configurazione, struttura» (p. 65). Ecco un secondo termine fondamentale nel lessico merleau-pontiano che richiama il suo primo grande libro, La struttura del comportamento. Il primato della percezione implica una materialità della coscienza percettiva da intendersi come processo di strutturazione. Se la percezione non è (solo) la passività di un soggetto empirico, ma l’attività — quantunque “passiva” — di una coscienza “materiale”, allora essa è a tutti gli effetti concepibile nei termini di un comportamento (nel senso, ad esempio, in cui quantisticamente una particella ha un comportamento), un’attività vincolata ad un mondo-ambiente. L’espressione percettiva non è un atto puro, ma una prassi “situata” in uno “sfondo” di passività. Il richiamo è qui alla Gestaltpsychologie, che Merleau-Ponty aveva studiato attentamente nel libro del 1942 (e che nel corso affronta tra la settima e la nona lezione). Ogni coscienza percettiva è una figura (Gestalt) che emerge da uno sfondo e «vi è sempre qualcosa di inarticolato e di sottinteso in ciò di cui vi è coscienza» (p. 67). Lungi dall’essere un’astratta sensazione senza soggetto, l’espressione sensibile è un processo di figurazione (Gestaltung) e la coscienza percettiva è una figura o forma materiale. La coscienza percettiva non è un cogito ma un corpo, non un’anima che emerge e s’innalza dalla materia, ma l’individuazione, l’attività immanente, la configurazione sensibile e materiale di un corpo. Il primato della percezione è il primato del corpo sull’anima, non nel senso “empiristico-naturalistico” di un primato dell’esteso sull’inesteso, ma di una indiscernibilità tra il mondo sensibile della corporeità e la sua espressione animale.
Allora fenomenologia diviene sinonimo di strutturazione ontologica — «non vi è differenza tra ontologia e fenomenologia» (p. 61) — e il primato della percezione conduce a una ontologia dinamica e processuale (Vanzago, 2001). Il mondo dell’espressione non è riducibile a un mondo formale, ha una sua materialità; il sensibile non è inerte o passivo. C’è espressività sensibile tanto quanto vi è sensibilità “spirituale”. Né inerte né formale: l’espressività del sensibile è movimento e la fenomenologia della percezione è manifestazione non richiudibile negli steccati formali dell’estetica trascendentale, poiché non vi è più un primato del formale estetico (dello spazio e del tempo formali). Si avvia qui quello che con Husserl (1991) potremmo chiamare rovesciamento della rivoluzione copernicana: è il movimento a determinare le forme del tempo e dello spazio, non il contrario. Anzi: spazio e tempo non sono più forme, ma figure (Gestalten). Il movimento (si veda in particolare la sesta lezione) è il fenomeno espressivo per eccellenza, tutt’altro dunque che l’esito di una rappresentazione soggettiva. Come la percezione, esso non è l’oggetto di un sapere né l’attributo di un cogito (p. 99), ma è qualcosa che può essere solo sentito, in cui si manifesta il movente. Non è neppure un mero accidente che capita a un oggetto empirico, non è, cioè, la variazione di luogo nel tempo di una “cosa” (Sache), ma il fenomeno per il quale “qualcosa” (Ding) si esprime, emerge spazialmente e temporalmente (geograficamente e storicamente) in quanto figura su sfondo.
Il movimento espressivo è l’installazione sensibile di una coscienza percettiva nel cuore dello spazio e del tempo, il suo modo di abitare lo spazio e il tempo (p. 103), i quali non sono relazioni formali né empiriche, bensì modali. C’è movimento, ovvero qualche cosa appare, c’è della percezione, c’è del comportamento, c’è della coscienza, c’è figurazione: espressione di un’immagine materiale. Il movimento espressivo (siamo alla quarta lezione del corso) è «spirito che si fa corpo e corpo che si fa spirito […] una logica del funzionamento percettivo» (p. 105). Rovesciamento della fenomenologia hegeliana: fenomenologia e logica della percezione; il corpo è lo spirito, il mondo sensibile esprime il mondo spirituale; l’unione non è sintesi assoluta, ma l’affinità trascendentale (p. 107) dello spirito col sensibile in sopravanzamento (overlapping) l’uno sull’altro, «sintesi di enjambement» (p. 109).
Il movimento espressivo è la sintesi senza concetto di spazio e tempo. La mente va a Bergson che più di chiunque altro nel Novecento si è sforzato di pensare il soggetto implicato nel movimento (pp. 119-125). Dopo aver esposto, all’inizio della sesta lezione, gli «argomenti di Zenone» (p. 118) sull’impossibilità ontologica del movimento, Merleau-Ponty vi si richiama: «Per lui quello che rende impossibile il movimento nel pensiero di Zenone è la divisione infinita e attuale del tempo e dello spazio, […] per rendere possibile il movimento occorre che il tempo e lo spazio siano divisibili, ma non divisi, che, posti a partire dal tutto, ammettano uno spazio “tra” le posizioni e gli istanti, cosa che non è possibile nell’in sé. È quindi necessario che il movimento , che è fatto del mondo, sconfini su di me come durata, sia anche fatto di coscienza» (p. 119). Tuttavia, Bergson nel cercare un tout indivisé del movimento è ancora troppo intellettualista, «resta coscienziale» (p. 121). Occorre essere, si legge tra le righe delle note di lavoro, più bergsoniani di Bergson, il quale «trionfa su Zenone mostrando che il tempo non è fatto di istanti né lo spazio di limiti di spazio, ed è vero. Ma resta da esplicitare la conseguenza […] crede che il problema sia concluso» (p. 239). Diventa necessaria «una teoria del corpo percipiente» (p. 240), un paradigma del corpo (Iofrida 2019) che troviamo tra l’undicesima e la tredicesima lezione (nel cuore, dunque, del corso): il movimento è sì un dato immediato della coscienza, ma di una coscienza percettiva, una coscienza-immagine che sia la sintesi esistenziale (materiale) della durata, la quale viene così reinterpretata come espressione sensibile, immagine-spaziotempo, figurazione espressiva.
La durata bergsoniana è “astratta” e manca, agli occhi di Merleau-Ponty, la “e”tra sensibilità ed espressività, una unità (dodicesima lezione) non teoretica, ma pratica, «unità dello schema corporeo […] unità di un’azione sul mondo, di una prassi» (p. 187), non nel senso di un pragmatismo utilitaristico (che per Merleau-Ponty manterrebbe la sussunzione dell’azione sensibile a uno scopo sovrasensibile), ma come attività passiva di creazione di immagini, una prassi che «comporta una teoria [Theoria] o gnosis che ne è lo sfondo, che essa modifica e che a sua volta la modifica» (ibidem). La durata espressiva è unità di teoria e di prassi, una praktognosia che non è un pragmatismo — esiste una materialità dei valori — né un empirismo — c’è, come rileva Dalmasso, una intenzionalità del sensibile (pp. 46-52). La durata come congiunzione del mondo sensibile e del mondo dell’espressione, una unità che si può a buon diritto definire estetica (se con Kant intendiamo “estetica” l’unità senza concetto, pre-logica).
Non è un caso che i corsi del ’53 si chiudano (quattordicesima lezione) con delle considerazioni sull’Arte in generale, e sul cinema in particolare. Le considerazioni estetiche di Merleau-Ponty sul cinema meriterebbero ben altre analisi (si rimanda ai lavori di Carbone e di Dalmasso), qui ci limitiamo solo a trarre una brevissima conclusione. Il cinema è la “prova ontologica” del primato della percezione e del movimento espressivo. Esso è una ritmologia della durata dell’immagine, un contrappunto di punti di vista, di immagini che sopravanzano l’una sull’altra. Nell’arte cinematografica si realizza l’unità di sensibile ed espressione, il vinculum substantiale di una molteplicità di immagini sensibili senza sussunzione entro i decreti formali dell’intelletto trascendentale. Nel movimento cinematografico appare una vera e propria monadologia sensibile (p. 64) che si insinua nel mezzo dei due mondi, che sono “separabili” ma non separati e nelle cui pieghe emergono molteplici mondi intermedi. Come scrive Carbone, nel cinema «si celebra il venire ad espressione […] del mondo sensibile» (p. 16).
Questi mondi intermedi sono il legame tra mondo sensibile e mondo dell’espressione e costituiscono l’ambiente originario nel quale la nostra capacità creativa di corpi animali o anime materiali riesce a trovare spazio per esprimersi e manifestarsi attraverso un’inaspettata fenomenologia dello spirito-carne che solo un primato della percezione può rendere visibile. Già solo questa breve conclusione a cui perviene Merleau-Ponty nei corsi dedicati alla duplicità sensibile/espressione, forse, vale da sola lo studio attento di questo volume.
di Gianluca De Fazio
[1] L’editore continua ancora oggi il suo lavoro di pubblicazione dei corsi al Collège de France di Merleau-Ponty. Si segnala il numero monografico dedicato al Mondo sensibile e mondo dell’espressione della rivista Chiasmi International (n. s. 12-2010).
Bibliografia
Baumgartem, A.G. (1993), Progetto dell’estetica, in A.G. Baumgarten, I. Kant, Il battesimo dell’estetica, a cura di L. Amoroso, ETS, Pisa.
Descola, P. (2005), Par-delà nature et culture, Gallimard, Paris.
Husserl, E. (1991), Rovesciamento della dottrina copernicana della corrente visione del mondo, «Aut-Aut», 245, pp. 3-18.
Iofrida, M. (2019), Per un paradigma del corpo: una rifondazione filosofica dell’ecologia, Quodlibet, Macerata.
Lanfredini, R. (2011, a cura di), Divenire di Merleau-Ponty. Filosofia di un soggetto incarnato, Guerini, Milano.
Lévi-Strauss, C. (1969), La struttura elementare della parentela, a cura di A.M. Cirese, Feltrinelli, Milano.
Ménasé, S. (2003), Passivité et création. Merleau-Ponty et l’art moderne, PUF, Paris.
Merleau-Ponty, M. (2004), Il primato della percezione e le sue conseguenze filosofiche, a cura di R. Prezzo, F. Negri Medusa, Milano.
Merleau-Ponty, M. (2008), Elogio della filosofia, a cura di C. Sini, SE, Milano.
Ruyer, R. (2018), Neofinalismo, a cura di U. Ugazio, V. Cavedagna, G. Vissio, Mimesis, Milano-Udine.
Simondon, G. (2011), L’individuazione alla luce delle nozioni di forma e d’informazione, a cura di G. Carrozzini, Mimesis, Milano-Udine.
Vanzago, L. (2001), Modi del tempo: simultaneità, processualità e relazionalità tra Whitehead e Merleau-Ponty, Mimesis, Milano-Udine.
Vuillerod, J.B. (2018), Merleau-Ponty hégélien?, «Chiasmi International», n.s. 19, pp. 101-114.
-
Wittgenstein filosofo della storia
Recensioni / Settembre 2022Alla fine del secolo scorso, l’idea che la storia fosse finita fu salutata con fiducia da molti, nella speranza che la scomparsa dell’Unione Sovietica e il trionfo del capitalismo sancissero l’inizio di una fase di stabilità e armonia in cui l’umanità avrebbe trovato il suo compimento definitivo. Negli anni a venire, quell’idea si è così radicata da diventare di senso comune: il nostro è il migliore dei mondi possibili, mentre il solo pensare a un cambiamento dell’organizzazione politica e istituzionale appare, se va bene, come un anacronismo, se va male, come un rifiuto della realtà. Logica e Tumulti. Wittgenstein filosofo della storia (Quodlibet, 2021) di Marco Mazzeo si oppone con fermezza a questa narrazione. Col pretesto di uno studio sul più grande filosofo del Novecento, l’autore combatte una lotta senza quartiere in difesa della dimensione storica dell’esperienza umana.
Per prima cosa bisogna fugare un equivoco: storia non è il mero scorrere del tempo, il costante succedersi degli eventi. Non va dunque confusa con la filogenesi, né con la deriva dei continenti. È invece «l’insieme delle trasformazioni istituzionali e produttive grazie alle quali gli esseri umani riescono a salvare la pelle. La storia indica, in primo luogo, il modo nel quale i sapiens producono le condizioni di possibilità della propria vita» (p. 10). Indica quei cambiamenti «imprevedibili» – perché non riconducibili a un repertorio d’istinti – e «necessari», senza i quali non riusciremmo a produrre i mezzi della nostra sussistenza. Mentre il tempo dei fenomeni naturali è continuo, storia è sinonimo di discontinuità e fa rima con improvvisi tumulti repressi nel sangue o con una nuova tecnologia che sconvolge l’organizzazione della vita.
Tuttavia, in questa operazione di salvataggio, Wittgenstein non è un alleato. La diagnosi del libro è netta: il filosofo è cieco alla storia. Con un apparato filologico che lascia poco spazio a dubbi (vengono classificati tutti i termini riconducibili alla famiglia della «Geschichte» presenti nel lascito testamentario), Mazzeo dimostra che l’autore delle Ricerche filosofiche prospetta un’«antropologia senza storia» (p. 38): offre istantanee dirompenti, ma non vede la differenza tra il tempo umano e i mutamenti geologici. In questo è un degno «allievo di Spengler» (p. 55), una tra le sue fonti più importanti. Nel secondo capitolo del libro viene soppesato il debito di Wittgenstein con l’autore del Tramonto dell’Occidente il quale, sulla scorta di Goethe, paragona le epoche storiche alle fasi di sviluppo di organismi viventi come le piante, riconducendo la temporalità umana all’andamento ciclico che caratterizza la vita naturale in generale. E così una rivoluzione può diventare un’escrescenza da tagliare, un governo autoritario la piena maturazione di una cultura.
Nell’ipotesi interpretativa di Mazzeo, la discussa amicizia di Wittgenstein con Sraffa (a sua volta amico di Gramsci) sarebbe giunta al capolinea proprio in virtù di questa ritrosia nei confronti della storia. Il primo capitolo è dedicato a una ricostruzione del rapporto tra il logico e l’economista, il quale, oltre a ritenere «insopportabile» che l’amico abbia in Spengler un «punto di riferimento», nei suoi appunti denuncia «in modo esplicito» la «scarsa presenza della dimensione storica» (p. 30) nelle riflessioni dell’interlocutore.
Wittgenstein può però venirci in soccorso quando meno ce lo si aspetterebbe, cioè quando si occupa di matematica. Nelle sue annotazioni sul calcolo e sui teoremi trapela una nozione, quella di storia naturale, che può essere promettente approfondire. È quello che fa Mazzeo nel vertice teorico del volume, il terzo capitolo, in cui propone «una riflessione circa l’intreccio tra natura e storia umana, a prescindere dalla filologia wittgensteiniana» (p. 94) (la filologia tornerà presto, nelle due appendici, dedicate l’una a un confronto tra l’uso filosofico degli scacchi in Saussure e Wittgenstein, l’altra al poco studiato rapporto del filosofo austriaco con la fotografia). L’espressione «storia naturale» è gravata da una lunga tradizione che impedisce di coglierne appieno la portata teorica, e di cui l’Historia naturalis di Plinio il Vecchio costituisce l’illustre testo fondativo. Il paradigma tradizionale, che nel corso dei secoli ha avuto grande fortuna, consiste in una sorta di modello enciclopedico, il cui obiettivo è raccogliere e descrivere gli oggetti che appartengono al regno della natura. La ricerca è simile a quella del collezionista che punta a reperire quanti più documenti possibile, ma senza un vero criterio di selezione. Motivo per cui vi si possono trovare aneddoti circa i lupi mannari accanto a descrizioni di cercopitechi, oppure ipotesi sul senso del pericolo degli elefanti, ma anche cataloghi delle tecniche di cattura da parte degli esseri umani. In tempi recenti questo genere letterario è entrato in una seconda giovinezza: il lemma «storia naturale» figura nel titolo di studi eterogenei, che possono riguardare la morale umana da una prospettiva evoluzionistica, oppure «il profumo, gli alberi, la birra», fino ad arrivare al «concetto di distopia» (p. 83). Al netto delle evidenti differenze tematiche, i corpi che popolano questo variegato firmamento sono accomunati dalla «temporalizzazione dei fenomeni naturali senza un confronto esplicito con la dimensione storica. Si tratta di una disposizione spaziale del sapere scientifico» (p. 87). La temporalità tipicamente umana viene eliminata, annacquando la specificità della nostra forma di vita in un generico calderone in cui tutte le vacche sono nere. Mazzeo propone, al contrario, di prendere sul serio la dicitura «storia naturale», la quale, oltre che un ossimoro, contiene anche un guanto di sfida: come tenere insieme «natura (ontogenesi, filogenesi) e storia (le trasformazioni istituzionali di lingue, riti, forme della tecnica, modi di produzione)» (p. 87)? È possibile un «naturalismo non rinunciatario» (p. 87), che non ceda alla tentazione di nascondere sotto al tappeto le continue trasformazioni culturali che sembrano segnare così profondamente la nostra specie?
La domanda è retorica, alcuni suggerimenti per provare a rispondere ce li fornisce Mazzeo in un elenco di «paradossi» (p. 94), anche se forse sarebbe più corretto chiamarli «tesi sul concetto di storia naturale». Non è in questa sede possibile ripercorrerne l’andamento con dovizia di particolari, mi limiterò a riprendere un punto particolarmente degno di nota, la critica al concetto di adeguatezza. Bersaglio polemico è l’idea ingenua, ma non per questo non diffusa, secondo la quale le condotte umane possono venir lette nei termini di «risposte perfezionate a esigenze precedenti» (p. 98), come se le vicende storiche – ivi comprese le trasformazioni dell’assetto produttivo – non fossero altro che una serie di graduali adattamenti in direzione di una fitness completamente realizzata, di una suprema armonia tra l’anthropos e i suoi bisogni. Wittgenstein è polemico con questa concezione e si chiede, non senza ironia: «viviamo perché è pratico vivere? Pensiamo perché è pratico pensare?» (Wittgenstein 1978, V, § 14) E poi: «è adeguato ai nostri bisogni che noi contiamo come contiamo» (Item 163, p. 30r), cioè in base dieci e non in base sessanta (come, per esempio, facevano i babilonesi)? Il fatto che si calcoli così, o che, più in generale, si viva così, implica che si faccia così e non altrimenti: è sempre possibile una strada alternativa. In altri termini,
«l’insistenza di un gesto che indica cosa facciamo "qui e ora" non esorta a contemplare la bellezza di una sovrapposizione perfetta e atemporale tra la vita e la sua forma, tra la natura e la cultura. Punta a far emergere il carattere contingente di quel che potrebbe essere completamente diverso perché non è chiamato a rispondere a criteri di adeguatezza. Questa contingenza, adeguata solo a cose fatte, si chiama "storia" (p. 99)».
In altri termini ancora, questa volta più filosofico-linguistici, le regole che guidano la nostra prassi – in modo eminente quella verbale – non possono essere considerate alla stregua di leggi biologiche o chimiche. Tra regola e applicazione vi è uno scarto tale che niente obbliga a rispondere a un insulto con un pugno e non con una frase sardonica, a un comando con obbedienza e non con sdegnata insubordinazione.
La storia naturale di Mazzeo è, insomma, un concetto con cui combattere una battaglia ideologica contro una precisa narrativa del potere. Uno strumento di difesa nei confronti di chi fa sua un’idea di natura per nulla innocua, che in fin dei conti uccide una croce, ma anche una delizia, tipica della vita umana, la contingenza. Infatti, se ciò che i sapiens fanno è motivato esclusivamente da un criterio di adeguatezza, da una fatale tendenza all’adattamento, allora è inevitabile che le cose vadano così e non altrimenti, angusto lo spazio per mettere in discussione l’organizzazione della vita caratteristica del mondo contemporaneo. Per chi condivide una simile battaglia, varrà la pena di dare uno sguardo alle criptiche riflessioni del filosofo viennese sulla matematica. Chissà che questo Wittgenstein non possa fornire un prezioso antidoto contro la rassegnazione allo status quo.
di Adriano Bertollini
Bibliografia
Mazzeo, M. (2021). Logica e tumulti. Wittgenstein filosofo della storia. Macerata: Quodlibet.
Wittgenstein, L. (1988). Osservazioni sopra i fondamenti della matematica. Trad. it. di M. Trinchero, Torino: Einaudi.
Wittgenstein, L. Wittgenstein’s Nachlass, Electronic Bergen Edition, Oxford University Press, Oxford
-
Storia della filosofia del lavoro
Recensioni / Settembre 2022«È ampiamente riconosciuto che per noi, membri delle società moderne, il lavoro conta molto […] Sapere per quali ragioni, è una domanda a cui rispondere è molto meno agevole». H-C., Schmidt Am Busch
Histoire philosophique du travail (Vrin, 2022), curato da Frank Fischbach, Anne Merker, Pierre-Marie Morel ed Emmanuel Renault, è uno dei risultati del progetto di ricerca «Approches philosophiques de la centralité du travail» diretto da Fischbach e Renault tra il 2014 e il 2017. A loro due si deve l’interessante introduzione, a cui seguono sedici saggi (per i titoli e gli autori, rinvio all’indice) organizzati in due sezioni, la prima dedicata alla filosofia antica, la seconda, più ampia, dedicata alla filosofia moderna. Completa il volume, una bibliografia che amplia i riferimenti proposti dai singoli saggi e che si rivolge quasi esclusivamente alla filosofia contemporanea, in particolare ai più recenti sviluppi della Teoria critica francese, di cui, d’altronde, Fischbach e Renault sono esponenti.
Histoire philosophique du travail non ambisce a proporsi come una «storia della filosofia» sul tema del lavoro. I curatori non hanno ricercato né la sistematicità né la completezza che avrebbe richiesto una simile opera: rimandano ai sette volumi curati da Antimo Negri (Negri 1980-1981) e al progetto in fieri di Jean-Philippe Deranty. I saggi, infatti, sono stati scelti tra gli interventi di tre diverse giornate di studio, tenutesi, tra il 2015 e il 2017, nell’ambito di suddetto progetto di ricerca, e presentano, pertanto, una certa aleatorietà. Così, sebbene i curatori stessi riconoscano che mancano, ad esempio, la filosofia medioevale e quella contemporanea (cfr. p. 11), nondimeno va notato che la selezione dei saggi riduce la filosofia antica a quella greca da cui, però, è escluso Platone (che pure era oggetto di più di una conferenza). Al contempo, occorre segnalare la pubblicazione dell’antologia curata dagli stessi Fischbach e Renault (Fischbach, Renault 2022) con cui integrano Histoire philosophique du travail della parte mancante sulla filosofia contemporanea (nell'indice, ad esempio, si trovano Simone De Beauvoir, Adina Schwartz e Elizabeth Anderson).
Alle mancanze contenutistiche, si può forse aggiungere una mancanza di tipo pratico, quella di un indice analitico. Componendo una mappa del nutrito elenco di termini che gravitano attorno al lavoro e che ricorrono nell’arco del volume, un indice analitico avrebbe certamente agevolato il lettore a muoversi trasversalmente tra i saggi e sarebbe stato coerente con un interesse teorico che i curatori sottolineano nell’Introduzione (cfr. pp. 12-13), cioè seguire le inflessioni di significato che, nel corso della storia della filosofia, i concetti che si riferiscono al lavoro hanno assunto. Inoltre, tanto più in un volume come questo, che presenta una notevole varietà tra gli autori trattati, ciò avrebbe reso possibile reperire i diversi fili rossi che s’intessono nelle riflessioni filosofiche sul lavoro. Piacere, macchina, corpo, dignità, ma anche democrazia, salute, tempo, solo per ipotizzare alcune delle possibili voci.
Tuttavia, non si può additare come lacunosa questa Histoire philosophique du travail, poiché si tratta di un progetto pionieristico e poiché presenta, comunque, una certa organicità. Sin dall’Introduzione, intitolata Historicité et centralité du travail, Fischbach e Renault fissano ed esplicitano il fulcro del volume, che è la centralità del lavoro. A quest’ultima è legato il chiaro obiettivo teorico a cui essi mirano, cioè favorire una rivalutazione delle «risorse» che la storia della filosofia mette a disposizione «per pensare l’importanza delle diverse poste in gioco del lavoro» (p. 9). L’intento è invitare a «rivisitare la storia della filosofia occidentale dal punto di vista del lavoro e così elevare il tema del lavoro alla dignità filosofica che merita e che raramente gli è stata riconosciuta dalla storia della filosofia» (p. 10).
Questo è il tono che i curatori danno al volume e a cui tutti i contributi s’accordano. Gli autori e le autrici si propongono di rileggere tale filosofo o filosofa o una certa tradizione, per dimostrare il valore euristico di tematizzare il lavoro all’interno della loro produzione. Pertanto, per una valida recensione dei singoli saggi, servirebbe l’intervento di altrettanti specialisti. Ad esempio, Morel (Démocrite et le travail technique. Comment produire en régime atomiste?)sceglie di interrogare «la coerenza globale della filosofia di Democrito» non sulla pista più battuta dell’etica bensì «per quanto riguarda l’attitudine umana a modificare la natura attraverso il lavoro» (p. 88), mentre Frédéric Porcher (Nietzsche, penseur du travail?) intende mostrare che in Nietzsche è possibile individuare una nozione positiva di lavoro su cui egli sviluppa la sua critica, alla quale, invece, si fermano normalmente i suoi interpreti.
È possibile, quindi, definire una prima portata dell’espressione «centralità del lavoro». Bisogna intenderla come il tentativo di contrastare l’idea che il lavoro sia un tema poco rilevante nella storia della filosofia o che ha acquisito interesse solo recentemente, con la modernità. Fischbach e Renault vogliono, invece, «rendere manifesta la presenza costante del tema del lavoro, rendere percettibili un più ampio numero delle sue implicazioni, e far apparire la ricchezza dei concetti e delle problematiche attraverso le quali esso è stato pensato» (p. 11). In altri termini, si tratta di affermare la centralità del lavoro per smuovere la filosofia dalla sua posizione affine alla «lunga tradizione di svalorizzazione delle attività lavorative» (p. 9).
È un obiettivo piuttosto urgente per Fischbach e Renault. Infatti, la filosofia, dopo aver assecondato il primo discorso sulla fine del lavoro (cfr. Rifkin 1995), potrebbe assecondare anche il nuovo discorso sulla fine del lavoro che si sta diffondendo e che si basa sull’intelligenza artificiale e il machine learning. Riprendendo le analisi di A. A. Casilli (cfr. Casilli 2020), i curatori sottolineano che anche questo nuovo discorso è solo un nuovo capitolo dell’«occultamento del lavoro, della sua cancellazione nei fatti e della sua svalorizzazione nelle norme […], e dell’estensione e della diffusione del regno della produzione di merci» (p. 7). È evidente, quindi, che la «centralità del lavoro» ha una portata che tracima i limiti della storia della filosofia.
Con la «centralità del lavoro» Fischbach e Renault, infatti, non intendono soltanto opporsi alla perifericità o alla trascurabilità del lavoro quale tema filosofico, bensì vogliono affermare una tesi a pieno titolo. L’espressione indica più propriamente l’opzione teorica su cui la Teoria critica di stampo francese si sta spendendo negli ultimi anni (cfr. Dejours et al. 2018), cioè affermare «il potere strutturante, tanto socialmente quanto psicologicamente, tanto individualmente quanto collettivamente» (p. 16) del lavoro. Contro certe critiche del capitalismo che considerano che il lavoro sia diventato centrale solo con l’avvento della modernità (cfr. Postone 1993), inoltre, ritengono che la svolta che quest’ultima rappresenta consiste nel fatto che il lavoro ha assunto una centralità ulteriore, quella sociale: «La centralità del lavoro diventa così essa stessa sociale nelle società moderne, nel senso che il lavoro vi diventa socialmente strutturante, di modo tale che questa nuova centralità sociale riconfigura completamente e di riflesso le modalità secondo cui il lavoro è e resta strutturante anche sui diversi piani economico, psicologico e politico» (p. 19).
L’articolo di Renault su John Dewey (Dewey, l’anti-Arendt) è quasi un prolungamento dell’Introduzione. Infatti, ricostruendo l’argomentazione del tutto originale del pragmatista americano a proposito della centralità del lavoro, Renault offre una lucida esposizione dell’articolazioni delle «dimensioni» di tale problema. La prima è quella epistemologica, ovvero l’estensione da assegnare al concetto di lavoro. La questione è decisiva perché, come spiega Renault, una «concezione ristretta» esclude la possibilità di riconoscere la centralità del lavoro, laddove una «concezione allargata» la ammette (cfr. p. 369). Tra l’altro, questo spiega perché in Histoire philosophique du travail, a dispetto del fatto che il primo tipo di definizioni siano quelle più diffuse nella storia della filosofia - le rappresenta, ovviamente, Arendt, qui discussa da K. Genel (Hannah Arendt, une critique du travail: comment sortir de «la triste alternative de l’esclavage productif et de la liberté improductive»?) -, sia il secondo tipo di definizioni a prevalere: oltre a quella di Dewey (cfr. pp. 359 e sg.), si veda, per esempio, quella di Weil, esaminata da M. Labbé (Le travail chez Simone Weil: réalité, subjectivité, liberté, cfr. pp. 309-312).
Posta in via preliminare tale questione, la centralità del lavoro si decide propriamente sotto tre riguardi, cioè decretando la sua posizione dal punto di vista antropologico, dal punto di vista psicologico e dal punto di vista della teoria sociale. A tal riguardo, secondo Renault, l’originalità di Dewey consiste nel fatto che la sua argomentazione investe tutti e tre gli ambiti congiuntamente, laddove altri autori e autrici sostengono la centralità del lavoro sotto uno solo di questi aspetti. Infine, vi è la questione della «diagnosi storica» della centralità del lavoro che riguarda il ruolo del lavoro nelle varie società, in particolare in quella contemporanea.
Negli articoli che compongono Histoire philosophique du travail, se ne può quindi individuare una serie che, mentre contribuiscono ad affermare l’interesse filosofico del tema del lavoro, alimentano la prospettiva «forte» della centralità del lavoro e la esplorano secondo le diverse prospettive degli autori che vengono discussi. A proposito della centralità del lavoro dal punto di vista antropologico, ad esempio, sono di grande interesse le pagine del ricco esame che Merker dedica alla concezione aristotelica di schiavitù (L’esclave-Organon d’Aristote: entre machine-outil et homme augmenté). L’inattesa conseguenza delle riflessioni di Aristotele sullo schiavo e il lavoro, infatti, è la sanzione dell’«inclusione indelebile della problematica del lavoro nella condizione umana» (p. 154). H.C. Schmidt Am Busch, invece, esaminando i Lineamenti di filosofia del diritto di Hegel (La valeur du travail: sur l’actualité de la théorie hégélienne de la société moderne) si propone indagare «il valore non monetario del lavoro» (p. 213) tanto per l’individuo quanto per la società.
Tra gli autori che compongono suddetta serie, ha un peso specifico Marx, in quanto è uno degli autori di riferimento per chi sostiene le «obiezioni storicistiche» alla centralità del lavoro (cfr. Deranty 2013). Dapprima, J. Quétier (Marx et le travail) ricostruisce la posizione di Marx a proposito della centralità del lavoro: essa è cruciale tanto per la sua antropologia quanto per la sua analisi del capitalismo e le sue prospettive emancipative. Per riprendere le parole di Quétier, la centralità del lavoro è per Marx «problematica: da una parte perché occultata, dall’altra perché incompleta» (p. 233). Quindi, Fischbach (Le salariat Le salariat doit-il quelque chose à l’esclavage? Capitalisme, esclavage et salariat selon Marx) si concentra su questo secondo aspetto, cioè sulle ragioni per cui, secondo Marx, la centralità del lavoro non può essere realizzata nel capitalismo. Quest’ultimo, infatti, non solo conserva la schiavitù ma ha «una tendenza permanente» (p. 345) a reinventarla e congiungerla con il salariato e con nuove forme indirette di subordinazione del lavoro.
In definitiva, grazie al consistente novero dei filosofi e delle filosofe che sono prese in esame, Histoire philosophique du travail persegue l’obiettivo di rendere meno «fantasmatica» l’esistenza del tema del lavoro nella storia della filosofia (cfr. p. 10). D’altro lato, Histoire philosophique du travail segnala l’interesse e l’urgenza di ampliare e sviluppare, se si accetta la metafora, il cantiere del «potere strutturante» del lavoro ovvero della sua centralità.
di Armando Arata
Bibliografia
Casilli, A. A. (2020). Schiavi del clic. Perché lavoriamo tutti per il nuovo capitalismo?, Feltrinelli, Milano.
Dejours, C., Deranty, J-Ph., Renault, E., Smith, N. H. (2018). The Return of Work in Critical Theory. Self, Society, Politics, Columbia University Press, New York.
Deranty, J-Ph. (2013). Cartographie critique des objections historicistes à la centralité du travail, in «Travailler. Revue internationale de Psychopathologie et Psychodynamique du Travail», 30, pp. 17-47.
Fischbach, F., Renault, E. (2022). Philosophie du travail. Activité, technicité, normativité, Libraire Philosophique J. Vrin, Paris.
Rifkin, J. (1995). La fine del lavoro. Il declino della forza lavoro globale e l'avvento del post-mercato, Baldini & Castoldi, Milano.
Negri, A. (1980-1981). Filosofia del lavoro. Storia antologica (7 volumi), Marzorati Editore, Milano.
Postone, M. (1993). Time, Labor and Social Domination: A Reinterpretation of Marx's Critical Theory, Cambridge University Press, New York and Cambridge.
-
PK#16 \ Meditazioni sull’amore
Rivista / Maggio 2022Come l’essere, anche l’amore si dice in molti modi. Diverse sono le grammatiche dell’amore, e diverse sono le fenomenologie dell’esperienza amorosa. Complicati sono pure i fili che annodano le grammatiche dell’amore, che permettono cioè di raccontare le storie d’amore, con le esperienze amorose, le quali, anche quando si dicono nella parola non pronunciata dell’estasi erotica o nel silenzio che accompagna il lutto dovuto alla perdita dell’oggetto amato, sono sempre tese verso il loro dirsi, verso una narrazione possibile. Purificare, o emendare, tali grammatiche non è impresa facile, ma, riconoscendo che in molte di esse si cela la presenza – a volte nemmeno tanto nascosta – del dominio maschile o patriarcale, è per lo meno auspicabile fornirne una decostruzione.

Like being, love is said in many ways. There are different grammars of love, and different phenomenologies of love experience. The threads that bind the grammars of love are also complex, and even when they are said in the unspoken words of erotic ecstasy or in the silence that accompanies the mourning due to the loss of the beloved object, they are always stretched towards their own saying, towards a possible narration. Purifying or amending these grammars is not an easy task, but recognising that many of them conceal the presence - sometimes not even so hidden - of male or patriarchal domination, it is at least desirable to provide a deconstruction.
A cura di Veronica Cavedagna e Giovanni Leghissa
Scarica PDF
English version
DOI: https://doi.org/10.13135/2385-1945/16.2022
Pubblicato: marzo 2022
Indice
EDITORIALE
I. TEORIE D'AMORE
Nicoletta Cusano - Amor, ch’a nullo amante amar perdona… [PDF It]
Sergio Benvenuto - Una sfida per la filosofia [PDF It]
Mara Montanaro - Uno scambio di fantasmi [PDF It]
Andrea Zoppis - L’amore al vaglio della contingenza. Note sulla relazione amorosa a partire da Merleau- Ponty e Simondon [PDF It]
Prisca Amoroso - Custodire la distanza. Una riflessione sulla profondità come dimensione amorosa a partire da François Jullien [PDF It]
Benoît Monginot - Figures, désir, dérive. Eros et poétique dans « Sed non satiata » de Charles Baudelaire [PDF Fr]
II. GLI SPAZI DELL'AMORE
Chiara Piazzesi - Towards a Sociological Understanding of Love: Insights from Research [PDF En]
Francesca Caiazzo - La temporalité de l’expérience amoureuse moderne à partir des apports d’Eva Illouz [PDF Fr]
Carlo Deregibus - Gli spazi dimenticati dell’eros. Progettare occasioni di spontaneità [PDF It]
III. RESISTENZE
Manon Garcia - Dall’oppressione all’indipendenza. La filosofia dell’amore nel "Il Secondo sesso" di Simone de Beauvoir [PDF It]
Veronica Maio - Amore clitorideo. Esperienza amorosa e sovversione dell’identità sessuale nell’autocoscienza di Carla Lonzi [PDF It]
Floriana Ferro - Beauty and Possession. Reversible Eros [PDF En]
IV. MODI DI SIGNIFICARE
Gianni Pellegrini - Chiodo scaccia chiodi! Spigolature dalle tradizioni intellettuali sud-asiatiche sull’amore e/o desiderio (kāma) come antidoto ai desideri [PDF It]
V. LETTURE, RILETTURE E TESTIMONIANZE
Chiara Pignatti, Marco Xerra - Godere di dio. La posizione mistica tra devastazione e amore [PDF It]
Noemi Magerand - « Se faire la complice d’un ordre qui nous opprime » : comment Réinventer l’amour avec Mona Chollet [PDF Fr]
Emilia Marra - De gli erotici furori: amore e relazioni nel nuovo abitare [PDF It]
-
Bernard Stiegler e la miseria simbolica
Recensioni / Aprile 2022Non c’è evoluzione tecnologica senza che, nel più profondo, avvenga una mutazione del capitalismo
G. Deleuze, Proscritto alle società di controlloPer cogliere il senso complessivo del denso lavoro di Bernard Stiegler, La miseria simbolica. L’epoca iperindustriale 1 (Meltemi, 2021) iniziamo con l’interrogare i termini che compongono il titolo dell’opera. In cosa consiste per l’autore “la miseria simbolica” che caratterizza le nostre società in quella che egli definisce l’“epoca iperindustriale?”
«La nostra epoca – scrive Stiegler – si caratterizza come presa di controllo del simbolico da parte della tecnologia industriale, laddove l’estetica è diventata al contempo l’arma e il teatro della guerra economica» (p. 25). L’effetto di un tale conflitto sugli individui è la miseria simbolica, vale a dire «la perdita di individuazione derivante a sua volta dalla perdita di partecipazione alla produzione di simboli, designanti, questi, tanto i frutti della vita intellettiva (concetti, idee, teoremi, saperi) che quelli della vita sensibile (arti, saper-fare, costumi)» (p. 38).
Come l’autore annuncia nella Prefazione, il testo va considerato come un commento al Proscritto sulle società di controllo (in Pourparler, Quodlibet, 2019) di Gilles Deleuze. In quelle poche pagine, com’è ben noto, Deleuze sostiene che le “società disciplinari” analizzate da Michel Foucault, con l’organizzazione dei grandi ambienti di internamento (famiglia, scuola, fabbrica, ospedale, carcere) che caratterizza la loro logica, e storicamente collocabili tra il XVIII e l’inizio del XX sec., siano ormai state sostituite dalle società di controllo, la cui peculiarità consiste nell’estensione, nell’intensificazione e nella complessificazione della logica dei processi distintivi della rivoluzione industriale applicati anche alla sfera simbolica del desiderio. Nell’attuale forma di capitalismo, che Stiegler definisce con Jeremy Rifkin «culturale» (p. 83), la dimensione estetica – qui intesa in senso ampio come dimensione del sentire in generale, e nella quale soltanto è possibile costituire un “io” e un “noi” a partire da un pathos comune – viene sistematicamente presa nelle maglie del calcolo, il cui dominio, anche grazie al recente processo di digitalizzazione, si è esteso ormai ben al di là della sfera della produzione, «nella integralità dei dispositivi caratteristici di ciò che Simondon chiama l’individuazione psichica e collettiva» (p. 82).
Nell’epoca iperindustriale la legge del capitale non è più la produzione, ma «il marketing in quanto controllo dei tempi di coscienza e dei corpi attraverso la macchinazione della vita quotidiana» (p. 83), così come il luogo paradigmatico non è più la fabbrica, ma l’impresa. L’iperindustrializzazione – è questa la tesi di Stiegler – ha dunque un riscontro paradossale: da un lato fa apparire una nuova immagine dell’individuo, il consumatore, dall’altro la generalizzazione del calcolo impedisce, o quantomeno ostacola fortemente, il processo di individuazione stesso che, solo, rende l’individuo possibile.
Del saggio deleuziano, Stiegler non condivide soltanto l’analisi insieme storica e logica relativa all’insediamento progressivo di un nuovo regime di dominazione, quello, cioè, caratteristico delle società di controllo, e che comporta una notevole perdita di individuazione, vale a dire la miseria simbolica, ma fa pienamente suo, se così possiamo esprimerci, anche lo spirito politico battagliero, che anima quelle pagine e che ben si esprime in queste parole, che lo stesso Stiegler cita: «Non è il caso né di avere paura né di sperare, bisogna cercare nuove armi» (Deleuze, 2019, p. 235). Come ben specifica Rosella Corda nell’Introduzione, il lavoro di Stiegler non si limita infatti «alla costatazione sterile o alla rassegnazione diagnostica», ma si pone l’obiettivo di trovare, «proprio in questo disperare, mancare di speranza, un po’ di possibile» (Stiegler, 2021, p. 9)
La questione delle armi, come esplicitamente afferma l’autore, è la «questione della tecnica in generale» – ovvero la questione cardine su cui ruota tutta l’opera di Stiegler fin dal suo primo lavoro La technique et le temps 1. La faute d’Épimethée, –, la quale è anche questione del politico, questione, cioè, «del destino di un noi» (Stiegler 2021, p. 38). La questione della tèchne, che, ricordiamolo, per Stiegler è un pharmakon, vale a dire insieme veleno e antidoto, si articola qui nell’ipotesi di un’organologia generale, la quale si pone l’obiettivo di indagare, dal punto di vista di una prospettiva antropologico-filosofica, la genesi del processo di ominazione. La domanda a cui l’organologia risponde è dunque una domanda sulla seconda natura dell’uomo, vale a dire sulla natura “originariamente” protesica, e cioè tecnica, dell’uomo. Un’adeguata interrogazione della secondarietà che contraddistingue l’umano rappresenta una condizione senza la quale non è possibile comprendere l’epoca attuale e la sua miseria simbolica, né risulta possibile – ed è questo ciò che più conta per Stiegler – indicare delle vie alternative a tale stato di miseria.
Il progetto di un’organologia generale prevede lo studio congiunto di quelle che Stiegler considera le «tre grandi organizzazioni che formano la potenza estetica dell’uomo: il suo corpo con la sua organizzazione fisiologica, i suoi organi artificiali (tecniche, oggetti, utensili, strumenti, opere d’arte) e le sue organizzazioni sociali che risultano dalla articolazione degli artefatti e dei corpi (pp. 31-32)». Il concetto chiave su cui l’autore costruisce tale progetto è il concetto di ritenzione terziaria, il quale, a differenza dei concetti di ritenzione primaria e di ritenzione secondaria con i quali Husserl indicava rispettivamente la dimensione della percezione e la dimensione dell’immaginazione, indica la dimensione artificiale della produzione da parte dell’uomo di oggetti di memoria esteriorizzata, come ad es. lo smartphone, i libri, gli edifici, le targhe commemorative, i film.
Nel terzo capitolo del libro “Allegoria del formicaio. La perdita di individuazione nell’epoca iperindustriale”, Stiegler ricostruisce per tappe storiche il processo di produzione delle ritenzioni terziarie, che egli chiama epifilogenesi. «L’ambiente epifilogenetico – scrive l’autore – come insieme delle ritenzioni terziarie costituisce il supporto dell’ambiente preindividuale permettendo l’individuazione del genere» (p. 89). Essendo l’epifilogensi il «deposito di memoria che è specifico di una forma di vita unica, quella del genere umano» (p. 66), ed essendo la natura dell’uomo già da sempre tecnica, la storia dell’epifilogenesi segna le tappe dell’individuazione dell’uomo, in particolare dell’uomo occidentale. Senza poter approfondire i vari passaggi che caratterizzano questa storia, che è anche la storia di una lotta per la definizione delle criteriologie dei dispositivi ritenzionali («processo di grammatizzazione», p. 90), ci preme mettere in luce il fatto che secondo Stiegler questo processo ha raggiunto un punto limite nell’epoca iperindustriale. Il processo di individuazione rischia cioè di annullarsi in favore di una «ipersincronizzazione» (p. 96) – ben resa dall’allegoria del formicaio – in cui la differenza tra “io” e “noi” collassa nel “si”, ovvero in quella condizione che Stiegler chiama anche di «mal-essere» (p. 98), tale per cui gli individui, non avendo più accesso alla produzione di simboli, perdono la loro singolarità e la correlata possibilità di proiettarsi in un “noi” e, dunque, in una dimensione politica. Privati di singolarità, gli individui cercano di singolarizzarsi mediante gli artefatti che il mercato mette loro a disposizione, il quale sfrutta la miseria propria del consumo stesso, e così facendo fanno esperienza del loro fallimento: «non si amano più e si rivelano sempre meno capaci di amare» (p. 99).
Concediamoci ora una considerazione generale sul senso dell’opera di un autore come Stiegler. Se ci soffermassimo soltanto sul lato diagnostico, sulla pars destruens del suo discorso correremmo il rischio di eludere l’aspetto più rilevante dello sforzo intellettuale – e non solo – dell’opera e della vita di Stiegler, il quale riguarda l’impegno con cui l’autore ha da sempre tentato di rispondere alla domanda: “che fare?”. Se infatti considerassimo solo l’aspetto analitico della sua opera, finiremmo per giudicare Stiegler, come pure è stato fatto soprattutto dopo la pubblicazione de La società automatica. 1. L’avvenire del lavoro (Meltemi, 2019), un autore catastrofista. Per quanto la situazione diagnosticata dall’autore sia effettivamente catastrofica, Stiegler, come si è detto, non cede nemmeno per un attimo al catastrofismo. È questo un punto battuto da tutti i curatori delle edizioni italiane recenti delle opere di Stiegler, sulla cui insistenza, potremmo dire, Meltemi ha costruito la cifra peculiare della sua operazione editoriale, che ha portato alla pubblicazione dei due volumi sulla miseria simbolica (Stiegler, 2021; La miseria simbolica. 2. La catastrofe del sentire) e a quello sulla società automatica (Stiegler, 2019) nella serie “Culture radicali” diretta da Gruppo Ippolita.
Come scrive Giuseppe Allegri in un articolo online su OPERAVIVA dal titolo Dentro, oltre e contro la società automatica, «il ricercare e l’agire di Stiegler si oppone radicalmente a qualsiasi visione apocalittica che altri rintracciano nel suo pensiero, del tutto inspiegabilmente e proprio leggendo il volume sulla Società automatica, mentre la postura del Nostro è anche e soprattutto quella progettuale e sperimentale, per la promozione e il sostegno di collettivi di ricerca che coinvolgano e che già coinvolgono ampi spezzoni di società, associazionismo di base e frammenti di classe dirigente, disposti ad accettare e orientare la trasformazione tecno-digitale e socio-economica nel senso di un ripensamento radicale delle categorie e delle pratiche sociali per maggiore autodeterminazione, dignità, felicità in favore dei molti» (https://operavivamagazine.org/dentro-oltre-e-contro-la-societa-automatica/). Lo stesso Allegri, autore della postfazione al testo qui recensito, e significativamente titolata Ricchezza delle pratiche inventive, fa un lungo elenco delle attività che hanno impegnato Stiegler dalla fine degli anni Novanta fino alla sua scomparsa nell’agosto del 2020, e che lo hanno coinvolto nella fondazione di «nuove istituzioni», quali, tra le molte altre, citiamo Ars Industrialis, «la cui “ragione sociale” è quella di un’associazione europea per una politica industriale delle tecnologie dello spirito», o «IRI – Institute pour la Recherche et l’Innovation presso il Centre Pompidou, all’interno del quale è riuscito a promuovere una rete di Digital Studies inaugurata nel 2012»,o che lo hanno visto collaborare al «progetto avviato nel maggio 2016 di Territoire Apprenant Contributif, che coinvolge i 9 comuni di Paris Nord/Seine-Saint-Denis» (pp. 160-161).
Specificamente per quel che riguarda La miseria simbolica 1. L’epoca iperindustriale, in tutte le pagine che compongono i quattro capitoli del libro, finanche nei punti in cui la disperazione emerge in maniera più forte, e, anzi, soprattutto lì, la domanda sul “che fare?” e la ricerca continua di quella che con una bella espressione Stiegler definisce l’«energia zoppicante della chance» (p. 124) non scompaiono mai dall’orizzonte. In particolare, si ha un riscontro evidente dell’insistenza con cui Stiegler si spende per “cercare nuove armi” nell’analisi dei due film On connaît la chanson di Alain Resnais e Tiresia di Bertrand Bonello, che egli conduce rispettivamente nel secondo (Come se ci mancassimo o di come trovare delle armi a partire da Parole parole parole… (On connaît la chanson) di Alain Resnais”) e nel quarto capitolo (“Tiresia e la guerra del tempo. A proposito di un film di Bertrand Bonello”) del testo.
Nel film di Resnais il nostro autore trova esemplarmente tracciata, nel modo in cui il regista compone e scompone cliché attraverso l’utilizzo della tecnica del sampling e più specificamente attraverso la ripetizione ventriloqua che i personaggi si trovano a fare dei ritornelli di alcune famosissime canzoni francesi, la via «per una nuova capacità di immaginare/sentire» (p. 15), che prenda le mosse proprio da quel processo che fa scomparire la differenza tra “io” e “noi” nel “si”, ma tentando di invertirne la direzione.
di Gian Marco Galasso