-
-
Alenka Zupančič – Che cosa è il sesso?
Recensioni / Maggio 2019 Che cosa è il Sesso? (trad. di P. Bianchi, Ponte alle Grazie, Genova 2018), ultima opera della filosofa slovena Alenka Zupančič, già autrice di lavori su Kant, Nietzche e Lacan, è un testo che raccoglie anni di riflessione sulla psicoanalisi freudo-lacaniana e che si pone la sfida di affrontare la sessualità come una questione intimamente ontologica. Lo scopo di Zupančič non è però quello di “recuperare” la psicoanalisi di Freud e Lacan e dare a essa uno statuto ontologico che nobiliti la disciplina psicoanalitica (che sicuramente ha sempre subito accuse di pseudoscientificità e determinismo sessuale). Quello di Zupančič non è neanche (o non solo) un tentativo di rispondere alle domande della filosofia con la psicoanalisi né una sua difesa acritica; anzi, la posizione della filosofa slovena è conflittuale anche internamente al discorso psicoanalitico, portando al centro una delle questioni che sono state problematiche sin dagli esordi freudiani – appunto, la sessualità. Il sesso di cui ci parla Zupančič non è semplicemente l’insieme di pratiche sessuali, a cui fornire uno statuto ontologico maneggevole che ci risollevi immaginariamente dagli imbarazzi e angosce che questa dimensione ha scatenato nel tempo; piuttosto la filosofa vuole andare a svelare quanto il sesso sia proprio quella faglia o mancanza strutturale che permette al soggetto di diventare tale. Il sesso protagonista di questo libro non è una presunta naturalità che dovremmo accettare, ma è esattamente quella dimensione “disontologica” e “disorientante” che fa che sì che emerga un soggetto e, quindi, un inconscio.
Che cosa è il Sesso? (trad. di P. Bianchi, Ponte alle Grazie, Genova 2018), ultima opera della filosofa slovena Alenka Zupančič, già autrice di lavori su Kant, Nietzche e Lacan, è un testo che raccoglie anni di riflessione sulla psicoanalisi freudo-lacaniana e che si pone la sfida di affrontare la sessualità come una questione intimamente ontologica. Lo scopo di Zupančič non è però quello di “recuperare” la psicoanalisi di Freud e Lacan e dare a essa uno statuto ontologico che nobiliti la disciplina psicoanalitica (che sicuramente ha sempre subito accuse di pseudoscientificità e determinismo sessuale). Quello di Zupančič non è neanche (o non solo) un tentativo di rispondere alle domande della filosofia con la psicoanalisi né una sua difesa acritica; anzi, la posizione della filosofa slovena è conflittuale anche internamente al discorso psicoanalitico, portando al centro una delle questioni che sono state problematiche sin dagli esordi freudiani – appunto, la sessualità. Il sesso di cui ci parla Zupančič non è semplicemente l’insieme di pratiche sessuali, a cui fornire uno statuto ontologico maneggevole che ci risollevi immaginariamente dagli imbarazzi e angosce che questa dimensione ha scatenato nel tempo; piuttosto la filosofa vuole andare a svelare quanto il sesso sia proprio quella faglia o mancanza strutturale che permette al soggetto di diventare tale. Il sesso protagonista di questo libro non è una presunta naturalità che dovremmo accettare, ma è esattamente quella dimensione “disontologica” e “disorientante” che fa che sì che emerga un soggetto e, quindi, un inconscio.
Santa Lucia di Domenico Beccafumi, utilizzato dall’autrice nel testo per mostrare la perversione della pulsione nel cristianesimo
Non è un caso, infatti – e Zupančič lo sottolinea continuamente nel testo – che Freud abbia sempre così insistito sulla centralità del Sesso nella psicoanalisi e che i suoi primi allievi, come Jung e Adler, abbiano sempre e sistematicamente reagito su questo punto. Ancora oggi la questione della sessualità rimane problematica e fa spesso da confine fra le varie correnti psicoanalitiche. André Green, nel 1995, pone una domanda apparentemente banale per la disciplina: “la sessualità ha ancora a che fare con la psicoanalisi?”. La questione, difatti, non è scontata: se in Europa (soprattutto in Francia) le nozioni di sessualità e pulsione avevano continuato a godere di un certo successo, oltreoceano invece la psicoanalisi aveva fatto vertere la propria pratica e la teoria verso concetti come quello di Sé e di Relazione. A dare ulteriore conferma del rapporto problematico della psicoanalisi con la sessualità, è una ricerca di Shalev e Yerushalmi (2009), ripresa anche da Zupančič, dove gli autori intervistano 10 psicoanalisti riguardo la tematica della sessualità in psicoterapia: ne emerge una generale e diffusa rimozione, e addirittura imbarazzo da buona parte dei clinici. La primigenia scoperta di Freud, la sessualità, piuttosto che essere l’elemento unificante delle varie divisioni e diaspore psicoanalitiche, è proprio il seme della discordia.
La domanda “Che cosa è il sesso?” – che, come abbiamo visto, è problematica anche per la stessa psicoanalisi – diventa il fil rouge per affrontare in maniera inedita e “rumorosa” domande classiche dell’ontologia. Non è senza peso che Freud, che aveva sempre cercato di tenersi distante dai riferimenti filosofici, in Endliche und Unendliche Analyse (1937) abbia riconosciuto proprio alla sessualità (come alla questione della pulsione di morte) un’origine filosofica nel dualismo empedocleo fra Eros e Neikos, che, sempre secondo Freud, avrebbe lavorato come criptomnesia inconscia. Ma in che misura il sesso (o meglio, l’interrogazione continua su quel punto di frattura e di inciampo che è il sesso) può funzionare come vettore nella lettura dei problemi dell’ontologia, del soggetto e della politica contemporanei? Non si tratta di ribadire, per Zupančič, semplicemente che il sesso c’è e che nasconderebbe in Sé quel senso e quella verità che tanto gli esseri umani si affannerebbero a cercare. Su questo la filosofa è chiara: il sesso non è “l’ultimo orizzonte del senso e della realtà”, qualcosa che semplicemente si può ritrovare dopo aver grattato la patina delle apparenze, eppure il Sesso è qualcosa di Reale. Ma questo Reale, ricavato dalle elaborazioni di Lacan, su cui tanto insiste Zupančič, non è la realtà dei filosofi, un orizzonte ontologico-epistemologico neutro e quasi rassicurante, piuttosto il Reale è, della realtà, quel nocciolo che resiste a ogni forma di simbolizzazione e ontologizzazione. Il Reale è esattamente ciò che viene tagliato fuori dall’Essere-in-quanto-essere perché sia possibile descriverlo e parlarne, e allo stesso tempo è quella dimensione che curva lo spazio ontologico dell’Essere. Non è un caso che sia Lacan sia Zupančič insistano tanto sulla sessualità di questo Reale, ed è l’inconscio il concetto che permette loro di giustificare questa insistenza. L’inconscio sessuale non è luogo di rimozione di un’istintività animale che “farebbe ritorno” in maniera disturbante, ma piuttosto un gap, un buco strutturale nel soggetto, che lo frattura dall’interno. Questo buco o negatività non è semplicemente un’assenza o uno zero, ma una quantità negativa (di eredità kantiana), inassimilabile e disgregante che funziona come luogo di emergenza del soggetto. Una crepa non è un niente, anzi conta spesso più dei muri, e il sesso è esattamente la crepa che divide i soggetti internamente. È in questo senso che la ripresa delle tavole della sessuazione lacaniana non serve a reiterare la formula della differenza sessuale, bensì a mostrare come essa lavori come operatore simbolico, tagliando il soggetto da dentro, piuttosto che dividendo i soggetti in due sessi o generi determinati fra di loro da un fantasmagorico rapporto sessuale (che non c’è). La sessualità, l’inconscio, il godimento e il Reale sono tutti nomi di ciò in cui il soggetto cartesiano inciampa svelando la frattura che lo domina dall’interno. Zupančič , riprendendo la questione lasciata aperta da Lacan (1973) nel Seminario XI su una sua possibile (para)-ontologia, in cui vi sarebbe una schisi fra l’Essere e il suo Reale, contribuisce a radicalizzare, anche in risposta ai progetti delle Object-Oriented Ontologies, nelle quali il soggetto tende a confondersi neutralmente con gli oggetti in una sorta di democrazia ontologica, l’immagine di un’ontologia dis-orientata agli oggetti, dove, invece, il soggetto continua a essere la frattura e l’alienazione scritta nel tessuto della realtà. Ed è proprio uno dei concetti fondamentali della psicoanalisi, la pulsione, a permettere la costruzione di una topologia del soggetto estimo, in cui i confini fra interiorità e esteriorità si deformano e l’oggetto (il famoso oggetto piccolo a lacaniano) si incista dentro il soggetto. Certo, parlare di pulsioni significa anche riportare all’attenzione antagonismi e conflitti rimossi o appiattiti in seno ai discorsi contemporanei.

Francis Bacon, Lying Figure
Si può dire che ciò che pone le basi del progetto (dis)ontologico di Zupančič sia proprio questa nozione di pulsione. Infatti, Zupančič riprende e rianalizza il Trieb freudiano, le cui vicissitudini di significante lo hanno portato ad essere tradotto e rinaturalizzato come istinto. Invece, ciò su cui insiste, a ragione, la filosofa slovena, è proprio l’innaturalità della pulsione, che poco ha a che fare con eventuali istinti biologico-riproduttivi: essa si produce piuttosto come scarto di godimento nel lavoro del corpo, eccedenza che ritorna sul soggetto, lavorando sui suoi bordi. E non è un caso che Zupančič riprenda quella sezione del Seminario XI dove Lacan parla della pulsione come “farsi vedere”, “farsi cacare”, “farsi masturbare”: pulsione è ritorno del godimento del soggetto, nelle parole di Freud “una bocca che si bacia da sola”. Nel bambino attaccarsi al seno non è semplicemente la soddisfazione di un istinto dell’ordine del nutrimento, ma si produce un resto di godimento, un’eccedenza “libera” nel neo-soggetto. Certo, come dice la filosofa, “con la soddisfazione in eccesso non si può ancora parlare di pulsione” (p. 156) ma è necessario che la soddisfazione inizi “a funzionare, allo stesso tempo, come incarnazione oggettiva […] del negativo e come gap implicito nell’edificio significante dell’essere” (p. 157). Allora la pulsione è proprio il rappresentante di questo negativo interno al soggetto, ne diviene la figura (dis)ontologica centrale. La pulsione è per definizione parziale e frammentaria: non ha un Eden perduto verso il quale tornare né una “teleologia” pulsionale. Non esiste, dunque, un carattere genitale maturo a cui il soggetto dovrebbe tendere. L’impasto pulsionale è sempre un azzardo, un incastro sregolato e polimorfo: “se c’è qualcosa cui la pulsione assomiglia, è a un montaggio” (Lacan, 1973 p. 172). Non c’è sessualità né desiderio normale (ma al massimo normalizzabile) proprio perché queste dimensioni non hanno una forma precisa alle quali le pulsioni si dovrebbero adattare. L’incastro è sempre necessariamente contingente, idiosincratico. E proprio a partire da questa ripresa della pulsione, Zupančič apre una possibilità (psicoanalitica) di ricucire la ferita aperta fra i queer studies e la psicoanalisi, mostrando il volto “anarchico” e “polimorfo” delle pulsioni e cercando di sollevare la psicoanalisi da quella posizione “normalizzatrice” di cui spesso è stata accusata (e di cui di fatto è stata responsabile in molti casi).
Altro merito della filosofa è quello che, seguendo il percorso della pulsione sessuale, fra Freud, Lacan e Deleuze, viene ritrovata la tanto temuta pulsione di morte. Come sostiene Lacan stesso: “Come stupirsi che il suo termine ultimo sia la morte? Poiché la presenza del sesso nel vivente è legata alla morte” (Lacan, 1973 p. 180). L’essere umano non è la lamella lacaniana, il mitico essere scissiparo e immortale: per noi la condizione della divisione sessuata implica la morte del soggetto individuale. L’equazione è questa: dove il soggetto è sessuato, significa che il soggetto deve morire. Allora, di nuovo con un gioco topologico, una condensazione si verifica: cercando il sesso sul nastro di Möbius, questo viene incontrato nel luogo della morte. Non solo, la pulsione di morte, primaria rispetto al brulichio delle pulsioni sessuali ci appare proprio come quell’incrinatura, quella contraddizione, “singolarità unificante” dalla quale le pulsioni emergono e alla quale ritornano: “Presa a questo livello, la sessualità è davvero sinonimo di pulsione di morte e non è un suo opposto come Eros con Thanatos.” (p. 176)
Se il lavoro di Zupančič è proprio quello di svelare filosoficamente le contraddizioni inerenti il soggetto (il sesso, la morte, l’inconscio, il Reale), allora proprio questo soggetto è “l’incarnazione oggettiva di questa contraddizione nella realtà” (p. 185). Per la filosofa incontrare la paradossalità della contraddizione non significa, però, doversi abbandonare a un atteggiamento scettico o cinico; si tratta, piuttosto, di accettare la contraddizione proprio come quel Reale accessibile al pensiero, di pensare la contraddizione, come gli stessi matemi lacaniani hanno fatto, portando la logica ai suoi punti di frattura e rendendo disponibile al pensiero, paradossalmente formalizzata, la contraddizione.

Francis Bacon, Three Studies for Figures at the Base of Crucifixion 2
What is Sex? è un libro originale, radicale e coraggioso per la forza con cui l’autrice invita a affrontare, pensare e concepire la contraddizione e il conflitto (e l’invito non è rivolto solo a filosofi e psicoanalisti, poiché la filosofa ha la capacità di sciogliere nodi intricati con battute immediatamente comprensibili). Chi volesse cercare qui una risposta alla domanda “cosa è il sesso” nel senso più rassicurante e definitivo di certo si troverebbe deluso, perché questo interrogativo diventa piuttosto l’intelaiatura di una riflessione filosofica che vuole prendere di petto tutte quelle contraddizioni, quei conflitti e quelle fratture che la psicoanalisi ha saputo riconoscere (e che, in molti casi, ha saputo anche dimenticare e rimuovere) nel soggetto, nella sessualità, nella morte, nell’inconscio e nell’ambiguità del legame sociale. In questo senso Che cosa è il Sesso? è anche un testo esplicitamente politico, che ci porta nuovamente di fronte quell’antagonismo strutturale che anima e agita la società dal suo interno, facendoci guardare con sospetto dove e quando il Rapporto (sessuale) e la Relazione sono state scritte con la R maiuscola, ponendo proporzioni “sacre” e determinate fra classi, sessi, popoli. Alenka Zupančič ci insegna a guardare con diffidenza chi istituisce questo rapporto in maniera ferrea (come i sistemi dittatoriali), ma anche chi tende a nascondere il conflitto insito nella relazione, neutralizzandolo nell’Etica. La filosofa, infatti, leggendo in chiave politica il famoso ed enigmatico detto di Lacan “non c’è rapporto sessuale”, ci restituisce l’immagine di un rapporto senza prototipo o modello ideale, ma che può sorgere, ogni volta nuovo e da ricostruire, sotto la “necessità” della contingenza, dell’idiosincrasia degli incontri fra i soggetti e nei conflitti che si generano dentro e fra i soggetti. Insomma, una prospettiva che ci fa assumere la responsabilità della contraddizione, piuttosto che negarla o rimuoverla, della frattura che ci domina da dentro e che noi incarniamo nel mondo anche in una dimensione autenticamente politica e trasformativa.
di Lorenzo Curti
Bibliografia:
Freud, S. (1937) Analisi terminabile e interminabile.Trad. it. R. Colorni. OSF Vol. XI. Torino: Bollati Boringhieri
Green, A. (1995) Has sexuality anything to do with psychoanalysis? International Journal of Psychoanalysis78: 871-883
Lacan, J (1973). Seminario: Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi. Trad. it. S. Loaldi e I. Molina. Torino: Einaudi, 1979
Shalev, O. & Yerushalmi, H. (2009) Status of sexuality in contemporary psychoanalytic psychotherapy as reported by therapists. Psychoanalytic Psychology, Vol. 26, No. 4, 343–361
Zupančič, A. (2018) Che cosa è il sesso?. Tr. it. P. Bianchi. Milano: Ponte alle Grazie.
-
«L’uomo, senza utopia, precipita nell’inferno di una quotidianità che lo espropria di ogni significato e lo uccide poco a poco; ma non appena mette mano alla realizzazione di quella utopia, al tempo stesso prepara le condizioni per una quotidianità sempre più atroce». Così, più di vent’anni fa, il matematico, mediattivista e futurologo prematuramente scomparso nel 2013 Antonio Caronia (1996, p. 58), riassumeva il nesso inscindibile che lega, come in un inquietante nastro di Moebius, le utopie alle distopie. Se l’utopia veniva, infatti, poco più di 500 anni fa, pensata – e in qualche modo “inventata” come genere letterario – da Thomas More come un “non-luogo” dove creare, tramite un esperimento mentale, una società ideale, paradigmatica, che funzioni da critica e da modello per i modelli socio-politici a lui contemporanei; dopo il crollo delle “utopie reali” del XX secolo parlare di utopie è diventato assolutamente demodé, per non dire politicamente sospetto.
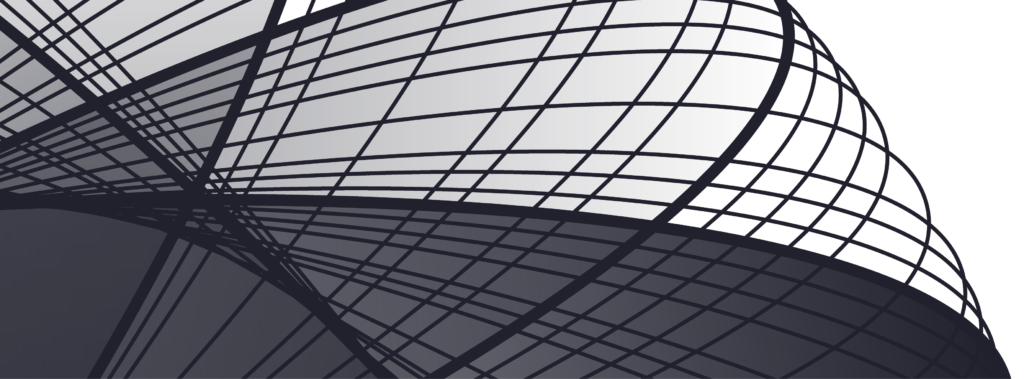
Eppure la rivendicazione dell’utopia come spazio per sfuggire all’inferno del reale, o di quel “Reale”, di cui l’onda lunga del lacanismo politico, da Zizek a Badiou, ha fatto l’oggetto principale della propria “passione”, resta ben presente nell’immaginario collettivo, così come lo era ancora ancora, anche a livello politico, nei propositi di Ernst Bloch. Un mondo ideale, dai tratti fantasmati, o fantasmatici, resta il telos di molte narrative della contemporaneità di grande successo: romanzi, serie televisive, produzioni cinematografiche spesso presentano e rappresentano mondi ideali dal forte potenziale di identificazione. Questo potenziale, però, come Caronia già nel 1996 rilevava, tende ad assumere rapidamente caratteri distopici: se le utopie rinascimentali (quella di Moro come la città del Sole di Campanella, quanto la Christianopolis di Andreae) appaiono al lettore odierno fortemente (pur involontariamente) distopiche, le “utopie” contemporanee, soprattutto quelle elaborate dopo le due Guerre Mondiali, appaiono sempre come utopie “di facciata”, che nascondono tratti distopici totalitari, eugenetici, bio- e tanatopolitici. Nelle distopie della letteratura sci-fi dagli anni ’60 fino a oggi, ma pure nei mondi post-apocalittici popolati da gruppi di uomini tornati allo stato di natura di molte narrazioni seriali e videogames, sembra che il potenziale critico dell’utopia sia stato mantenuto, rovesciando però il suo segno distintivo da positivo a negativo, andando così di pari passo con sfiducia per la ragione tipica dell’epoca che va dal Dopoguerra a oggi.
A cura di Antonio Lucci e Mario Tirino
Scarica PDF
English version
DOI: https://doi.org/10.13135/2385-1945/10.2019
Pubblicato: marzo 2019
Indice
Editoriale
A. Lucci, M. Tirino - Filosofia, narrazioni, media [PDF It]
Sezione I: Archeologie del futuro, genealogie del presente
G. De Matteo, S. Proietti - Altri spazi, in controtempo: letture e visioni dalle nuove frontiere della fantascienza [PDF It]
A. Amendola - La visione distopica di Philip K. Dick. Indagine su "The Man in The High Castle": dal romanzo al processo seriale [PDF It]
D. Comberiati - L’anno 3000 di Paolo Mantegazza. L’utopia scientifica al servizio del progresso coloniale [PDF It]
A. Fattori - Pietra, ferro, fuoco, ombra: città nere da Magdeburg a Los(t) Angeles Patatopia. Una scienza degli spazi-tempi immaginari [PDF It]
Sezione 2: Utopie, Distopie, Eterotopie: pensare spazi e tempi altri
G. Didino - Mondi dentro mondi. Eterotopie e iperoggetti nella narrativa di Kim Stanley Robinson [PDF It]
L. Palombini - Note per un’eterotopologia del punk cibernetico [PDF It]
M. Bergamaschi - Dopo l’utopia. Ipotesi sul cyborg neoliberista a partire dalla serie tv "Black Mirror" [PDF It]
M. Maestrutti, C. Tondo - Il fascino indiscreto del potere. Mondi regressivi e sopravvivenze utopiche [PDF It]
Sezione 3: Film, Romanzo, Videogiochi, Serie Televisive, Videoclip: media e strumenti narrativi alternativi della riflessione filosofica
L. Gineprini - L’utopia egoista nei film di David Lynch: una ribellione contro i limiti della realtà [PDF It]
M. Tirino - Doris Lessing oltre il muro. Catastrofe e trascendenza in "Memoria di una sopravvissuta" [PDF It]
A. Lucci - "Detroit Become Human" e "Horizon Zero Down": fantascienza, narrazioni videoludiche e filosofia dei media [PDF It]
A. Alfieri - “È così che finisce il mondo, non già in un frastuono, ma in un lungo piagnisteo”. Catastrofe e distopia nella nuova serialità narrativa e nell’immaginario videomusicale [PDF It]
APPENDICE
DUSTYEYE - Utopia e Singolarità Tecnologica. Una conversazione tra un transumanista e N. 44° primo androide emotivamente avanzato [PDF It]
-
Carlo Ginzburg – Nondimanco. Machiavelli, Pascal
Recensioni / Febbraio 2019 Vi sono dei momenti nella storia del pensiero saggistico in cui lo studio di un autore o l’esegesi di un’opera sanno trasformarsi in un racconto sapiente capace di srotolare e riannodare, quasi d’improvviso, il filo di idee ritenute immutabili. Nell’ultimo lavoro di Carlo Ginzburg (Nondimanco. Machiavelli, Pascal, Adelphi, Milano, 2018, pp. 242, € 18,00), assistiamo alla storia silenziosa ma incisiva di una parola sottile, larvata, che passo dopo passo guida e rivela al lettore gli intrichi nascosti nel cuore del pensiero politico e filosofico rinascimentali. Formalmente il volume raccoglie nove saggi più un’Appendice. Alcuni di questi, già precedentemente pubblicati, sono stati sottoposti a un processo di riscrittura o traduzione sostanziale da cui scaturisce un’opera per larga parte inedita, dotata di spirito unitario e armonico. Il primo dei saggi raccolti nel volume (Machiavelli, l’eccezione e la regola. Linee di una ricerca in corso) contiene forse quella che può definirsi la novità più dirompente degli ultimi studi machiavelliani. La scoperta riguarda proprio il termine che dà il titolo all’opera: nondimanco. Parente quattrocentesco dell’odierno “nondimeno”, questa semplice congiunzione appare, in realtà, lo specchio di un messaggio potente e arcano. Come un rintocco incalzante, essa fa capolino nei passaggi più intensi delle principali opere machiavelliane, scandendo lo svolgersi dei paragrafi, il susseguirsi dei pensieri, ma soprattutto enfatizzando il ruolo che oppone la regola all’eccezione, la norma generale alla singolarità del caso.
Vi sono dei momenti nella storia del pensiero saggistico in cui lo studio di un autore o l’esegesi di un’opera sanno trasformarsi in un racconto sapiente capace di srotolare e riannodare, quasi d’improvviso, il filo di idee ritenute immutabili. Nell’ultimo lavoro di Carlo Ginzburg (Nondimanco. Machiavelli, Pascal, Adelphi, Milano, 2018, pp. 242, € 18,00), assistiamo alla storia silenziosa ma incisiva di una parola sottile, larvata, che passo dopo passo guida e rivela al lettore gli intrichi nascosti nel cuore del pensiero politico e filosofico rinascimentali. Formalmente il volume raccoglie nove saggi più un’Appendice. Alcuni di questi, già precedentemente pubblicati, sono stati sottoposti a un processo di riscrittura o traduzione sostanziale da cui scaturisce un’opera per larga parte inedita, dotata di spirito unitario e armonico. Il primo dei saggi raccolti nel volume (Machiavelli, l’eccezione e la regola. Linee di una ricerca in corso) contiene forse quella che può definirsi la novità più dirompente degli ultimi studi machiavelliani. La scoperta riguarda proprio il termine che dà il titolo all’opera: nondimanco. Parente quattrocentesco dell’odierno “nondimeno”, questa semplice congiunzione appare, in realtà, lo specchio di un messaggio potente e arcano. Come un rintocco incalzante, essa fa capolino nei passaggi più intensi delle principali opere machiavelliane, scandendo lo svolgersi dei paragrafi, il susseguirsi dei pensieri, ma soprattutto enfatizzando il ruolo che oppone la regola all’eccezione, la norma generale alla singolarità del caso.Un semplice esempio può apparire chiarificatore. In un breve inciso dei Discorsi (iii, 40) concernente l’uso che dell’inganno si fa nelle circostanze di guerra, Machiavelli scrive: «Ancora che lo usare la fraude in ogni azione sia detestabile, nondimanco nel maneggiare la guerra è cosa laudabile e gloriosa».
L’opposizione è chiara: esiste una regola, che ordinariamente va seguita, ma esiste anche l’irruzione del reale, il suo scarto, la sua dinamica intrinseca di eccezionalità, che impone, come contro-regola, la violazione stessa del principio generale. I due argomenti, si badi, viaggiano insieme, ma il secondo («laudabile e glorioso») prevale sempre sul primo.
Ecco dunque che quello che può sembrare un dettaglio insignificante nello stile narrativo di Machiavelli – un avverbio dotato di semplice funzione oppositiva – diviene in realtà il centro di una serie di interrogativi fondamentali. Da dove nasce, infatti, quest’uso? Cosa rappresenta filosoficamente la congiunzione “nondimanco” nell’argomentare specifico di Machiavelli? E quale valenza politico-giuridica assume nell’economia complessiva del suo pensiero?
Ginzburg risolve l’enigma con un gesto preciso e geniale. Analizzando la biblioteca dei volumi di casa Machiavelli, e soffermandosi in particolare sul libro mastro degli acquisti di Bernardo – il papà di Niccolò –, Ginzburg rinviene l’esistenza di un testo misterioso e dimenticato, la Novella intitulum de regulis iuris (nota anche come Quaestiones mercuriales). Opera principale del giurista medievale Giovanni D’Andrea, in essa è racchiuso un breve passaggio in cui l’autore distingue tra princìpi generali (ad esempio, l’usura è condannabile) e deroga ai princìpi imposta dalle circostanze (l’usura è ammissibile). Incredibilmente, nella commedia La Mandragola, Machiavelli utilizzerà questo stesso identico approccio per poi farlo rimbalzare, quasi del tutto intatto, nel corpo testuale de Il Principe.
Ecco così originarsi, da questa semplice ma rivoluzionaria scoperta, il vero fuoco dell’analisi di Ginzburg. “Nondimanco” non opera più come una semplice congiunzione, bensì come termine-concetto, come una soglia capace di incorporare l’eco lontana di un pensiero giuridico-medievale intriso di casi, di eccezioni, di deroghe. Più radicalmente, nondimanco marca l’operare stesso di una cesura: quella che oppone princìpi generali e anomalie, regole e caso serio, canone e precetto pratico. Il giovane Niccolò, erede quattrocentesco di questa tradizione, assimilò appieno lo spirito degli antichi trattati medievali trasmutandone la diegesi casuistica. Ciò che ne scaturirà, come noto, sarà una filosofia di aspetto profondamente diverso, più vigorosa e nervosa forse, di certo pronta per risuonare nelle tumultuose vicende della politica prerinascimentale italiana, ma pur sempre raccolta nel ricordo pulsante della sua antica origine giuridico-canonista.
Ma Nondimanco non è soltanto un saggio che rivolta dal di dentro il pensiero machiavelliano. Esso è anche la storia di una virgola, quella che campeggia nel sottotitolo del volume e che congiunge (o meglio, oppone) la figura del pensatore fiorentino a una, per certi versi, molto più inaspettata.
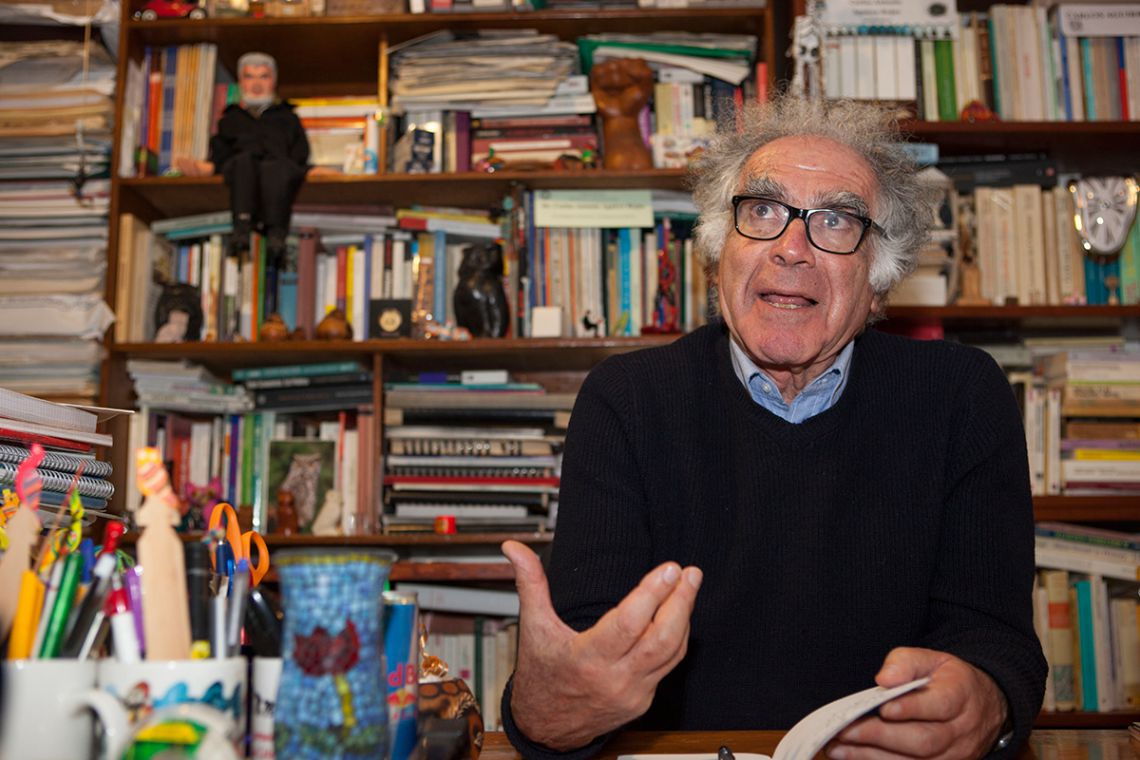
Nelle Provinciali, testo ricolmo di sottilissime ambiguità, sarà infatti proprio Pascal – o meglio il suo alter-ego, Louis de Montalte – a entrare in feroce polemica con la casistica medievale, arrivando financo a sbeffeggiare beffardamente la stessa opinione che si possano dare eccezioni vive contro regole morte. Eppure, intersecando la biografia di Pascal con i suoi più celebri Pensieri, Ginzburg riesce a rilevare l’intima similarità che accomuna il pensatore francese agli insegnamenti machiavelliani. Come si legge in un noto passaggio, «[g]li stati perirebbero se non si facessero piegare spesso le leggi alla necessità, ma la religione non ha mai ceduto a questo e non ne ha approfittato. Perciò occorrono questi adattamenti [accommodements] oppure dei miracoli» (Pensieri, 263). La salvezza di uno stato è consustanziale alla sua emergenza, si potrebbe chiosare. L’exceptio, o gli accommodements, sono ciò che riempie di senso vivo il guscio vuoto e privo di concretezza della regula juris. Anche per Pascal, lontano estimatore di Machiavelli, il miracolo diviene allora il caso serio, il gesto improvviso che squaderna una volontà superiore e dirompente: un emblema dell’eccezione, si potrebbe forse dire, tale e quale a quello che raffigurerà, secoli dopo, Carl Schmitt nella sua Teologia politica (1922; 1934).
Proprio per questo motivo quella piccola virgola incisa impercettibilmente nel sottotitolo del saggio diviene, per Ginzburg, qualcosa di più di una semplice interpunzione. Esattamente come la parola nondimanco, essa racchiude la storia di un’alchimia intellettuale, di un dialogo tra gli anni smarrito e poi ritrovato, condotto nell’esegesi dei documenti antichi, nel perdersi dei cataloghi, degli archivi, delle pagine apparentemente interrotte. In questo incontro mancato ma reso oggi nuovamente possibile, Pascal e Machiavelli sembrano ricomparire sul comune terreno della casuistica e, da lì, dialogare in un rinnovato intrecciarsi di posizioni, di tensioni, di conflitti.
Il merito ultimo del volume di Ginzburg, si può forse concludere, sta nell’incorporare sapientemente la corrispondenza nascosta tra schemi del pensiero, tra autori e filosofie apparentemente inconciliabili, per riordinarli poi attraverso un percorso diverso, non visto, non percepito, eppure da sempre silenziosamente operante. Quello che resta sul tavolo è un saggio denso, articolato e allo stesso fondamentale – un’opera in cui la storiografia critica sa farsi racconto appassionante e l’analisi dei testi e dei documenti antichi abbrivio per una ricerca nuova, coraggiosa, e forse ancora del tutto inesplorata.
di Mauro Balestrieri
-
Enzo Melandri – L’inconscio e la dialettica
Recensioni / Gennaio 2019 Logica, assenza della logica, impossibilità di rinunciare alla logica, conversione alla dialettica e all'analogia. Sono questi i passaggi cruciali compiuti da Enzo Melandri nel saggio L'inconscio e la dialettica, pubblicato per la prima volta nel 1983 e oggi riproposto dalla casa editrice Quodlibet. Melandri ci pone di fronte a una questione decisiva e quanto mai attuale: quella della contraddizione come oggetto. La domanda è duplice: a) si danno oggetti contraddittori, cioè stati di cose che violano il principio di non contraddizione? b) come possiamo conoscere questi oggetti, e quindi formulare un discorso non contraddittorio su di essi? Ogni forma filosofica di dialettica nasce esattamente dal tentativo di rispondere a tali questioni. Il confronto con la psicoanalisi diventa così un banco di prova di estrema importanza, perché «l'inconscio non è semplicemente qualcosa di illogico, d'irrazionale; ma è contraddittorio in sé» (p. 8).
Logica, assenza della logica, impossibilità di rinunciare alla logica, conversione alla dialettica e all'analogia. Sono questi i passaggi cruciali compiuti da Enzo Melandri nel saggio L'inconscio e la dialettica, pubblicato per la prima volta nel 1983 e oggi riproposto dalla casa editrice Quodlibet. Melandri ci pone di fronte a una questione decisiva e quanto mai attuale: quella della contraddizione come oggetto. La domanda è duplice: a) si danno oggetti contraddittori, cioè stati di cose che violano il principio di non contraddizione? b) come possiamo conoscere questi oggetti, e quindi formulare un discorso non contraddittorio su di essi? Ogni forma filosofica di dialettica nasce esattamente dal tentativo di rispondere a tali questioni. Il confronto con la psicoanalisi diventa così un banco di prova di estrema importanza, perché «l'inconscio non è semplicemente qualcosa di illogico, d'irrazionale; ma è contraddittorio in sé» (p. 8).L'incipit del saggio è una constatazione. Mentre la logica formale e le scienze naturali per sopravvivere debbono escludere la contraddizione dal loro oggetto, le scienze sociali tendono ad includere la contraddizione nel loro oggetto, come dimostrano marxismo e psicoanalisi. Non è dunque un caso che il prosieguo del saggio sia una lunga analisi dell'opera dello psicanalista cileno Matte Blanco, che più di ogni altro si è confrontato con il problema della contraddittorietà dell'inconscio cercando nella matematica dell'infinito una risposta convincente a tale enigma. La posizione di Blanco è chiara: «[...] solo se si è sicuri della formulazione perfettamente corretta del nostro concetto, cioè che non trasmetta contraddittorietà per infezione, si potrà eventualmente esaminare quali siano le risultanze di un oggetto intrinsecamente contraddittorio sul piano ontologico» (p. 10) com'è l'inconscio. Per Blanco, la soluzione del problema sta nella possibilità di una traduzione dell'inconscio in termini matematici.
Melandri si accosta al problema compiendo tre digressioni. La prima concerne l'applicazione della matematica e la distinzione di tre forme / gradi di applicabilità della matematica alla realtà: debole (statistica), forte (misura, calcolo, sistema ipotetico-deduttivo, come in fisica) e raffigurativa (la matematica usata in senso metaforico, analogico). La seconda digressione riguarda invece i rapporti tra matematica e psicologia. Secondo Melandri, la matematizzazione in senso forte della psicologia è possibile, ma va compresa in maniera specifica. Una strada è quella dell'applicazione della matematica alla psicologia attraverso la fisica postulando quindi un parallelismo psico-fisico. Le opzioni di fondo sono due: o conformiamo la psicologia alla fisica e al principio di non contraddizione, ma così perdiamo l'essenza della psicologia, ossia la contraddittorietà dell'inconscio; oppure conformiamo la fisica alla psicologia, modificando la nostra visione del mondo fisico-matematico e lasciando entrare in essa la plausibilità della contraddizione.
La terza digressione riguarda la nozione di inconscio in Freud (sezione 7). L'origine della psicoanalisi sta – dice Melandri – nella sintesi tra la comprensione dei fenomeni isterici, l'interpretazione dei sogni e l'analisi delle manifestazioni neurotiche in generale. Il concetto di inconscio nasce proprio per dare una spiegazione unitaria a questi fenomeni che hanno la caratteristica comune di essere assurdi, paradossali. Per questo l'inconscio – inteso sia in senso aggettivale che sostantivale – non potrà mai designare una sostanza né un oggetto. «Prendiamo dunque l'inconscio come l'obiettivo di un certo sistema di incongruenze, comprendente al limite anche le più incorreggibili contraddizioni» (p. 24). L'inconscio non è illogico perché sede di conflitti o tensioni tra forze. L'illogicità è un tratto strutturale dell'inconscio. In altre parole, l'illogicità dell'inconscio è causa formale, non efficiente. Un conflitto energetico non è di per sé contraddittorio. L'inconscio è invece intrinsecamente contraddittorio.
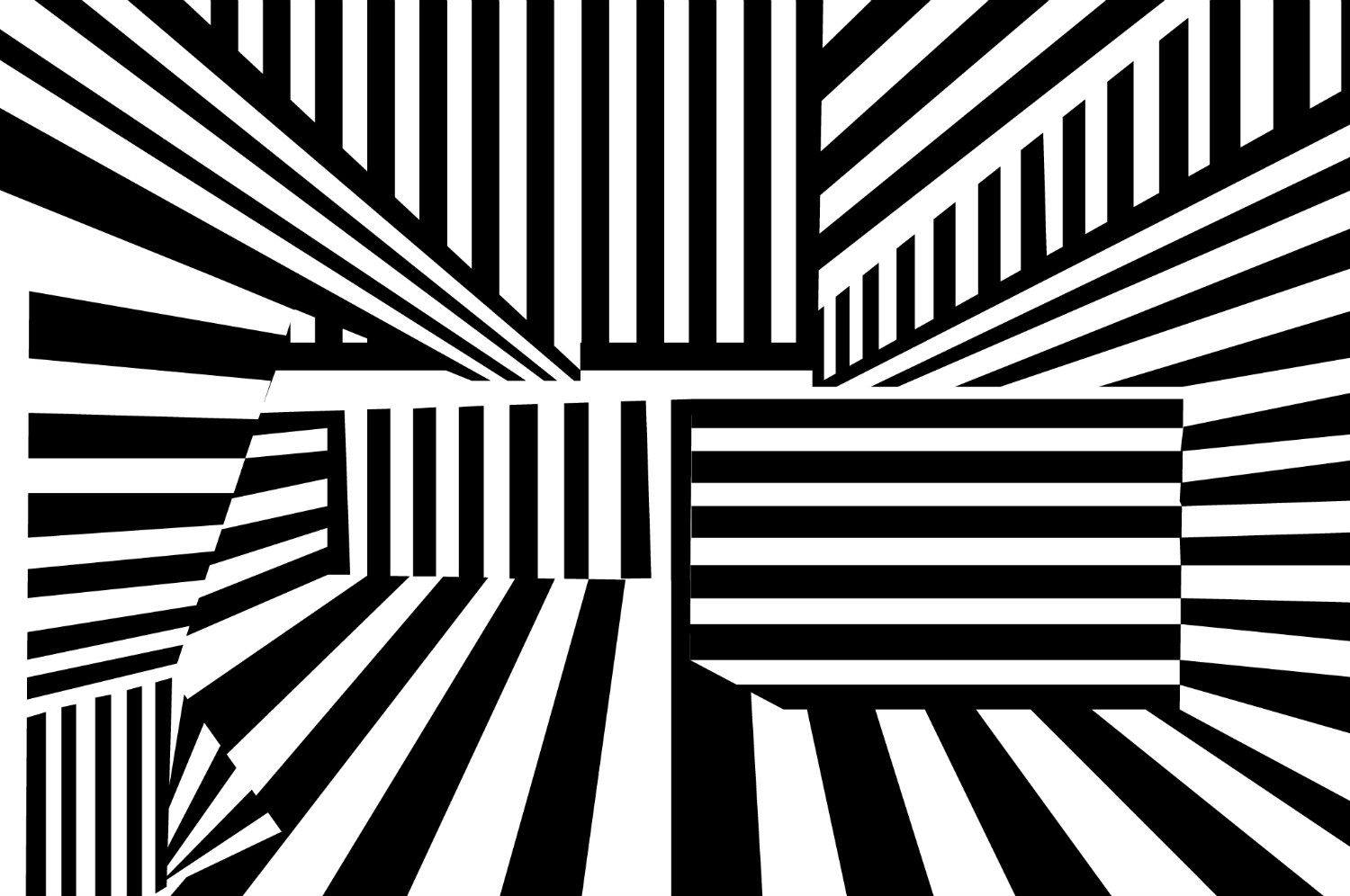
Si giunge così a un'alternativa, quella tra inconscio soggettivo e inconscio oggettivo. Il primo – dice Melandri nella sezione 11 – è qualcosa che appartiene alle profondità del soggetto in quanto “cattivo soggetto” o alter ego, e che quindi soltanto attraverso una “sapienza poetica”, di natura linguistica e retorica, può essere portato alla luce. Il secondo è invece concepito in maniera naturalistica, trascendente, e dipende da una teoria fisica delle neurosi. In entrambi i casi l'inconscio produce contraddizioni. Di qui il problema: «Una volta stabilito che l'oggetto è autocontraddittorio, esso non risulta individuabile se non negativamente: possiamo solo dire che cosa esso non è. E da ciò deriva la conseguenza, epistemologicamente deleteria, per cui non abbiamo più alcun criterio per mantenere libero da contraddizioni il nostro rapporto conoscitivo con un oggetto del genere» (p. 49). La psicoanalisi non può non tenere conto di questo punto cruciale, e drammatico. Il lavoro di Blanco ne è l'esatta riprova: una formulazione matematica dell'inconscio resta ancora nel dominio della logica. Non riesce veramente a cogliere quel radicale al di là della logica cui ci pone di fronte l'inconscio.
Dall'analisi critica dell'impostazione di Blanco emerge quindi la posizione melandriana sullo statuto della psicoanalisi. Sapere del complementare, la psicoanalisi è dialettica. La dialettica unisce razionale e irrazionale; essa tematizza l'irrazionale a partire dal limite del razionale, aprendo il razionale a quel limite. L'illogicità dell'inconscio è il riflesso dell'incapacità del pensiero logico-linguistico (nel senso della logica classica) di afferrarlo e articolarlo. Per pensare l'inconscio occorre un sapere che non è logico-linguistico in senso classico. Occorre un sapere ermeneutico e archeologico. Occorre aprirsi all'irrazionale, che non è l'illogico. In effetti, l'illogico è ancora una categoria logica, che dipende dal principio di non contraddizione. L'irrazionale è qualcosa di più profondo e ambiguo. Avvicinarsi ad esso vuol dire a) aprire il proprio orizzonte teoretico abbandonando ogni forma di dogmatismo; b) tematizzare il non-conosciuto quale complementare al conosciuto. L'analogia, che è una forma di complementarietà, è il risultato di questa operazione. L'inconscio e la dialettica riporta quindi in primo piano i temi dell'opus magnum di Melandri, La linea e il circolo (1968), e la sua lettura non può essere disgiunta da quest'ultimo.
di Luca M. Possati
-
Su “Marx eretico” di Carlo Galli
Recensioni / Gennaio 2019“C’è sempre un motivo storico reale per la lotta sulle interpretazioni del pensiero di Marx”. La frase, presa nella sua superficiale assolutezza, suona forse un po’ apodittica;
 essa risente di tutto il marxismo irriflesso, e inevitabile, del suo autore. Agli occhi estranei a una concezione materialistica della storia questa affermazione potrebbe risultare in effetti problematica, per due ordini di ragioni fondamentali, che danno però il senso generale della prospettiva di fondo del testo nel quale questa frase appare: la causa strutturale, potremmo definirla, della storia delle interpretazioni marxiane, e la loro competizione pratica, ovvero la loro lotta nell’agone dialettico della storia. Al di là dell’apparente problematicità, che eventualmente riconsidereremo più avanti ma che per noi, è bene dirlo, non sussiste, queste due ragioni hanno il merito di collocare e circoscrivere con precisione l’intenzione teorica del volume Marx eretico, recentemente pubblicato per il Mulino da Carlo Galli. Esse indicano, a nostro avviso, il contesto e il confine attraverso cui poter pensare ancora Marx, e con Marx. Fare di Marx, per come esso empiricamente si presenta nella storia del pensiero, la pietra di paragone non tanto tra lui e ciò che l’ha, di volta in volta, completato, corretto, criticato, smentito più o meno parzialmente, sublimato o riscoperto (i vari marxismi del ventesimo secolo), ma piuttosto tra, semplicemente e essenzialmente, lui e il suo sistema, tra la sua integrità teorica e la sua storica incompiutezza (il motivo storico della citazione), nella consapevolezza delle quali è racchiuso il cuore pulsante della sua intima, attuale, eresia. Il termine eresia, non a caso, indica, nel suo significato etimologico, il gesto di una scelta, un’inclinazione o una proposta, congiunto all’atto pratico dell’afferrare, del cogliere; è in questo preciso senso che si può intendere il significato di ciò che abbiamo chiamato competizione pratica, in riferimento allo scontro tra le interpretazioni che di Marx si sono succedute: esse sono sostanzialmente eresie di un pensiero eretico, incompiutezze di una compiuta incompiutezza, mille modi di interpretazione per una teoria critica, che ha avuto il beffardo destino di essere eretta artificiosamente a dogmatica. Ma l’eresia, nel senso suggeritoci da Galli, non è solo successione storica di deviazioni o fraintendimenti, essa è attuale, proficuamente attuale, poiché consente a lui, e a noi, di scegliere e afferrare Marx al di là dei limiti costitutivi della lotta fra interpretazioni e dei suoi motivi storici reali, cioè di ciò che abbiamo chiamato la competizione pratica e la causa strutturale, e ciò proprio attraverso questi ultimi e alla loro potenzialità euristica: essi, da limiti interpretativi dell’interpretazione, si superano, dialetticamente, in opportunità analitica, in forza della quale una lettura del pensiero di Marx sarà sempre non solo possibile, ma anche sempre immune, almeno potenzialmente, da quella pretesa dogmatica che ogni volta l’ha minacciato e costretto: poiché è Marx stesso che ci dice che anche per lui, e non solo per tutto il marxismo fattosi legittimamente o meno suo portavoce, valgono, anche qui, di nuovo, come limiti ma anche come criteri, la storia e la lotta: la storia come condizionamento storico-sociale necessario, come basamento strutturale sottostante la teoria, la lotta come processo dialettico, (del tutto hegeliano o meno, comunque dialettico), costitutivamente aperto alla contraddizione; in una parola: il materialismo storico.
essa risente di tutto il marxismo irriflesso, e inevitabile, del suo autore. Agli occhi estranei a una concezione materialistica della storia questa affermazione potrebbe risultare in effetti problematica, per due ordini di ragioni fondamentali, che danno però il senso generale della prospettiva di fondo del testo nel quale questa frase appare: la causa strutturale, potremmo definirla, della storia delle interpretazioni marxiane, e la loro competizione pratica, ovvero la loro lotta nell’agone dialettico della storia. Al di là dell’apparente problematicità, che eventualmente riconsidereremo più avanti ma che per noi, è bene dirlo, non sussiste, queste due ragioni hanno il merito di collocare e circoscrivere con precisione l’intenzione teorica del volume Marx eretico, recentemente pubblicato per il Mulino da Carlo Galli. Esse indicano, a nostro avviso, il contesto e il confine attraverso cui poter pensare ancora Marx, e con Marx. Fare di Marx, per come esso empiricamente si presenta nella storia del pensiero, la pietra di paragone non tanto tra lui e ciò che l’ha, di volta in volta, completato, corretto, criticato, smentito più o meno parzialmente, sublimato o riscoperto (i vari marxismi del ventesimo secolo), ma piuttosto tra, semplicemente e essenzialmente, lui e il suo sistema, tra la sua integrità teorica e la sua storica incompiutezza (il motivo storico della citazione), nella consapevolezza delle quali è racchiuso il cuore pulsante della sua intima, attuale, eresia. Il termine eresia, non a caso, indica, nel suo significato etimologico, il gesto di una scelta, un’inclinazione o una proposta, congiunto all’atto pratico dell’afferrare, del cogliere; è in questo preciso senso che si può intendere il significato di ciò che abbiamo chiamato competizione pratica, in riferimento allo scontro tra le interpretazioni che di Marx si sono succedute: esse sono sostanzialmente eresie di un pensiero eretico, incompiutezze di una compiuta incompiutezza, mille modi di interpretazione per una teoria critica, che ha avuto il beffardo destino di essere eretta artificiosamente a dogmatica. Ma l’eresia, nel senso suggeritoci da Galli, non è solo successione storica di deviazioni o fraintendimenti, essa è attuale, proficuamente attuale, poiché consente a lui, e a noi, di scegliere e afferrare Marx al di là dei limiti costitutivi della lotta fra interpretazioni e dei suoi motivi storici reali, cioè di ciò che abbiamo chiamato la competizione pratica e la causa strutturale, e ciò proprio attraverso questi ultimi e alla loro potenzialità euristica: essi, da limiti interpretativi dell’interpretazione, si superano, dialetticamente, in opportunità analitica, in forza della quale una lettura del pensiero di Marx sarà sempre non solo possibile, ma anche sempre immune, almeno potenzialmente, da quella pretesa dogmatica che ogni volta l’ha minacciato e costretto: poiché è Marx stesso che ci dice che anche per lui, e non solo per tutto il marxismo fattosi legittimamente o meno suo portavoce, valgono, anche qui, di nuovo, come limiti ma anche come criteri, la storia e la lotta: la storia come condizionamento storico-sociale necessario, come basamento strutturale sottostante la teoria, la lotta come processo dialettico, (del tutto hegeliano o meno, comunque dialettico), costitutivamente aperto alla contraddizione; in una parola: il materialismo storico.L’interpretazione, data da Galli, di Marx come pensatore intrinsecamente eretico, e della categoria di eresia come strumento ermeneutico per la sua opera, sembra collocarsi proprio su questa linea argomentativa, nella quale quella compiuta incompiutezza del sistema, quella “coerente contraddizione” viene messa in evidenza in tutte le sue potenzialità teoriche. Da un lato, infatti, egli sottolinea chiaramente, sin dall’introduzione, il presupposto “fallimentare” dell’operazione teorica, ovvero la strutturale scissione tra utopia e scienza soggiacente a tutto l’impianto concettuale di Marx, scissione che altro non sarebbe se non il riflesso nella teoria della pretesa coincidenza di pensiero e realtà, per cui «il pensiero non è una teoria da realizzare, un dover essere da imporre al reale […] ma è una logica immanente alla Cosa, che si vuole trasformare in prassi senza residui di astrazione e senza cesure» (p. 19). Dall’altro lato, nonostante e in virtù di questa “zavorra” metodologica di fondo, intende rilevare e caratterizzare ciò che, all’interno del sistema, si rivela ancora in tutta la sua cogenza e lucidità critica. Eccolo allora delineare, dapprima, il profilo di un Marx teorico del sospetto (secondo la nota definizione data da Paul Ricoeur), smascheratore e fugatore delle false verità e delle contraddizioni della società capitalistica, impegnato nell’obiettivo di «identificare il punto che spiega radicalmente l’intero processo sociale non come vuole presentarsi ma come veramente è» (p. 25), attraverso le armi riaffilate della critica dialettica (anche qui, sempre con e contro Hegel). Qui Galli sembra aderire alla contrapposizione canonica, benché agita su un piano pressoché esclusivamente filologico, tra un Marx umanista, critico della religione, dello Stato e della filosofia, e il Marx scienziato, maturo critico dell’economia politica (pag. 29), salvo poi mettere esplicitamente in chiaro che l’obiettivo fondamentale, unico, dell’analisi marxiana, in contrasto, sottolinea Galli, sia con le tendenze conciliatrici della dialettica hegeliana sia con le presunte derive nichilistiche del pensiero critico decostruttivo e negativo (p. 44), consiste nella sola determinazione della Verità come contraddizione concreta (p. 33) del reale capitalistico.
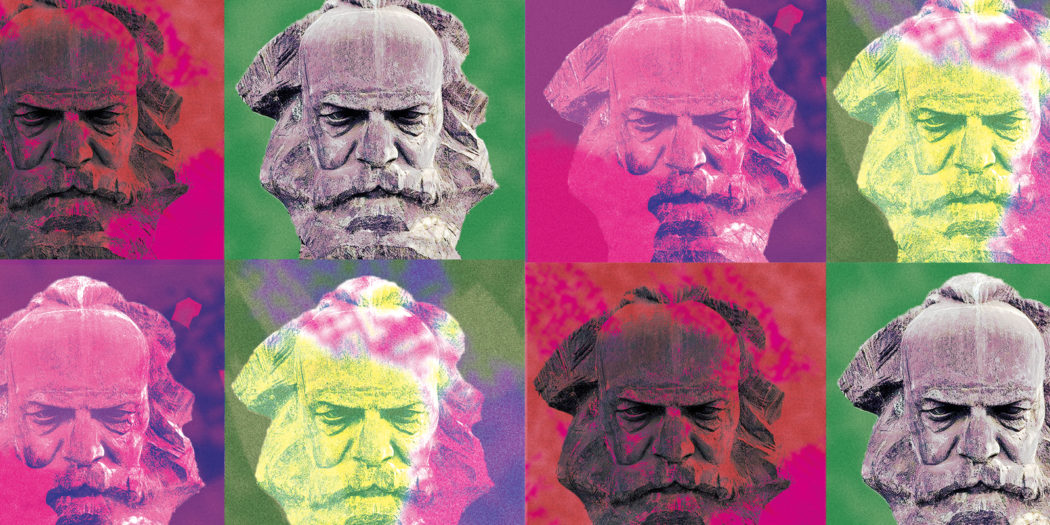
Successivamente, nel secondo e nel terzo capitolo, il tema della ricongiunzione possibile, al di là del presupposto metodologico del sospetto, tra pensiero e realtà, tra teoria e prassi, viene sviluppato illustrando quelle che Galli definisce essere le certezze epistemiche della critica marxiana; esse vanno a costituire la base dell’evoluzione teorica che conduce il Marx filosofo, innovatore della dialettica (quello, in sostanza, delle Tesi su Feuerbach), sul terreno empirico della «scienza immanente della contraddizione» (pag. 78), ovvero della critica all’economia politica classica. Queste sono ravvisate, in sequenza, nel rifiuto del materialismo tradizionale, in favore di un nuovo materialismo che colga la materialità «nella dialettica della realtà storica e sociale a partire dal basso, dal luogo in cui si genera, dai processi storici» (pag. 49), connesso alla coppia concettuale struttura- sovrastruttura, e nella delineazione del proletariato come categoria storico-sociale nella quale risiede la contraddizione strutturale della società capitalista, come sintomo, per usare il linguaggio lacaniano, di «quella contraddizione, perché ne è prodotto, perché la esprime con una potenza che è, appunto, potenziale ma che è destinata a divenire attuale» (p. 51). Su questo preciso versante si consuma, conseguentemente, il passaggio tra certezza filosofica e analisi scientifica: «per il fatto» spiega Galli «che esiste una contraddizione reale tra la potenza potenziale proletaria e il potere reale dei capitalisti, fra ricchezza della produzione […] e miseria della società, quella contraddizione può e deve essere tolta, con la rivoluzione, da un soggetto che da quella contraddizione è generato» (p. 68). Il punto della questione consiste però nel fatto che, nell’evolversi della teoria di Marx, non è tanto attraverso l’enunciazione dottrinaria del comunismo, come superamento autoevidente e immediato del sistema capitalistico-borghese, che questa contraddizione tenta di essere risolta, quanto, invece, per mezzo della sua inscrizione nel luogo originario della sua riproduzione (il trauma, per continuare la metafora psicoanalitica), cioè il capitale. Ecco la scienza della contraddizione, cui abbiamo fatto riferimento prima, mettersi in moto: “le stringenti logiche di svolgimento del capitale” (p. 78) vengono rese evidenti nel momento in cui si mostra che quest’ultimo «mette quindi in moto processi ambivalenti e, nel presente, contraddittori, razionali quanto al metodo ma irrazionali in sé e anche quanto alla consapevolezza che ne hanno gli stessi capitalisti» (p. 88). È, questo, il passaggio che consente alla critica dell’economia politica di tenere insieme “scienza” e “politica” (tema del quarto capitolo); l’intrinseca contraddizione non pertiene più solo, infatti, al sistema capitalistico in quanto modello economico o sistema di produzione, ma anche, e soprattutto, al tipo di rapporto che questo sistema produce tra economia e politica. La politica, precisa Galli, è per Marx proprio il frutto della contraddittorietà e conflittualità emerse dalla verità, pratica, dell’analisi del capitale: essa è l’effetto coessenziale della produzione, del processo di valorizzazione, e delle loro contraddizioni, «l’economia è politica […] in quanto ha in sé la politicità» (p. 88-89).
Da qui l’autore si muove per sviluppare alcune considerazioni conclusive almeno due delle quali meritano, tra le altre, di essere rilevate. Una prima, più circoscritta, è data dalla specificazione che Galli si premura di fornire rispetto all’eventuale rigidità che il binomio struttura-sovrastruttura potrebbe innescare applicato alla coppia corrispondente economia e politica; egli ci allontana dal pericolo riduzionista “alleggerendo” la portata euristica della dicotomia affermando che «la determinazione ultima delle diverse posizioni politiche, certo, è data dalla loro collocazione rispetto al rapporto antagonistico fra operai e capitale, ma la centralità dell’economico risulta più un’istanza di concretezza analitica che non un dogma meccanico, né si riduce alla formula astratta struttura-sovrastruttura» (p.118). La seconda, di portata più generale e di più ampio spessore teorico, riprende la questione dell’uso eretico di Marx, inteso come valore interno alla sua eredità. Fra gli spiragli del sistema lasciati aperti dal filosofo, sostiene Galli, ve ne sono soprattutto due che sembra abbiano occupato, e siano destinati a occupare ancora, la scena teorica contemporanea, proprio nella veste di prosecutori eretici della sua opera. Da un lato, vi è la prospettiva, figlia della tradizione poststrutturalista e proposta soprattutto da Pierre Macherey e Jacques Bidet, che congiunge la riflessione marxiana e foucaultiana al fine di interpretare il capitale come un immenso dispositivo biopolitico, produttore non solo di merci, ma di uomini e donne, di soggetti, a un tempo assoggettati e capaci di agire e resistere (p. 98). Dall’altro lato, infine, da un’angolazione strettamente neomarxista, vi è la posizione, portata avanti dallo stesso Bidet, di una rilettura metastrutturale di Marx, inteso come teorico della modernità, interamente appartenente al suo paradigma, ma nello stesso tempo scopritore delle sue contraddizioni economiche; rilettura il cui esito pare coincidere perfettamente con ciò che Galli ritiene essere il cuore vivo del pensiero di Marx: la sua capacità, eretica, di smascherare l’ultima teologia dogmatica della storia, il neoliberismo, e, congiuntamente, l’opportunità di organizzare, ancora e sempre grazie e nonostante lui, una nuova teoria critica (p.151).
di Enrico Zimara
-
Manifesto Cyborg. Ieri e oggi
Recensioni / Dicembre 2018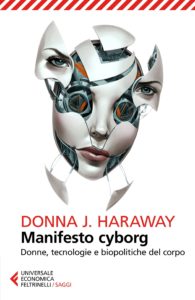 La nuova edizione di Manifesto cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo (Feltrinelli, 2018) raccoglie tre saggi di Donna Haraway, teorica femminista e storica della scienza allieva di Georges Canguilhem. I saggi in questione sono stati pubblicati la prima volta nel 1991, in Italia nel 1994, all’interno di una raccolta dal titolo Simians, Cyborgs and Women. The Reinvention of Nature (Routledge). L’importanza della riedizione di un testo considerato ormai un classico può ricercarsi nella necessità di rivalutare la portata teorica e filosofica della riflessione di Haraway, portata che fino ad ora sembra essere stata scarsamente considerata. Ciò che andrebbe messo in discussione è un inquadramento “specialistico” del testo, che lo vorrebbe di interesse unicamente per chi si occupa di “questioni legate al genere” e, ancora più nello specifico, per chi nella cornice degli studi di genere riflette sui problemi della scienza e della tecnologia. Nella rivalutazione delle implicazioni teoretiche di Manifesto Cyborg è in gioco, più in generale, la riconsiderazione dell’importanza filosofica dei cosiddetti studi di genere e postcoloniali, che normalmente trovano legittimazione solo se inseriti nella cornice dei cultural studies. Il testo di Haraway eccede queste cornici disciplinari, e con le sue incursioni “spregiudicate” nel terreno delle scienze biologiche, biomediche e delle teorie dei sistemi, può essere considerato un’argomentazione a favore della contaminazione come importante strumento di produzione e creatività teorica.
La nuova edizione di Manifesto cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo (Feltrinelli, 2018) raccoglie tre saggi di Donna Haraway, teorica femminista e storica della scienza allieva di Georges Canguilhem. I saggi in questione sono stati pubblicati la prima volta nel 1991, in Italia nel 1994, all’interno di una raccolta dal titolo Simians, Cyborgs and Women. The Reinvention of Nature (Routledge). L’importanza della riedizione di un testo considerato ormai un classico può ricercarsi nella necessità di rivalutare la portata teorica e filosofica della riflessione di Haraway, portata che fino ad ora sembra essere stata scarsamente considerata. Ciò che andrebbe messo in discussione è un inquadramento “specialistico” del testo, che lo vorrebbe di interesse unicamente per chi si occupa di “questioni legate al genere” e, ancora più nello specifico, per chi nella cornice degli studi di genere riflette sui problemi della scienza e della tecnologia. Nella rivalutazione delle implicazioni teoretiche di Manifesto Cyborg è in gioco, più in generale, la riconsiderazione dell’importanza filosofica dei cosiddetti studi di genere e postcoloniali, che normalmente trovano legittimazione solo se inseriti nella cornice dei cultural studies. Il testo di Haraway eccede queste cornici disciplinari, e con le sue incursioni “spregiudicate” nel terreno delle scienze biologiche, biomediche e delle teorie dei sistemi, può essere considerato un’argomentazione a favore della contaminazione come importante strumento di produzione e creatività teorica.Fin dalle prime pagine di Manifesto Cyborg è chiara l’urgenza teorica e politica che muove la riflessione dell’autrice: la necessità per il femminismo socialista e in generale per gli allora nuovi movimenti di sinistra di ripensarsi, alla luce del confronto con le profonde trasformazioni globali che segnavano il contesto dell’elezione di Reagan alla presidenza degli Stati Uniti negli anni ’80. Il cyborg, protagonista dell’opera, rappresentava provocatoriamente quella peculiare “creatura” contraddistinta da un’intrinseca necessità di evadere ogni forma di pensiero dicotomico, ogni forma di razionalità strutturata intorno a stringenti dualismi, in favore di un nuovo punto di vista in grado di rendere conto di una realtà infinitamente complessa ed eccedente che il suo stesso apparire metteva prepotentemente alla ribalta. A quasi trent’anni di distanza, in cui la modalità dominante di gestione della complessità (sociale, psichica, politica, scientifica) sembra ancora rimanere il riduzionismo, in cui lo scenario pare ancora caratterizzato dal riproporsi di un pensiero dicotomico e dall’intensificarsi delle logiche di dominazione patriarcale, razzista e capitalista connaturate a esso, provare a immaginare un modello di razionalità che non evade la complessità ma che se ne fa carico non si rivela meno urgente. La posta in gioco è l’elaborazione di modalità alternative e sfaccettate di gestione della complessità, rifiutando quindi anche quel pensiero che vedrebbe nella postmodernità il terreno in cui si consuma la crisi della razionalità dominante che non lascia spazio a null’altro se non alla contingenza e alla “differenza” irriducibile, intese come negazione dell’elaborazione teorica e della prassi. Manifesto Cyborg riapre invece con forza l’elaborazione teorica, etica e politica, al cuore della postmodernità e lo fa oggi non meno di ieri.
Lo sguardo attraverso cui Haraway analizza le trasformazioni che segnano il suo tempo è quello che deriva dalla sua storia in quanto biologa: in particolare, l’autrice mette in luce la profonda rielaborazione e ripensamento della biologia in relazione all’emergere di nuovi saperi, quali la cibernetica, le teorie dei sistemi, le scienze della comunicazione e dell’informazione.
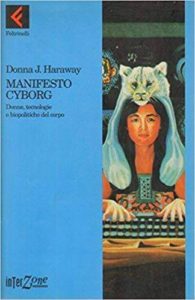 Il ripensamento della biologia in seguito alla contaminazione con nozioni, teorie e concetti provenienti da queste scienze è stato profondo al punto che, secondo Haraway, si può sostenere che l’“organismo” biologico, come oggetto della scienza, abbia cessato di esistere, e sia stato sostituito da sistemi di comunicazione completamente denaturalizzati. Gli organismi sono quindi diventati artefatti, sempre contingenti, le cui modalità di costruzione non sono vincolate da nessun’architettura naturale. Contemporaneamente, le macchine hanno preso vita: se quelle pre-cibernetiche potevano essere ancora distinte dagli organismi in quanto pensate e costruite dall’uomo, le macchine cibernetiche rendono completamente ambigua la distinzione tra autosviluppo e progettazione esterna (p.43).
Il ripensamento della biologia in seguito alla contaminazione con nozioni, teorie e concetti provenienti da queste scienze è stato profondo al punto che, secondo Haraway, si può sostenere che l’“organismo” biologico, come oggetto della scienza, abbia cessato di esistere, e sia stato sostituito da sistemi di comunicazione completamente denaturalizzati. Gli organismi sono quindi diventati artefatti, sempre contingenti, le cui modalità di costruzione non sono vincolate da nessun’architettura naturale. Contemporaneamente, le macchine hanno preso vita: se quelle pre-cibernetiche potevano essere ancora distinte dagli organismi in quanto pensate e costruite dall’uomo, le macchine cibernetiche rendono completamente ambigua la distinzione tra autosviluppo e progettazione esterna (p.43).Le ondate di denaturalizzazione e de-essenzializzazione che secondo N. Katherine Hayles definiscono il postmodernismo hanno quindi investito anche i corpi biologici: se le prime teorizzazioni degli organismi come sistemi cibernetici riposavano ancora su una concezione olistica e mantenevano intorno a questi un certo involucro, le teorie sociobiologiche di uno scienziato dalla sensibilità postmoderna come Richard Dawkins hanno radicalizzato questa tendenza, rompendo definitivamente con i paradigmi olistici e ripensando l’individualità biologica come costrutto contingente ad ogni livello. Come mettono in luce le escursioni di Haraway nel territorio delle moderne biologie della comunicazione, i processi di decostruzione e ricostruzione dei corpi occupano il centro del discorso, non solamente dal punto di vista del critico culturale o dell’archeologo delle scienze umane, ma anche dello scienziato postmoderno: le biologie moderne si occupano di tecnologie d’inscrizione e codici, di processi di disassemblaggio e riassemblaggio, di sistemi di controllo altamente tecnologizzati. La centralità delle tecnologie di scrittura emerge in modo evidente se si considerano i lauti investimenti direzionati a progetti come quello di mappatura e ricostruzione del genoma umano. Questo progetto emblematizza un “umanesimo postmoderno” in cui la ricerca biologica segnata dalla rilevanza sempre maggiore delle tecnologie d’inscrizione è messa al servizio della tradizionale ideologia umanista e del sogno ad essa associato di poter finalmente definire l’umano, di poter finalmente tracciare un confine netto e chiaro, privo di ambiguità e porosità tra il sé e il non-sé.
Il cyborg, segnalando importanti cedimenti di confine come quello tra macchina e organismo e tra umano e animale, si presenta come figurazione non dicotomica della nostra realtà sociale e corporea, che consente quindi di rompere con i dualismi che hanno strutturato la razionalità occidentale: naturale/artificiale, natura/cultura, uomo/donna, mente/corpo, materia/forma, umano/animale, soggetto/oggetto. Come ci ricorda Haraway, queste non sono mai solo opposizioni dicotomiche: attraverso questi dualismi, la razionalità occidentale ha intrecciato il suo destino a pratiche di dominio e di oppressione legate al genere, alla razza e alla specie.
D’altra parte, il cyborg in occidente è anche espressione di una cultura maschilista e guerrafondaia, che concepisce la vulnerabilità che contraddistingue la dimensione corporea come segno di una “mancanza” costitutiva, a cui far fronte attraverso un progressivo miglioramento delle strategie di difesa. Se le individualità cyborg sono per definizione contingenti e instabili, l’immagine della corsa agli armamenti e della guerra perenne lascia trasparire in filigrana il “telos apocalittico” (p. 41) di un sé finalmente libero da ogni forma di dipendenza. La realizzazione di un sé autonomo e integro, che ha “disassemblato” e digerito ogni forma di eterogeneità e alterità si accompagna al dispiegamento di un apparato di controllo diffuso e capillare, che Haraway indica come “informatica del dominio” (p. 55). Con questa figurazione si vogliono mappare i nuovi inquietanti meccanismi di controllo che attraversano il nostro tempo: alle gerarchie che contraddistinguono il “patriarcato capitalista bianco” (p. 57) si sostituisce un sistema polimorfo e reticolare, che agisce attraverso l’allacciamento di connessioni multiple. Ai vecchi sistemi di controllo centralizzato si sostituisce la delocalizzazione, la decentralizzazione, la diffusione e la moltiplicazione dei centri.

Ma il cyborg è anche un costrutto femminista, e in questo senso elicita possibilità oppositive e liberatorie. Cyborg è quel particolare oggetto di conoscenza e pratica femminista, l’esperienza delle donne, che proprio in quanto fatta oggetto di sapere, è ricostruita come aperta, non finita, contestata, vulnerabile, presa in un gioco di perenne decostruzione e riscrittura. Haraway a questo proposito da particolare importanza ai processi di decostruzione e di de-naturalizzazione che hanno interessato il femminismo in seguito al prendere voce di quelle soggettività, come le donne nere, che sfuggono al sistema di categorie attraverso cui i teorici e le teoriche occidentali hanno tentato di rappresentare il mondo degli oppressi. Questi processi hanno consentito al soggetto femminista di riarticolarsi lungo assi inediti, di immaginare e di praticare nuove forme di unità e di identità al di fuori dell’impianto dicotomico e oppositivo che ha strutturato i miti politici occidentali. La critica post-coloniale ha ricostruito le identità femministe come identità sempre parziali, contraddittorie e problematiche, definite dal non poter essere naturalizzate o essenzializzate. Haraway legge in questo senso la Sister outsider della poetessa nera Audre Lorde (p. 74), ovvero come ricostruzione letteraria dell’identità attraverso l’esclusione, la non appartenenza in quanto eccedenza rispetto a categorie prestabilite. Le identità ricostruite nelle pratiche di scrittura delle donne di colore sono identità sempre contraddittorie e frantumate, prive del privilegio dell’identità a sé, prerogativa dei corpi non marcati come quelli maschili e bianchi. Se i processi decostruttivi e de-essenzializzanti impediscono di radicare la politica nelle identità “naturali”, questo non significa che sia stata minata radicalmente la possibilità di legami: la loro ricostruzione implica politiche dell’affinità, che non ripristinano unità naturali, ma non per questo impediscono legami (parziali ma potenti) e comunità per soggetti postmoderni.
Con l’elaborazione della nozione di “saperi situati” Haraway si inserisce in un altro dibattito che attraversa il femminismo: il rapporto con l’epistemologia e la scienza e, strettamente connesso a questo, il dibattito circa lo statuto dell’oggetto di conoscenza. Proponendo “saperi situati” Haraway intende pensare una versione femminista di oggettività scientifica, che consenta di uscire dalla polarizzazione del dibattito attuale, caratterizzato dal contrapporsi di posizioni radicalmente costruzioniste ed empiriste. La rielaborazione della nozione di oggettività che Haraway propone si appoggia a un ripensamento della metafora della visione. Se quest’ultima ha significato, nella storia della razionalità occidentale, la capacità di alcuni corpi (quelli maschili, benestanti e occidentali) di “smaterializzarsi” in uno sguardo venuto dal nulla mentre si inscrivevano i corpi marcati nel mito, con la nozione di saperi situati assume un significato opposto. L’oggettività e la visione non significano più neutralità e distanza, ma corporeità, parzialità, localizzabilità, impegno e coinvolgimento. (p. 115) L’oggettività ha a che fare non con la scoperta distaccata, ma con la strutturazione reciproca e di solito ineguale; solo saperi parziali, vulnerabili e impegnati garantiscono una conoscenza oggettiva, ovvero che non sia un’illusione. Oggettività e visione non segnalano più un “trucco da dio”, che consente di scomparire arrogandosi il potere di rappresentare senza essere rappresentati, ma diventano modi per stare nel corpo, pratiche di assunzione corporea.

In How we became posthuman, Katherine Hayles sostiene che l’affermarsi di quell’entità chiamata informazione si sia accompagnata a processi di “smaterializzazione” dei corpi, di progressivo abbandono e trascendimento dei vincoli della materialità. L’approccio di Haraway ai mondi alto-tecnologici mostra una realtà più complessa: i corpi radicalmente decostruiti e ricostruiti dalle moderne biotecnologie e dalle scienze informatiche non comportano tanto la smaterializzazione di questi in puri flussi informativi, problemi di codifica e di ricerca di un linguaggio comune che permetta la perfetta comunicazione. Anche l’informazione per Haraway ha una specifica dimensione materiale, così come i testi e i codici, che dovrebbero venire ripensati attraverso la nozione di embodiment. Facendo riferimento alla dimensione corporea, Haraway non si riferisce quindi a una dimensione prettamente biologica: le tecnologie di visualizzazione sono ripensate come sistemi di percezione attivi, nelle quali siamo immersi e con le quali siamo inestricabilmente intrecciati nella costruzione di specifiche forme di vita: un aspetto del nostro embodiment.
Il ripensamento della nozione di corporeità consente ad Haraway di riprendere e al tempo stesso di andare oltre l’analisi biopolitica inaugurata da Michael Foucault, ovvero dell’analisi che fa del corpo l’entità bioculturale per eccellenza e che consente di indagare i rapporti di potere che si concentrano direttamente sul soggetto in quanto entità corporea. La decostruzione della corporeità come sistema di comunicazione tecnologico consente di indagare gli effetti del biopotere oltre la sfera organismica: oggetto delle relazioni di potere non è più un corpo organico e organizzato gerarchicamente, ma sistemi cibernetici completamente decostruiti, assemblaggi ricomposti in modo sempre parziale, costrutti contingenti. Le biopolitiche che interessano corpi ricostruiti come sistemi di comunicazione non sono quelle del sesso e della riproduzione, ma dell’immunità, legate ai processi di replicazione di un sé estremamente vulnerabile e contingente (p.159). Quali tipi di sé vengono costruiti dal discorso sul sistema immunitario? L’intento di Haraway è di risignificare il paradigma immunitario: da dispiegamento di una guerra diffusa e capillare, in cui la replicazione del sé è funzione delle sue strategie di difesa e di attacco di fronte a una minaccia costante di “invasione”, a sistema che “apre” il sé e lo mantiene aperto. In quanto dispiegamento di una rete capillare di blackout e crolli delle comunicazioni, di confusione di confini, il sistema immunitario continuamente “disfa” il sé, mantenendolo contraddittorio ed eterogeneo, impedendone la chiusura e l’autonomizzazione. In questa dimensione riposa la “promessa illegittima” (p. 42) del cyborg: la sua natura artefatta, saltando il gradino dell’unità originaria, impedisce la realizzazione del suo telos apocalittico. In quest’ottica, inoltre, la differenza irriducibile con cui obbligano a fare i conti la postmodernità e i processi a essa inestricabilmente connessi, come quelli di decolonizzazione, non segnala tanto la “morte del soggetto”, come vorrebbero alcuni, ma piuttosto ci costringe a ripensare il soggetto come non isomorfico, auto-contraddittorio e multidimensionale.
di Ambra Lulli
-
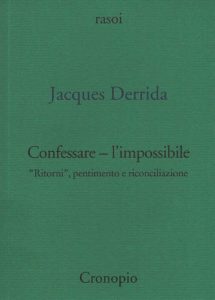 Esce in edizione italiana, a cura di Francesco Ferrari, Confessare – l’impossibile. “Ritorni”, pentimento e riconciliazione di Jacques Derrida (Cronopio, Napoli 2018), testo che segna uno dei primi e decisivi momenti della riaffermazione, nell’opera derridiana, delle proprie origini ebraiche e dell’eredità ebraico-cristiana. Il testo originale, Avouer – l’impossible. “Retours”, repentir, réconciliation, inizialmente pubblicato negli atti di un convegno del ’98, era stato riedito solo nel 2014 da Galilée trovando luogo editoriale adeguato in coppia con il più noto e recente testo Abramo, l’altro.
Esce in edizione italiana, a cura di Francesco Ferrari, Confessare – l’impossibile. “Ritorni”, pentimento e riconciliazione di Jacques Derrida (Cronopio, Napoli 2018), testo che segna uno dei primi e decisivi momenti della riaffermazione, nell’opera derridiana, delle proprie origini ebraiche e dell’eredità ebraico-cristiana. Il testo originale, Avouer – l’impossible. “Retours”, repentir, réconciliation, inizialmente pubblicato negli atti di un convegno del ’98, era stato riedito solo nel 2014 da Galilée trovando luogo editoriale adeguato in coppia con il più noto e recente testo Abramo, l’altro.Per cogliere l’importanza e il ruolo specifico di Confessare – l’impossibile non solo nell’opera derridiana ma anche nel panorama dell’epoca, nonché per constatare quanto possa ancora interpellarci questo testo, a vent’anni di distanza, bisogna ricollocarlo tra gli altri testi derridiani in cui emerge il riferimento all’ebraicità, ricostruire la sede in cui vede la luce, e per finire accennare al dibattito etico, politico e giuridico in cui si inserisce.
Confessare – l’impossibileha come precedente fondamentale Circonfessione (1991), il primo testo in cui Derrida – che già in passato aveva disseminato riferimenti a temi e autori ebraici – parla in modo autobiografico della propria origine ebraica. Il cambiamento è dovuto a ragioni complesse e stratificate, biografiche e teoretiche, prima tra tutte l’approfondirsi della lettura di Lévinas. Il nostro testo segue, inoltre, Un temoignage donné (1996) intervista (ancora inedita in italiano) compresa in un volume interamente dedicato al rapporto di alcuni intellettuali francesi dell’epoca – di origine ebraica o meno – con l’ebraismo. Precede, infine, il già menzionato Abramo, l’altro (2000), intervento al convegno, Judéités. Questions à Jacques Derrida, ormai direttamente e interamente dedicato a interrogare la o le judéités di Derrida stesso. La riaffermazione di una certa eredità ebraica diventa da questo momento in poi regolarmente presente nell’opera derridiana, intrecciata ad ogni altro tema. Come giustamente afferma il curatore nella puntuale post-fazione, Confessare – l’impossibile costituisce dunque, insieme agli altri testi in cui Derrida parla del proprio rapporto con l’ebraismo, l’«estremo approdo di quella koiné d’intellettuali ebraici diasporici che nel secolo scorso si sono confrontati, su posizione talora antitetiche, con la Judenfrage» (p. 84).
Rispetto agli altri testi, però, la sede in cui vede la luce il nostro testo gli conferisce un’importanza specifica. Esso segna infatti il momento in cui per la prima volta Derrida accetta di prendere la parola pubblicamente da una posizione e in un contesto fino ad allora evitati: in quanto intellettuale ebreo, in un convegno organizzato dalla comunità ebraica, le cui questioni sono rivolte anzitutto al pensiero e alla tradizione ebraica. Si tratta più precisamente della 37esima edizione dei Colloques des intellectuels juifs de langue française, convegni fortemente caratterizzati in senso comunitario, cui, pertanto, molti non si aspettavano che Derrida potesse mai partecipare; lo ricorda egli stesso in apertura del proprio intervento, citando una biografia di Lévinas che ne escludeva a priori la possibilità (p. 19). L’organizzazione, fondata nel ’57 come ramo del World Jewish Congress, era nata per ricostruire dopo la Shoah la comunità ebraica di Francia ed era divenuta in seguito, sotto la direzione di André Néher e Jean Halpérin, un appuntamento prestigioso della scena intellettuale francese, grazie anche alla regolare partecipazione di filosofi come Jankélévitch, Wahl e Lévinas. Il tema scelto per il ’98 è “Come vivere insieme?”, questione che doveva venir affrontata, si legge nell’introduzione agli atti del convegno, attraverso una «dimensione ebraica», certo, ma non «isolata dal resto» (Comment vivre ensemble?, p. 9) in considerazione della portata universale delle questioni in gioco. La scelta di questo tema era sfociata non a caso, si dice ancora nell’introduzione, in un dibattito sul cinquantesimo anniversario dell’adozione della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo da parte delle Nazioni Unite a Parigi (ibidem).
Questo riferimento al contesto storico è da precisare ulteriormente in quanto «quello che accade ogginel mondo» (p. 46) spiega, a detta di Derrida stesso, ragioni e portata del proprio intervento, che prende posizione nel vivo di un dibattito capitale degli anni Novanta, ricostruito efficacemente nella postfazione (pp. 85-92). Da questo punto di vista, Confessare – l’impossibile va idealmente in coppia con Perdonare. L’imperdonabile e l’imprescrittibile, un testo pubblicato nel 2004 ma la cui redazione risale a seminari e conferenze tenute proprio nel ’97/’98, ove le medesime questioni sono ulteriormente sviluppate. Il cinquantenario dei diritti umani coincide infatti con un fatto nuovo e importante proprio per la loro storia: l’inaugurazione della Corte penale internazionale dell’Aja, luogo di competenza giuridica dei “crimini contro l’umanità”, nozione codificata dopo la Shoah dal Tribunale di Norimberga (pp. 48-49). Tale nozione indica crimini in cui la vittima è l’umanità intera, il cui ambito di giudizio è mondiale, sovrastatale e internazionale, e il cui tempo di validità è imprescrittibile, cioè infinito. Il nuovo principio giuridico crea le condizioni per inediti scenari che riarticolano il rapporto tra sovranità nazionale e internazionale, tra etica, politica e diritto: si assiste in quegli anni a una «teatralizzazione della confessione» (p. 46), a diverse scene pubbliche di pentimento e di richiesta di perdono a nome di capi di Stato, ministri, o della Chiesa, e non solo per la Shoah, ma anche per sofferenze inflitte ad altri popoli. Proprio qualche mese prima si conclude la Commissione Verità e Riconciliazione nel Sudafrica post-Apartheid, preceduta da istituzioni analoghe in Cile e in Argentina, in cui traumi nazionali compaiono davanti a un’istanza giuridica sovra-statale e in cui l’accertamento dei crimini non è disgiunto da un difficile processo di riconciliazione nazionale (pp. 50-51).
La scena di questo tribunale/confessionale mondiale costituisce, a detta di Derrida, un momento di «innegabile rottura nella storia del politico, del giuridico, dei rapporti tra le comunità, la società civile e lo Stato, tra gli Stati sovrani, il diritto internazionale e le organizzazioni non governative» (p. 46), un processo che va certamente salutato positivamente, come «progresso irreversibile» del diritto, e, di più, come «l’orizzonte di tutti i progressi a venire del diritto internazionale» (p. 52). Ma questo cambiamento rinvia ad una trasformazione più vasta, e più complessa, del rapporto tra diritto e religione, che Derrida ha altrove inscritto all’interno del «ritorno del religioso» e della «mondialatinizzazione» (Fede e sapere, 1995): ossia l’epoca in cui nozioni provenienti dalla tradizione ebraico-cristiana – la giustizia, la confessione, il perdono – si trovano senza particolare consapevolezza riutilizzate dalla politica e dalla legge, richiedendo dunque un’analisi specifica per coglierne senso, deviazioni, limiti, eventuali manipolazioni.
È dunque a fronte di una tale urgenza teoretica, politica e giuridica, che Derrida sceglie di parlare per la prima volta da intellettuale ebreo franco-algerino, proprio nel contesto dei Colloques, e appunto a proposito del tema di come“vivere insieme”. L’eredità ebraica è convocata anche da lui, dunque, per interrogare il “vivere insieme”, più precisamente alla luce di tale inedita configurazione etico-politico-giuridica. Ecco pertanto che il titolo scelto, Avouer – l’impossible richiama con una variazione significativa quelli di Circonfession e di Un temoignage donné: se confesser rinvia alla confessione religiosa della colpa, e temoignage può indicare l’atto di testimoniare in ambito religioso, etico come in sede processuale, avouer traduce l’ammettere un crimine in sede giuridica (p. 9, cf. anche la nota 1 N.d.C.). Si annuncia quindi l’ambito specifico – etico-politico e giuridico – di tale intervento rispetto ai precedenti testi sull’ebraicità.
La questione è affrontata in un senso più generale, relativo al “vivere insieme”, e poi applicata al dibattito contingente, alla trasformazione in corso nel diritto. Per quanto riguarda il primo punto, la tradizione ebraica è convocata perché, in effetti, il «vivere insieme», il «vivere insieme bene» o «all’insegna del bene» (nota 6 N.d.C., p. 21), è obiettivo che non può essere raggiunto solo in virtù dell’aderenza a un dato di natura, né attraverso i soli strumenti coercitivi e punitivi delle leggi. Solo una Legge al di sopra delle leggi, un’esigenza di giustizia e di pace sovra-giuridica, permette di immaginare come vivere bene insieme. La questione è allora cosa sia questa Legge, e se proprio la tradizione ebraica possa o meno essere la fonte per pensare una tale Legge del vivere insieme bene, se cioè «può un dichiararsi ebreo in qualunque modo esso sia (e ce ne sono tanti), dare un accesso privilegiato a quella giustizia, a quella legge al di là delle leggi» (p. 34).

La risposta alla domanda per Derrida è duplice: da un lato sì, la tradizione ebraica, in effetti è il custode eletto di una Legge al di là delle leggi, che è promessa del bene, della pace, del perdono e della giustizia. «Insieme con tanti ebrei nel mondo, questa cura innocente di compassione (modo fondamentale, ai miei occhi, del vivere insieme), di questa compassione di giustizia e equità (Rahmamin, forse), la rivendicherei se non come l’essenza dell’ebraismo», almeno con qualcosa di «inseparabile» dalla propria memoria ebraica (p. 43). Il riferimento è soprattutto all’ebraismo identificato con la giustizia verso l’altro, lo straniero, da Lévinas, di cui cita un brano di Envers autrui, pronunciato proprio nella medesima sede anni prima (p. 39).
Tuttavia, per Derrida, per poter essere all’altezza di ciò che tale Legge/Giustizia al di là delle leggi impone di pensare, è necessario riaffermare l’ebraicità in un senso paradossale, rifiutando qualsiasi identificazione con l’esser-ebreo e ogni appartenenza alla comunità ebraica. L’«ipotesi» è «che questa dissociazione con sé lo renda al tempo stesso tanto meno ebreo quanto più ebreo» (p. 17): esser-ebreo, rispondere alla Legge, vorrebbe dire rompere l’identità, l’identico, e solo così poter essere aperti all’altro e alla differenza. L’esser ebreo in tal senso contesta ogni Insieme, inteso come sostantivo che indica l’Uno o la Com-unità, e rende possibile il vivere-insieme, inteso come avverbio (p. 15). L’accesso privilegiato a questa ebraicità si rivela essere proprio l’esperienza originaria di un bambino algerino, nato ebreo, cresciuto francofono in un paese arabo-musulmano occupato da cristiani, privo di un’identità semplice, non appartenente a nessuna comunità: ecco la ragione della scelta di presentarsi adesso come «marrano paradossale» o «l’ultimo degli ebrei» (p. 37).
Tornando alla necessità di riaffermare l’eredità ebraica per analizzare le sfide contemporanee del “vivere insieme”, si tratta allora di cercare di capire se il progresso del giuridico di cui si è detto corrisponda o meno all’imperativo di questa Legge custodita dall’ebraismo. Può l’eredità ebraica così intesa contribuire a restare lucidi sui meriti, e gli eventuali limiti, di una tale trasformazione etico-politico-giuridica in corso?
In effetti, la fedeltà all’imperativo ebraico deve condurre a operare una distinzione tra quel che accade in ambito giuridico-politico e quel che accade in ambito mediatico-politico, per giungere a isolare ed ad analizzare la logica etica delle domande pubbliche, e televisive, di perdono e di riconciliazione, che ai processi per crimini contro l’umanità si affiancano o si sovrappongono. Tali “scene” di riconciliazione finiscono infatti, secondo Derrida, con il semplificare una questione etica estremamente più complessa, e cioè con l’identificare l’idea del perdono tout courtcon quella del perdono condizionato e domandato. «L’etica del perdono», invece, è «profondamente divisa da due motivi eterogenei all’interno della tradizione abramitica, ebraica, cristiana e islamica che l’ha tramandata» (p. 58), e non può che esserne lacerata. Una contraddizione indecidibile, un’aporia la definisce e non può essere risolta: da un lato, è giusto che il perdono sia accordato solo a condizione che ci sia confessione di colpa, pentimento e domanda di perdono; dall’altro, la logica “iperbolica” del perdono, con termine di Jankélévitch, vuole che esso venga donato appunto per-dono, cioè in modo assoluto e incondizionato, a prescindere anche dal pentimento dell’altro.
L’eredità ebraica, allora – ma dovremmo dire in realtà abramitica, ebraico-cristiano-islamica – consiste in questo: nel restare vigilanti nei confronti della «profonda cristianizzazione – “hegeliana” in verità – che segna il linguaggio di questa mondializzazione della confessione» (p. 58), in nome di un’idea iperbolica del perdono «che resta eterogeneo nella sua incondizionalità a tutti questi ordini (etico, politico, giuridico) e alle intenzioni di riconciliazione» (p. 61) e che deve rimanere sempre in tensione con ciò che del perdono fenomenicamente può apparire, il perdono condizionato. Per quanto sembri contraddittorio, l’idea incondizionata di perdono va slegata da ogni progetto di riconciliazione: il riferimento, ebraico anch’esso a suo modo, è a Walter Benjamin e al suo accenno ellittico ad un «perdono senza riconciliazione» (p. 65), una tempesta del perdono divino che spira fino alla fine dei tempi, senza confondersi mai con la riconciliazione.
Proprio per questo, l’eredità abramitica consiste infine nel riconoscere nell’enormità del male che attraversa il Novecento una paradossale opportunità di restare fedeli al comandamento incondizionato del bene. Proprio la nozione di imprescrittibile, legata ai crimini contro l’umanità, può essere infatti all’altezza della logica iperbolica del perdono: l’imprescrittibile è l’equivalente giuridico di una riconciliazione impossibile, e sembra dunque apparentemente il corrispettivo dell’imperdonabile tout court. Mentre è proprio il contrario, almeno per Derrida – e se l’affermazione è certamente disturbante e contestabile, è difficile tuttavia non riconoscerne la pertinenza. Seguendo la logica folle, l’eccesso, lo scandalo del comandamento del perdono, è solo l’imperdonabile ad esserne all’altezza: «Al di là del suo codice giuridico e dei suoi limiti penali, il concetto di imprescrittibilità accenna a un Giudizio universale: fino alla fine dei tempi, il criminale (dittatore, torturatore, Stato nazione colpevole di crimini contro l’umanità) dovrà comparire a giudizio e rendere conto. La responsabilità che il colpevole dovrebbe assumere non ha più fine. Per sempre. È di questo impossibile che avrei volute parlarvi come della sola opportunità di perdono» (p. 65).
di Silvia Geraci
Bibliografia
Derrida, J., Abraham, l’autre, in AA. VV., Judéités. Questions pour Jacques Derrida, a cura di J. Cohen e R. Zagury-Orly, Galilée, Paris 2003, pp. 11-42; tr. it. di T. Silla, Abramo, l’altro, a cura di G. Leghissa e T. Silla, Cronopio, Napoli 2003;
Derrida, J., Circonfession, in J. Derrida, G. Bennington,Jacques Derrida, Seuil, Paris 1991; tr. it. di F. Viri, Circonfessione, in G. Bennington, Derridabase– J. Derrida, Circonfessione, tr. di D. De Santis (Derridabase), Lithos, Roma 2008;
Derrida, Un témoignage donné, in E. Weber, Questions au judaïsme. Entretiens avec Elisabeth Weber, Desclée de Brouwer, Paris 1994;
VV., Comment vivre ensemble?, Actes du XXXVII colloque des intellectuels juifs de langue française, Albin Michel, Paris 2001;
Derrida, J., Fede e sapere. Le due fonti della “religione” ai limiti della semplice ragione, tr. it. di A. Arbo, in AA. VV., La Religione. Annuario Filosofico Europeo, a cura di J. Derrida e G. Vattimo, Laterza, Roma-Bari 1995; versione francese Foi et Savoir. Le deux sources de la « religion » aux limites de la simple raison. Suivi par Le Siècle et le Pardon, Seuil, Paris 2000;
Derrida, J., Pardonner: l’impardonnable et l’imprescriptible, “Cahiers de l’Herne”, 83, 2004; Jacques Derrida; tr. it. a cura di L. Odello,Perdonare. L’imperdonabile e l’imprescrittibile, Cortina, Milano 2004.
-
 Comprensibilmente la critica si è perlopiù finora tenuta lontana dall’arduo compito di delineare un confronto puntuale tra l’opera di Günther Anders e quella di Hannah Arendt: il volume Scrivimi qualcosa di te, ora tradotto in italiano, si può a buon diritto considerare un imprescindibile punto di riferimento per qualunque studioso che, d’ora in poi, voglia misurarsi con le biografie intellettuali di due tra le più eminenti personalità del Novecento. Prima della pubblicazione, il carteggio era custodito in parte nel lascito andersiano presso l’archivio della Österreichische Nationalbibliothek di Vienna, e in parte in quello arendtiano conservato presso la Library of Congress di Washington: di quest’ultimo lascito, inoltre, sono custodite delle copie in microfilm presso l’Hannah Arendt Zentrum della Carl von Ossietzky Universität di Oldenburg. Il notevole lavoro editoriale che sta alla base del volume in questione rappresenta certamente un mirabile tentativo di raccordo tra le due biografie dei due autori in questione – così simili, eppure così divergenti; ma più ancora, si configura come una base solida oltre che irrinunciabile per ogni studio futuro che si soffermi su somiglianze e divergenze anche sul piano teoretico, non solo biografico, nella consapevolezza che, nel caso di queste due personalità intellettuali, la dimensione del pensiero sia inscindibile da quell’“odissea” esistenziale di cui nulla meglio di un epistolario può tenere traccia. Il volume è composto da una prefazione all’edizione italiana, una prefazione all’edizione originale, e tre sezioni: nella prima sono contenuti il carteggio Arendt-Anders, composto da 54 lettere in tutto, e tre lettere di Anders al romanziere Lion Feuchtwanger; nella seconda sezione sono inclusi i saggi “speculari” su Rilke e Mannheim; la terza sezione comprende gli scritti in nome del comune amico Walter Benjamin. Al centro, vi è una piccola sezione di fotografie, e il volume si chiude con una postfazione della curatrice.
Comprensibilmente la critica si è perlopiù finora tenuta lontana dall’arduo compito di delineare un confronto puntuale tra l’opera di Günther Anders e quella di Hannah Arendt: il volume Scrivimi qualcosa di te, ora tradotto in italiano, si può a buon diritto considerare un imprescindibile punto di riferimento per qualunque studioso che, d’ora in poi, voglia misurarsi con le biografie intellettuali di due tra le più eminenti personalità del Novecento. Prima della pubblicazione, il carteggio era custodito in parte nel lascito andersiano presso l’archivio della Österreichische Nationalbibliothek di Vienna, e in parte in quello arendtiano conservato presso la Library of Congress di Washington: di quest’ultimo lascito, inoltre, sono custodite delle copie in microfilm presso l’Hannah Arendt Zentrum della Carl von Ossietzky Universität di Oldenburg. Il notevole lavoro editoriale che sta alla base del volume in questione rappresenta certamente un mirabile tentativo di raccordo tra le due biografie dei due autori in questione – così simili, eppure così divergenti; ma più ancora, si configura come una base solida oltre che irrinunciabile per ogni studio futuro che si soffermi su somiglianze e divergenze anche sul piano teoretico, non solo biografico, nella consapevolezza che, nel caso di queste due personalità intellettuali, la dimensione del pensiero sia inscindibile da quell’“odissea” esistenziale di cui nulla meglio di un epistolario può tenere traccia. Il volume è composto da una prefazione all’edizione italiana, una prefazione all’edizione originale, e tre sezioni: nella prima sono contenuti il carteggio Arendt-Anders, composto da 54 lettere in tutto, e tre lettere di Anders al romanziere Lion Feuchtwanger; nella seconda sezione sono inclusi i saggi “speculari” su Rilke e Mannheim; la terza sezione comprende gli scritti in nome del comune amico Walter Benjamin. Al centro, vi è una piccola sezione di fotografie, e il volume si chiude con una postfazione della curatrice.Il carteggio e i documenti pubblicati nel volume sono una preziosa testimonianza di vita privata e di riflessione filosofica – il legame tra le due dimensioni risulta, come si diceva, di particolare importanza – condivise da due pensatori che hanno intrattenuto rapporti intensi, seppur discontinui, dalla metà degli anni Venti fino al 1975. I due si conoscono ad un seminario di Heidegger nel 1925 a Marburgo, quando Günther Anders portava ancora il suo cognome di nascita, Stern, e Hannah Arendt intratteneva una relazione clandestina con il suo maestro. Si può dire che, per Anders, quella di Heidegger sia stata una presenza ingombrante anche dopo gli anni di Marburgo, almeno per due motivi: innanzitutto, per via di un confronto polemico con quello che, d’altronde, era stato anche il suo maestro, e in secondo luogo, a causa di una rivalità personale con l’uomo con cui la Arendt aveva intrattenuto una relazione amorosa non soltanto ancora viva nei suoi ricordi, ma anche riflessa dal ricco carteggio che ella continuava a intrattenere con il suo maestro. È interessante, infatti, notare come il nome di Heidegger compaia nel carteggio solo una volta, menzionato da Hannah, in un riferimento polemico che cade nel vuoto, come testimonia la lettera del 31 maggio 1958. Anders e Arendt non si rivedranno fino al 1929 a Berlino, ad un ballo in maschera: qui si sposeranno frettolosamente, e resteranno insieme fino al 1937. Il loro rapporto è stato estremamente complesso, e le numerose differenze riscontrabili nelle rispettive personalità intellettuali, si può ipotizzare, non sono certo state estranee alla rottura; sicuramente, gli eventi politici che attanagliarono l’Europa in quegli anni contribuirono alla fine annunciata del loro matrimonio, consegnando entrambi ad una fase travagliata di instabilità e indigenza, dovuta all’emigrazione, per salvarsi dalle persecuzioni naziste. Una ripresa dei loro rapporti per via epistolare avviene appunto nel 1939, quando la Arendt, insieme al secondo marito Heinrich Blücher, berlinese conosciuto a Parigi, ha bisogno dei documenti necessari per l’espatrio e chiede all’ex marito, già emigrato, di procurarglieli. Nella presentazione dell’edizione italiana che apre il volume, Donatella Di Cesare evidenzia l’asimmetria (p. XII) nel rapporto tra i due, che emerge nell’affetto profondo e duraturo da parte di Anders nei confronti di Arendt, e ricambiato, si può dire, a stento e non tanto a lungo da lei. Si può supporre che una delle ragioni di tale asimmetria sia da rintracciarsi anche nei percorsi di vita incompatibili intrapresi da entrambi nel dopoguerra. Se Hannah Arendt, dopo i primi anni negli Stati Uniti dedicati all’attività umanitaria in soccorso dei profughi ebrei, riuscì infine a integrarsi con successo nel mondo accademico americano, Anders, al contrario, a causa dei suoi primi insuccessi nello stesso ambito, si rivolse verso il mondo della carta stampata, e durante i primi anni da rifugiato in America si dedicò ai lavori più disparati, dal traduttore all’operaio. E al contrario di Arendt, di conseguenza, ormai ben installata nell’ambiente accademico statunitense, Anders nel 1950 avrebbe colto la possibilità di tornare in Europa. La decisione di Anders si fondò su una disillusione verso gli ideali di pace e libertà incarnati dagli Stati Uniti d’America, che egli giudicava traditi da quell’evento traumatico che fu l’«Olocausto atomico» del 1945. La seconda parte dell’epistolario registra appunto questa distanza incolmabile, non solo geografica, ma anche di ambizioni e di scopi: si susseguono gli incontri mancati fino al 1961, anno in cui i due si rivedono a Monaco, evento che non manca di ispirare ad Anders parole che risuonano dell’antico affetto, mai sopito, riportate nella lettera del 13 dicembre 1961. Il carteggio prosegue fino alla morte di lei, avvenuta nel 1975 nel suo appartamento di New York, per un attacco cardiaco.

Una matrice comune del pensiero di Anders e Arendt può sicuramente essere rintracciata a partire dalle origini ebraiche, che portarono entrambi a guardare alle vicende politiche europee da un punto di vista diverso: quello del pariah, dell’emarginato, dell’escluso, il quale, in virtù della propria emarginazione, ma anche indipendenza intellettuale, acquisisce un punto di vista eccentrico in relazione alle vicende del mondo. Inoltre, la forte comunione intellettuale tra i due, che coincise con gli anni del matrimonio, ha portato entrambi a risultati teorici che riecheggiano, indirettamente, nelle opere successive di entrambi. Eppure, nonostante tale comunione di idee, invano si cercherebbero citazioni o riferimenti incrociati – almeno in termini espliciti – tra le rispettive opere. Anzi, sembra quasi che i due si siano reciprocamente trattati secondo una “congiura del silenzio”, ognuno evitando di confrontarsi apertamente con il pensiero dell’altro. Certamente, nella loro opera, Arendt e Anders si confrontano e analizzano quel mondo industrializzato da cui sembra drammaticamente scomparire la possibilità di un’azione libera e responsabile. Ma mentre Arendt avrà la possibilità di esporre le sue tesi con chiara fermezza, riflesso dell’autorevolezza della comunità accademica, ad Anders, per via delle tormentate vicende della sua vita, non verrà mai concessa l’occasione di fare altrettanto, o almeno non negli stessi termini: la frustrazione, l’amarezza, il sarcasmo si riflettono tragicamente, come ha notato Pier Paolo Portinaro, in quel «rigorismo morale» tipico della sua opera. La critica, tuttavia, per via del comune terreno di confronto e degli orizzonti culturali in cui entrambi si sono mossi, non ha esitato a considerarli persino “sinfilosofi”, in virtù della forte comunione di pensiero tra i due, che emerge dagli altri testi inclusi nel volume relativi a quegli anni: corrispondono infatti al 1930 il commento, scritto a quattro mani, delle Elegie duinesi di Rilke, e le due analisi speculari di Ideologia e utopia di Karl Mannheim. I risultati di tale sinergia riecheggiano, indirettamente, nelle opere successive di entrambi, da cui emerge una chiara convergenza filosofica, anche dettata dalle conclusioni tragiche a cui è costretta a giungere la “filosofia dopo Auschwitz”.
Vale la pena menzionare l’affascinante commistione di lingue a cui i due fanno ricorso nel loro scambio epistolare, testimonianza della loro odissea esistenziale, comune a tanti intellettuali ebrei costretti a fuggire dall’Europa, per i quali il libro più bello che si conosca «è il passaporto», come scrive Hannah nella lettera del 29 dicembre 1959. Ciononostante, il loro legame con la lingua e la cultura tedesca ha sempre costituito il fil rouge che raccorda le varie tappe di questo viaggio. Nel corso della loro esistenza travagliata e i loro spostamenti tra l’Europa e gli Stati Uniti, infatti, non hanno mai rinunciato, e il carteggio lo dimostra, al legame con le proprie origini, il quale si manifestava nell’uso della lingua madre soprattutto nelle lettere private, unico contatto con gli amici di lingua tedesca sparsi per il mondo per sfuggire alle persecuzioni. Sia in Anders che in Arendt si rinviene un’ammissione di debito nei confronti della lingua tedesca, e un sentimento di appartenenza, dunque, non tanto a un luogo, quanto a una cultura e ad un universo di pensiero. Tutto ciò spiegherebbe il loro atteggiamento conflittuale nei confronti della lingua inglese. Entrambi, nell’epistolario, fanno ampio uso delle espressioni inglesi, intersecandole con il tedesco, come a volte fanno le persone bilingui che scoprono le risorse linguistiche di un altro idioma, quando la propria lingua madre non sa esprimere altrettanto bene lo stesso concetto; eppure, si tratta di brevi frasi, a volte ironiche, coronate dal commento divertito di Hannah, nella già menzionata lettera del 29 dicembre: «Non penserai davvero che sono diventata un’“americana”». Forse anche per via di questo stretto legame affettivo con la lingua madre, Hannah non riuscì mai a parlare un inglese fluente e senza accento o, per dirla con le sue parole, «in modo idiomatico». Quanto a Günther, il rigetto della lingua e della cultura inglesi sicuramente giocarono un ruolo decisivo nella sua scelta di abbandonare gli Stati Uniti e tornare a vivere in Europa. Non si può fare a meno di notare, dunque, un certo orgoglio da parte di entrambi in questo loro rifiuto di imparare a parlare fluentemente in inglese, come se ciò comportasse una rinuncia a quel legame esclusivo con la lingua madre e con la natia Germania, con l’insieme dei valori che essa portava con sé.
È interessante la scelta dell’edizione originale tedesca di selezionare una frase dalla lettera del 20 febbraio 1956 come titolo della raccolta: «Schreib doch mal 'hard facts' über Dich», scelta che non è stata del tutto mantenuta in italiano, da cui è stato espunto il riferimento agli “hard facts”, cioè l’aspetto della quotidianità, della concretezza dell’esistenza. Un meraviglioso esempio di tale concretezza si trova nella sezione fotografica, in cui è riprodotto il telegramma inviato da Hannah a Günther il 23 maggio del 1941 per annunciare il suo arrivo sul suolo americano: “Sind gerettet”, si legge, e in queste parole si legge l’epilogo di un’odissea, e un nuovo inizio. In definitiva, l’opera costituisce un riferimento fondamentale per gli studiosi del settore, ma non si fatica a vederne spunti di lettura stimolanti anche per il grande pubblico: in queste pagine si ritrova una sorta di diario intellettuale che, ben più che registrare «hard facts» delle rispettive vite è anche una preziosa testimonianza di un ininterrotto dialogo filosofico tra due dei più importanti intellettuali del Novecento.
di Alessandra Maglie
-
PK#9 \ Soggettivazioni. Segni, scarti, sintomi
Rivista / Settembre 2018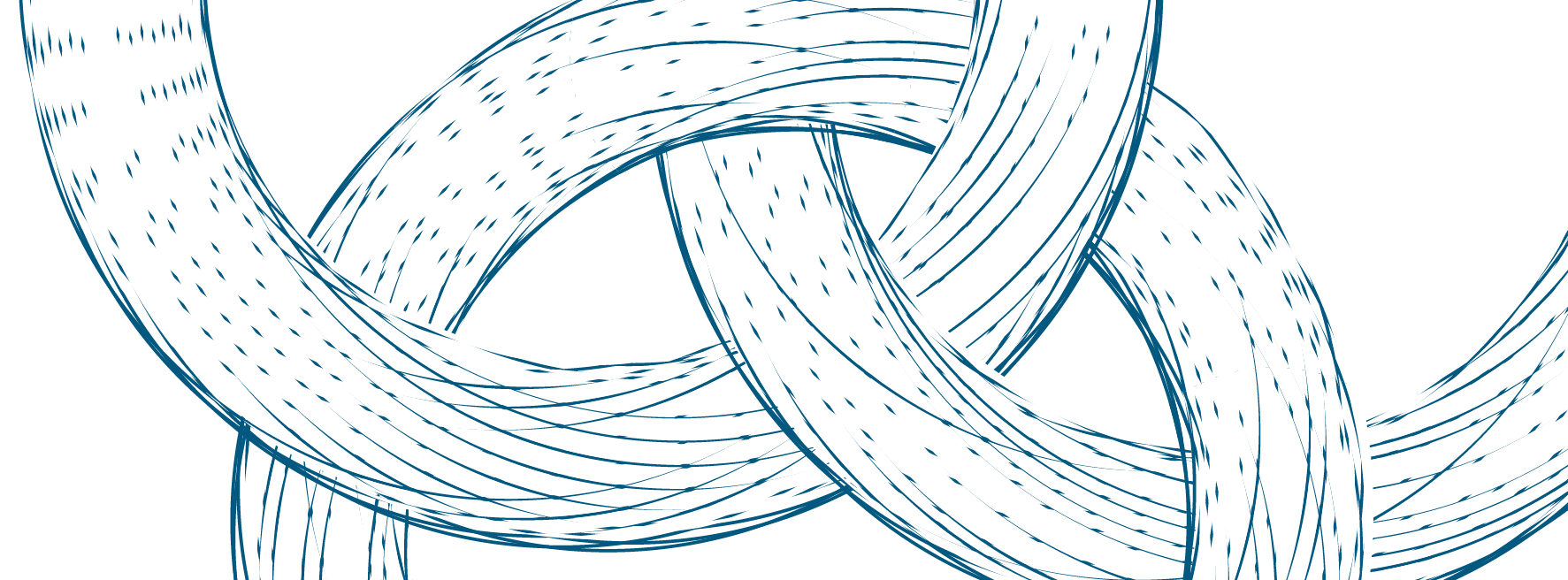
L’intento di questa raccolta, che prende il titolo di “Soggettivazioni”, è stato quello di aprire una riflessione attorno alla teoria della soggettivazione lacaniana, così per come ce l’ha lasciata in eredità Lacan, a singhiozzi, nei testi stabiliti a partire dai suoi trent’anni di insegnamento orale. Cosa può dirci una psicoanalisi asistematica, distante dalle istituzioni universitarie rispetto a problemi di una concretezza innervata di realtà? Chi frequenta i dipartimenti di Psicologia e assieme l’insegnamento lacaniano sa che è incommensurabile la distanza che intercorre tra la specificità e la settorializzazione degli strumenti istituzionali a confronto con l’universalità dei concetti larghi e volontariamente mai definiti dello psicoanalista parigino. Tra l’estremamente particolare (l’ad hoc della psicologia contemporanea) e l’estremamente universale (il concetto, unità sintetica della filosofia) si rischia di incorrere in un deragliamento del punto focale, causato da uno scontro di metodi epistemologici che si sono stabilizzati ai bordi opposti l’uno rispetto all’altro. Nella scelta di prendere in considerazione un tema vasto e generale come la teoria della soggettivazione c’era l’interesse, da parte nostra, di porlo in dialogo con il campo altrettanto vasto e generale del presente. Speriamo che questa prima ricerca possa costituirsi come un’indagine (sebbene parziale) sullo statuto del soggetto in quanto campo epistemologico aperto: attingendo dalla teoria psicoanalitica e dal dibattito che ne è scaturito, il presente volume segue molteplici sentieri analitici e sottolinea di contributo in contributo la difficoltà di giungere a un’idea organica di soggetto, per la varietà di ipotesi spesso contrastanti in merito alla sua rappresentazione, formalizzazione e interpretazione. In questa raccolta crediamo che i punti maggiormente messi in rilievo da chi ha collaborato riguardino il problema della genesi, lo statuto della trasformazione, e infine un’attenzione specifica è stata rivolta al registro del Reale e ai suoi effetti.
A cura di Lorenzo Curti e Irene Ferialdi
Scarica PDF
English version
DOI: https://doi.org/10.13135/2385-1945/9.2018
Pubblicato: settembre 2018
Indice
Editoriale
L. Curti, I. Ferialdi, Soggettivazioni: tra vuoti e contiguità [PDF It]
I. Genesi
P. G. Curti, Estrarre il soggetto [PDF It]
C. Mola, Intrecci concettuali. Il soggetto tra Hegel, Kojève e Lacan [PDF It]
A. Lattuada, L’atto reale e la genesi del soggetto nella psicoanalisi di Jacques Lacan [PDF It]
D. Tolfo, Per un'analisi non significante della soggettività: la funzione del punto-segno ne l'Anti-Edipo [PDF It]
II. Trasformazioni
L. Melandri, La parola contaminata dei movimenti non autoritari degli anni Settanta [PDF It]
R. Chiafari, Drammaturgia e metamorfosi del genio maligno: soggetti e spettri tra follie e ragione [PDF It]
M. Di Bartolo, La psicoanalisi come estetica dell'esistenza [PDF It]
A. Soares De Moura Costa Matos, Streaming Subjectivation: Two Questions and One Thesis about Netflix [PDF En]
III. Reale
F. Cimatti, La lingua c'è. Saussure, Chomsky e Lacan [PDF It]
A. Pagliardini, Verso il reale: schizofrenia/psicoanalisi [PDF It]
F. Vergine, Le origini trascendentali del mondo. Per un'ontologia topologica del reale [PDF It]
Traduzioni
A. Zupančič, Differenza sessuale e ontologia [PDF It]
F. Rambeau, La fosforescenza delle cose [PDF It]
Interviste e recensioni
Intervista a Franco Lolli [PDF It]
F. Zambonini, Una quasi-recensione a "Lacan, oggi. Sette conversazioni per capire Lacan" di Sergio Benvenuto e Antonio Lucci. Considerazioni marginali sul rapporto filosofia-psicanalisi [PDF It]
-
La danza delle immagini – Didi-Huberman
Sconfinamenti, Serial / Settembre 2018 Aperçues è uno dei libri più singolari di Georges Didi-Huberman. Raccoglie numerosi testi brevi (ognuno dei quali reca un proprio titolo e una precisa data di composizione) che riguardano immagini, non tanto analizzate per esteso quanto piuttosto «intraviste» (è questo il significato del titolo). Il medesimo concetto viene ribadito nell’epigrafe, tratta da un discorso del poeta tedesco Paul Celan: «E cosa sarebbero allora le immagini? Ciò che una volta, e ogni volta è l’unica volta, è soltanto qui e ora, viene intravisto e ha da essere percepito». Conviene parlare genericamente di immagini perché, nella sua vasta produzione saggistica, Didi-Huberman non si è interessato soltanto alle opere d’arte pittoriche o scultoree – antiche, moderne o contemporanee che siano –, ma ad ogni sorta di elementi visivi (stampe, manifesti, fotografie, video, film, ecc.). Egli potrebbe, come Baudelaire, definire le immagini «la mia grande, la mia unica, la mia primitiva passione, nel senso che le considera, oltre che come fonte di fascino, anche come oggetto di un’inesausta riflessione.
Aperçues è uno dei libri più singolari di Georges Didi-Huberman. Raccoglie numerosi testi brevi (ognuno dei quali reca un proprio titolo e una precisa data di composizione) che riguardano immagini, non tanto analizzate per esteso quanto piuttosto «intraviste» (è questo il significato del titolo). Il medesimo concetto viene ribadito nell’epigrafe, tratta da un discorso del poeta tedesco Paul Celan: «E cosa sarebbero allora le immagini? Ciò che una volta, e ogni volta è l’unica volta, è soltanto qui e ora, viene intravisto e ha da essere percepito». Conviene parlare genericamente di immagini perché, nella sua vasta produzione saggistica, Didi-Huberman non si è interessato soltanto alle opere d’arte pittoriche o scultoree – antiche, moderne o contemporanee che siano –, ma ad ogni sorta di elementi visivi (stampe, manifesti, fotografie, video, film, ecc.). Egli potrebbe, come Baudelaire, definire le immagini «la mia grande, la mia unica, la mia primitiva passione, nel senso che le considera, oltre che come fonte di fascino, anche come oggetto di un’inesausta riflessione.Scarica il PDF
A cura di
Giuseppe Zuccarino è critico e traduttore. Ha pubblicato vari saggi: La scrittura impossibile, Genova, Graphos, 1995; L’immagine e l’enigma, ivi, 1998; Critica e commento. Benjamin, Foucault, Derrida, ivi, 2000; Percorsi anomali, Udine, Campanotto, 2002; Il desiderio, la follia, la morte, ivi, 2005; Il dialogo e il silenzio, ivi, 2008; Da un’arte all’altra, Novi Ligure, Joker, 2009; Note al palinsesto, ivi, 2012; Il farsi della scrittura, Milano-Udine, Mimesis, 2012; Prospezioni. Foucault e Derrida, ivi, 2016. Tra i libri da lui tradotti figurano opere di Mallarmé, Bataille, Klossowski, Blanchot, Caillois e Barthes. Ha inoltre curato un fascicolo monografico della rivista «Riga» (n. 37, 2017) dedicato a Maurice Blanchot.
-
Richard Sennett – Costruire e abitare. Etica per la città
Recensioni / Settembre 2018L’OMBRA DEL POPULISMO. ABITARE E COSTRUIRE LA CITTÀ CONTEMPORANEA
 Da sempre, le città sono l’opera più grandiosa dell’uomo. Per le loro dimensioni, metropolitane già duemila anni fa, ma soprattutto perché esse concretano il sistema politico, economico e sociale di una civiltà: ne sono determinate, e insieme lo influenzano. Questo vale per qualunque epoca e cultura: come il sistema erariale, economico e sociale influenzava la forma delle città medievali, o induceva la trasformazione degli isolati giapponesi da machi in cho, al contrario cinte daziarie, mura difensive e impianti stradali determinavano il modo di vivere gli spazi e le stratificazioni sociali. Nel suo ultimo lavoro, Richard Sennett ci dice che questa relazione ha sostanzialmente funzionato fino alle grandi trasformazioni dell’Ottocento: quando sorge un’urbanità che Paolo Sica considerava «rappresentazione perfetta della società borghese», e in cui invece Sennett ravvisa le prime crisi del rapporto tra costruito e abitare. Nell’opera del barone Haussmann che riforma (nel senso letterale) Parigi, di Ildefons Cerda che traccia il suo piano per Barcellona, di Frederick Law Olmsted che, insieme al mai citato Calvert Vaux, disegna il Central Park a New York, Sennett vede cioè le prime trasformazioni che escludono i cittadini. I nuovi boulevard parigini, pensati per il traffico moderno, impoverirebbero la vita dei parigini facendo sparire vicoletti e café; gli isolati di Cerda, spazi potenzialmente passanti e porosi, sarebbero in realtà corti chiuse e opprimenti; e Central Park, pensato per far socializzare le persone, ne evidenzierebbe solo la divisione in classi. Insomma, gli urbanisti avrebbero dimenticato i cittadini e il loro abitare, inseguendo sogni e illusioni o agendo in malafede. È una visione radicale, anche se tendenziosa: in fondo, quelle stesse trasformazioni permisero la creazione di reti fognarie e aree verdi mai viste prima, aumentando di vent’anni l’aspettativa di vita di quei cittadini che Sennett considera traditi. Ciò che davvero cambia, nell’Ottocento, è il tempo: la rivoluzione industriale induce rapide trasformazioni sulla città e sull’abitare, amplificandone le frizioni. Ma di questo, Sennett non fa menzione: più che a spiegare cosa causi la (supposta) crisi, pare interessato a narrarla in termini emotivi e drammatici. Chiama così in causa due colleghi, Jane Jacobs e Lewis Mumford, e i loro tentativi di ricucire costruire e abitare: la prima promuovendo processi di rigenerazione con azioni dal basso; il secondo teorizzando interventi utopici e ideali, come le città-giardino di Ebenezer Howard. Azioni alla piccola scala, presentate non per illustrare strade possibili, quanto per rinforzare l’idea che le due polarità – il costruire e l’abitare – siano entità separate, indipendenti.
Da sempre, le città sono l’opera più grandiosa dell’uomo. Per le loro dimensioni, metropolitane già duemila anni fa, ma soprattutto perché esse concretano il sistema politico, economico e sociale di una civiltà: ne sono determinate, e insieme lo influenzano. Questo vale per qualunque epoca e cultura: come il sistema erariale, economico e sociale influenzava la forma delle città medievali, o induceva la trasformazione degli isolati giapponesi da machi in cho, al contrario cinte daziarie, mura difensive e impianti stradali determinavano il modo di vivere gli spazi e le stratificazioni sociali. Nel suo ultimo lavoro, Richard Sennett ci dice che questa relazione ha sostanzialmente funzionato fino alle grandi trasformazioni dell’Ottocento: quando sorge un’urbanità che Paolo Sica considerava «rappresentazione perfetta della società borghese», e in cui invece Sennett ravvisa le prime crisi del rapporto tra costruito e abitare. Nell’opera del barone Haussmann che riforma (nel senso letterale) Parigi, di Ildefons Cerda che traccia il suo piano per Barcellona, di Frederick Law Olmsted che, insieme al mai citato Calvert Vaux, disegna il Central Park a New York, Sennett vede cioè le prime trasformazioni che escludono i cittadini. I nuovi boulevard parigini, pensati per il traffico moderno, impoverirebbero la vita dei parigini facendo sparire vicoletti e café; gli isolati di Cerda, spazi potenzialmente passanti e porosi, sarebbero in realtà corti chiuse e opprimenti; e Central Park, pensato per far socializzare le persone, ne evidenzierebbe solo la divisione in classi. Insomma, gli urbanisti avrebbero dimenticato i cittadini e il loro abitare, inseguendo sogni e illusioni o agendo in malafede. È una visione radicale, anche se tendenziosa: in fondo, quelle stesse trasformazioni permisero la creazione di reti fognarie e aree verdi mai viste prima, aumentando di vent’anni l’aspettativa di vita di quei cittadini che Sennett considera traditi. Ciò che davvero cambia, nell’Ottocento, è il tempo: la rivoluzione industriale induce rapide trasformazioni sulla città e sull’abitare, amplificandone le frizioni. Ma di questo, Sennett non fa menzione: più che a spiegare cosa causi la (supposta) crisi, pare interessato a narrarla in termini emotivi e drammatici. Chiama così in causa due colleghi, Jane Jacobs e Lewis Mumford, e i loro tentativi di ricucire costruire e abitare: la prima promuovendo processi di rigenerazione con azioni dal basso; il secondo teorizzando interventi utopici e ideali, come le città-giardino di Ebenezer Howard. Azioni alla piccola scala, presentate non per illustrare strade possibili, quanto per rinforzare l’idea che le due polarità – il costruire e l’abitare – siano entità separate, indipendenti.È una forzatura, funzionale però a introdurre i problemi abitativi delle città contemporanee. Solo che le scelte di Sennett per raccontarceli sono quantomeno curiose. Si comincia, ragionevolmente, con le megalopoli e il loro sviluppo schizofrenico, frutto di speculazione e incompetenza progettuale. La reprimenda è comprensibile e condivisibile, anche se Sennett nemmeno accenna alle rivoluzioni che esasperano l’urbanesimo (che, a beneficio di traduttrice ed editore, è il fenomeno di migrazione delle masse verso le città, non un sinonimo di urbanistica), quasi che le città siano frutto del capriccio degli urbanisti e non di precise strategie politiche ed economiche: esemplare in questo il superficiale accenno alle ghost city cinesi. Ma sorprende che Sennett non dedichi nemmeno un pensiero a un tema drammaticamente attuale e che riguarda un miliardo di persone: quello della città post-industriale, che pure, tra spazi da ripensare e comunità in cerca di identità, investe esattamente il rapporto tra costruito e abitare. Invece, Sennett trova più perturbanti le smart city, quelle città in cui l’uso di reti e big data dovrebbe migliorare la fruibilità di infrastrutture e servizi. Delle varie sperimentazioni in materia – in Italia, Torino è tra le città più attive – Sennett dà una visione distopica: i sistemi ci ottundono, sentenzia infatti (p. 171), soprattutto se facili da usare. Meglio sarebbe se funzionassero male, perché saremmo stimolati dalla loro inefficienza – con buona pace di Derrick De Kerckhove e dell’intelligenza connettiva. La smart city viene dipinta come una sorta di collodiano paese dei balocchi, dove i cittadini perdono poco per volta la loro volontà e capacità di giudizio, rallegrandosene. Quasi fosse uno strumento creato da oscure forze del male (urbanisti malintenzionati): e non invece il prodotto, forse inevitabile, di un mondo in cui oltre 5 miliardi di persone accede a internet, e oltre 3 miliardi hanno account social. Un prodotto non necessariamente buono, magari, ma la cui fenomenologia è ben più profonda: una nuova forzatura, dunque, ad attestare una polarità tra costruire e abitare che appare sempre più artificiosa.
Ma tutto diventa chiaro con la terza parte del libro, quando arriva la risposta alla vexata questio: come si può tenere insieme costruire e abitare? Come progettare e vivere una città finalmente giusta? Fedele alla polarità così faticosamente costruita, Sennett dedica consigli tanto ai cittadini quanto agli urbanisti. I primi dovranno farsi più consapevoli, inclusivi e tolleranti: ad esempio camminando di più, ritrovando la conoscenza itinerante del flâneur (p. 206), imparando la «conoscenza incarnata del luogo» (p. 200), riscoprendo la propria dimensione (p. 212) e facendo esperienze autentiche (p. 228) – azioni che non sembrano molto tarate sulle fasce povere della popolazione. Dal canto loro, gli urbanisti dovranno padroneggiare le «5 forme» (p.230): alternanza tra luoghi pubblici e privati; “punteggiatura” urbana (un’antiquata visione semiotica in cui i monumenti sono punti, le panchine punti e virgola, e così via); bordi porosi, cioè non invalicabili come le autostrade urbane; forme-tipo (una versione quantomeno semplicista della tradizione rossiana); molteplicità e non-finito. E quando infine sia i produttori dell’abitare sia quelli del costruito saranno diventati competenti, insieme potranno costruire la città attraverso la “coproduzione” (p. 269). Cioè una partecipazione in cui i cittadini non scelgano solo tra alternative preparate dai progettisti, ma possano davvero “giocare” con le (cinque) forme proposte dagli urbanisti, usando magari grossi modelli in cartone, scoprendo alternative e diventando protagonisti.
Non vale la pena discutere le qualità raccomandate al cittadino, né le fantomatiche “5 forme”. Più importante è notare quanto Sennett cerchi, con questo testo, di smarcarsi dal suo ruolo di sociologo per proporsi come un vero guru: solo in quest’ottica si spiegano infatti gli innumerevoli aneddoti di sapore autocelebrativo. Quando Sennett ci racconta dei suoi trascorsi alla White Horse Tavern, «un locale bohémien [...] rumoroso e pieno di fumo con una clientela mista costituita da artisti, scaricatori di porto, gay e infermiere del vicino ospedale» (p. 97), o della sua amicizia col signor Suhdir, «meraviglioso malgrado le piccole truffe», o degli immigrati clandestini che vendono merce rubata e che si confidano con lui (p. 114), o del ragazzino che lo guida nelle favelas evitando pericolose gang criminali (p. 199), o della panetteria di Boston il cui pane era tanto buono (forse per questo ricicla l’aneddoto da L'uomo flessibile, dopo quasi vent’anni), lo fa per presentarsi come uomo di mondo, esperto dei rapporti umani, anticonformista: una persona da cui accettare consigli. E, parallelamente, Sennett dispensa pillole tecniche del tutto inutili e spesso al limite del ridicolo. Ci spiega che per creare un luogo piacevole «la regola è sistemare un numero sufficiente di panchine da poter accogliere in un posto solo sei famiglie numerose» (p.75), qualunque cosa ciò significhi. Discetta dei gradini, che a seconda del capitolo devono essere alti «16 centimetri all’esterno e 21 (!) all’interno» (p. 73) oppure «110millimetri all’esterno, 150millimetri all’interno» (p. 257). Ex cathedra, sintetizza che «esistono tre forme di città» (p. 52), a pianta ortogonale, a struttura cellulare e a griglia additiva, stabilendo senza alcuna prova a carico che le prime due sono adatte all’abitare e la terza no, e pazienza per tutte le metropoli che non rientrano in questo schema, da Londra a Vienna. E naturalmente, distribuisce vaghi riferimenti alle sue numerose consulenze urbanistiche: costruendosi così un’immagine di competenza professionale che dia peso alle ricette espresse nella terza parte.
Nella stessa logica è la manifesta scelta di uno slogan. Domina infatti il mito della città aperta, «più egualitaria e democratica di quanto non lo siano quasi tutte le società attuali, con una spartizione delle ricchezze tra l’intero corpus sociale e non accumulate ai vertici» (p. 19). Sennett sostiene che le organizzazioni che funzionano siano sistemi aperti: l’esempio è il Media Lab o la prima Silicon Valley, dove i ricercatori si confrontavano liberamente, mentre nei sistemi “chiusi” come il Googleplex (la sede di Google), essi sarebbero inconsapevolmente oppressi. Che ciò sia vero o meno, è chiaro che l’analogia con i sistemi non interessa Sennett: altrimenti noterebbe che proprio le opere di rigenerazione (cioè meccanismi di retroazione positiva) in atto in molte città da lui definite chiuse testimoniano che la città è un sistema aperto, che lo si voglia o no. Qui invece il termine ha una dimensione puramente mediatica: aperto è il nuovo buono e giusto, si direbbe in inglese.
Ma questi sono peccati veniali, in fondo. Così come lo sono le numerose e a tratti deliranti divagazioni (i cinesi farebbero copie perché incapaci di stare al passo con lo sviluppo delle loro città, la meritocrazia sarebbe il grande male dei nostri tempi, e così via), figlie forse di una scrittura a più mani che avrebbe meritato un editing più severo.

Ciò che davvero è grave è che, nella costruzione artificiosa della polarità tra abitare e costruire, la complessità della città vada completamente perduta. Sennett racconta di un costruire e di un abitare (soavemente chiamati ville e cité), come fossero dimensioni semplici, univoche: ma gli abitare sono tanti, concorrenti, coerenti, contrastanti. E ognuno di loro ha un rapporto diverso con la forma, che in una metropoli sono le forme, mutevoli, di varia scala. Dimenticando l’ormai storica lezione di Rem Koolhass e del suo Delirious New York (1978), Sennett ricade cioè nel mito del controllo che tanto avversa: senza accettare che il carattere delirante che tanto lo spaventa è in realtà costitutivo della città. Se cioè il legame di reciproca causalità tra costruire e abitare è sempre effettivo e performativo, al tempo stesso esso non ha carattere di necessità o di univocità: le forme sopravvivono al modo di abitarle, e società simili possono creare forme molto diverse, e ciò implica un approccio costitutivamente tentativo. È imperdonabile allora l’idea che bastino cittadini e urbanisti “ben intenzionati” (p. 74) per produrre una città giusta: il modello di coproduzione sennettiano potrebbe apparire simile alla Teoria dell’agire comunicativo, ma in effetti cancella tutta la tensione sulla responsabilità che per Habermas sottendeva il contributo del singolo al processo, scivolando verso una logica da social network in cui tutti hanno potere di dire tutto su tutto, anche senza saperne nulla. E favoleggiando di un mondo in cui la valenza previsionale degli scenari viene affidata ai (futuri?) abitanti, senza coinvolgere alcuno dei “poteri forti” cui attribuisce tutti i mali della città contemporanea (politici, imprenditori ecc.), e parallelamente liberando gli urbanisti di ogni responsabilità: un paradosso amaro. Sennett cavalca così l’onda del populismo e della (finta) democrazia diretta: in un mondo finalmente privo di politicanti e speculatori, ognuno dirà la sua, e la città sarà finalmente “aperta”.
E con un colpo di coda, nelle ultime pagine ci viene ricordato che questo raffazzonato lavoro sarebbe il compimento di una trilogia sull’uomo iniziata con il riuscito L'uomo artigiano (2008) e lo zoppicante Insieme (2012): come un’opera artigiana infatti, «generalmente una città aperta è più riparabile di una città chiusa» (p. 314), anche se non si sa perché. Siamo ormai nel campo generalizzato del sensazionalismo e del like: certo, «se foste contadini, capireste subito di che cosa si tratta, ma purtroppo avete trascorso troppo tempo nei bar» (p. 262), quindi questo è ciò che vi meritate.
di Carlo Deregibus
-
 Nel 1996 Lev Manovich, in polemica con le derive commerciali della computer art, pubblica un articolo su Rhizome in cui contrappone la terra di Duchamp e la terra di Turing: se per il teorico dei nuovi media l’arte dopo Duchamp è sostanzialmente autoreferenziale, autoironica, complicata e orientata al contenuto, quella che utilizza le nuove tecnologie dell’informazione è invece semplice, incentrata sulla forma e rispettosa del proprio medium (qui inteso come dispositivo). Questa divaricazione fra le due terre, però, che in Duchamp Meets Turing Gabriela Galati si pone l’obbiettivo di ricongiungere, si basa su un presupposto dualismo fra contenuto e forma che, opponendo realtà e rappresentazione, rimane incapace di cogliere le modalità performative dell’arte inaugurate da Duchamp ma proprie anche degli ambienti mediali digitali, e considerare così la linea di confine fra le due “terre” come un medium connettivo (e anzi generativo) invece che come un taglio insanabile.
Nel 1996 Lev Manovich, in polemica con le derive commerciali della computer art, pubblica un articolo su Rhizome in cui contrappone la terra di Duchamp e la terra di Turing: se per il teorico dei nuovi media l’arte dopo Duchamp è sostanzialmente autoreferenziale, autoironica, complicata e orientata al contenuto, quella che utilizza le nuove tecnologie dell’informazione è invece semplice, incentrata sulla forma e rispettosa del proprio medium (qui inteso come dispositivo). Questa divaricazione fra le due terre, però, che in Duchamp Meets Turing Gabriela Galati si pone l’obbiettivo di ricongiungere, si basa su un presupposto dualismo fra contenuto e forma che, opponendo realtà e rappresentazione, rimane incapace di cogliere le modalità performative dell’arte inaugurate da Duchamp ma proprie anche degli ambienti mediali digitali, e considerare così la linea di confine fra le due “terre” come un medium connettivo (e anzi generativo) invece che come un taglio insanabile.Facendo implodere la costellazione di dicotomie che ha sostanziato la nozione di rappresentazione tradizionale, fondativa del canone moderno e solo apparentemente superata in quello postmoderno, diventa invece possibile cogliere la dimensione incarnata dell’informazione e, per converso, quella informata della materia, ovvero i feedback loop che modulano i collegamenti fra attori umani e non umani in ambienti immersivi e dinamici insieme fisici e virtuali, dove corporeità e cognizione si performano continuamente in relazioni mediate e processi contingenti e distribuiti (pp. 15-16), come ben esemplifica uno dei casi di studio più interessanti scelti da Galati, la performance Excellences and Perfections realizzata su Instagram da Amalia Ulman fra l’Aprile e il Settembre del 2014 (pp. 72-77).
 Sospesi nella cesura tra originale e copia, segno e cosa, mente e corpo, il Soggetto (un soggetto che sappiamo adesso riconoscere come marcato e posizionato, appartenente alla tradizione umanista e liberale dell’Occidente) l’oggetto e il medium sono rimasti, invece, sostanzialmente divisi. In Duchamp Meets Turing, Galati propone una radicale revisione di una serie di nozioni chiave (ripetizione, simulacro, archivio, incoporazione e medium) che hanno contribuito a produrre questa interminabile catena di duplicazioni adoperate per giustificare “rappresentazionalmente” la rappresentazione – e confluite nella divaricazione fra analogico e digitale, servendosi di alcuni fondamentali antidoti teorici quali la ripetizione o la piega di Deleuze, la différance di Derrida, il postumano di Hayles, o il modello semiotico triadico di Pierce. L’obiettivo dell’autrice non è tanto quello di rintracciare una continuità delle espressioni artistiche negli ambienti digitali, né quello di garantire nuova legittimità al discorso estetico sul digitale, quanto piuttosto quello di scovare il “punto cieco” (p. 18) a partire dal quale l’umano e il macchinico avrebbero potuto ritrovarsi nel mezzo, e invece si sono ritrovati uno di fronte all’altro, pur se – ma solo in apparenza – sembrerebbe sia stato il contrario. Ma immaginare l’umano come una macchina, controllando il passaggio delle informazioni nel corpo per la gestione del suo equilibrio e del suo potenziamento (si veda la prima formulazione della teoria del cyborg di Clynes e Kline (1960), oppure la macchina come un umano, testando fino a che punto può spingersi l’intelligenza di un computer, secondo le interpretazioni prevalenti del test di Turing (la cui iniziale componente performativa e di genere è stata quasi subito assorbita in quella cognitivista-rappresentazionale), sono operazioni che presuppongono entrambe una scissione sostanziale fra l’umano e la macchina, e che possono soltanto contemplare una loro analogia o una loro reciproca sostituzione (con tutte le derive tecnoutopistiche o tecnodistopiche che ciò ha comportato), ma mai la loro coimplicazione (vedi p. 86).
Sospesi nella cesura tra originale e copia, segno e cosa, mente e corpo, il Soggetto (un soggetto che sappiamo adesso riconoscere come marcato e posizionato, appartenente alla tradizione umanista e liberale dell’Occidente) l’oggetto e il medium sono rimasti, invece, sostanzialmente divisi. In Duchamp Meets Turing, Galati propone una radicale revisione di una serie di nozioni chiave (ripetizione, simulacro, archivio, incoporazione e medium) che hanno contribuito a produrre questa interminabile catena di duplicazioni adoperate per giustificare “rappresentazionalmente” la rappresentazione – e confluite nella divaricazione fra analogico e digitale, servendosi di alcuni fondamentali antidoti teorici quali la ripetizione o la piega di Deleuze, la différance di Derrida, il postumano di Hayles, o il modello semiotico triadico di Pierce. L’obiettivo dell’autrice non è tanto quello di rintracciare una continuità delle espressioni artistiche negli ambienti digitali, né quello di garantire nuova legittimità al discorso estetico sul digitale, quanto piuttosto quello di scovare il “punto cieco” (p. 18) a partire dal quale l’umano e il macchinico avrebbero potuto ritrovarsi nel mezzo, e invece si sono ritrovati uno di fronte all’altro, pur se – ma solo in apparenza – sembrerebbe sia stato il contrario. Ma immaginare l’umano come una macchina, controllando il passaggio delle informazioni nel corpo per la gestione del suo equilibrio e del suo potenziamento (si veda la prima formulazione della teoria del cyborg di Clynes e Kline (1960), oppure la macchina come un umano, testando fino a che punto può spingersi l’intelligenza di un computer, secondo le interpretazioni prevalenti del test di Turing (la cui iniziale componente performativa e di genere è stata quasi subito assorbita in quella cognitivista-rappresentazionale), sono operazioni che presuppongono entrambe una scissione sostanziale fra l’umano e la macchina, e che possono soltanto contemplare una loro analogia o una loro reciproca sostituzione (con tutte le derive tecnoutopistiche o tecnodistopiche che ciò ha comportato), ma mai la loro coimplicazione (vedi p. 86).Per Galati, questo punto cieco – che è anche il paradossale punto di vista di nessun soggetto in particolare, ma a partire dal quale ogni soggettività può essere costituita – è proprio il ready-made di Duchamp, che riprendendo la nozione di Lévi-Strauss, l’autrice definisce “significante fluttuante dei media” (p. 148), ovvero un medium vuoto potenzialmente riempibile in modi sempre diversi, piuttosto che qualcosa di fatto e finito stando a una traduzione letterale del termine. Un medium che si presta a spiegare il funzionamento anche dei processi digitali partendo dall’idea di un soggetto e un oggetto emergenti nel mezzo, relazionali e assemblati come quelli che popolano le riflessioni sul postumano e sul cyborg di autori come Haraway, Hayles o Caronia. Nel ready-made, l’opera d’arte si libera finalmente dalla tirannia del referente esterno di cui sarebbe segno e copia, e acquisisice una medialità immanente e radicale, senza punti di partenza né approdi (si veda la recente riflessione di Grusin in proposito).
L’intera operazione duchampiana, che ha nel ready-made il suo fulcro, è una rivolta contro lo statuto retinico dell’arte, che travolge a un tempo l’idea di estetica come contemplazione, di pittura come produzione di oggetti (unici) per un mercato e di spettatore come soggetto esclusivamente guardante, nonché il privilegio della visione (disincarnata) sugli altri sensi. Con Duchamp, l’opera cessa di essere rappresentazione e diventa medium perché il medium scavalca il privilegio del significante e anche del significato come dati nel testo e, passando al contesto, “esplode” (Krauss cit. in Galati, p. 188) facendosi processo – in quanto evento, e non stato, sempre diversamente ripetibile (pp. 62-66). Nell’“indifferenza visiva” del ready-made come opera che non viene fatta il medium non coincide con gli strumenti tecnici della pittura (supporto e pigmenti), come al contrario ribadirà Greenberg sostenendo il primato del significante nell’“esperienza puramente ottica” della pittura, né d’altra parte il ready-made come opera senza autore può essere il contenitore di un messaggio. In tal senso, la difesa duchampiana dell’arte concettuale contro l’arte “animale” come arte che piace più facilmente non va letta come un suo rifiuto della materialità, ma pittosto della piena comunicabilità dei valori che l’arte sarebbe in grado di veicolare una volta per tutte, e del gusto che questi fonderebbero a partire dalla “callistica” dominante.
Duchamp, anzi, definisce coefficiente d’arte il rinvio, lo scarto tra ciò che nell’arte si progetta e ciò che accade, tra intenzione e risultato, ovvero tra controllo e casualità, una nozione che ben si presta a essere letta all’interno di un approccio performativo come quello proposto da Galati, in cui ogni opera è attualizzazione sempre diversa di un “nodo di tendenze” (Lévy cit. in Galati, p. 120) che ne costituisce la virtualità senza fondo. Potremmo dire, allora, che il ready-made esplora il medium come interfaccia, incontro, appuntamento casuale, resi possibili da una trasparenza che, come quella de Le Grand Verre (La Mariée mise à nu par ses célibataires, même, 1915-1923) – tecnicamente non un ready-made ma operante secondo la medesima logica –, non allude a una leggibilità, quanto piuttosto alla necessità dell’attraversamento e del rimando, una trasparenza che partendo dal contesto e attraversando il testo riporta ancora, ma sempre diversamente, al contesto. Trasparenza impura, soggetta al caso che può incrinarla, come effettivamente accadde a Le Grand Verre – opera aperta per eccellenza, mai più riparata né finita – durante un trasporto, o persino opacizzarla, come testimonia Elévage de Poussière di Man Ray, fotografia del 1920 (a sua volta ready-made elevato a potenza) che ci mostra un Vetro appena riconoscibile, in posizione orizzontale e ricoperto da uno spesso strato di polvere. Qui, come anche in un’altra opera “indicale” duchampiana, Tu m’ (1918), la trasparenza si trasforma addirittura in traccia, differimento della presenza, impossibilità dell’origine, direbbe Derrida.

“L’arte è una condizione, una condizione eraclitea di continuo mutamento, no?”, dice Duchamp a Dore Ashton in un’intervista del 1966. Una condizione ready-made, dunque, fluttuante e in divenire, che istituisce lo sguardo (e il suo soggetto) altrove ogni volta, perché sempre già in ritardo o ancora in anticipo rispetto a ciò che è.
di Federica Timeto
-
Bataille e la notte del non-sapere
Recensioni, Sconfinamenti / Luglio 2018 Sono molte e significative le vicende, personali e culturali, attraversate da Georges Bataille nel corso degli anni Trenta. La più singolare è forse quella legata a una rivista da lui fondata, «Acéphale», e alla società segreta che recava lo stesso nome. L’intento del duplice progetto era, in un certo senso, di tipo religioso, ma di una religiosità che prendeva atto fin da subito della morte di Dio annunciata da Nietzsche. La setta, che riuniva attorno a Bataille un ristretto numero di adepti, svolgeva un’attività di riflessione sulle opere del filosofo tedesco, ma praticava anche dei rituali di tipo cerimoniale. L’esperienza è stata importante per lo scrittore, anche se è durata solo pochi anni e se alla fine egli è sembrato giudicarla, per molti aspetti, mancata. Ha ricordato infatti, in una nota autobiografica, quanto segue: «Avevo passato gli anni precedenti [al 1940] con una preoccupazione insostenibile: ero deciso, se non a fondare una religione, almeno a dirigermi in tal senso. […] Per quanto una simile ubbia possa sembrare stupefacente, io la presi sul serio. È l’epoca in cui feci apparire con degli amici la rivista “Acéphale”. […] Voglio solo precisare che l’inizio della guerra rese decisamente avvertibile l’insignificanza di questo tentativo»
Sono molte e significative le vicende, personali e culturali, attraversate da Georges Bataille nel corso degli anni Trenta. La più singolare è forse quella legata a una rivista da lui fondata, «Acéphale», e alla società segreta che recava lo stesso nome. L’intento del duplice progetto era, in un certo senso, di tipo religioso, ma di una religiosità che prendeva atto fin da subito della morte di Dio annunciata da Nietzsche. La setta, che riuniva attorno a Bataille un ristretto numero di adepti, svolgeva un’attività di riflessione sulle opere del filosofo tedesco, ma praticava anche dei rituali di tipo cerimoniale. L’esperienza è stata importante per lo scrittore, anche se è durata solo pochi anni e se alla fine egli è sembrato giudicarla, per molti aspetti, mancata. Ha ricordato infatti, in una nota autobiografica, quanto segue: «Avevo passato gli anni precedenti [al 1940] con una preoccupazione insostenibile: ero deciso, se non a fondare una religione, almeno a dirigermi in tal senso. […] Per quanto una simile ubbia possa sembrare stupefacente, io la presi sul serio. È l’epoca in cui feci apparire con degli amici la rivista “Acéphale”. […] Voglio solo precisare che l’inizio della guerra rese decisamente avvertibile l’insignificanza di questo tentativo»Scarica il PDF
A cura di
Giuseppe Zuccarino è critico e traduttore. Ha pubblicato vari saggi: La scrittura impossibile, Genova, Graphos, 1995; L’immagine e l’enigma, ivi, 1998; Critica e commento. Benjamin, Foucault, Derrida, ivi, 2000; Percorsi anomali, Udine, Campanotto, 2002; Il desiderio, la follia, la morte, ivi, 2005; Il dialogo e il silenzio, ivi, 2008; Da un’arte all’altra, Novi Ligure, Joker, 2009; Note al palinsesto, ivi, 2012; Il farsi della scrittura, Milano-Udine, Mimesis, 2012; Prospezioni. Foucault e Derrida, ivi, 2016. Tra i libri da lui tradotti figurano opere di Mallarmé, Bataille, Klossowski, Blanchot, Caillois e Barthes. Ha inoltre curato un fascicolo monografico della rivista «Riga» (n. 37, 2017) dedicato a Maurice Blanchot.
-
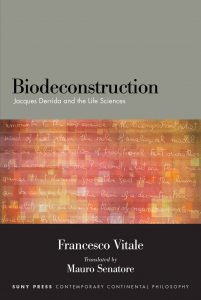 Tra le scuole di pensiero marcatamente connotate dalla presenza di un capostipite fondatore – si pensi alla fenomenologia di Husserl, all’ermeneutica di Heidegger, e alla biopolitica di Foucault – oggi è forse la decostruzione a godere della più vasta pervasività; e non tanto per intensità e clamore mediatico, quanto piuttosto in termini di tacita assunzione e di capillarità. A nostro modo di vedere, ciò è potuto accadere poiché, situandosi a cavallo di istanze epistemologico-metodologiche e di ipotesi ontologiche forti, il pensiero di Derrida ha raggiunto lo statuto di referente teorico ineludibile, sia dal punto di vista dei detrattori sia da quello dei più strenui fautori. Equipaggiando la filosofia di un metodo critico di lettura e riscrittura, così come, al contempo, drenando dai bacini delle filosofie decostruite operatori concettuali dormienti, la decostruzione ha fornito strumenti e spazi di disputa. È divenuta cioè il teatro ideale di animate discussioni, tanto interne, volte ad affinare la lettura degli stessi testi derridiani, quanto esterne, ossia vertenti sulla possibilità o meno di applicare le procedure e le nozioni decostruttive in relazione a prospettive di diverso lignaggio. Ora, è esattamente in direzione di questo doppio binario che si inserisce il recente lavoro di Francesco Vitale, Biodeconstruction. Jacques Derrida and Life Sciences (Suny Press, 2018). Frutto di un’attenta ricerca filologica, capace di coordinare l’approccio storico-ricostruttivo con quello più spiccatamente propositivo, il testo di Vitale si situa a pieno titolo tra i lavori della “scuola” decostruttiva progressista, intendendo con questa espressione quel filone di studi derridiani – di cui Rodolphe Gasché è probabilmente il nume tutelare – impegnati a manifestare fedeltà metodologica alla decostruzione, tramite un’espansione della sua area di operatività. Dopotutto il volume di Vitale, come si vedrà, cerca di assecondare quello che fu l’auspicio stesso di Derrida: preservare la singolarità del gesto decostruttivo tradendone però, di volta in volta, i limiti epistemici.
Tra le scuole di pensiero marcatamente connotate dalla presenza di un capostipite fondatore – si pensi alla fenomenologia di Husserl, all’ermeneutica di Heidegger, e alla biopolitica di Foucault – oggi è forse la decostruzione a godere della più vasta pervasività; e non tanto per intensità e clamore mediatico, quanto piuttosto in termini di tacita assunzione e di capillarità. A nostro modo di vedere, ciò è potuto accadere poiché, situandosi a cavallo di istanze epistemologico-metodologiche e di ipotesi ontologiche forti, il pensiero di Derrida ha raggiunto lo statuto di referente teorico ineludibile, sia dal punto di vista dei detrattori sia da quello dei più strenui fautori. Equipaggiando la filosofia di un metodo critico di lettura e riscrittura, così come, al contempo, drenando dai bacini delle filosofie decostruite operatori concettuali dormienti, la decostruzione ha fornito strumenti e spazi di disputa. È divenuta cioè il teatro ideale di animate discussioni, tanto interne, volte ad affinare la lettura degli stessi testi derridiani, quanto esterne, ossia vertenti sulla possibilità o meno di applicare le procedure e le nozioni decostruttive in relazione a prospettive di diverso lignaggio. Ora, è esattamente in direzione di questo doppio binario che si inserisce il recente lavoro di Francesco Vitale, Biodeconstruction. Jacques Derrida and Life Sciences (Suny Press, 2018). Frutto di un’attenta ricerca filologica, capace di coordinare l’approccio storico-ricostruttivo con quello più spiccatamente propositivo, il testo di Vitale si situa a pieno titolo tra i lavori della “scuola” decostruttiva progressista, intendendo con questa espressione quel filone di studi derridiani – di cui Rodolphe Gasché è probabilmente il nume tutelare – impegnati a manifestare fedeltà metodologica alla decostruzione, tramite un’espansione della sua area di operatività. Dopotutto il volume di Vitale, come si vedrà, cerca di assecondare quello che fu l’auspicio stesso di Derrida: preservare la singolarità del gesto decostruttivo tradendone però, di volta in volta, i limiti epistemici. -
Start Up: paradossi
Serial, Start up / Giugno 2018“New York is shit” (concettualmente, “tanta roba”), dichiara Irma, tra le personalità di spicco della scena teche creativa newyorkese contemporanea mentre girovaghiamo nella nuovissima sede di Grand Central Tech, tra Madison e Park Avenue, e dalle cui finestre si guarda l’iconica Grand Central Station, simbolo storico di degrado e rinascita contemporanea urbana. Forse Foucault si è immaginato uno spazio così, una città cosìquando, a ragione, aveva detto che «quella attuale potrebbe […] essere considerata l’epoca dello spazio. Viviamo nell’epoca del simultaneo, nell’epoca della giustapposizione, nell’epoca del vicino e del lontano, del fianco a fianco, del disperso. Viviamo in un momento in cui il mondo si sperimenta […] come un reticolo che incrocia dei punti e che intreccia la sua matassa» (Foucault 2010). In effetti, a New York c’è “il mondo” e nel mondo c’è New York: dello spazio si è fatto il mito e del mito uno spazio. Pensateci: anche se non ci siete mai stati, già sapete come vi sentireste, conoscete le sue strade, godete dei suoi sapori e vi immaginate in modo chiaro: non è questa l’essenza del mito? Uno script da seguire rispetto a un certo modo di stare al mondo?

Persistence of Memory - Daniel Horowitz (2016)
Seguire il filo del dispiegarsi del mito, il suo fissarsi negli oggetti e sui muri, nelle parole dette e taciute, è importante e lo è per diverse ragioni, in primis per svelarsi in quanto soggetti assoggettati al suo discorso. In altre parole, per esser un po’ meno governati (Foucault, 2007), è necessario comprendere bene la presa discorsiva a cui siamo assoggettati. E’ un gesto che mostrerebbe a tutti gli effetti la vulnerabilità dell’uomo rispetto all’ambiente già fatto in cui nasce. Non è forse paradossale che in un mondo sempre più pervaso da oggetti che regolano, delimitano, direzionano il discorrere e il trascorrere quotidiano della vita, gli umani amino, forse ancor più che in passato, narrar di se stessi una storia finalmente libera da vincoli? Il controllo è una cosa assai strana: nessuno ama riconoscere la presa che altri esercitano su di sé, neppure il masochista che gode di questo, ma ancora meno quella esercitata dai non-umani, quasi che il controllo e il potere esistessero soprattutto in stati d’eccezione, i soli degni d’essere ricordati nelle pagine dei libri di storia. «L’illusione della libertà psichica dell’individuo», scriveva Freud ne L’Interpretazione dei Sogni con riferimento alle resistenza a prendere i sogni (notturni, in questo caso) sul serio. Questa resistenza si rinviene, come il padre della psicoanalisi ha argomentato in più occasioni, anche con rifermento ai sogni diurni, alle fantasie e, più in generale, aggiungerei, agli spazi immaginari. Questi ultimi, si può supporre, si collocano in una sorta di curioso spazio altro, di soglia, abitato da umani e non-umani e dotato in certo senso di “vita propria”. In effetti, il problema dell’immaginario sta proprio in questo, ovvero nel fatto che si spinga, nei suoi effetti, molto al di là di quanto sia stato autorizzato a spingersi: questo perché è governato, nel caso del sogno diurno, da “Sua maestà” l’Io (con il conclamato vizietto di credersi onnipotente) oppure, nel caso del sogno notturno, da indisciplinate pulsioni inconsce che incessantemente ambiscono a “sfondare” gli argini creati per contenerli. Paradossalmente - questo il secondo paradosso - nel momento in cui si rinviene un continuo richiamo all’immaginario, ci si nutre di esso secondo una certa letteratura critica e da un punto di vista pratico si fonda la politica sulle sue fragili basi, al tempo stesso si nega con forza la presa che esso stesso ha su di noi. Non è forse fantasioso dire di “cambiare il mondo” tramite l’innovazione? Eppure non è forse vero che, a parte per i cinici, questo è il lessico divenuto ormai familiare, circolante e dominante nello spazio sociale contemporaneo? Un buon esercizio per approfondire la questione consiste nel mettere al lavoro il concetto analitico di “fantasia”, iniziando innanzitutto col dire che è cosa serissima.
di Anna Paola Quaglia
Freud, S. (2010), Introduzione alla psicoanalisi (1915), trad. ita. di Tonin Dogana M. e Sagittario E., Torino, Bollati Boringhieri, pp. 606.
Freud, S. (1966), “L’interpretazione dei sogni” (1899), Opere 1989 (Opere di Sigmund Freud a cura di Mussatti C.L.), Torino, Bollati Boringhieri, pp. 637.
Freud, S.(2003), “The Creative Writer and Daydreaming” (1908), in Maclintock D. (a cura di), The Uncanny, London: Penguin Books, pp. 25-34.
Jacobs J. (2006), Vita e morte delle grandi città. Saggio sulle metropoli americane, Torino, Einaudi, pp. 426.
Malservisi C. (1983), “L’aula: un posto per viverci” in L’Educatore Italiano, 4.
Piazzoni F. (1983), “Ancora l’aula e i corridoi” in L’Educatore Italiano, 4.
Pile S. (2005), “Building Dreams Space, Psychoanalysis, and the City” in Annual of Psychoanalysis, 33, pp. 79-91.
-
 La constatazione della pervasività degli automatismi che intessono la nostra esistenza individuale e collettiva porta Pelgreffi a sviluppare un’interrogazione radicale intorno all’essenza di tale fenomeno. L’automatismo viene considerato a partire dall’ampiezza del suo senso, che trova applicazione in ambiti apparentemente eterogenei, come il biologico e il sociale, rivelando, fin dall’inizio, la sua costitutiva ambiguità, che porta, tra l’altro, a un’essenziale riconfigurazione della tradizionale opposizione tra naturale e culturale. Il comportamento automatico si rivela essere, da una parte, il modo di manifestarsi di ciò che è spontaneo, non programmato, emergente. In quest’ottica, afferisce all’ambito del biologico, delle procedure innate radicate nel profondo del bios, dell’inconscio corporeo e psichico. Dall’altra, richiama ciò che è stato appreso ed è diventato abitudine, nel senso di ciò che si impone come prassi automatica a seguito di ripetizioni esercitanti. Si tratta, in questo caso, dello spettro di significati che rimandano al contesto della “seconda natura”, ossia delle abitudini acquisite nel corso della vita, le quali si installano sugli automatismi innati, rimpiazzandoli e riconfigurandoli.
La constatazione della pervasività degli automatismi che intessono la nostra esistenza individuale e collettiva porta Pelgreffi a sviluppare un’interrogazione radicale intorno all’essenza di tale fenomeno. L’automatismo viene considerato a partire dall’ampiezza del suo senso, che trova applicazione in ambiti apparentemente eterogenei, come il biologico e il sociale, rivelando, fin dall’inizio, la sua costitutiva ambiguità, che porta, tra l’altro, a un’essenziale riconfigurazione della tradizionale opposizione tra naturale e culturale. Il comportamento automatico si rivela essere, da una parte, il modo di manifestarsi di ciò che è spontaneo, non programmato, emergente. In quest’ottica, afferisce all’ambito del biologico, delle procedure innate radicate nel profondo del bios, dell’inconscio corporeo e psichico. Dall’altra, richiama ciò che è stato appreso ed è diventato abitudine, nel senso di ciò che si impone come prassi automatica a seguito di ripetizioni esercitanti. Si tratta, in questo caso, dello spettro di significati che rimandano al contesto della “seconda natura”, ossia delle abitudini acquisite nel corso della vita, le quali si installano sugli automatismi innati, rimpiazzandoli e riconfigurandoli.L’intento di Pelgreffi è rendere tale ambiguità, consustanziale al concetto di automatismo, non già paradosso paralizzante, ma apertura di senso produttiva e meritevole di essere indagata nella sua doppiezza. Tale approccio permette di chiamare in causa un’altra ambiguità del concetto di automatismo, che concerne il suo riferirsi, al tempo stesso, alla vita individuale e collettiva. Gli automatismi sviluppati dai singoli individui si riflettono e dialogano costantemente con le dinamiche che regolano la convivenza, culturalmente codificata, all’interno di un collettivo. Tale prisma semantico viene messo in luce tramite un’attenta e avveduta rassegna delle teorie di coloro che si sono occupati, ciascuno a modo proprio ma anche in dialogo reciproco, del concetto di automatismo. Dalle analisi classiche intorno al concetto aristotelico di hexis si giunge alla filosofia francese novecentesca, passando per Hume, Nietzsche e Butler. Non viene tralasciato il dialogo, da una parte, con le scienze psicologiche (in particolare Pavlov e Janet) e, dall’altra, con la pratica artistica dell’attore, compresa attraverso le riflessioni di Diderot e di Stanislavskij. Tali incursioni ermeneutiche permettono a Pelgreffi di approdare a un dialogo serrato con i risultati teorici ottenuti da Merleau-Ponty, in particolare nella sua Fenomenologia della percezione, e mettere in evidenza il ruolo cruciale che la corporeità svolge all’interno di una teoria generale degli automatismi.

Il corpo, compreso come limite e soglia, si configura come il punto fondamentale di incrocio e trasformazione tra le diverse forme di automatismo evidenziate in precedenza. Tale approccio permette di delineare la funzione formante degli automatismi, ossia la circostanza, secondo la quale l’acquisizione di abitudini ripetute ha valore soggettivante, nella misura in cui plasma la modalità di esistenza di chi incarna tali abitudini. È una simile prospettiva che permette a Pelgreffi di introdurre la dinamica eminentemente etica aperta da una filosofia dell’automatismo, nella misura in cui la funzione formante di quest’ultimo rivela, come suo doppio costitutivo, la presenza di una resistenza basale, della possibilità di uno stacco produttore di divergenza, nel processo di acquisizione degli automatismi e nella loro riconfigurazione. In tale potenzialità trasformante si cela la possibilità etica e il focus gnoseologico che permettono di comprendere come si possa produrre differenza attraverso la ripetizione, ossia come sia possibile la de-automatizzazione dei propri automatismi, pur dimorando all’interno dell’orizzonte ampiamente automatizzato in cui la vita si esplica in quanto tale.
La peculiarità dell’approccio adottato da Pelgreffi consiste nel situare nel corpo e, pertanto, nell’insieme di pratiche che possono proporsi di istituire i criteri di un’etica della corporeità, la soglia di tale possibilità di de-automatizzazione, ossia di riconfigurazione critica dei propri automatismi attraverso gli automatismi stessi: «la corporeità è la zona intermediale in cui l’automatismo come senza precedenti e l’automatismo come risultato della ripetizione trovano una sintesi non neutralizzante, aperta anche alla diversione dalla forma sintetica operante» (p. 88). Una tale prospettiva viene conquistata considerando gli automatismi nella loro dimensione genetica e processuale, al fine di comprendere l’acquisizione di un’abitudine nel suo svolgersi e affermarsi e metterne in luce la struttura composta da esercizi ripetuti con effetti di ritorno plastici e in continuo dialogo con una resistenza produttiva installata nella corporeità. Particolare rilievo assume, in una tale ottica, l’attenzione al processo di apprendimento delle abitudini, nel quale si celano le codificazioni sociali (Bourdieu) e i presupposti manuali della tecnica (Sennett). L’intento è quello di ricondurre criticamente il potere della ripetizione automatizzantesi contro la ripetizione stessa, in quanto «all’interno dell’automatismo, esistono contro-movimenti di de-automatizzazione che si tratta di veicolare, di guidare e gestire dall’interno» (p. 220). A partire da questa prospettiva, è importante rilevare come un tale approccio permetta di aprire la strada a una radicale riconfigurazione del ruolo della soggettività, la quale non viene abbandonata, ma ridimensionata e ricondotta alle pratiche di vita, innervate nella corporeità e nel suo fondo inconscio, solo a partire dalle quali la figura del soggetto si può manifestare, dato che «non c’è soggetto senza automatismo, senza estroflessione originaria al dispositivo» (p. 179). È al livello di tali pratiche, delle quali il soggetto rappresenta il risultato epifenomenico parziale e posteriore, che un’etica della resistenza produttiva e della ripetizione differenziante può essere codificata.
di Marco Pavanini
-
 Se volessimo individuare le idee che si collocano alla base della nascita della filosofia in India dovremmo articolare un discorso attraverso tre passaggi tra loro collegati. Innanzitutto dovremmo dire che i testi radicali della riflessione filosofica indiana, le Upaniṣad, sono interamente pervasi dalla ricerca della corrispondenza tra macro e micro cosmo. Questa istanza di unità diventò però immediatamente l’occasione per riflettere su due problemi interconnessi. Il primo problema è quello che in occidente definiremmo del “trascendentale”, intendendo con ciò un’anticipazione della visione kantiana secondo cui la realtà empirica è soltanto la forma in cui la realtà essenziale si presenta alla coscienza, ma tale realtà empirica non sussiste indipendentemente da una coscienza. In tempi antichissimi, intorno al secondo millennio avanti Cristo, tale visione della correlazione tra coscienza e mondo e insieme della necessità di un suo superamento verso una dimensione unitaria dell’esperienza divenne manifesta ai veggenti vedici assisi in meditazione nelle foreste indiane. Le Upaniṣad dettero il nome di ātman (letteralmente: “sé”) alla scoperta di questo principio trascendentale. Da un punto di vista metafisico l’ātman è un principio reggitore e ordinatore dell’universo e, quando viene considerato come Sé universale, possiede anche un aspetto psichico che lo rende auto-cosciente del tutto. Il punto centrale di questo primo aspetto della riflessione indiana delle origini è quindi l’identificazione del cosmico con lo psichico, nel senso che l’ātman si configura come un assoluto che possiede insieme i caratteri dell’essere e del pensiero. La coscienza-ātman non ha quindi niente fuori di sé, e tutti gli oggetti e le relazioni dell’universo esistono solo in quanto oggetti-di-conoscenza. Questo quadro concettuale, che possiede una innegabile connotazione trascendentalista, compare per la prima volta nella Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad (tra il IX e l'VIII secolo a.C), attraverso il punto di vista del maestro Yājñavalkya [1] e sarà una delle direttrici principali della riflessione filosofica indiana matura. Durante il periodo classico della filosofia indiana (V-VIII secolo d. C.) – in cui troviamo dei sistemi filosofici distinti che però condividono alcune idee di base che provengono dalla fase upaniṣadica – portato fondamentale di tale concezione trascendentale sarà il concetto di māyā, ovvero 1) il fatto che il mondo empirico sia “apparenza”, dal momento che non è possibile conoscere la reale essenza delle cose, e 2) che la pluralità non sia reale in senso proprio, dal momento che solo l’unità è reale, e questa unità è l’unità della coscienza, cioè dell’ātman. [2]
Se volessimo individuare le idee che si collocano alla base della nascita della filosofia in India dovremmo articolare un discorso attraverso tre passaggi tra loro collegati. Innanzitutto dovremmo dire che i testi radicali della riflessione filosofica indiana, le Upaniṣad, sono interamente pervasi dalla ricerca della corrispondenza tra macro e micro cosmo. Questa istanza di unità diventò però immediatamente l’occasione per riflettere su due problemi interconnessi. Il primo problema è quello che in occidente definiremmo del “trascendentale”, intendendo con ciò un’anticipazione della visione kantiana secondo cui la realtà empirica è soltanto la forma in cui la realtà essenziale si presenta alla coscienza, ma tale realtà empirica non sussiste indipendentemente da una coscienza. In tempi antichissimi, intorno al secondo millennio avanti Cristo, tale visione della correlazione tra coscienza e mondo e insieme della necessità di un suo superamento verso una dimensione unitaria dell’esperienza divenne manifesta ai veggenti vedici assisi in meditazione nelle foreste indiane. Le Upaniṣad dettero il nome di ātman (letteralmente: “sé”) alla scoperta di questo principio trascendentale. Da un punto di vista metafisico l’ātman è un principio reggitore e ordinatore dell’universo e, quando viene considerato come Sé universale, possiede anche un aspetto psichico che lo rende auto-cosciente del tutto. Il punto centrale di questo primo aspetto della riflessione indiana delle origini è quindi l’identificazione del cosmico con lo psichico, nel senso che l’ātman si configura come un assoluto che possiede insieme i caratteri dell’essere e del pensiero. La coscienza-ātman non ha quindi niente fuori di sé, e tutti gli oggetti e le relazioni dell’universo esistono solo in quanto oggetti-di-conoscenza. Questo quadro concettuale, che possiede una innegabile connotazione trascendentalista, compare per la prima volta nella Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad (tra il IX e l'VIII secolo a.C), attraverso il punto di vista del maestro Yājñavalkya [1] e sarà una delle direttrici principali della riflessione filosofica indiana matura. Durante il periodo classico della filosofia indiana (V-VIII secolo d. C.) – in cui troviamo dei sistemi filosofici distinti che però condividono alcune idee di base che provengono dalla fase upaniṣadica – portato fondamentale di tale concezione trascendentale sarà il concetto di māyā, ovvero 1) il fatto che il mondo empirico sia “apparenza”, dal momento che non è possibile conoscere la reale essenza delle cose, e 2) che la pluralità non sia reale in senso proprio, dal momento che solo l’unità è reale, e questa unità è l’unità della coscienza, cioè dell’ātman. [2] -
Da qualche tempo alcuni autori italiani attivi nel campo disciplinare della filosofia stanno conoscendo una notevole fortuna all’estero, in special modo nell’area anglosassone. Si è così potuto parlare, addirittura, di una Italian Theory, da affiancare alla French Theory quale risorsa da mobilitare in vista della costruzione di un discorso critico sul presente. Per contro, risulta del tutto caduta nell’oblio, sia in patria che all’estero, una tradizione di pensiero legata al liberalismo la quale, in maniera forse ancor più marcata rispetto all’Italian Theory, ha sempre posto al centro del proprio discorso la necessità di riflettere sul senso della vita associata, sui fondamenti del buon governo, sulla legittimità del potere, sul nesso che lega libertà e giustizia, su ciò che funge da presupposto alla realizzazione di una vita democratica pienamente intesa.
In generale, si potrebbe dire che sin dalle proprie origini il discorso filosofico in Italia - potremmo, volendo, far cominciare questa storia con il De monarchia dantesco - ha legato le proprie sorti a una riflessione sul politico, e quasi sempre ciò è avvenuto a partire dalla necessità di indagare problemi concreti, strettamente intrecciati alla vita civile e politica della penisola o dei singoli stati che ne costellavano il territorio. Tuttavia, qui si vorrebbe porre l’accento su una peculiare linea di pensiero che, partendo dall’Ottocento, giunge sino alla prima metà del Novecento per poi in qualche modo insabbiarsi, lasciando il campo a dibattiti di tutt’altro genere, che sembrano non poter (o non voler) nemmeno comunicare con essa. Insomma, si tratta di una tradizione che pare non abbia lasciato eredi. I nomi di riferimento potrebbero essere i seguenti: Melchiorre Gioia, Gian Domenico Romagnosi, Carlo Cattaneo, Pietro Gobetti, i fratelli Rosselli, Gaetano Salvemini, Luigi Einaudi, Emilio Lussu, Ernesto Rossi, Bruno Leoni, Guido Calogero, arrivando fino a Norberto Bobbio. Dai nomi appena evocati, risulta chiaro che parlare qui di “tradizione” forse può apparire come una forzatura sul piano storiografico. Di fatto, però, è innegabile come sia riscontrabile la presenza di un legame che permette di accostare tra loro questi autori e di nominarli assieme - fino a formare una sorta di sequenza ideale. Qui di seguito, proviamo a formulare ciò che potrebbe costituire un provvisorio elenco degli elementi portanti del complesso di idee che li accomuna.

Impegno teorico a favore di una “civile filosofia” (l’espressione è del Romagnosi) che sappia interagire con i problemi concreti posti dall’arte di governo. Necessità di partire da un’antropologia di tipo realistico, svincolata dall’eccessivo ottimismo di matrice illuminista, ma nel contempo erede di esso. Tutto ciò vuol dire sia fiducia nell’educabilità degli umani, che si spera possano diventare cittadini responsabili e partecipi, sia consapevolezza del peso che hanno i pregiudizi, l’ignoranza, le conseguenze del malgoverno, assieme a quelle forme di propaganda che diffondono atteggiamenti e concezioni populiste, reazionarie, antidemocratiche. A questo aspetto si collega il tratto che forse davvero accomuna tutti gli autori sopra menzionati: la volontà, cioè, di articolare un discorso teorico mai astratto, mai votato all’edificazione di sistemi di pensiero, ma sempre aderente alla contingenza della fase storica in cui si trova a operare il soggetto chiamato a dar conto degli effetti che la propria teoria può eventualmente produrre. Ed è, questo tratto, ciò che nel contempo permette di convocare sulla scena il termine liberalismo. Si tratta di un liberalismo che potremmo definire “eretico”, se si considera il fatto che esso ha potuto, a un certo punto, dar vita a quello strano ossimoro che è il “liberalsocialismo”; ma è liberalismo autentico in virtù dell’insistenza sulla libertà individuale quale valore fondante della vita associata, una libertà che si riconosce indissolubile dalla giustizia e dalla necessità di porre al centro sia dell’agenda politica, sia dell’agenda teorica che su quella riflette, il problema dell’ineguaglianza sociale e della disparità nell’accesso alle risorse.
In relazione a tale peculiarità della tradizione liberale italiana che vorremmo individuare - e, forse, contribuire a “costruire” più che ricostruire storiograficamente, in un modo che non intende essere troppo artificioso - resta infine da chiedersi in che misura il pensiero di questi autori può essere considerato attuale. Certo, a prima vista questa sembra una domanda del tutto illegittima: legato alla contingenza di lotte politiche che non sono più le nostre, il pensiero degli autori sopra menzionati sembra offrirsi al nostro sguardo solo più come oggetto di studio rilevante in sede di storia della filosofia – o di storia del pensiero politico. Tuttavia, se consideriamo il dibattito filosofico contemporaneo, il quale sembra oscillare da un lato in direzione di questioni rilevanti solo sul piano gnoseologico e ontologico, dall’altro in direzione di una mescolanza di temi foucaultiani e temi di ascendenza marxista al fine di produrre un discorso critico la cui radicalità, a volte, è però solo retorica ed è inficiata da una notevole mancanza di rigore teoretico, ecco che dalla tradizione del liberalismo italiano ricaviamo forse delle lezioni ancora utili per definire la cornice critica entro la quale ripensare gli snodi problematici del presente.
A cura di Giovanni Leghissa e Alberto Giustiniano
Scarica PDF
English version
DOI: https://doi.org/10.13135/2385-1945/8.2018
Pubblicato: marzo 2018
Indice
Editoriale
G. Leghissa, A. Giustiniano - Introduzione [PDF It]
I. La via italiana al liberalismo
S. Veca - Sul liberalismo politico e la giustizia come equità [PDF It]
P. P. Portinaro - Italian Style. La cifra del realismo politico [PDF It]
II. Storia della rivoluzione liberale
M. Lasala - Nel nome della rivoluzione liberale. Da Gobetti a Bobbio [PDF It]
M. Ferrari - Etica, politica, socialismo. Un capitolo del caso italiano [PDF It]
R. Cubeddu - I liberisti della cultura politica italiana [PDF It]
III. Liberali ed eretici
G. Panizza - Giuseppe Ferrari. Un pensatore eterodosso del nostro risorgimento [PDF It]
A. Zarlenga - Ernesto Buonaiuti tra liberalismo modernista e socialismo cristiano [PDF It]
G. Becchio - Luigi Einaudi. Un economista e un liberale a Torino [PDF It]
G. Giorgini - Nicola Matteucci. Un liberale eretico [PDF It]
-
 Nelle sei lezioni che compongono Il senso della possibilità, edito a gennaio per Feltrinelli (2018), Salvatore Veca completa una trilogia di saggi ̶ iniziata nel 1997 con Dell’incertezza e continuata nel 2011 con L’idea di incompletezza ̶ che rappresenta uno dei più complessi itinerari teorici del panorama filosofico italiano degli ultimi vent’anni. Nello specifico, in questo terzo volume, Veca si impegna nella difficile impresa di delineare il senso della nozione di possibilità entro il quadro di un’interpretazione filosofica delle modalità che si dimostri in grado di dar conto della connessione tra l’impiego dei termini modali (attuale, possibile, necessario, contingente) e i nostri atteggiamenti proposizionali ordinari del reputare “come stanno le cose” nel mondo che ci circonda. In altre parole, l’autore muovendo da una prospettiva epistemica prova a far luce sui processi che generano le nostre descrizioni e prescrizioni e, in particolar modo, sulle ragioni del loro trasformarsi nel tempo, imputabili in vario modo ai mutamenti nell’ambito delle teorie e delle pratiche (p. 16).
Nelle sei lezioni che compongono Il senso della possibilità, edito a gennaio per Feltrinelli (2018), Salvatore Veca completa una trilogia di saggi ̶ iniziata nel 1997 con Dell’incertezza e continuata nel 2011 con L’idea di incompletezza ̶ che rappresenta uno dei più complessi itinerari teorici del panorama filosofico italiano degli ultimi vent’anni. Nello specifico, in questo terzo volume, Veca si impegna nella difficile impresa di delineare il senso della nozione di possibilità entro il quadro di un’interpretazione filosofica delle modalità che si dimostri in grado di dar conto della connessione tra l’impiego dei termini modali (attuale, possibile, necessario, contingente) e i nostri atteggiamenti proposizionali ordinari del reputare “come stanno le cose” nel mondo che ci circonda. In altre parole, l’autore muovendo da una prospettiva epistemica prova a far luce sui processi che generano le nostre descrizioni e prescrizioni e, in particolar modo, sulle ragioni del loro trasformarsi nel tempo, imputabili in vario modo ai mutamenti nell’ambito delle teorie e delle pratiche (p. 16).A partire dalle precedenti ricerche sulle nozioni di incertezza e incompletezza, ritenute rispettivamente l’origine della tensione teoretica e il carattere proprio del risultato che ne scaturisce, Veca ci accompagna in un tortuoso itinerario lungo i limiti della pratica filosofica, fino al punto di rottura in cui il necessario diviene contingente e l’inaspettato si manifesta nella forma dello scacco. L’intento però non è soltanto porre l’accento sullo stato di crisi di fiducia o legittimità che investe ciclicamente l’impresa del senso ma di indagarne il ruolo epistemologico. Il ripetersi della crisi, manifestantesi attraverso l’esigenza di impegnarsi in manovre metateoriche, andrebbe interpretato piuttosto come un promemoria antiriduzionistico dovuto a una sorta di inesauribilità propria degli oggetti dell’indagine filosofica. La natura di tali oggetti stimolerebbe l’adozione di una molteplicità di punti di vista in una manovra intellettuale che fa “di necessità virtù” ma che nel contempo rappresenta la possibilità stessa di una relazione conoscitiva con “ciò che c’è”. Si pensi al senso di povertà e angustia che ci assale quando dimostriamo le ragioni irrevocabili di un unico punto di vista rispetto agli enigmi ricorrenti o inaspettati della filosofia, ci ricorda l’autore. Da queste considerazioni preliminari (oggetto della Prima lezione), seguendo una linea che dall’enciclopedia di Husserl porta ai giochi linguistici di Wittgenstein per giungere fino al paradigma della spiegazione di Nozick, Veca torna a chiedersi se «non dovremmo guardare all’attività filosofica come a un ventaglio di stili d’indagine e di scopi e obiettivi di ricerca differenti e alternativi» che, se prendiamo sul serio la storia, ci accorgiamo «persistere quasi nella forma di motivi musicali, nel repertorio o nell’archivio» (pp. 32-33). Ed è proprio qui, all’incrocio tra dimostrazione e spiegazione, che la nozione modale di possibilità diviene elemento cruciale per mettere a fuoco la stretta connessione tra contingenza e verità. Connessione che si manifesta in tre sensi del possibile: 1) reputare qualcosa possibile in senso ampio (epistemico); 2) immaginare e sperimentare mentalmente mondi possibili; 3) pensare se stessi nella durata e dunque nel proprio essere oggetto di trasformazione.
A fornire la struttura portante del saggio è la lunga riflessione rivolta al primo senso del possibile, che si svolge trasversalmente a tutte le sei lezioni ma che diviene protagonista, in particolare, della prima e della quarta. Qui, ripartendo dall’analisi delle categorie e dei giudizi modali svolta da Kant nella Critica della ragione pura, Veca osserva innanzitutto che quando reputiamo possibile, attuale o necessario qualcosa non facciamo riferimento al contenuto proposizionale degli enunciati «quanto piuttosto al tipo di relazione fra l’atteggiamento del soggetto che giudica e l’enunciato corrispondente». Le modalità hanno dunque a che vedere con i nostri atteggiamenti proposizionali, con «la posizione che noi specifichiamo, assegnando epistemicamente modalità alternative agli stessi stati di cose. x è p: possibile, attuale, necessario» (p. 41). Questo genera due problemi per la riflessione kantiana che si rivelano cruciali per l’indagine. In primo luogo, il fatto che le categorie modali risultano distinte nettamente dalle altre categorie in quanto tetiche: esse accompagnano le variazioni del “porre” dando conto del soggetto e non dei modi dell’oggetto. In secondo luogo, diviene centrale la categoria dell’attuale (wirklich) e il giudizio assertorio. Queste assumono un ruolo prioritario poiché chiamano in causa la posizione “in quanto tale” dell’oggetto nello spazio e nel tempo (absolute Setzung) mentre possibilità e necessità di un oggetto indicano soltanto rispettivamente l’accordo con la regola o la posizione secondo una regola. In questo senso l’attuale (nel senso della Wirklichkeit), implicando l’assegnazione di esistenza a qualcosa, «è immerso in un intorno in cui si danno ex ante possibilità e, ex post, necessità» (p. 42). In questo senso, secondo Veca, la priorità dell’attuale così come intesa da Kant indica l’unica via d’accesso per il soggetto al possibile e al necessario e nondimeno implica una gerarchia in cui l’orizzonte di partenza ineludibile è l’esperienza presente. Il problema che tuttavia permane nella prospettiva kantiana è il suo realismo empirico: perché l’esemplificazione esistenziale abbia successo è necessario soddisfare la condizione della percezione nello spazio e nel tempo di un oggetto. Tale componente del sistema kantiano è però inutilmente restrittiva e non tiene conto di una vasta gamma di modi con cui assegniamo esistenza a qualcosa nel nostro linguaggio ordinario. L’autore fa qui riferimento ai recenti sviluppi logici dei temi kantiani elaborati da Hintikka per mostrare come il nostro reputare vero o falso un qualsiasi stato di cose sia implicitamente legato a processi di comparazione tra una serie di stati di cose possibili al fine di classificare quelli che sono compatibili con ciò che viene percepito come stato attuale. Questo significa che quando esploriamo il mondo che ci circonda mettiamo in atto «giochi di ricerca e ritrovamento» sul modello dei giochi linguistici di Wittgenstein che però in questo caso si svolgono tra il ricercatore e la natura. Che qualcosa esista è l’esito riuscito di tale attività che, come sostenuto da Kant, si svolge nell’ambito delle nostre percezioni di oggetti. Gli oggetti nello stato attuale a loro volta vanno intesi come ciò cui possiamo riferirci alla luce dell’esito positivo dei nostri giochi di ricerca e ritrovamento, e fino a prova contraria (pp. 43-44).

Fan Ho - The Lonely Conductor
È bene precisare che l’idea guida di queste analisi non mira a negare l’importanza degli aspetti aletici o deontici al contrario vuole impegnarsi «a connettere l’impiego dei termini modali ai nostri atteggiamenti ordinari e, in particolare, ai nostri atteggiamenti proposizionali, ai nostri giudizi intuitivi di modalità, al nostro reputare» come stanno le cose in una varietà di domini. Questo significa impegnarsi nell’elaborazione di una versione del realismo che integri l’assunzione realistica elementare, secondo cui esiste un mondo là fuori indipendente da noi, e che tenga conto della rilevanza del fatto che all’attuale è possibile riferirsi in più di un modo. Sostenere infatti che qualcosa c’è non è affatto controverso, più complesso è rispondere alla domanda a proposito di ciò che diciamo che vi è (p. 44). In particolare nella quarta lezione, dal titolo Epistemologia, necessità e realismo, Veca si propone di mostrare come la progressiva trasformazione dell’immagine della scienza ̶ dalla visione statica neopositivista della prima metà del secolo all’interesse per la dinamica dell’impresa scientifica dalla seconda metà in avanti ̶ abbia determinato una profonda revisione, non soltanto della nostra concezione del rapporto tra teoria e realtà, ma anche dell’appropriato significato epistemico da attribuire all’operatore modale di necessità (p. 130). La svolta causata nel Circolo di Vienna dal falsificazionismo di Popper prima e dalle Ricerche filosofiche di Wittgenstein dopo ha messo fuoco la dinamica storica che caratterizza il cambiamento concettuale dell’impresa scientifica, ponendo l’accento sulla sua dimensione pragmatica e in un secondo momento sociologica, chiudendo così i conti con le posizioni concernenti la plausibilità di isomorfismo strutturale fra proposizioni e stati di cose. In termini modali, secondo l’autore, questo ha generato l’esigenza di una riformulazione della nozione di necessità che, con le parole di Nozick, da «necessità incondizionata che resiste a qualsiasi controesempio a un tempo dato, connessa alla verità di qualcosa in tutti i mondi possibili» passa a «necessità condizionata […] sino a prova contraria» ovvero fino a che dimostri di resistere a tutti i controesempi concepibili nel tempo (p. 132-133). È facile dunque comprendere come dall’assunzione del carattere condizionato della necessità derivino gravi problemi sul piano ontologico e semantico per quelle prospettive filosofiche che aspirino a prendere sul serio le pratiche scientifiche come vincolo per qualsivoglia programma di ricostruzione concettuale. Qui emerge la tesi di Veca: il riconoscimento del carattere in ogni caso condizionato della necessità ha natura prettamente epistemica quindi «non c’è nulla che ci autorizzi a sostenere che non si diano o non siano definibili relazioni o proprietà necessarie che hanno a che vedere con come sono fatte o stanno le cose» semmai «non sappiamo che farcene di necessità metafisiche» (p. 136). Anche se la necessità dipende dalla serie di circostanze in cui quella relazione è inserita non significa che non sia per noi uno strumento efficace di accesso al mondo. Proprio come avviene per i designatori rigidi di Kripke quando definiamo qualcosa come necessario facciamo riferimento a un oggetto la cui interpretazione riteniamo stabile a un tempo dato e che lo definisce entro un qualche ordine o una qualche ontologia formale. Riconosciamo in esso una certa invarianza rispetto ad almeno alcuni gruppi di trasformazioni. Veca definisce questo tipo di oggetti saturi rispetto all’interpretazione, gli oggetti insaturi sono invece quegli oggetti per cui è disponibile una varietà di interpretazioni divergenti. Ora gli oggetti insaturi sono connessi in qualsivoglia spazio concettuale a oggetti saturi che svolgono il ruolo di limiti per la loro interpretazione, secondo un principio olistico della connessione delle nostre credenze (p. 139). Questo non significa che gli oggetti saturi siano speciali, come le necessità metafisiche: più semplicemente assumono un rilievo particolare a un tempo dato poiché accade che nel loro caso abbiamo una singola interpretazione a fissarne il riferimento. Come per i designatori rigidi, una volta fissato il riferimento «si è liberi di variare in modo puramente combinatorio le proprietà dell’oggetto designato, semplicemente considerandolo come al centro di un insieme di mondi possibili che ruotano intorno ad esso» (p. 143). In tal modo saremo in grado di pensare una varietà di mondi possibili ma tale libertà sarà limitata dalle proprietà essenziali dell’oggetto in quanto saturo. Siamo qui al confine tra epistemico e aletico ed è per questa ragione che «è sensato pensare un mondo possibile in cui Cesare non passa il Rubicone, mentre appare irragionevole pensare un mondo possibile in cui Cesare è un coccodrillo» (p. 143). L’attuale teoria scientifica sarebbe dunque il riferimento iniziale che stabilisce ciò che è saturo fino a prova contraria e in questo modo verrebbe meno la cogenza della celebre distinzione fregeana tra Sinn e Bedeutung: «se il senso di qualcosa attiene al modo con cui ci viene dato l’accesso al riferimento a qualcosa, questo ha luogo entro il dominio epistemico che è certo distinto ma non indipendente dal dominio aletico che ospita solo il riferimento a oggetti. Accettiamo il significato come riferimento, ma non rinunciamo dal punto di vista epistemico alla prospettiva del senso inteso come una tra le possibili vie del riferimento» (p. 145).
Veca giunge a proporre una forma di realismo scientifico dallo sfondo modale fondato sull’equilibrio riflessivo tra l’intuizione empiristica rappresentata dal riferimento fisso, cui pertiene il carattere aletico del significato, e l’intuizione costruttivista rappresentata dalle modalità epistemiche, che garantiscono la possibilità di definire differenti descrizioni nel tempo del medesimo oggetto. La varietà delle vie del riferimento coincide con la possibilità di essere aperti al mondo (con McDowell) nel senso della doppia esigenza di conservare un attrito con esso, in quanto limite per le nostre ragioni, e al contempo di mantenere una certa distanza al fine di rendere possibile quel gioco di ricerca e ritrovamento con un cui miriamo a descrivere la realtà. Tuttavia, come avverte Putnam, il mondo non ci si “rivela”: abbiamo bisogno di un grande lavoro concettuale per metterci nelle condizioni di accedervi. Questo però non equivale a costruire il mondo ma semplicemente a cercarlo nella pratica non epistemicamente ideale di esseri che fanno uso del termine vero (p. 150).
di Alberto Giustiniano
-
 Nell’ultimo libro nato dal loro sodalizio intellettuale, Deleuze e Guattari scrivevano «le scienze, le arti, le filosofie sono ugualmente creatrici, anche se spetta solo alla filosofia creare dei concetti in senso stretto». Stante la differenza di ambiti, la creatività condivisa da arte e filosofia permette quel particolare fenomeno di risonanza tra pratiche diverse che nutre la riflessione estetica. A un caso particolare di questa risonanza, quello tra musica contemporanea e filosofia, è dedicato l’ultimo lavoro di Giacomo Fronzi, Philosophical Considerations on Contemporary Music. Sounding Constellations edito per i tipi di Cambridge Scholar Publishing, che descrive un paesaggio variegato e multiforme approntando per il lettore una mappa chiara e utile, basata su nove punti cardinali. Si susseguono così nove termini chiave (Estremi, Rumore, Silenzio, Tecnologia, Audience, Ascolto, Disintegrazione, New Media) attorno ai quali l’autore ricostruisce lo sviluppo storico e tecnico della musica contemporanea (Primo Movimento), il rapporto tra produzione e ricezione (Secondo Movimento) e le letture filosofiche originate dalle nuove esperienze musicali (Terzo Movimento). Come si sarà notato, lo sviluppo del discorso segue un modello musicale, articolato in tre movimenti, cui si aggiunge un Intermezzo (tra il secondo e il terzo movimento) dedicato a un altro termine chiave, Libertà, incarnato nelle pagine di Fronzi dalla figura di Thelonious Monk, pianista e compositore tra i più influenti nella storia del jazz.
Nell’ultimo libro nato dal loro sodalizio intellettuale, Deleuze e Guattari scrivevano «le scienze, le arti, le filosofie sono ugualmente creatrici, anche se spetta solo alla filosofia creare dei concetti in senso stretto». Stante la differenza di ambiti, la creatività condivisa da arte e filosofia permette quel particolare fenomeno di risonanza tra pratiche diverse che nutre la riflessione estetica. A un caso particolare di questa risonanza, quello tra musica contemporanea e filosofia, è dedicato l’ultimo lavoro di Giacomo Fronzi, Philosophical Considerations on Contemporary Music. Sounding Constellations edito per i tipi di Cambridge Scholar Publishing, che descrive un paesaggio variegato e multiforme approntando per il lettore una mappa chiara e utile, basata su nove punti cardinali. Si susseguono così nove termini chiave (Estremi, Rumore, Silenzio, Tecnologia, Audience, Ascolto, Disintegrazione, New Media) attorno ai quali l’autore ricostruisce lo sviluppo storico e tecnico della musica contemporanea (Primo Movimento), il rapporto tra produzione e ricezione (Secondo Movimento) e le letture filosofiche originate dalle nuove esperienze musicali (Terzo Movimento). Come si sarà notato, lo sviluppo del discorso segue un modello musicale, articolato in tre movimenti, cui si aggiunge un Intermezzo (tra il secondo e il terzo movimento) dedicato a un altro termine chiave, Libertà, incarnato nelle pagine di Fronzi dalla figura di Thelonious Monk, pianista e compositore tra i più influenti nella storia del jazz.È difficile rendere conto della vastità degli interessi musicali e della quantità delle problematiche speculative affrontate dall’autore; ci limiteremo pertanto a indicare alcuni snodi particolarmente significativi nel percorso proposto dal libro. La musica contemporanea (per usare un’espressione “comoda”, sebbene l’autore si interroghi sulle diverse possibilità di definizione: musica moderna, post-moderna, contemporanea) offre una pluralità di esperienze differenti e addirittura contraddittorie: in essa si può riconoscere una dialettica tra determinazione e indeterminazione, tra dematerializzazione e saturazione, tra seduzione e razionalità (cap. 1). La coppia che in maniera più netta mostra la vocazione della musica contemporanea alle alternative radicali è il binomio di rumore (cap. 2) e silenzio (cap. 3). Se nel primo termine dobbiamo leggere in filigrana la possibilità di una riflessione estetica sul brutto (sulla scorta della teorizzazione di Karl Rosenkranz) e un’istanza politica di resistenza ed emancipazione, attorno al secondo termine si condensano quei tentativi (non meno politici) di trasformazione dell’esperienza dell’ascolto e, attraverso questa, dell’esperienza del mondo tout court. Trattando il tema del silenzio Fronzi non si sofferma soltanto sul caso emblematico di Cage, che con 4’33’’ riesce a superare la tradizionale barriera tra realtà musicale ed extramusicale (p. 78), ma analizza anche la musica sempre più rarefatta di Anton Webern, in cui si assiste a una graduale dissoluzione della materialità del suono.
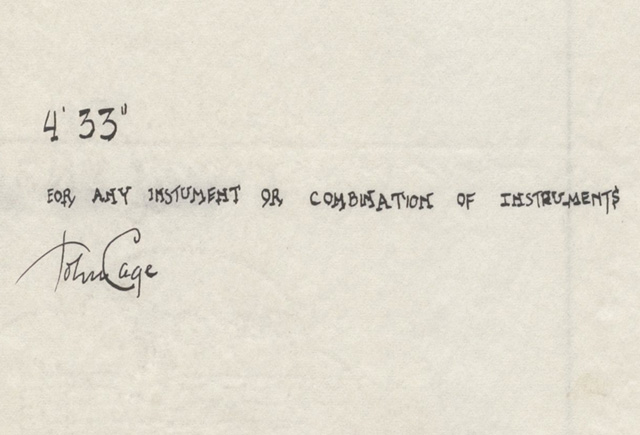
L’impostazione che vede la musica contemporanea divisa tra tendenze antitetiche trova un ulteriore caso applicativo: la tecnologia (cap. 4). Imprescindibile tanto nella produzione quanto nella ricezione, essa si dispone in maniera polarizzata intorno a due nuclei alternativi: l’estremo rigore (ad esempio nelle esperienze elettroacustiche tedesche) o il ritorno del dionisiaco attraverso la liberazione del corpo (si pensi al fenomeno rave). Allo stesso modo la ricezione (cap. 5), divisa tra l’individualismo dell’ascolto solitario e il collettivismo forzato derivante da una economizzazione dell’arte, testimonia la condizione di crisi permanente in cui versa ormai la musica. Il tema dell’ascolto (cap. 6) viene poi affrontato secondo lo schema interpretativo offerto da Adorno, forse l’autore più presente all’interno del volume: raramente appropriato, più frequentemente regressivo, l’ascolto musicale si scontra spesso con un’obiezione di carattere quasi cognitivo (“questo proprio non lo capisco”) che mette in luce la necessità di un’educazione all’esperienza estetica. In questo ambito però lo sviluppo tecnologico, che pure pone numerosi quesiti di ordine pratico e teorico, può svolgere un’utile funzione, mettendo a disposizione di un vasto pubblico i mezzi necessari per riascoltare: la ripetizione dell’ascolto, effettuabile attraverso un sempre crescente numero di mezzi e supporti, si rivela così uno strumento indispensabile per l’analisi e per l’educazione musicale.
L’ultima parte del libro si concentra sul tema del disordine (cap. 8) e sulle sfide proposte dai new media all’estetica musicale (cap. 9). L’autore declina il primo termine secondo tre linee di sviluppo: rapporto tra musica e teoria dell’informazione; relazione tra ordine e disordine strutturale; musica elettroacustica come realizzazione di un “corpo senza organi” («a formless, disorganised, non-stratified or de-stratified body», p. 186). Quest’ultima linea, impostata a partire dalla riflessione di Deleuze e Guattari, mi pare particolarmente feconda: non solo perché mostra un’oggettiva assonanza con le tendenze estetiche più caratteristiche della musica contemporanea, e in particolare della musica elettroacustica («The developments of western music may be integrally read in the light of the dialectic between territorialisation and de-territorialisation, with a tendency to suppression, in the 20th century, of the former by the latter», p. 184), ma anche perché consente di rispondere in maniera alternativa ai quesiti posti nell’ultimo capitolo: «a) is an aesthetic experience activated by technological music a real possibility? b) if so, what characteristics may it have […]?» (p. 212).
La risposta avanzata da Fronzi, sulla scorta delle definizioni di esperienza estetica proposte da autori come Jauss, Dewey, Levinson, ma anche Perniola, Franzini e Tedesco, pare negativa:
In any case, what seems clear is that the specific experience of technological (or electroacoustic) contemporary music developed in the dimension of listening makes it difficult to speak beyond doubt of aesthetic experience in the ‘strong’ sense, as happens, for example, with the contemplative-cognitive experience that may be generated by the relationship with a traditional cultural object (p. 214).
La «fine delle grandi esperienze estetiche» (Ibidem), così come la fine delle grandi narrazioni, presuppone un’idea di estetica tipicamente cognitivo-contemplativa che proprio la teoria di Deleuze e Guattari, citata in apertura, revoca in dubbio: se l’arte, così come la filosofia e la scienza, è una forma di creazione, l’esperienza estetica potrà abbandonare le tradizionali connotazioni basate su attenzione disinteressata, cognizione e giudizio per appropriarsi di quei caratteri espressivi («disarticulation and de-stratification […] tracing the lines of a plan […] distribution of singularity and haecceity, tremolos and intensities […] construction and mapping of a body or an assemblage», p. 187) messi a disposizione proprio dalla musica elettroacustica.
In realtà è lo stesso Fronzi che, in alcuni passi del libro, offre gli strumenti per pensare la musica contemporanea come il superamento di quella concezione dell’esperienza estetica che Benjamin avrebbe definito “borghese”. Con la musica elettroacustica infatti si abbandona l’epoca della riproducibilità tecnica per entrare in quella della riproducibilità tecnologica (p. 138): non più solo la riproduzione, ma lo stesso processo di produzione è costitutivamente intrecciato agli sviluppi e alle applicazioni degli ultimi ritrovati tecnologici. Si può pensare dunque che l’abbandono dell’atteggiamento contemplativo, tradizionalmente associato alla fruizione dell’opera d’arte, venga radicalizzato e generalizzato da questa “seconda rivoluzione” tecnologica. L’epoca della riproducibilità tecnologica introdotta dalla musica elettroacustica costituirebbe in questo modo il compimento di un processo e non l’irruzione di una inaspettata novità, la definitiva apertura di un nuovo spazio di esperienza e non semplicemente, rubando un’espressione di Luigi Nono, la «tragedia dell’ascolto». Ed è per questo motivo forse che la fine delle “grandi” esperienze estetiche, come afferma l’autore al termine del libro, «non è necessariamente un cattivo segno» (p. 214).
di Stefano Oliva
-
La ragione del testo Che cosa si fa quando si fa filosofia?, scritto da Rossella Fabbrichesi ed edito da
 Raffaello Cortina (2017), è delineata esplicitamente nella Premessa e si articola significativamente all’interno dell’ambiente da cui prende avvio. Fabbrichesi, all’interno dell’aula universitaria milanese dove svolge la sua professione di insegnante, decide di affrontare i suoi studenti con una domanda spiazzante, nella sua apparente semplicità: “Che cos’è la filosofia?”. A partire da questa domanda, il tema della filosofia – intesa come campo di sapere determinato e, allo stesso tempo, come insieme delle procedure che la pongono in atto – viene dipanato nel corso di quindici capitoli e integrato da alcune riflessioni finali emerse a lezione e successivamente strutturate tramite un lavoro collettivo dell’autrice e dei suoi studenti. Il lavoro di conduzione seminariale, punto di partenza per la nascita del testo, è consistito in un processo di “e-ducazione” in cui l’autrice, limitandosi – a suo dire – a «orientare discorsi che venivano partoriti e circolavano tra gli astanti, alimentandosi negli scambi comuni», ha condotto con sé delle anime «insegnando loro a battere il ritmo del canto corale» (p. xiv) e, richiamandosi al modo originario di fare filosofia, l’ha posto in atto all’interno di quella comunità di studenti che, in poco, sarebbe diventata una comunità di “amici della filosofia”, una comunità di ricerca fondata su una condivisione di interessi e su una radicata volontà di attualizzarli.
Raffaello Cortina (2017), è delineata esplicitamente nella Premessa e si articola significativamente all’interno dell’ambiente da cui prende avvio. Fabbrichesi, all’interno dell’aula universitaria milanese dove svolge la sua professione di insegnante, decide di affrontare i suoi studenti con una domanda spiazzante, nella sua apparente semplicità: “Che cos’è la filosofia?”. A partire da questa domanda, il tema della filosofia – intesa come campo di sapere determinato e, allo stesso tempo, come insieme delle procedure che la pongono in atto – viene dipanato nel corso di quindici capitoli e integrato da alcune riflessioni finali emerse a lezione e successivamente strutturate tramite un lavoro collettivo dell’autrice e dei suoi studenti. Il lavoro di conduzione seminariale, punto di partenza per la nascita del testo, è consistito in un processo di “e-ducazione” in cui l’autrice, limitandosi – a suo dire – a «orientare discorsi che venivano partoriti e circolavano tra gli astanti, alimentandosi negli scambi comuni», ha condotto con sé delle anime «insegnando loro a battere il ritmo del canto corale» (p. xiv) e, richiamandosi al modo originario di fare filosofia, l’ha posto in atto all’interno di quella comunità di studenti che, in poco, sarebbe diventata una comunità di “amici della filosofia”, una comunità di ricerca fondata su una condivisione di interessi e su una radicata volontà di attualizzarli.Attualizzare i contenuti di un sapere che da lungo tempo viene messo in discussione, tanto nei suoi luoghi di tradizionale appartenenza – le accademie – tanto nella quotidianità – luogo di prassi da cui origina la filosofia – interrogandoli nelle sue parti elementari (“Che cos’è la filosofia?”, “Che cosa si fa quando si fa filosofia?”) piuttosto che ribadirli e al fine di strutturarli in un sistema nuovo, sempre ri-organizzato secondo le esigenze della contemporaneità, assume un profondo significato politico; si sceglie di riappropriarsi degli strumenti originari della filosofia, per riabitarne i luoghi, per richiamarne il ruolo di critica e di conseguente produzione creativa e alternativa del reale.
I presupposti del testo, che già dalle prime righe si mostrano articolati secondo due linee principali, una teorica e l’altra pratica, si intersecano per tutta la sua durata e, intrecciandosi intorno alle domande fondanti della filosofia – “Che cos’è?” (il “ti esti?” di socratica origine) e “che cosa si fa?” (il methodos dell’indagine) – generano un continuo rimando di livello tra il conoscitivo e il pratico. I rimbalzi di significato giungono a compiersi, senza mai concludersi per loro stessa natura, nell’Appendice – nominata significativamente L’esercizio della prassi teorica – in cui gli studenti si interrogano personalmente su che cosa fanno quando fanno filosofia, quasi a suggerire al lettore un bilancio del percorso che ha individualmente compiuto lasciandosi suggestionare e coinvolgere dalle riflessioni dei capitoli precedenti. In questo senso, se “Che cos’è la filosofia?” «Non è affatto una domanda rivolta a dei principianti» (p. xii), poiché non segna un’arché, ma anzi, presuppone un arsenale concettuale consolidato a seguito di anni di speculazione, il chiedere “Che cosa si fa quando si fa filosofia?” apre lo scenario a chiunque abbia mai sperimentato una “forza erotica”, nel senso platonico del termine, nei confronti di tutto «ciò che è insolito, stupefacente, difficile e divino» (p.74), a chiunque creda che non esista la filosofia, ma la pratica filosofica e a chiunque veda il proprio godimento alla base della ricerca filosofica potenziato dalla «crescita della ragionevolezza in un’ottica comunitaria» (p.76). In questo senso, coloro che, staccandosi dall’idea della filosofia come formazione originariamente paideutica, intendono l’attività professionale dell’insegnamento come unica e adeguata declinazione dalla formazione filosofica, difficilmente proveranno meraviglia o stupore (per richiamare – come fa l’autrice – le emozioni primarie che tradizionalmente designano i moventi originari dell’interrogazione filosofica del mondo) di fronte alla rassegna di concezioni o di visioni del mondo di filosofi noti che hanno provato, con parole diverse ma con univoca passione, ad attribuire significato alla prassi filosofica.

Considerando però che attribuire significato a una prassi significa anche, tramite interrogazione critica, fondarla trascendentalmente e dotarla di senso, la forza di questo testo consiste nella volontà di indagare il nesso che caratterizza la filosofia come insieme delle dottrine da apprendere e la filosofia come insieme delle prassi che, agite, alterano e modificano il mondo in cui ci orizzontiamo, più che nella padronanza con cui vengono richiamate e fatte dialogare le autorità filosofiche del nostro passato tramite i loro impianti speculativi. Sondare questo nesso corrisponde ad abitare il “limite” di cui parla Foucault e solo la consapevolezza della sua ineliminabile duplicità (Cfr. Amare la duplicità, pp. 57-62) ci farà progredire nella pratica filosofica; indagare un oggetto dirà tanto più sul metodo d’indagine che sulla natura dell’oggetto in sé e, d’altro canto, indagare sé non è altro che mettere in luce la verità in cui abitiamo, con un ricorso inevitabile a ciò che noi crediamo essere la verità. L’esercizio di ginnastica mentale che compiamo quindi su di noi facendo filosofia coincide – a ben vedere – con l’atto di approfondimento verso il reale per come ci si dà e nel suo non poter essere altrimenti, generando un flusso tanto più ininterrotto e dinamico tra etica e conoscenza quanto più diveniamo coscienti che «è la vita che produce la verità, e non la verità che si rivela aspirazione della vita» (p. 38).
di Evelina Praino
-
Extra#2 \ TURNS. Dialoghi tra architettura e filosofia
Extra / Febbraio 2018TURNS. Dialoghi tra architettura e filosofia è la traccia di un dialogo spesso acceso, ricco di incomprensioni e riconciliazioni, che coinvolge architetti e filosofi, docenti e professionisti, e ancora biologi, dottori di ricerca, studenti. È il racconto di due discipline, architettura e filosofia, che si voltano per guardarsi reciprocamente, provando a innescare una svolta concettuale che deve divenire un nuovo punto di partenza. Precisamente questo è il doppio significato del termine “Turns”.
Da un lato infatti, il filosofo ha sempre avuto difficoltà a interloquire con l’architetto, sia per ragioni storiche sia per ragioni strettamente legate al suo metodo e ai suoi obiettivi. L’architetto sembra infatti presentarsi allo sguardo del filosofo come un personaggio al contempo perturbante e conturbante, in un misto di attrazione e biasimo, di invidia e ammirazione: una figura tanto sfuggente da investire la riflessione filosofica con effetto retroattivo, facendo scricchiolare le sue fondamenta concettuali e mettendo in dubbio nozioni fondamentali quali verità, libertà, realtà, conoscenza, invenzione, possibilità, necessità, che hanno rappresentato per secoli il lessico base del pensiero occidentale. L’interesse verso una simile figura sembrerebbe ovvio. Eppure, quasi sempre è il filosofo che viene interpellato, utilizzato o coinvolto nel lavoro dell’architetto, in molti casi con l’intento di distillare spazialmente il senso dei suoi discorsi nel progetto. Non che ciò sia impossibile, ma, forse, dovremmo domandarci se è proprio questo quello che vogliamo: o se invece non sia compito del filosofo esercitare una sistematica e implacabile strategia di provocazione interessata, al fine di produrre un effetto, una particolare condizione dello sguardo. Creare la crisi, mettendo in discussione ciò che è dato, sapendo che, come spesso accade, l’apertura verso un nuovo oggetto di conoscenza lascia insoluti quei quesiti che lo vedono direttamente implicato per produrre un effetto retroattivo di chiarificazione nel soggetto indagatore, impegnato a leggersi ora attraverso una nuova forma di mediazione.
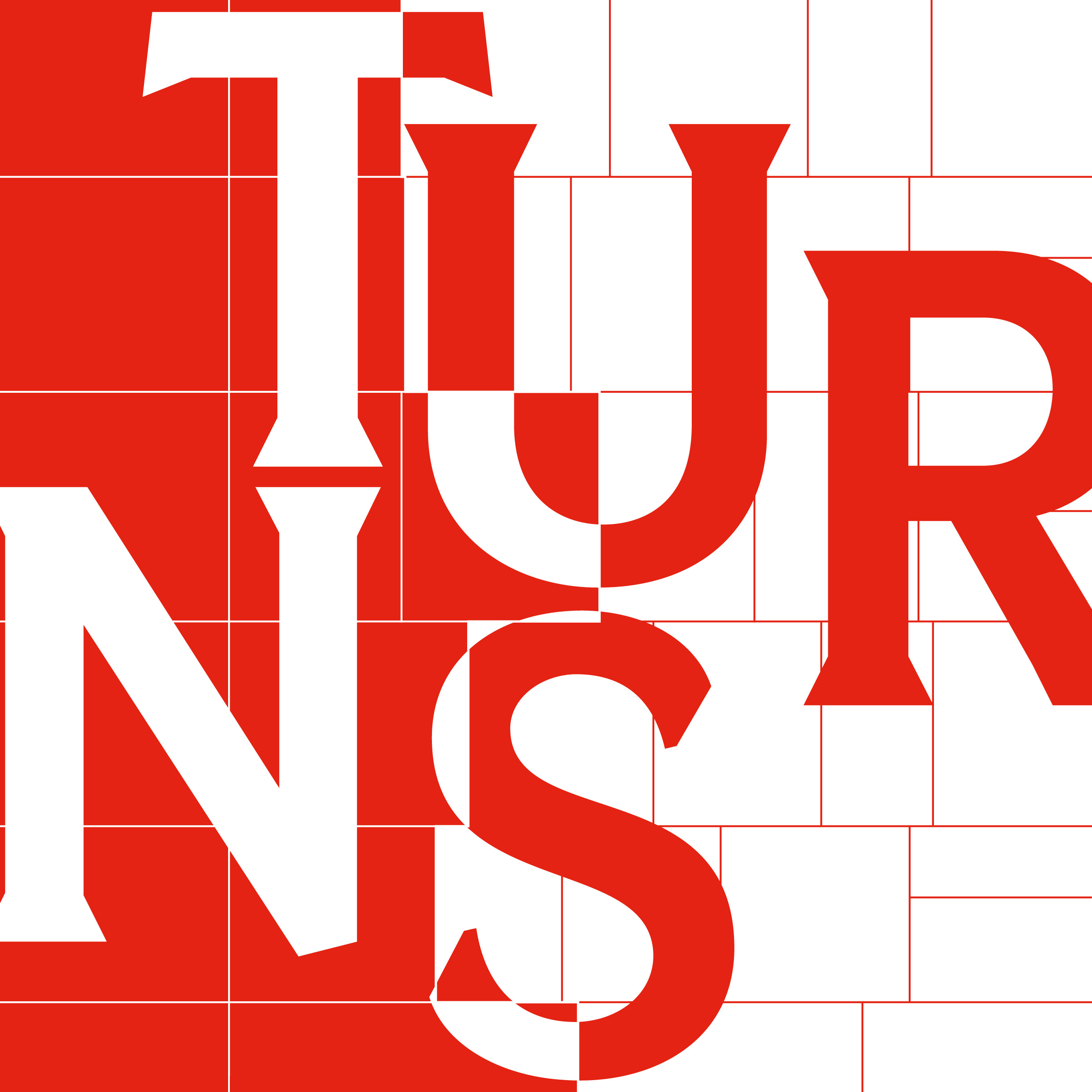
Dall’altro lato, per l’architettura il rapporto con la filosofia è storicamente naturale, quasi che questa fosse una visione complementare sul mondo rispetto al suo operato: questo era possibile perché la società si evolveva in modo relativamente lento, attraverso sedimentazioni di usi che diventavano convenzioni sociali, di pensiero, di stile. Così andava nell’architettura egizia, in quella classica, nel medioevo, nel rinascimento, finanche nel Modernismo: i significati erano decifrabili perché si condivideva un sostrato convenzionale. Ma qualcosa è cambiato. Le correnti durano pochi anni: poi passano, come le mode, spesso senza lasciar traccia – tranne edifici già superati, ovviamente. Così, spariscono le teorie dell’architettura, cioè sistemi che dicano cosa sia giusto costruire. E senza una teoria che legittimi le scelte, fioriscono le retoriche e le poetiche personali, spesso così ridicole da essere persino (e giustamente) oggetto di satira. La condizione di fragilità dell’architettura contemporanea è ormai fisiologica. Ed è qui che la filosofia diventa non solo utile, ma necessaria. A patto, certo, di non usarla in senso analogico, con derivazioni dirette che trasformano concetti in forme e pensieri in stili. Dialogare con i filosofi serve perché essi ragionano su temi che, in qualche modo, toccano gli architetti – ad esempio, lo spazio, l’invenzione, la città, la generazione della forma, il potere. Capire qualcosa di quei temi aiuterà a progettare con una maggior consapevolezza, o una più approfondita convinzione sulle ragioni del progetto, e a capirne meglio effetti ed esiti.
A cura di Carlo Deregibus e Alberto Giustiniano
Scarica PDF
English version
DOI: https://doi.org/10.13135/2385-1945/1.2018
Pubblicato: gennaio 2018
Indice
Alberto Giustiniano - ARCHITECTURAL TURN. Il filosofo e le sfide del progetto [PDF It]
Carlo Deregibus - PHILOSOPHICAL TURN. Fragilità dell’architettura contemporanea [PDF It]
(S)Block-Seminar
.
DA LASCAUX AI JUNKSPACE
Giovanni Leghissa - Da Lascaux ai junkspaces (passando per Ippodamo da Mileto) [PDF It]
Giovanni Durbiano – Descrivere il progetto dello spazio [PDF It]
Riccardo Palma – Molteplicità e non naturalità degli spazi nella produzione del progetto di architettura [PDF It]
RIFERIMENTI di Andrea Dutto [PDF It]
.
DECOSTRUZIONE, IMMANENZA, ILOMORFISMO
Giulio Piatti – Simondon e Deleuze di fronte all’ilomorfismo. Appunti sul rapporto forma-materia [PDF It]
Carlo Deregibus – Appunti su Chōra, spazio e architettura. Da Platone a Derrida [PDF It]
Paola Gregory – Le nuove scienze e la conquista dell’informale [PDF It]
Riccardo Palma – L’assenza necessaria dell’architettura [PDF It]
RIFERIMENTI di Andrea Canclini [PDF It]
.
FENOMENOLOGIA E PROGETTO
Claudio Tarditi – Fenomenologia e architettura. Introduzione al problema della percezione spaziale in Edmund Husserl [PDF It]
Alberto Giustiniano – Tempo, forma, azione. Il senso del progetto nel dialogo tra Enzo Paci e Ernesto Nathan Rogers [PDF It]
Silvia Malcovati – Per un razionalismo relazionale [PDF It]
Carlo Deregibus – L’orizzonte del progetto e la responsabilità dell’architetto [PDF It]
RIFERIMENTI di Federico Tosca [PDF It]
.
MORFOGENESI E AUTOORGANIZZAZIONE
Veronica Cavedagna & Danilo Zagaria - Quale spazio per la morfogenesi e l'auto-organizzazione? [PDF It]
Paola Gregory – Morfogenesi architettonica e “vita artificiale” [PDF It]
Carlo Deregibus – Progetto e complessità. Fascino dell’analogia e libero arbitrio [PDF It]
RIFERIMENTI di Edoardo Fregonese [PDF It]
.
ANTROPOGENESI E COSTRUZIONE DELLO SPAZIO
Roberto Mastroianni – Regimi dello sguardo. Sloterdijk e la metafora spaziale [PDF It]
Alessandro Armando – La scrittura del futuro e la promessa del progetto [PDF It]
Daniele Campobenedetto – Leggibilità e materialità dello spazio [PDF It]
RIFERIMENTI di Federico Cesareo [PDF It]
.
POTERE E SPAZIO
Luigi Giroldo – Genealogie dello spazio contemporaneo. Utopie moderne e nascita dell’urbanistica [PDF It]
RIFERIMENTI di Andrea Canclini [PDF It]
BIBLIOGRAFIA
.
-
Start-Up: liberi di sbagliare
Serial, Start up / Febbraio 2018Viviamo, suggeriscono voci diverse, in un’epoca di grande trasformazione. Nulla sarà più come prima e ciò che si trasforma non è “solo” il modo di produrre, ma i modi di vita individuali e collettivi. Questo dato, la trasformazione epocale in corso, accomuna le letture più diverse, scientifiche e non, e si presenta in questa veste come un fatto sociale interessante su cui riflettere. In altre parole, se le prognosi, ovvero ciò che andrebbe fatto per favorire, rallentare o ostacolare la “rivoluzione”, differiscono, le diagnosi che molti autori avanzano circa lo stato delle cose sembrano convergere su alcune questioni cruciali quali lo spazio e il tipo d’uomo (e soprattutto alcune sue qualità), principi della contemporaneità. Si tratta dello spazio urbano che ha sostituito la fabbrica (Florida, 2002; Hardt-Negri, 2009) e del cittadino-imprenditore di se stesso (Foucault, 2015) che ha preso il posto dell’uomo dell’organizzazione in senso lato, sia esso un impiegato o un operaio.
Abbiamo di fronte, come la conoscenza contemporanea ci insegna, un anthropos urbano. Egli (o ella, ma soprattutto, egli), senza chiedere troppo, è in grado di gestirsi e prendersi cura di sé, è fedele al proprio interesse e non prende ordini; al tempo stesso, mostra un genuino interesse verso la comunità politica di appartenenza alla quale intende dare un proprio soggettivo contributo, richiamando alla mente il cittadino della polis di Aristotele, unico vero e possibile spazio di civiltà. Il cittadino-imprenditore si adatta, si trasforma, in virtù del proprio capitale umano e del proprio senso critico e strategico, all’ambiente intorno a lui. Ciò che ha dentro di sé - che lo si pensi innato o socialmente costituito, risiedere nella mente, nel corpo o in entrambi - è una risorsa economica e politica. Egli è agito dal e agisce sul cambiamento, ma sembra disporre, forse a differenza di chi lo ha preceduto, di un certo tipo di potere.
Richard Florida, autore di un testo classico, L’ascesa della nuova classe creativa (2003), che ha, senza esagerare, dato il la a un acceso dibattito lungi dall’essersi esaurito, ha teorizzato l’emergere di una nuova classe sociale: la classe creativa. Essa mostra, tuttavia, scarsa coscienza di classe: in buona sostanza, secondo Florida, non sa, a differenza della classe operaia dell’epoca fordista, ciò che la renderebbe tale, sia in termini di diritti sia di doveri. Ovvero, essa non è consapevole del legame produttivo che accomunerebbe e distinguerebbe i suoi membri dal resto della società: la creatività in una lettura floridiana, ma più in generale, su un piano più astratto, la capacità cognitiva e affettiva che distingue i suoi membri in quanto produttori di beni e servizi e, cosa ben più rilevante, cittadini. Questa seconda e più generale lettura, relativa all’importanza delle skills cognitive in quanto risorse economiche, difficilmente troverebbe smentita nel dibattito scientifico attuale: questa è la cifra dell’anthropos contemporaneo, il suo potere. Ma qui è opportuno segnalare un passaggio importante, già presente nel testo di Florida: se è pur vero che il ricorso quotidiano a queste skills e soprattutto la capitalizzazione economica delle stesse sono ancora circoscritti ad alcune pratiche economiche, la “creatività”, dice Florida, è un attributo umano. La coscienza di classe che va dunque risvegliata non andrà in una direzione oppositiva, di una lotta di classe appunto, ma inclusiva: tutti noi siamo parte di questa classe, disponendo di default, in quanto esseri umani, di un’innata creatività e, mutatis mutandis, la stratificazione sociale risulta così “asciugata”: non ci sono più classi. Questo, credo, sia il nocciolo della straordinaria trasformazione di cui si narra da più parti. Ma dir creatività o capacità cognitiva non dice granché sulle modalità di esercizio di questo nuovo potere. Quest’ultimo si può supporre risieda in un metodo cognitivo, ovvero in un metodo che attiene tanto alle capacità soggettive di conoscere quanto a una singolare consapevolezza di ciò che si può conoscere, e dunque ai limiti della conoscenza acquisibile.

Her Majesty’s Pleasure - Daniel Horowitz (2016)
Paradossalmente, sembra affermarsi un soggetto che “può tutto”, come la massima del discorso dell’innovazione “cambiare il mondo” esemplifica bene, ma al tempo stesso riflette un particolare rapporto con la conoscenza: ovvero non solo l’uomo nuovo non ha paura di non sapere, ma non ha paura di dire che non sa e - aspetto importantissimo per le pratiche economiche innovative - di fallire. Quasi che onnipotenza e umiltà si condensassero e confondessero in questo metodo e in questo uomo.
A ben pensarci, questa attitudine riflette un mutato rapporto con tre elementi intimamente legati gli uni con gli altri: il rischio, l’incertezza e il futuro. Partendo da quest’ultimo per avviare il ragionamento, il futuro non è pianificabile poiché è ragionevolmente impensabile esercitare un controllo totalizzante su tutte le variabili che concorreranno a determinare il reale che verrà. Tale metodo mette da parte l’assioma del soggetto razionale, inteso come colui che ha il pieno controllo e si muove coerentemente rispetto a un fine noto e solo se conosce la direzione, per accogliere un uomo che si adatta ragionevolmente e intenzionalmente alla situazione rispetto un ventaglio di obiettivi, ma si muove nel non-noto e nell’incerto: ciò che l’economista Armen Alchian in un suo articolo seminale (1950) chiamò «purpusive behaviour in the presence of uncertainty and incomplete information». Fortuna o design, secondo Alchian, illuminano gli esiti del comportamento di uomo ragionevole. Si giustappongono qui una conoscenza totale a una conoscenza situata; la massimizzazione del profitto alla ricerca di profitto, la razionalità alla ragione.
Il metodo sta dunque nella “riflessione in azione”, concetto coniato da Donald Schön nel testo seminale Il professionista riflessivo pubblicato nel 1983. Si conosce agendo e auto-osservandosi nell’azione: il soggetto che descrive (e prescrive) l’autore, in buona sostanza, accoglie l’incertezza del proprio agire e da questo atto di consapevolezza si mette nelle condizioni di generare nuova conoscenza.
Facciamo un esempio pratico. Dal 2012 esiste una curiosa iniziativa che prende il nome di FuckUp Nights che si descrive come un movimento globale nato a Città del Messico da un’idea avuta da un gruppo di amici il cui intento è quello di celebrare le storie di fallimento imprenditoriale. Si tratta di una serata informale che si svolge in diverse città nel mondo, in cui personalità che “ce l’hanno fatta” raccontano i propri fallimenti e si può dire impersonino la celebre frase di Samuel Beckett: “ho provato, ho fallito. Non importa, riproverò. Fallirò meglio”. Se nomen omen, FuckUp Night combina insieme e su di sé le due pulsioni fondamentali, l’eros e la pulsione di distruzione (Freud, 1938) in un processo di distruzione creatrice schumpeteriana. Vedere per credere.
Febbraio 2016, Milano - La sala è gremita di gente, le luci sono basse, lo stile è casual, l’atmosfera è piacevole, la birra è servita. Tutto è pronto per la prima FuckUp Night milanese del nuovo anno. «Ciao, sono Lucia, sono una ricercatrice di falliti». Così introduce la serata l’organizzatrice dell’evento e prosegue: «L’obiettivo è sfatare un taboo e mostrare come il filo che unisce le storie di successo di questa sera, dei nostri fuckuppers, sia il fallimento. Per meglio dire, il coraggio di fallire e di ripartire». Si susseguono una serie di “falliti”, parlano di sé, di ciò che è andato storto, delle lezioni indispensabili imparate “facendo” e fallendo. Knowing-in-action appunto, come diceva Donald Schön rispetto all’apprendimento riflessivo: sbaglio, rifletto, imparo osservandomi, riprovo. A ben pensarci (e credo il lettore concorderà), la legittimità del proprio errare è una fonte notevole di piacere, se non altro per il sollievo che comporta dalla vergogna sociale. Ma c’è di più: errare, riconoscere i propri errori e imparare da essi è in questo caso indispensabile per l’imprenditore/innovatore. Gli stessi programmi di incubazione, la nuova frontiera formativa dell’imprenditore di se stesso, riflettono e esemplificano bene questo metodo: durante gli stessi vi è un continuo e serrato riesame del progetto imprenditoriale.
Sappiamo che dal punto di vista della storia della conoscenza, non si scopre mai davvero nulla, ma si impostano nuovi modi di conoscere, si “illuminano le cose diversamente” così da poter dire “Ah, ora ho capito come stanno veramente le cose”. Questa verità acquisita riflette la coscienza che un governo ha di sé in un dato momento storico e si traduce in pratiche. Rispetto a questa impostazione e alle riflessioni qui avanzate, emerge come siamo ben lontani oggi da un’arte di governo secondo una verità assoluta. Se così fosse, tuttavia, l’interrogativo che si apre è il seguente: secondo quale verità si articola l’arte di governo contemporanea? Prima ancora, c’è una verità che orienta, struttura la pratica di governo e l’uomo contemporaneo? Se, supponiamo, la verità è che non c’è una verità, qual potrà mai essere la portata trasformativa di una tale arte? Questo è un nodo politico importante da sciogliere, sul quale lo stesso Foucault lascia molto a intendere.
di Anna Paola Quaglia
Alchian A. (1950). Uncertainty, Evolution, and Economic Theory, The Journal of Political Economy, 58, 3, 211-221.
Florida R. (2003). L’ascesa della nuova classe creativa. Stile di vita, valori e professioni. Milano: Mondadori.
Foucault M. (2015), La Nascita della Biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979). Milano: Feltrinelli.
Hardt M.-Negri T. (2009). Commonwealth. Cambridge (MA): The Belknap Press of Harvard University Press.
Schön D. (1999). Il professionista riflessivo. Per una nuova epistemologia della pratica professionale. Bari: Dedalo.
-
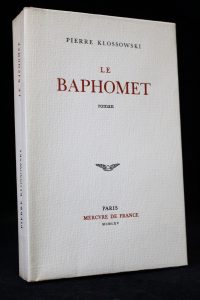 Le Baphomet di Pierre Klossowski, pubblicato nel 1965, si potrebbe definire uno dei romanzi più insoliti del secolo scorso. Ricordiamo che l’autore non era soltanto un raffinato romanziere, ma anche un saggista e filosofo, un traduttore (dal latino e dal tedesco) e persino un pittore-disegnatore. Le Baphomet ha costituito, al momento della sua comparsa, un prodotto letterario imprevedibile persino da chi conoscesse già i testi narrativi pubblicati da Klossowski in precedenza. Essi, infatti, erano ambientati in epoca contemporanea, mentre il romanzo in questione ci riporta, almeno in prima istanza, al Medioevo. Ma Le Baphomet presenta anche implicazioni di natura filosofica, come si intuisce già dal fatto che reca una dedica a Michel Foucault, pensatore che stimava molto gli scritti klossowskiani. Il libro presenta una trama complessa (anche perché articolata su piani temporali diversi), che tuttavia può essere chiarita grazie alle informazioni fornite dall’autore in alcuni scritti o interviste. L’opera inizia con un prologo che «introduce i personaggi reali o immaginari di una situazione storica determinata (l’anno 1307), che riguarda un ambiente sociale e spirituale (l’ordine dei Templari) – ossia un evento preciso della storia di Francia: la distruzione dell’ordine da parte di Filippo il Bello – in questo senso, il prologo sarebbe quello di un romanzo pseudostorico del genere “Walter Scott”. Il capo d’accusa – principale pretesto della distruzione dell’ordine da parte del re per impadronirsi delle ricchezze del Tempio – è il supposto culto sodomita di un idolo: il Bafometto – in realtà, nome chiave di una dottrina esoterica, ovvero alchimistica, praticata in seno all’ordine. L’azione preliminare del prologo culmina nella descrizione di un rito di questo culto». È vero in effetti che tra le accuse, vere o false che fossero, rivolte ai Templari, vi era quella di essere dediti alla sodomia e a cerimonie quasi sataniche. Se ne trova traccia anche in testi letterari dell’epoca, come il Roman de Fauvel (non a caso scritto da appartenenti alla Cancelleria Reale parigina). Dei Templari vi si dice fra l’altro: «Adesso sono diventati eretici / e peccatori contro natura. / Il mio cuore s’affligge e si duole / perché nelle catene del demonio / sono rimasti tanto a lungo: / c’erano dentro tutti fino al collo. / Sono oramai più di cent’anni pieni / da quando hanno iniziato le loro malefatte. / Tra loro avevano dato vita a un ordine / così orribile e vile, così sozzo / che dirlo fa spavento: / quando accoglievano qualcuno / subito gli facevan rinnegare Dio, / ed oltraggiare Gesù e la croce, / perché imponevano di sputarvi sopra. / Baci fra loro si davan sul didietro: / che statuto veramente immondo! / Ah, come infelicemente nacquero da Adamo, / perché saranno tutti dannati, dispersi ed abbattuti».
Le Baphomet di Pierre Klossowski, pubblicato nel 1965, si potrebbe definire uno dei romanzi più insoliti del secolo scorso. Ricordiamo che l’autore non era soltanto un raffinato romanziere, ma anche un saggista e filosofo, un traduttore (dal latino e dal tedesco) e persino un pittore-disegnatore. Le Baphomet ha costituito, al momento della sua comparsa, un prodotto letterario imprevedibile persino da chi conoscesse già i testi narrativi pubblicati da Klossowski in precedenza. Essi, infatti, erano ambientati in epoca contemporanea, mentre il romanzo in questione ci riporta, almeno in prima istanza, al Medioevo. Ma Le Baphomet presenta anche implicazioni di natura filosofica, come si intuisce già dal fatto che reca una dedica a Michel Foucault, pensatore che stimava molto gli scritti klossowskiani. Il libro presenta una trama complessa (anche perché articolata su piani temporali diversi), che tuttavia può essere chiarita grazie alle informazioni fornite dall’autore in alcuni scritti o interviste. L’opera inizia con un prologo che «introduce i personaggi reali o immaginari di una situazione storica determinata (l’anno 1307), che riguarda un ambiente sociale e spirituale (l’ordine dei Templari) – ossia un evento preciso della storia di Francia: la distruzione dell’ordine da parte di Filippo il Bello – in questo senso, il prologo sarebbe quello di un romanzo pseudostorico del genere “Walter Scott”. Il capo d’accusa – principale pretesto della distruzione dell’ordine da parte del re per impadronirsi delle ricchezze del Tempio – è il supposto culto sodomita di un idolo: il Bafometto – in realtà, nome chiave di una dottrina esoterica, ovvero alchimistica, praticata in seno all’ordine. L’azione preliminare del prologo culmina nella descrizione di un rito di questo culto». È vero in effetti che tra le accuse, vere o false che fossero, rivolte ai Templari, vi era quella di essere dediti alla sodomia e a cerimonie quasi sataniche. Se ne trova traccia anche in testi letterari dell’epoca, come il Roman de Fauvel (non a caso scritto da appartenenti alla Cancelleria Reale parigina). Dei Templari vi si dice fra l’altro: «Adesso sono diventati eretici / e peccatori contro natura. / Il mio cuore s’affligge e si duole / perché nelle catene del demonio / sono rimasti tanto a lungo: / c’erano dentro tutti fino al collo. / Sono oramai più di cent’anni pieni / da quando hanno iniziato le loro malefatte. / Tra loro avevano dato vita a un ordine / così orribile e vile, così sozzo / che dirlo fa spavento: / quando accoglievano qualcuno / subito gli facevan rinnegare Dio, / ed oltraggiare Gesù e la croce, / perché imponevano di sputarvi sopra. / Baci fra loro si davan sul didietro: / che statuto veramente immondo! / Ah, come infelicemente nacquero da Adamo, / perché saranno tutti dannati, dispersi ed abbattuti».>A cura di:
Giuseppe Zuccarino è critico e traduttore. Ha pubblicato vari saggi: La scrittura impossibile, Genova, Graphos, 1995; L’immagine e l’enigma, ivi, 1998; Critica e commento. Benjamin, Foucault, Derrida, ivi, 2000; Percorsi anomali, Udine, Campanotto, 2002; Il desiderio, la follia, la morte, ivi, 2005; Il dialogo e il silenzio, ivi, 2008; Da un’arte all’altra, Novi Ligure, Joker, 2009; Note al palinsesto, ivi, 2012; Il farsi della scrittura, Milano-Udine, Mimesis, 2012; Prospezioni. Foucault e Derrida, ivi, 2016. Tra i libri da lui tradotti figurano opere di Mallarmé, Bataille, Klossowski, Blanchot, Caillois e Barthes. Ha inoltre curato un fascicolo monografico della rivista «Riga» (n. 37, 2017) dedicato a Maurice Blanchot.
-
Il gesto oltre l’azione. Una filosofia dell’innocenza
Longform / Dicembre 2017
 Il problema della colpa è il problema dell’azione, e di colui che la compie. La colpa, lungi dall’appartenere intrinsecamente alla sfera giuridica, ne costituirebbe piuttosto la soglia d’accesso.
Il problema della colpa è il problema dell’azione, e di colui che la compie. La colpa, lungi dall’appartenere intrinsecamente alla sfera giuridica, ne costituirebbe piuttosto la soglia d’accesso.
La colpa è un concetto che traccia i limiti di una seria questione filosofica, prima ancor che giurisprudenziale: come si costituiscono i confini del diritto? Come si traccia la frontiera tra la struttura del diritto e l’immanenza in sé del vivente? Come si può, altresì, definire la colpevolezza del soggetto a partire dall’imputabilità dell’azione e dalla pena comminata? E soprattutto, una volta posto in questi termini il problema, è possibile superare la concezione dell’azione in quanto imputabile? È possibile, per il soggetto, fuoriuscire dalla struttura del diritto - e quindi dalla triangolazione azione-colpa-pena - per “consacrarsi” a quell’innocenza radicale che attraversa originariamente tutto ciò che vive?
Sono questi alcuni degli interrogativi che trapelano, talvolta tra le righe, spesso più manifestamente, dalle pagine dell’ultimo libro di Giorgio Agamben, Karman. Breve trattato sull’azione, la colpa, il gesto (Bollati Boringhieri, 2017). Read More » -
Roberto Calasso – L’innominabile attuale
Recensioni / Novembre 2017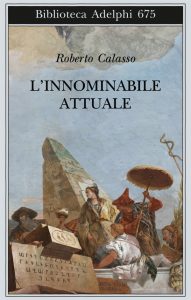 L'innominabile attuale, uscito quest’anno per i tipi di Adelphi, è l'ultimo anello della collana di opere scritte da Roberto Calasso. Il titolo riprende un'espressione che si trova nella prima pubblicazione dell'autore, La rovina di Kasch (Adelphi, 1983), sancendo così un collegamento tra l'inizio e la provvisoria fine della sua vasta produzione. Così come l'attuale di cui si occupa il testo, altrettanto sfuggente è l'opera di Calasso, irriducibile a un genere e a uno stile. Anni fa Pietro Citati, recensendo il suo I quarantanove gradini (Adelphi, 1991), ebbe a definirlo «uno scrittore imprendibile: sta celato nei suoi libri, come un animale occulto, enigmatico e pericoloso. […] Se tutto, nella sua mentalità e nella sua educazione, lo predisponeva a essere un saggista filosofo, il caso o gli astri o altri libri hanno voluto che egli diventasse molto di più: uno scrittore» (La Repubblica, 3 novembre 1991). Interrogato in merito al crogiolo di saperi e parole che appronta nelle sue opere, Calasso si è espresso così: «in rapporto a quello che scrivo l'espressione di Nietzsche pensiero impuro mi sembra una buona approssimazione» (“Il Venerdì”, 15/7/2016). Indubbiamente un'eco nietzscheana (non a caso l'opera omnia di Nietzsche è stata una delle prime pubblicazioni di Adelphi, la casa editrice di cui Calasso è proprietario e direttore) si avverte anche nell'Innominabile attuale: nello stile ricercato e potente, tendente all'aforisma; nello sguardo acuto, allo stesso tempo disincantato e meravigliato, che si posa sulle cose del mondo. Si potrebbe definire l'opera di Calasso un esercizio di pensiero, forse un po' nascosto, se, come l'autore stesso scrive, «al pensiero sarebbe quanto mai utile un periodo di occultamento, di vita clandestina e camuffata, da cui tornare a emergere in una situazione che potrebbe avvicinarsi a quella dei presocratici» (2017, p. 47).
L'innominabile attuale, uscito quest’anno per i tipi di Adelphi, è l'ultimo anello della collana di opere scritte da Roberto Calasso. Il titolo riprende un'espressione che si trova nella prima pubblicazione dell'autore, La rovina di Kasch (Adelphi, 1983), sancendo così un collegamento tra l'inizio e la provvisoria fine della sua vasta produzione. Così come l'attuale di cui si occupa il testo, altrettanto sfuggente è l'opera di Calasso, irriducibile a un genere e a uno stile. Anni fa Pietro Citati, recensendo il suo I quarantanove gradini (Adelphi, 1991), ebbe a definirlo «uno scrittore imprendibile: sta celato nei suoi libri, come un animale occulto, enigmatico e pericoloso. […] Se tutto, nella sua mentalità e nella sua educazione, lo predisponeva a essere un saggista filosofo, il caso o gli astri o altri libri hanno voluto che egli diventasse molto di più: uno scrittore» (La Repubblica, 3 novembre 1991). Interrogato in merito al crogiolo di saperi e parole che appronta nelle sue opere, Calasso si è espresso così: «in rapporto a quello che scrivo l'espressione di Nietzsche pensiero impuro mi sembra una buona approssimazione» (“Il Venerdì”, 15/7/2016). Indubbiamente un'eco nietzscheana (non a caso l'opera omnia di Nietzsche è stata una delle prime pubblicazioni di Adelphi, la casa editrice di cui Calasso è proprietario e direttore) si avverte anche nell'Innominabile attuale: nello stile ricercato e potente, tendente all'aforisma; nello sguardo acuto, allo stesso tempo disincantato e meravigliato, che si posa sulle cose del mondo. Si potrebbe definire l'opera di Calasso un esercizio di pensiero, forse un po' nascosto, se, come l'autore stesso scrive, «al pensiero sarebbe quanto mai utile un periodo di occultamento, di vita clandestina e camuffata, da cui tornare a emergere in una situazione che potrebbe avvicinarsi a quella dei presocratici» (2017, p. 47).Il libro è diviso in tre parti. La prima, Turisti e terroristi, è dedicata al mondo contemporaneo, sfuggente al punto da provocare la sensazione di non sapere dove si stanno mettendo i piedi, «l'opposto del mondo che Hegel intendeva stringere nella morsa del concetto» (p. 13). L'uomo che abita l'innominabile attuale, definito da Calasso Homo secularis, ha smarrito non tanto la religione quanto il brivido del sacro, il senso del divino. Ha sperimentato un alleggerimento da tutti i vincoli, senza però riuscire a viverlo come una possibilità liberatoria, ma avvertendo piuttosto un costante senso di minaccia, gravato dal peso dell'inconsistenza.
C'è però un'eredità delle epoche passate talmente potente e cruciale da non riuscire a tramontare: il sacrificio. Presenza costante nell'opera di Calasso, in questo libro viene accostato al fenomeno del terrorismo. Negli atti terroristici dei fondamentalisti islamici, osserva l'autore, è l'attentatore stesso a essere la vittima sacrificale, mentre la popolazione che viene uccisa è il mezzo per compiere il sacrificio. Secondo Calasso il terrorismo jihadista è compiuto in odio alla società secolare, che è dilagata nel mondo islamico portando con sé un frutto avvelenato: la pornografia. La possibilità improvvisa di vedere milioni di corpi nudi femminili che fanno sesso «fu un oltraggio estremo e una attrazione indominabile», capace di scatenare in modo incontrollato la pulsione di morte, più che quella erotica. La convergenza tra culture oggi infatti si verifica, secondo l'autore, proprio attraverso la pornografia, e ancor più con il turismo. In entrambi i mondi, nei quali le azioni sono prevedibili e ripetitive, l'estetica è omologata, l'esecuzione meccanica prevale sul dubbio. Le pagine dedicate al turismo, che denunciano come l'esperienza dell'altro venga sottratta allo shock dell'inatteso e addomesticata, suonano a dire il vero un po' banali.

Hubert Robert - Paysage avec des bergers dans des ruines
Osservazioni penetranti riguardano invece il pensiero dell'età secolare, se di pensiero si può parlare. La società secolare, privata della possibilità di rivolgersi al trascendente, ha finito per adorare se stessa; un'ulteriore trasformazione del sacrificio è avvenuta attraverso l'esperimento: l'estensione del campo dello sperimentabile all'intero materiale umano ha condotto agli esiti drammatici del totalitarismo. La stessa logica si ritrova in una nuova «religione secolare», il transumanesimo, che considera la morte alla stregua di un problema da risolvere. Una delle voci più forti tra quelle pronunciate dall'Homo secularis è oggi progressista e umanitaria, talvolta anche spirituale, ma espressione di un umanitarismo e di una spiritualità infondati, retorici, dimentichi delle proprie origini. Della stessa mancanza di fondamento soffre del resto la democrazia, che risiede unicamente in un insieme di procedure, ma è la sola forma di governo capace di rendere sopportabile la convivenza umana. La società secolare, che esalta l'immediatezza e la disintermediazione, mette a rischio il metodo democratico, basato, come del resto l'intera esistenza, sulla mediazione.
Calasso si sofferma poi sulla «religione dell'informazione», l'ossessione per i bit e gli algoritmi che pervade la nostra era, condivisa da buona parte delle élites imprenditoriali e scientifiche. L'informazione, che è necessariamente una grandezza discreta, non potrà mai chiarire il mistero della coscienza, che è invece situata al confine tra discreto e continuo, ma certamente è irriducibile a qualsiasi logica autistica e binaria. Come nel caso del turismo, anche nell'era informatica Calasso individua una minaccia alla possibilità del fare esperienza: «La digitabilità è il più grave assalto che abbia subito l'inclinazione a esporsi allo shock dell'ignoto» (p. 88).
Di fronte a tutto questo, secondo l'autore non resta che coltivare il proprio senso di non appartenenza, situandosi tra le pieghe della società, come «contemplanti nascosti e non riconosciuti», senza indulgere in lamentele che si rivelerebbero inconsistenti quanto la realtà di cui si dolgono. Una soluzione di ripiegamento individualistico, venata di pessimismo nei confronti dell'attuale, che lascia un po' a desiderare.
La seconda parte del testo, La Società Viennese del Gas ripercorre invece l'epoca che precede l'affermarsi dell'innominabile attuale: il periodo che va dal 1933 al 1945, in cui «il mondo ha compiuto un tentativo di autoannientamento, parzialmente riuscito». La storia viene ripercorsa attraverso una selezionata cronologia composta dalle testimonianze di scrittori e intellettuali: tra gli altri, Céline, Walter Benjamin, Brasillach, Ernst Jünger, Simone Weil, Klaus Mann, Curzio Malaparte, Vasilij Grossman. Sono le pagine migliori del libro: Calasso, attingendo alla sua sconfinata erudizione, riesce a dipingere un affresco inquietante e illuminante, impossibile da riassumere e tutto da leggere.
La terza e ultima parte, Avvistamento delle Torri, riprende un frammento di Baudelaire, in cui viene descritto un sogno, che è anche un triste presagio: un'immensa torre sta per cadere, è impossibile trovare l'uscita, ma nessuno sembra accorgersene, né sembra possibile avvertire alcuno.
L'innominabile attuale è una lettura che non lascia indifferenti; a suo modo, una testimonianza del fatto che lo «shock dell'ignoto», tanto caro all'autore, è possibile ancora oggi attraverso la fruizione di un prodotto culturale. Non mancano tuttavia le pagine in cui prevale uno sguardo elitario, ai limiti dello snobismo: questo accade quando lo sforzo di dare un nome alla contemporaneità, pure definita come inafferrabile, indulge in una solerzia eccessiva e quasi semplificatrice. Ciò di cui si avverte la mancanza, in fondo, è il gusto di cogliere l'innominabilità evocata nel titolo come qualcosa di misterioso, di irrisolto, ma foriero di possibilità inedite. Di certo il presente risulta irriducibile a visioni tranquillizzanti e lascia poco spazio a ogni ingenuo volontarismo progressista, ma non per questo deve essere ricoperto, con un opposto gesto di sottile moralismo, da un velo di negatività.
di Luca Pagano
-
 Il profumo del tempo del filosofo coreano Byung-Chul Han (Vita e Pensiero,2017) è un libro sul rapporto che le società contemporanee intrattengono con il loro tempo, probabilmente il nostro bene più prezioso. Di qui la necessità di analizzare un’epoca che sta pericolosamente trascurando l’importanza del tempo, appiattendolo sul presente con l’effetto di sminuirlo a mera attualità, e obliando così le sue altre dimensioni, il passato in primis, visto come qualcosa di non più “agente” (come se non esistesse più, o addirittura non fosse mai esistito) e quindi poco interessante. Byung-Chul Han parla di una vera e propria “crisi del tempo” che dipende dall’assolutizzazione della vita activa e della relativa degradazione dell’uomo ad animal laborans ossessionato dall’imperativo del lavoro. Il tempo ha perso il suo valore, il suo profumo, la sua durata. È frammentato, atomizzato, intempestivo perché slegato da una narrazione temporale che possa infine portare alla compiutezza di un percorso. Non ha direzione. Perché si è arrivati a questo non è facile dirlo, ma ha certamente a che fare con lo svuotamento di senso e significato del mondo, a favore di un modo di esistere più superficiale e provvisorio, improntato sull’azione, avverso alla contemplazione.
Il profumo del tempo del filosofo coreano Byung-Chul Han (Vita e Pensiero,2017) è un libro sul rapporto che le società contemporanee intrattengono con il loro tempo, probabilmente il nostro bene più prezioso. Di qui la necessità di analizzare un’epoca che sta pericolosamente trascurando l’importanza del tempo, appiattendolo sul presente con l’effetto di sminuirlo a mera attualità, e obliando così le sue altre dimensioni, il passato in primis, visto come qualcosa di non più “agente” (come se non esistesse più, o addirittura non fosse mai esistito) e quindi poco interessante. Byung-Chul Han parla di una vera e propria “crisi del tempo” che dipende dall’assolutizzazione della vita activa e della relativa degradazione dell’uomo ad animal laborans ossessionato dall’imperativo del lavoro. Il tempo ha perso il suo valore, il suo profumo, la sua durata. È frammentato, atomizzato, intempestivo perché slegato da una narrazione temporale che possa infine portare alla compiutezza di un percorso. Non ha direzione. Perché si è arrivati a questo non è facile dirlo, ma ha certamente a che fare con lo svuotamento di senso e significato del mondo, a favore di un modo di esistere più superficiale e provvisorio, improntato sull’azione, avverso alla contemplazione.Conseguenze di questa nuova dimensione temporale sono la noia e l’accelerazione tipiche dei nostri giorni, ma anche angoscia e inquietudine. La Storia custode del tempo, che ha ormai lasciato il posto alle informazioni “senza profumo” (senza senso), perde la sua tensione narrativa, frammentandosi. Così, in questo vuoto lasciato dal tempo, si impone l’accelerazione, un esistere senza ostacoli, ormai annullati dalla mancanza di significati. Il tempo corre e noi con esso, incapaci di fermarci, sùbito preda della noia, e per questo sempre in procinto di fare. «Per la mancanza di tensione narrativa – scrive Byung-Chul Han –, il tempo atomizzato non può trattenere a lungo l’attenzione e per questo la percezione viene alimentata sempre con qualcosa di nuovo e radicale. Il tempo puntuale non concede alcun indugiare contemplativo» (p. 27). Unico nostro scopo, in tutti gli ambiti della vita, è ormai quello di eliminare l’intervallo, interpretato come noiosa sospensione, perché priva di senso e significato, in favore dell’azione. Non sappiamo più indugiare, ovvero fare l’esperienza della durata, in sostanza assaporare l’esistenza – eppure, ricorda il filosofo sudcoreano, «non la quantità di eventi, ma l’esperienza della durata rende più piena la vita» (p. 44). Siamo abituati a scolarci questa vita senza nemmeno avvertirne il sapore sulla lingua.

Sul piano psicologico la mancanza della solidità della durata si riflette in un’angoscia diffusa di un individuo che, nel suo approcciarsi al mondo, ha sempre più a che fare con l’inatteso e l’imprevisto. Non solo il tempo, ma anche noi siamo discontinui, sospesi nel vuoto di significato. Sul piano sociale, invece, ciò comporta la perdita di importanza di pratiche quali la promessa, la fedeltà e il vincolo. La crisi temporale si fa così una vera e propria crisi d’identità individuale e sociale.
La dissoluzione del nostro tempo, l’unico in grado di dare un significato all’esistere, è una condanna a vivere un’esistenza surrogata, mai approfondita nella sua pienezza. Siamo “animali della durata”, non coscienze intermittenti ridotte alla sola dimensione del presente. La società contemporanea, al contrario, ci sta conducendo sempre più verso il primato del presente: «ciò che non si lascia ridurre al presente non esiste. Tutto deve essere presente. Spazi e tempi intermedi che agiscono in senso contrario alla riduzione al presente vengono soppressi. Restano infatti soltanto due condizioni: il nulla e il presente. Non vi è più il “tra”. Ma essere è più che essere-presente» (p. 47).
Siamo sempre meno animali della soglia, per i quali le soglie provocano sofferenza ma anche e soprattutto felicità; sempre meno “uomini dell’attesa”, per i quali la vita è ricca di momenti intermedi in cui crescere e formarsi – senza questi momenti intermedi non esisterebbe la cultura umana (che cosa sono, ad esempio, le feste?); e infine sempre meno uomini capaci di indugiare sulle cose, afferrandone il profumo per custodirlo nei ricordi. Ma «l’indugiare contemplativo – ci dice Byung-Chul Han – concede invece tempo, amplia l’essere, che è più di un essere-attivo. La vita guadagna tempo e spazio, durata e ampiezza, quando recupera questa capacità contemplativa» (p. 132).
Come sfuggire all’unica imperante dimensione – quella dell’animal laborans – in cui ormai ci ha costretto questa società attiva? Han risponde: «la democratizzazione del lavoro dovrebbe essere […] seguita da una democratizzazione dell’otium, perché la prima non degeneri in schiavitù di tutti» (p. 132). La via di mezzo è sempre la soluzione più auspicabile; ma abbiamo tutti il dovere di non dimenticarci che è stato proprio l’indugiare della filosofia a condurci a questa soluzione.
a cura di Stefano Scrima
-
 Sebbene la coscienza sia stata a lungo considerata caratteristica peculiare dell’essere umano, negli ultimi anni si è assistito a un fiorire di studi dedicati alla mente negli animali non-umani[1]. Si tratta di un tema che solleva numerose difficoltà, chiamando in causa il problema delle altre menti in una forma estrema, dato che gli animali non hanno un linguaggio tramite il quale descrivere le loro sensazioni. Nonostante l’assenza di una definizione non ambigua di coscienza, quando si parla di menti non-umane si intendono alcune capacità riscontrabili in numerosi gruppi tassonomici e cioè percezione, discriminazione, consapevolezza e categorizzazione degli stimoli, nonché pianificazione di comportamenti complessi. L’ultimo libro di Peter Godfrey-Smith, professore di storia e filosofia della scienza all’Università di Sidney e professore emerito presso la City University of New York, si inserisce in questo filone di studi e presenta al lettore in maniera chiara e discorsiva – ma non per questo meno rigorosa – alcuni protagonisti straordinari del regno animale: i cefalopodi. Una domanda sembra echeggiare fra le pagine di questo libro ed è una variante della famosa domanda espressa da Thomas Nagel[2] relativamente a cosa si provi a essere un pipistrello: in questo caso, tuttavia, ciò che interessa all’autore è cosa si provi a essere un polpo e, come vedremo, la risposta è forse ancora più complessa.
Sebbene la coscienza sia stata a lungo considerata caratteristica peculiare dell’essere umano, negli ultimi anni si è assistito a un fiorire di studi dedicati alla mente negli animali non-umani[1]. Si tratta di un tema che solleva numerose difficoltà, chiamando in causa il problema delle altre menti in una forma estrema, dato che gli animali non hanno un linguaggio tramite il quale descrivere le loro sensazioni. Nonostante l’assenza di una definizione non ambigua di coscienza, quando si parla di menti non-umane si intendono alcune capacità riscontrabili in numerosi gruppi tassonomici e cioè percezione, discriminazione, consapevolezza e categorizzazione degli stimoli, nonché pianificazione di comportamenti complessi. L’ultimo libro di Peter Godfrey-Smith, professore di storia e filosofia della scienza all’Università di Sidney e professore emerito presso la City University of New York, si inserisce in questo filone di studi e presenta al lettore in maniera chiara e discorsiva – ma non per questo meno rigorosa – alcuni protagonisti straordinari del regno animale: i cefalopodi. Una domanda sembra echeggiare fra le pagine di questo libro ed è una variante della famosa domanda espressa da Thomas Nagel[2] relativamente a cosa si provi a essere un pipistrello: in questo caso, tuttavia, ciò che interessa all’autore è cosa si provi a essere un polpo e, come vedremo, la risposta è forse ancora più complessa.Le specie che rientrano nella classe dei cefalopodi sono numerose, ma l’autore si sofferma su polpi, seppie e calamari, accomunati da un sistema nervoso complesso, un grosso cervello, sensi ben sviluppati e capacità cognitive e comportamentali sorprendenti. La straordinarietà dei cefalopodi, tuttavia, non risiede soltanto nelle loro attuali caratteristiche, ma, nondimeno, nella loro storia evolutiva che non potrebbe essere stata più differente dalla nostra.
Other Minds. The Octopus and the Evolution of Intelligent Life (Harper Collins, 2016), si apre (Meeting Across the Tree of Life, p. 3) con uno sguardo al nostro passato, teso alla ricerca di un antenato comune all’uomo e al polpo. Godfrey-Smith cerca l’ultimo tratto condiviso della storia evolutiva di due specie diversissime, un mammifero e un mollusco che, nonostante le profonde differenze, sembrano condividere qualcosa di distintivo. Il più recente antenato comune a uomini e polpi è vissuto circa 600 milioni di anni fa e di lui sappiamo pochissimo: era, presumibilmente, un vermicello che nuotava nell’oceano o strisciava sul fondale e che rappresenta il punto di biforcazione di due enormi rami dell’albero evolutivo, da un lato, il ramo che porterà ai vertebrati, come gli uccelli e i mammiferi, dall’altro, il ramo degli invertebrati, come gli insetti e i molluschi; e se nel primo ramo si evolverà diffusamente il sistema nervoso e il comportamento complesso, non si potrà dire lo stesso del secondo. Tuttavia, all’interno di questo sterminato gruppo di invertebrati si trova quella che Godfrey-Smith definisce un’“isola di complessità mentale” che può essere ragionevolmente considerata un esperimento indipendente nell’evoluzione del cervello, vista la lontananza filogenetica fra uomo e polpo. I cefalopodi sembrano essere, cioè, quel che di più simile a un alieno potremmo incontrare. Un alieno molto simile all’uomo, per alcuni versi.
Dopo una breve “Storia degli animali” (A History of Animals, p. 15) che fornisce al lettore un’agile cornice evolutiva e descrive l’emergere degli organismi pluricellulari, del sistema nervoso e della simmetria corporea bilaterale, l’autore si concentra sull’evoluzione e sulle caratteristiche dei cefalopodi (Mischieff and Craft, p. 43), la cui storia è, in parte, la storia dei molluschi – il loro phylum. Durante il Cambriano i molluschi si dotarono di un esoscheletro, detto conchiglia, a seguito delle nuove condizioni ambientali e dei nuovi predatori che popolavano i loro ambienti e, sotto la conchiglia, si sviluppò una piccola appendice muscolare, una sorta di “piede”, che permise loro di muoversi sul fondale marino. Tuttavia, a un certo punto, i cefalopodi riuscirono a staccarsi dal fondale producendo una certa quantità di gas che, trattenuta nella conchiglia, li trasformò in piccoli dirigibili, mentre il piede, libero, diventò un sifone grazie a cui l’animale poté cominciare a muoversi in diverse direzioni invece di galleggiare o farsi trasportare dalle correnti. In seguito, il piede si sviluppò ancora, ed emersero tentacoli dotati di uncini capaci di manipolare e afferrare oggetti e altre creature. In altre parole, da prede i cefalopodi si trasformarono in predatori e i loro movimenti si fecero sempre più complessi finché questi animali persero l’esoscheletro ottenendo, con ciò, un’impareggiabile agilità e flessibilità. Il polpo, per esempio, non ha attualmente alcuna parte ossea né cartilaginea, tranne il becco, e può quindi introdursi e nascondersi in cavità minuscole, passando attraverso fori del diametro del suo occhio. Tuttavia, contemporaneamente a questa evoluzione corporea, i cefalopodi furono protagonisti di un’evoluzione ancora più stupefacente, ossia quella del loro sistema nervoso e del loro comportamento, di cui l’autore riporta esempi esilaranti, come i dispetti e le malefatte intenzionalmente compiute da questi astuti animali in laboratorio (From White Noise to Consciousness, p. 77). Di primo acchito, i polpi sembrano essere molto intelligenti e la loro è un’intelligenza ingegnosa ed eccentrica, tuttavia l’osservazione del comportamento non è l’unico modo per determinare l’intelligenza di un animale. Un’altra via è quella di valutare la grandezza del suo cervello e il numero di neuroni che lo compongono, paragonandone le prestazioni a quelle di animali filogeneticamente a noi più vicini, come i mammiferi e, nello specifico, le scimmie. Nel caso dei polpi, tuttavia, sebbene le dimensioni del cervello siano fuori misura rispetto agli altri invertebrati e il numero di neuroni sia estremamente elevato (500 milioni, all’incirca come un cane), sorge un’affascinante difficoltà: il sistema nervoso dei polpi è organizzato in un modo totalmente diverso rispetto a quello dei vertebrati, a tal punto diverso da scardinare la stessa concezione di mente/corpo. Se nei cordati (pesci, rettili, uccelli e mammiferi) il sistema nervoso è composto da un fascio di nervi che corre lungo il corpo e da un cervello sviluppatosi a una delle sue estremità, il sistema nervoso dei cefalopodi è invece meno centralizzato. Soltanto la metà dei loro neuroni si trova nel cervello, l’altra metà si trova nei tentacoli, che sono perciò parzialmente autonomi: il polpo insomma, suggerisce Godfrey-Smith, “lives outside the usual mind/body divide” (p. 76) e questa circostanza è uno dei molti motivi per cui lo studio di questi animali potrebbe gettar luce sul problema della coscienza. D’altro canto, un altro motivo corrisponde alla teoria più propriamente filosofica del libro, una teoria che dipende dall’affascinante capacità cromatica dei cefalopodi e dalle peculiarità linguistiche della mente umana. Da un lato, infatti (Making colors, p. 107), i cefalopodi presentano un corpo e soprattutto una cute che può essere paragonata a uno schermo ad altissima risoluzione, capace di riprodurre una varietà straordinaria di colori, sequenze e pattern cromatici che solo in parte hanno la funzione di comunicare con i loro simili o di permettere una mimetizzazione con l’ambiente marino. Dall’altra (Our Minds and Others, p. 137), l’uomo ha sviluppato la capacità di comunicare a un livello di complessità unica attraverso il linguaggio, ma questo tratto, secondo Godfrey-Smith e altri autori da lui citati, non ha questa unica funzione. Il linguaggio è uno strumento importantissimo per il pensiero stesso e per decenni si è persino pensato che il linguaggio complesso fosse la condizione di possibilità del pensiero complesso. Così non è, come suggeriscono numerosi studi citati dall’autore, e tuttavia il linguaggio resta utile a organizzare le idee e il pensiero, soprattutto nella sua forma di inner speech, quel linguaggio mentale che nessuno può davvero sentire – e talora controllare – ma che si fa silente flusso di pensieri in grado di trasportare informazioni e renderle disponibili al soggetto. Emerge una somiglianza fra la mente umana e la mente dei cefalopodi: se la nostra complessa attività mentale si manifesta attraverso questo continuo e privato flusso di pensieri, l’attività interna dei cefalopodi si manifesta tramite un continuo flusso cromatico, un incessante variare di colori e forme, una sorta di “sinfonia” di sfumature portatrici di significati interiori e privati. Perché privati? Perché, inaspettatamente, i cefalopodi non vedono i colori e così al “mental chatter” umano corrisponderebbe una sorta di “chromatic chatter”, un flusso di informazioni continuo, testimone di una brulicante, quanto forse incomunicabile, attività interiore: “There’s a simple social life, hence less to say, but such extraordinary things expressed nonetheless” (pag. 133).

La concezione di mente che emerge dal testo di Godfrey-Smith è quindi connotata in senso evolutivo: la coscienza non è un fenomeno univoco formatosi una volta per tutte, bensì una struttura biologica variegata e multiforme, e non è prerogativa dell’uomo, né dei mammiferi, né dei vertebrati. Ridimensionatane la nozione, l’autore può riconoscere versioni di coscienza non-umane, tracciando una sorta di storia che va dalle sue forme più elementari, definite metaforicamente “white noises”[3], fino alla coscienza propriamente detta degli uomini. “Evolution built minds twice” (pag. 9): la coscienza non è un fenomeno inatteso e anomalo, bensì uno strumento adattivamente utile, essenziale anzi al comportamento complesso, innegabilmente dimostrato dai polpi. Godfrey-Smith ci conduce ad Octopolis (Octopolis), l’anomalo sito australiano che ospita da anni delle piccole comunità di polpi, animali normalmente solitari: i polpi giocano, dimostrano grande curiosità, usano strumenti, li smontano, li rimontano, se li tirano addosso, riconoscono i loro conspecifici, così come le persone, e vi interagiscono in modi non triviali, sviluppando anzi spiccate simpatie o antipatie. Come la vita, dunque, anche la mente sembra nata negli oceani, e nonostante si tratti di una mente diversissima, quasi aliena, mai quanto grazie alla lettura di questo libro ci sembrerà vicina e familiare.
di Erica Onnis
[1] Cfr. fra gli altri Allen, Colin and Trestman, Michael, "Animal Consciousness", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2017 Edition), Edward N. Zalta (ed.), https://plato.stanford.edu/archives/win2017/entries/consciousness-animal; Ârhem, P., & Liljenström, H., & Lindahl, B. I. B. (2002). Evolution of Consciousness: Report of Agora Workshop in Sigtuna, Sweden, August 2001. Journal of Consciousness Studies, 9, 81–84; Barron, A.B. & Klein, C. (2016). “What insects can tell us about the origin of consciousness.”, Proceedings of the National Academy of Sciences, 113, pp. 4900-4908; Brandon, R. (1990). Adaptation and Environment. Princeton, NJ: Princeton University Press; Browne, D. (2004). Do dolphins know their own minds? Biology & Philosophy, 19, 633–653; Bronfman, Z. Z., Ginsburg, S., & Jablonka, E. (2016). “The Evolutionary Origin of Consciousness.”, Journal of Consciousness Studies, 23(9-10), pp. 7–34; Cabanac, M., & Cabanac, J., & Paren, A. (2009). The emergence of consciousness in phylogeny. Behavioural Brain Research, 2(198), 267–272; Dennett, D. (2016). From Bacteria to Bach and Back. The Evolution of Minds. New York: W. W. Norton & Company; Merker, B. (2005). “The Liabilities of Mobility: A Selection Pressure for the Transition to Consciousness in Animal Evolution.” Consciousness and Cognition, 14, pp. 89–114.
[2] Nagel, T. (1974). “What Is It Like to Be a Bat?”, The Philosophical Review, 83(4), 435-450
[3] Il riferimento qui è a una metafora usata da Simona Ginzburg ed Eva Jablonka, cfr. S. Ginzburg, E. Jablonka, The Transition to Experiencing: II. The Evolution of Associative Learning Based on Feelings, Biological Theory 2(3) 2007, 231–243
-
Derrida lettore di Celan
Sconfinamenti, Serial / Ottobre 2017 Il primo libro di Jacques Derrida interamente dedicato a un poeta appare nel 1986 e concerne Paul Celan. Si tratta del testo di una conferenza pronunciata due anni prima a Seattle, nel corso di un convegno internazionale. Cominciamo con l’esplicitare il titolo del volumetto, Schibboleth. Esso riprende quello di una poesia celaniana, ma il vocabolo – come il filosofo non manca di ricordare – ha origini assai più remote, che risalgono all’Antico Testamento. In un passo del libro dei Giudici, si narra ciò che avvenne dopo una battaglia vinta dai Galaaditi contro gli Efraimiti: «E Galaad bloccò i guadi del Giordano agli Efraimiti, in modo che quando qualcuno dei fuggitivi di Efraim diceva: “Fatemi passare!” gli uomini di Galaad gli chiedevano: “Sei tu di Efrata?” ed egli rispondeva: “No!”. Però quelli insistevano: “Di’ Schibboleth”; l’altro invece rispondeva “Sibboleth!” poiché non riusciva a pronunciarlo bene. Allora lo afferravano e lo sgozzavano nei guadi del Giordano, tanto che in quel giorno caddero uccisi quarantaduemila Efraimiti». Ecco come una parola in apparenza innocua (schibboleth in ebraico significa «spiga» o «torrente») può assumere risonanze sinistre, dato che la sua pronuncia scorretta, in una particolare circostanza bellica, fu sufficiente a causare una morte immediata e cruenta. Più tardi, però, nella cultura europea, il senso del vocabolo è cambiato, venendo ad assumere l’accezione più ampia e neutra di «segno di riconoscimento», «parola d’ordine». Così, per limitarci a ricordare due autori ben noti a Derrida, Hegel può scrivere che «l’odio per la legge, per il diritto legalmente determinato, è lo schibboleth con cui si rivelano il fanatismo, l’imbecillità e l’ipocrisia», oppure Freud può indicare nella distinzione tra coscienza e inconscio il «primo schibboleth della psicoanalisi».
Il primo libro di Jacques Derrida interamente dedicato a un poeta appare nel 1986 e concerne Paul Celan. Si tratta del testo di una conferenza pronunciata due anni prima a Seattle, nel corso di un convegno internazionale. Cominciamo con l’esplicitare il titolo del volumetto, Schibboleth. Esso riprende quello di una poesia celaniana, ma il vocabolo – come il filosofo non manca di ricordare – ha origini assai più remote, che risalgono all’Antico Testamento. In un passo del libro dei Giudici, si narra ciò che avvenne dopo una battaglia vinta dai Galaaditi contro gli Efraimiti: «E Galaad bloccò i guadi del Giordano agli Efraimiti, in modo che quando qualcuno dei fuggitivi di Efraim diceva: “Fatemi passare!” gli uomini di Galaad gli chiedevano: “Sei tu di Efrata?” ed egli rispondeva: “No!”. Però quelli insistevano: “Di’ Schibboleth”; l’altro invece rispondeva “Sibboleth!” poiché non riusciva a pronunciarlo bene. Allora lo afferravano e lo sgozzavano nei guadi del Giordano, tanto che in quel giorno caddero uccisi quarantaduemila Efraimiti». Ecco come una parola in apparenza innocua (schibboleth in ebraico significa «spiga» o «torrente») può assumere risonanze sinistre, dato che la sua pronuncia scorretta, in una particolare circostanza bellica, fu sufficiente a causare una morte immediata e cruenta. Più tardi, però, nella cultura europea, il senso del vocabolo è cambiato, venendo ad assumere l’accezione più ampia e neutra di «segno di riconoscimento», «parola d’ordine». Così, per limitarci a ricordare due autori ben noti a Derrida, Hegel può scrivere che «l’odio per la legge, per il diritto legalmente determinato, è lo schibboleth con cui si rivelano il fanatismo, l’imbecillità e l’ipocrisia», oppure Freud può indicare nella distinzione tra coscienza e inconscio il «primo schibboleth della psicoanalisi».Nel libro viene introdotto subito il tema che sta particolarmente a cuore al filosofo, ossia quello del rapporto tra la scrittura poetica e i richiami al tempo cronologico. Questo fa sì che a Derrida appaia inopportuno «dissociare da una parte gli scritti di Celan a proposito della data, quelli che nominano il tema della data, e dall’altra i tracciati poetici della datazione». La frase richiede qualche chiarimento, nel senso che non esistono testi di Celan incentrati sul tema della data, benché qualche accenno ad esso compaia nei rari pronunciamenti pubblici del poeta; inoltre conviene specificare che, parlando di «tracciati poetici della datazione», Derrida non allude soltanto al fatto che, nella loro versione manoscritta, le liriche di Celan sono spesso datate con precisione, ma anche ai riferimenti a date (antiche o recenti, private o storiche) che compaiono all’interno dei suoi versi.
SCARICA IL PDF
A cura di:
Giuseppe Zuccarino è critico e traduttore. Ha pubblicato vari saggi: La scrittura impossibile, Genova, Graphos, 1995; L’immagine e l’enigma, ivi, 1998; Critica e commento. Benjamin, Foucault, Derrida, ivi, 2000; Percorsi anomali, Udine, Campanotto, 2002; Il desiderio, la follia, la morte, ivi, 2005; Il dialogo e il silenzio, ivi, 2008; Da un’arte all’altra, Novi Ligure, Joker, 2009; Note al palinsesto, ivi, 2012; Il farsi della scrittura, Milano-Udine, Mimesis, 2012; Prospezioni. Foucault e Derrida, ivi, 2016. Tra i libri da lui tradotti figurano opere di Mallarmé, Bataille, Klossowski, Blanchot, Caillois e Barthes. Ha inoltre curato un fascicolo monografico della rivista «Riga» (n. 37, 2017) dedicato a Maurice Blanchot.
-
 Nell’introduzione dei due curatori del numero, Simone Guidi e Alberto Romele, l’infosfera viene presentata come un fatto totale, non soltanto sociale (secondo la nota locuzione di Marcel Mauss, poi ripresa in ambito strutturalista), ma anche etico, antropologico e filosofico. Il modo in cui viene usato il termine “infosfera” e altre parole chiave (come onlife e third order technologies) richiamano il punto di vista di Luciano Floridi sulla quarta rivoluzione in corso nelle società ad informazione matura (Floridi, 2014), ma la prospettiva proposta nella rivista e riassunta dal titolo è diversa: assumendo che gli esseri umani abbiano iniziato ad estendere il proprio dominio sulla natura da quando sono diventati capaci di registrare e leggere tracce, la discontinuità contemporanea viene ricondotta all’invenzione di macchine diverse da quelle classiche e all’emergenza di ambienti automatici in grado di scrivere e leggere tracce autonomamente (pp. 10-11). Questo è il fatto totale che spinge a riconsiderare complessivamente le possibilità dell’essere umano, circondato di dispositivi di cui può disporre e che, al tempo stesso, sembrano poter disporre di lui in modi sempre più pervasivi e per vie complesse da “tracciare”.
Nell’introduzione dei due curatori del numero, Simone Guidi e Alberto Romele, l’infosfera viene presentata come un fatto totale, non soltanto sociale (secondo la nota locuzione di Marcel Mauss, poi ripresa in ambito strutturalista), ma anche etico, antropologico e filosofico. Il modo in cui viene usato il termine “infosfera” e altre parole chiave (come onlife e third order technologies) richiamano il punto di vista di Luciano Floridi sulla quarta rivoluzione in corso nelle società ad informazione matura (Floridi, 2014), ma la prospettiva proposta nella rivista e riassunta dal titolo è diversa: assumendo che gli esseri umani abbiano iniziato ad estendere il proprio dominio sulla natura da quando sono diventati capaci di registrare e leggere tracce, la discontinuità contemporanea viene ricondotta all’invenzione di macchine diverse da quelle classiche e all’emergenza di ambienti automatici in grado di scrivere e leggere tracce autonomamente (pp. 10-11). Questo è il fatto totale che spinge a riconsiderare complessivamente le possibilità dell’essere umano, circondato di dispositivi di cui può disporre e che, al tempo stesso, sembrano poter disporre di lui in modi sempre più pervasivi e per vie complesse da “tracciare”.Saltando dall’introduzione al contributo conclusivo – un’intervista di Alberto Romele a Luciano Floridi – notiamo peraltro che il secondo non condivide l’utilizzo del concetto di “traccia” e mette in guardia in primis dal suo portato metaforico: «Questa delle tracce e del “materiale esausto”, i residui di ciò che “esce dal tubo di scappamento” sono metafore che a me non piacciono molto. Dal punto di vista retorico sono accattivanti ma dal punto di vista filosofico le trovo preoccupanti» (p. 169); «Certo c’è anche una seconda maniera di pensare alle tracce come alle impronte lasciate sulla strada durante un viaggio. Questo utilizzo lo trovo vagamente preferibile ma anch’esso ha le sue trappole […]. Ci porta infatti a distinguere tra tracciante e tracciato, come se si stesse parlando delle tracce che un animale ha lasciato nel bosco» (pp. 169-170). Più in generale, Floridi sottolinea che lo spazio non euclideo di Internet non va interpretato come uno spazio geografico, ma come uno spazio logico in cui, tra l’altro, ciò che accade dove arriva l’infrastruttura tecnologica alla base della rete influenza pervasivamente anche ciò che accade dove l’infrastruttura non arriva: questo vale in particolare nelle società «in cui la rete Internet è un servizio come la rete idrica ed elettrica» (p. 173), ossia nelle mature information societies a cui si è fatto riferimento.
Riguardo al tema della traccia, i contributi della rivista che lo affrontano in modo esplicito e prioritario spaziano dal soffermarsi su questioni molto specifiche all’analisi teorica generale: del primo caso è esemplare il contributo di Enrico Terrone (Causal Routes to Nowhere. On Digital Photographs as Traces, pp. 61-72), che discutendo la distinzione tra simboli autografici e allografici di Nelson Goodman illustra come le fotografie digitali possano essere considerate tracce; del secondo tipo di analisi è esemplare il contributo di Bruno Bachimont (Traces, Calculation and Interpretation. From the Measure to Data, pp. 13-36), che affronta il problema contemporaneo della raccolta, del trattamento e della visualizzazione dei dati, dopo avere discusso la complessa relazione tra dati e tracce (che non sono la stessa cosa, p. 20), distinte in tipi (involontarie, volontarie, provocate): il nodo sta nel fatto che la gestione tradizionale dei segni – esemplificata dalla sintesi sinottica della scrittura – si accompagnava a forme di comprensione e interpretazione che oggi sembrano venir meno nella sintesi calcolante tecnologicamente assistita, che omogenizza grandi quantità di dati eterogenei e li elabora con procedure astratte. Da tali elaborazioni dovrebbero emergere informazioni significative per gli esseri umani (nonché per qualsiasi dispositivo connesso alla rete), ma a partire dalla distinzione tra modalità di sintesi (sinottica tradizionale e calcolante) emerge la questione dell’intelligibilità non scontata delle informazioni che nel secondo caso diventano visualizzabili.
Un’altra discontinuità è quella indagata da Marcello Vitali-Rosati (Digital Architectures: the Web, Editorialization, and Metaontology, pp. 95-112), che parte da un racconto di Paul Valéry sulle differenze tra scrittura e architettura (Eupalinos ou l’architecte) per sostenere che la scrittura alla base degli spazi digitali e il connesso processo di editorializzazione (éditorialisation) sono concepibili come azioni e progettazioni performative e architettoniche, in quanto il loro compito fondamentale non si traduce nella pretesa di rappresentare la realtà (ripercorrendo per così dire la trama di un’ontologia esterna alla scrittura), ma si realizza piuttosto come produzione di realtà su più livelli. I livelli di realtà prodotti, più specificamente, sono i molteplici piani dello spazio vivente digitale in cui si inseriscono le nostre possibilità di movimento e interazione: uno spazio e al tempo stesso una cultura digitale, in cui si entra trasformandosi come aderendo ad una religione (cfr. Doueihi, 2011, sulle digital cultures).
Il numero monografico della rivista dà conto di punti di vista differenti sui fenomeni osservabili nell’infosfera e sulle loro implicazioni per il futuro, dal breve al lungo termine. Quanto possano differenziarsi tali punti di vista lo si coglie confrontando con i contributi fin qui richiamati la conversazione tra Francesco Monico e Derrick De Kerckhove (Cybersorveglianza, guerra e religione, il mondo a una dimensione, pp. 159-168) e il contributo di Pierre Lévy (The Data-Centric Society, pp. 129-140). Nel confronto tra Monico e De Kerckhove ci si chiede a che punto siamo arrivati con la cybersorveglianza, tra Marcuse e Minority Report: mentre De Kerckhove richiama la tesi secondo cui Internet sta «diventando un Panopticon molto inquisivo e, peggio, un ‘non-opticon’, come lo chiama Siva Vaidhyanathan, sottolineando il fatto che, a differenza del prigioniero di Jeremy Bentham, il soggetto della rete non sa mai se è veramente spiato, né perché, né quando» (p. 162), Monico si riferisce ad un processo tecnocratico irrazionale e riprovevole, capace di sostenere nuove «antropotecniche basate su meri punta-e-clicca» in cui la cybersorveglianza potrà essere percepita (e perciò richiesta) anche come «vantaggio personale» (p. 167). La stessa domanda sugli usi delle tecnologie e delle macchine – con l’alternativa, se siamo ancora noi a usare le macchine o se le macchine usino noi – sembra saltare, nel momento in cui si sottolinea che le macchine sono già con noi e dentro di noi. Eppure resta uno spiraglio, nel passaggio dalle diagnosi sul presente alle prognosi sul futuro, per inattese prospettive di trasparenza che potrebbero riguardare sia noi, sia il Governo, sia «le istituzioni digitali che stanno cercando di irretirci» (p. 166). Come interpretare il seguente paragrafo di De Kerckhove? «La trasparenza va in entrambe le direzioni. Sì, siamo trasparenti, ma così è anche per il Governo, lo sono le istituzioni digitali che stanno cercando di irretirci; solo una volta che avremo firmato un contratto sociale di reciproca trasparenza, beni comuni e di mutuo rispetto arriveremo in una situazione sana, e risolveremo i veri problemi del pianeta» (p. 166). Quale Governo sarà davvero trasparente? Chi e come deciderà quali siano i veri problemi del pianeta da risolvere grazie alla trasparenza? Il futuro contratto sociale di reciproca trasparenza non sarà altrettanto mitico e fittizio di quello che taluni hanno immaginato all’origine della società? Domande come queste, peraltro, possono nascere e restare in sospeso quando la rivoluzione in corso viene proposta secondo le chiavi di lettura dell’apocalisse o della palingenesi sociale. Pierre Lévy introduce il lettore ad un paesaggio concettuale e metaforico ancora diverso. La società centrata sui dati (Data-Centric), infatti, viene declinata al futuro come una civiltà in cui gli esseri umani vivranno in una sorta di sensorium aumentato (augmented sensorium), che permetterà loro di modellare le soggettività grazie a software che li mettono in relazione con dati, algoritmi e social networks. Nel sensorium espanso dell’intelligenza algoritmica ipotizzato da Lévy sarà possibile ragionare ed agire su di sé attraverso avatars semantici (semantic avatars) o in uno «specchio universale (universal mirror) osservabile da chiunque» (p. 138), su cui gli attori sociali del futuro potranno proiettare ciò che vorranno della propria attività software. Il passaggio richiede l’elaborazione di nuovi diritti, tra cui quello di accesso alla rete. Ma non è soltanto questione di accesso alla rete: questo contributo più di altri mette in evidenza che le ICTs attese potranno dare (a noi e ad altri) una serie di inediti accessi a noi stessi.
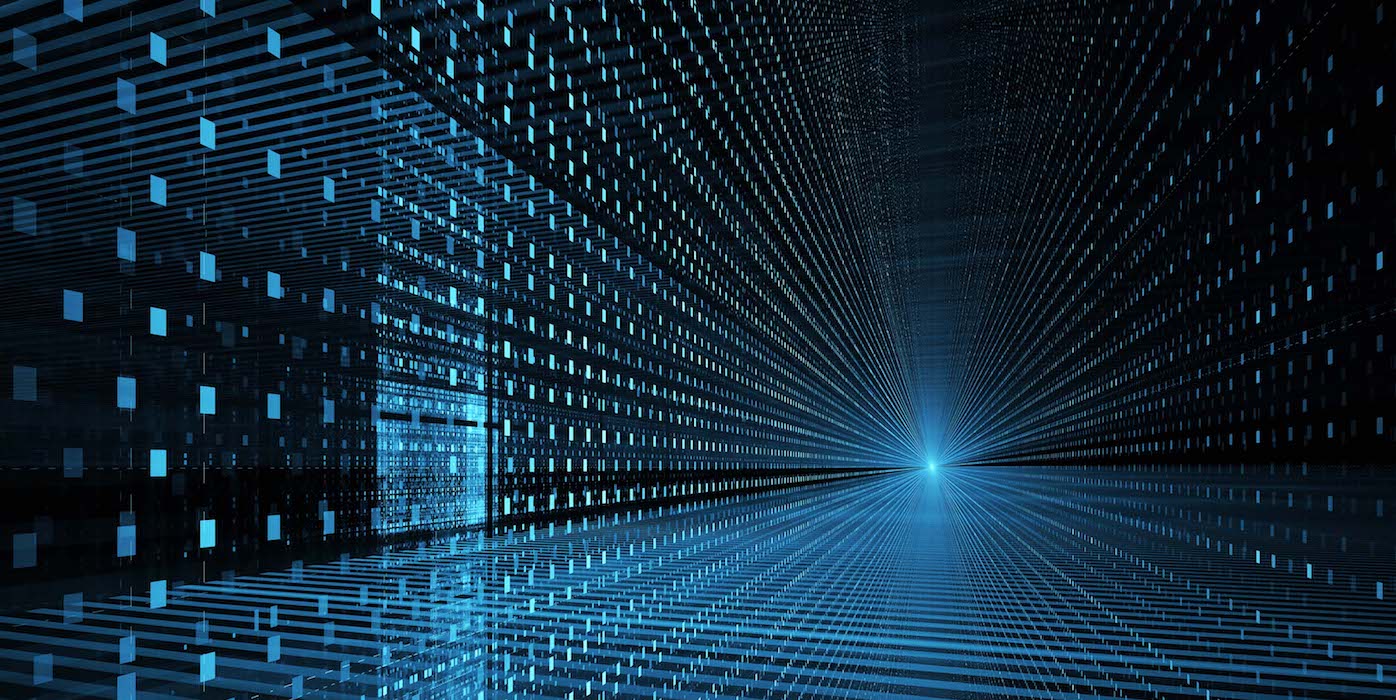
Così, Cléo Collomb (Pour un concept technologique de trace numérique, pp. 37-60) sottolinea che le tracce digitali introducono ad «un nuovo paradigma che invita a ripensare l’umano» (p. 60) e la «composizione del nostro “noi”», accompagnandoci non alla fine del mondo, ma alla fine di una certa avventura antropologica, fondata sull’«eccezionalismo antropologico». La nuova sfida consiste nel comprendere cosa significhi avere a che fare con macchine computazioni che funzionano raccogliendo, elaborando e mettendo in circolazione – come noi, per noi, per alcuni anziché per altri ecc. – tracce digitali. Così, Simone Guidi e Alberto Romele (Deforming the Subject. Digital Traces and the Post- of Humanism, pp. 73-94) invitano a comprendere se stessi al di fuori di ogni «ontologia statica» (p. 93), suggerendo che il tema delle tracce digitali e delle tecnologie connesse svelano all’essere umano (nuovamente, si potrebbe dire, e tuttavia in un modo che appare rivoluzionario) la sua essenza mediologica (likewise-mediological essence, p. 93): assumere finalmente la propria etero-costituzione tecnologica, comprendendone l’inedita articolazione contemporanea, diventa in questa prospettiva il primo passo per poter rinegoziare le frontiere dei poteri bio-tecnologici (p. 94) senza presumere di attingere ad un’umanità sussistente in sé e per sé. Al contrario, le migliori possibilità di rinegoziazione di cui disponiamo non passano dall’appello ad una fantomatica umanità pura dalla tecnologia, ma dal riconoscimento della multistabilità tecnologica (technological multistability), che ci permette di sperimentare molteplici accoppiamenti strutturali con i dispositivi di cui disponiamo e che progettiamo.
Un’indicazione simile la si ritrova anche in Maurizio Ferraris (Dalla mobilitazione totale all’azione esemplare, pp. 141-158), quando scrive che «non c’è un in sé della natura umana, c’è un divenire storico, in cui la tecnica gioca un ruolo costitutivo: capiamo che cosa vogliamo e chi siamo dalle tecniche che adoperiamo» (p. 143). Non diversamente da quanto accaduto in altre epoche, secondo Ferraris Internet ci mostra (e conferma) che la nostra specie è incline alla mobilitazione e alla sottomissione e che proprio attraverso la mobilitazione accediamo alla socialità e alla razionalità. Più precisamente ancora, con la sua capacità di mobilitare la nostra intenzionalità (p. 146) – paragonabile a quella attribuita classicamente al Capitale – il Web ci palesa il nostro essere animali costitutivamente mobilitabili e mobilitati, sottomessi e documentalmente dipendenti. Se una volta ci si sottometteva agli dèi, ai sacerdoti oppure a pochi potenti, oggi ci si sottomette alle «imposizioni che ci vengono dal web», esemplificate dalla «coazione a rispondere» (p. 145). Per comprendere lo scenario attuale e per tracciare qualche via praticabile di emancipazione, secondo Ferraris dovremmo lasciar perdere concetti come “alienazione” e “sfruttamento”, in quanto rimandano a un’immagine idealizzata dell’essere umano e quindi ad un insieme di possibilità che non esistono; si tratta invece di leggere meglio il reale inemendabile del terreno su cui camminiamo (facendoci attrito) e di noi stessi, in versione non idealizzata, perché l’emancipazione può nascere «solo se avremo riconosciuto la sottomissione come il carattere fondamentale dell’umano, invece di fare di quest’ultimo un polo di autonomia, libertà, potenza e virtù» (p. 149).
Bibliografia
Doueihi, M. (2011). Digital Cultures. Cambridge: Harvard University Press.
Floridi, L. (2014). The Fourth Revolution: How the Infosphere is Reshaping Human Reality. Oxford: Oxford University Press.
Valéry, P. (1980), Eupalinos ou l’architecte. In Id. Oeuvres II (pp. 79-147). Paris: Gallimard.
a cura di Luca Mori
-
 «In principio era l’Azione». Se si dovesse scegliere una frase da porre in esergo al volume di Alessandro Bertinetto (Eseguire l’inatteso. Ontologia della musica e improvvisazione, Il glifo ebook, Roma 2016) dedicato alla pratica dell’improvvisazione musicale, non si potrebbe che scegliere il celebre verso goethiano (ripreso da Ludwig Wittgenstein nelle annotazioni raccolte sotto il titolo Della Certezza). Il lavoro di Bertinetto pone il fenomeno improvvisativo al centro dell’indagine e definisce le sue caratteristiche distintive seguendo le coordinate proprie dell’estetica analitica, riservando particolare attenzione agli aspetti ontologici della pratica artistica in cui «processo e prodotto coincidono» (p. 52). Ma l’analisi filosofica dell’improvvisazione musicale impone, alla fine dell’indagine, una complessiva rielaborazione delle determinazioni concettuali attraverso le quali l’estetica analitica ha finora pensato l’ontologia della musica: il caso dell’improvvisazione mostra cioè che le categorizzazioni abitualmente adottate dalla riflessione filosofica non sono sufficienti a rendere conto della complessità del fenomeno musicale, così come esso effettivamente si presenta. Come nota l’autore, il rischio che corre la filosofia è infatti quello di sostituire agli oggetti che intende studiare delle pure astrazioni, capaci forse di soddisfare i criteri che la riflessione arbitrariamente sceglie per sé ma non corrispondenti alla realtà dell’esperienza. Bertinetto non si limita dunque ad analizzare l’improvvisazione musicale, ma utilizza i risultati della ricerca per rimettere in discussione alcuni assunti di base dell’estetica analitica, come il primato dell’ontologia sull’estetica – vale a dire la priorità della risposta alle domande “che cosa c’è?” e “che cos’è quello che c’è’” rispetto all’indagine relativa alla concreta esperienza legata a una pratica artistica – e la relazione tra opera ed esecuzione (abitualmente intesa secondo il binomio type/token, modello/occorrenza).
«In principio era l’Azione». Se si dovesse scegliere una frase da porre in esergo al volume di Alessandro Bertinetto (Eseguire l’inatteso. Ontologia della musica e improvvisazione, Il glifo ebook, Roma 2016) dedicato alla pratica dell’improvvisazione musicale, non si potrebbe che scegliere il celebre verso goethiano (ripreso da Ludwig Wittgenstein nelle annotazioni raccolte sotto il titolo Della Certezza). Il lavoro di Bertinetto pone il fenomeno improvvisativo al centro dell’indagine e definisce le sue caratteristiche distintive seguendo le coordinate proprie dell’estetica analitica, riservando particolare attenzione agli aspetti ontologici della pratica artistica in cui «processo e prodotto coincidono» (p. 52). Ma l’analisi filosofica dell’improvvisazione musicale impone, alla fine dell’indagine, una complessiva rielaborazione delle determinazioni concettuali attraverso le quali l’estetica analitica ha finora pensato l’ontologia della musica: il caso dell’improvvisazione mostra cioè che le categorizzazioni abitualmente adottate dalla riflessione filosofica non sono sufficienti a rendere conto della complessità del fenomeno musicale, così come esso effettivamente si presenta. Come nota l’autore, il rischio che corre la filosofia è infatti quello di sostituire agli oggetti che intende studiare delle pure astrazioni, capaci forse di soddisfare i criteri che la riflessione arbitrariamente sceglie per sé ma non corrispondenti alla realtà dell’esperienza. Bertinetto non si limita dunque ad analizzare l’improvvisazione musicale, ma utilizza i risultati della ricerca per rimettere in discussione alcuni assunti di base dell’estetica analitica, come il primato dell’ontologia sull’estetica – vale a dire la priorità della risposta alle domande “che cosa c’è?” e “che cos’è quello che c’è’” rispetto all’indagine relativa alla concreta esperienza legata a una pratica artistica – e la relazione tra opera ed esecuzione (abitualmente intesa secondo il binomio type/token, modello/occorrenza).Per apprezzare la portata del lavoro che stiamo discutendo occorre però seguire il percorso scandito dai sette capitoli che compongono il saggio. Il lettore viene introdotto inizialmente nel dibattito dell’ontologia della musica, il cui orizzonte è caratterizzato dal dualismo tra opera ed esecuzione (cap. 1). Contro l’opinione (generalmente ammessa) secondo cui, per apprezzare una performance, dovremmo essere in grado di giudicarne l’appropriatezza rispetto al modello normativo rappresentato dall’opera, Bertinetto mette in luce il carattere processuale che determina l’attualizzazione dell’opera nelle diverse esecuzioni, preannunciando quella che sarà una delle tesi portanti del suo lavoro: l’opera stessa, attraverso le sue interpretazioni, viene modificata incessantemente, in un continuo processo formativo e trasformativo. Il mainstream dell’ontologia musicale si basa pertanto su un presupposto tacito ma non per questo neutrale:
A partire dall’assioma, assunto come indiscutibile, della ripetibilità dell’opera senza perdita d’identità, esse [le ontologie generalmente ammesse in ambito analitico] spiegano la relazione tra l’opera e le sue esecuzioni, dando per scontata la validità normativa dell’ideale della fedeltà (Treue) all’opera (Werk) (pp. 20-21).
Le ontologie della Werktreue, dettagliatamente analizzate e criticate da Bertinetto, sposano il modello basato sul dualismo tra opera ed esecuzione, proiettando il primo termine in un orizzonte normativo e atemporale e relegando il secondo in posizione subalterna. Ma, come detto in apertura, nell’ambito dell’esperienza musicale l’azione ha un’evidente priorità: è questo il punto su cui fa leva l’autore, proponendo all’ontologia della musica l’experimentum crucis dell’improvvisazione (capp. 2 e 3). Se infatti la musica – come argomentato da Bertinetto in un lavoro precedente[1] – è essenzialmente arte dei suoni, le concrete esperienze dell’ascolto e della pratica (strumentale e vocale) non possono essere relegate al ruolo di inessenziale “sonorizzazione” di una struttura ritmica, armonica e melodica precedentemente data. Il primato del suono e l’autonomia rispetto a modelli estrinseci divengono lampanti nell’esperienza dell’improvvisazione, in cui «il processo-prodotto accade contemporaneamente alla sua percezione da parte dell’ascoltatore» (p. 52). Bertinetto analizza il complesso rapporto che lega e distingue l’improvvisazione dalla composizione e individua successivamente alcune peculiarità di quel tipo di creatività in cui composizione e esecuzione coincidono. Irreversibilità, situazionalità, singolarità, presenza, autenticità definiscono l’improvvisazione come pratica paradossale: spontanea ma radicata in una continua frequentazione delle tecniche strumentali; intenzionale ma non predeterminata da decisioni prese in anticipo; fondata su abitudini ma portatrice di risultati imprevedibili. Viene dunque analizzato il rapporto tra improvvisazione e interpretazione, mettendo in luce il «carattere eminentemente auto-espressivo» (p. 101) della pratica improvvisativa, nella quale il soggetto musicale, così come l’opera, si costituisce e si sviluppa in concomitanza con l’esperienza del suono. L’improvvisazione diventa dunque il luogo di un’inedita soggettivazione, in cui trovano spazio nuove rappresentazioni di sé che possono coinvolgere e retroagire sulla collettività e sul contesto da cui pure hanno preso origine. Sulla scorta di queste analisi, Bertinetto può affermare l’inadeguatezza del modello type/token ai fini di una soddisfacente descrizione della pratica improvvisativa. Costituendo un caso limite in cui è impossibile distinguere tra opera ed esecuzione, così come tra strutture essenziali e coloriture contingenti, l’improvvisazione sfugge al modello della ripetibilità dell’opera ma non per questo deve essere “declassata” a mera performance; piuttosto, è il concetto stesso di “opera” a dover essere rimesso in discussione.
Dopo aver esaminato nel cap. 3 alcuni casi in cui i confini tra opera e improvvisazione tendono a sfumare (la composizione come risultato dell’improvvisazione, l’improvvisazione come determinazione di opere indeterminate, l’improvvisazione su opere), l’autore analizza dettagliatamente la relazione tra improvvisazione e musica registrata (andando a toccare un tema recentemente molto dibattuto nell’ambito dell’ontologia musicale[2]; cap. 4) e presenta il caso paradigmatico della contraffattura (cap. 6), pratica musicale di appropriazione e rielaborazione di temi, melodie, strutture armoniche attraverso cui si dà luogo a “nuove” opere.
Se i capp. 4 e 6 presentano dunque due possibili articolazioni del discorso sull’improvvisazione, il cuore teorico del saggio può essere invece individuato nei capp. 5 e 7, dedicati rispettivamente alla definizione della natura finzionale dell’opera e alla logica improvvisativa dell’ontologia musicale.
Nel cap. 5 Bertinetto afferma decisamente la natura culturalmente costruita dell’opera musicale e stabilisce il primato dell’esecuzione sul modello. Attraverso una mossa teorica che si potrebbe definire decostruttiva, l’autore sferra una critica decisiva alle ontologie della Werktreue notando come «la finzione dell’opera musicale che rimane identica attraverso le sue esecuzioni ha un’origine evidente nelle pratiche di scrittura potenziate dall’invenzione della stampa a caratteri mobili» (p. 203). Il singolare equilibrio di Bertinetto sta nel non liquidare però il riferimento all’opera come un richiamo inutile o insensato: affermando che l’opera vive nelle sue interpretazioni, viene ribadito il legame con una struttura normativa, intesa però non più come modello atemporale bensì come regola. Ma la logica che, wittgensteinianamente, sorregge il seguire una regola determina contemporaneamente un’apertura a diverse possibili esecuzioni e una incessante ridefinizione della regola stessa:

L’alterazione (anche minimale) o la violazione (anche radicale) della norma possono produrre nuove norme attraverso la modificazione della norma precedente, qualora venga seguita e dunque riconosciuta come tale dai partecipanti alla pratica. In ciò consiste il carattere formativo della normatività all’opera nell’improvvisazione (p. 268).
Il carattere ricorsivo e dinamico della normatività, esemplificato in modo paradigmatico dalla pratica dell’improvvisazione, può di fatto essere esteso all’intera pratica musicale, anche laddove si riconosca l’esistenza di opere, intese come entità finzionali, nel senso precedentemente specificato. Si può dunque pensare che il principio formante, presente in ogni composizione, non finisca di agire quando il compositore abbia tracciato la doppia stanghetta al termine dell’ultima battuta del pentagramma, ma che continui ad animare le diverse performances che nella partitura trovano la propria regola, la propria “ricetta” per preparare “piatti” diversi e innovativi. In definitiva, il modello type/token è da rifiutare perché mentre «l’esemplare non aggiunge nulla al tipo, semplicemente lo realizza», al contrario «la performance, realizzando l’opera, non la ripete identica. Altrimenti, tra l’altro, che senso avrebbe offrire più di un’esecuzione di un’opera musicale?» (p. 310). Quest’ultima riflessione, così come le sottili analisi dei capitoli precedenti, preparano un’ultima mossa teorica rilevante, vale a dire l’affermazione del primato dell’estetica sull’ontologia, che coincide con un posizionarsi nella «prospettiva dei partecipanti».
Data l’ampiezza del tema trattato e la ricchezza di informazioni, articolazioni, argomentazioni, non è facile rendere conto di un saggio come Eseguire l’inatteso. Una semplice constatazione, utile forse a contestualizzare il lavoro di Bertinetto, può essere l’individuazione di tre assi concettuali, tre linee argomentative che il lettore facilmente potrà ritrovare nelle pagine dedicate all’ontologia dell’improvvisazione. Per indicare questi tre assi faremo uso di altrettanti termini, ognuno legato a un autore esplicitamente richiamato nei capitoli del saggio. L’improvvisazione, intesa come paradigma capace di ristrutturare l’intera ontologia della musica, si situa dunque nel punto di intersezione tra formatività, regola e storia degli effetti, vale a dire in una ripresa di alcune tematiche legate alle riflessioni di Luigi Pareyson, Ludwig Wittgenstein e Hans Georg Gadamer.
Definendo l’arte come «un tal fare che, mentre fa, inventa il modo di fare»[3] Pareyson dà inavvertitamente una tra le più calzanti definizioni di “improvvisazione” e invita implicitamente a leggere l’intera attività formativa sotto la lente della pratica improvvisativa. La creazione artistica non implicherebbe dunque la realizzazione di un piano o di un progetto virtuale, ma si presenterebbe come un processo dinamico di scoperta, aperto tanto alla riuscita quanto al fallimento, sebbene non ordinato secondo norme preesistenti. Le regole dell’attività artistica seguono pertanto la massima con cui Wittgenstein definisce il funzionamento dei giochi linguistici: «We make up the rules as we go along»[4]. La norma che presiede all’improvvisazione coincide in realtà con quest’ultima e, al limite, è individuabile solamente ex post; estendendo questa riflessione all’intero ambito della creazione musicale, l’opera risulta non essere altro che l’insieme delle istruzioni rivolte dal compositore all’interprete, affinché nell’esecuzione (l’unica realtà che valga la pena di definire “musicale”) la composizione dispieghi la vita che le è propria. La vita dell’opera, infatti, continua in quella che Gadamer chiama Wirkungsgeschichte[5], storia degli effetti: in ambito musicale la performance, in quanto attualizzazione dell’opera e sua recezione, sviluppa in senso trasformativo il testo di partenza e mette in moto un processo retroattivo che va dall’esecuzione all’opera.
Il lavoro di Bertinetto ha il merito di rimettere in moto la riflessione sugli aspetti ontologici dell’esperienza musicale, determinando una problematizzazione dei modelli di riferimento abitualmente adottati. Ulteriore merito è quello di condurre la discussione fuori dalle secche dell’ontologia analitica senza rifiutarne aprioristicamente il quadro concettuale ma superandolo, per così dire, dall’interno, argomentando e rispondendo alle possibili obiezioni, ascrivibili alle voci più autorevoli dell’estetica musicale contemporanea, puntualmente citate e interrogate nel discorso. Un ultimo motivo di apprezzamento consiste nella reintroduzione nel dibattito di autori troppo spesso dimenticati nell’ambito della riflessione musicale: i tre esempi di Pareyson, Wittgenstein e Gadamer, poco presenti nella discussione analitica (su due dei tre nomi non ci dovrebbero essere dubbi, nel caso di Wittgenstein la questione della recezione analitica è di certo più complessa), comportano un ampliamento del panorama da cui la filosofia della musica non può che trarre giovamento.
di Stefano Oliva
[1] A. Bertinetto, Il pensiero dei suoni. Temi di filosofia della musica, Bruno Mondadori, Milano 2012.
[2] Cfr. Ontologie musicale. Perpectives et débats, sous la direction de A. Arbo, M. Ruta, Paris, Hermann 2014 (in partic. la sez. III, dedicata a Œuvres et enregistrements).
[3] L. Pareyson, Estetica. Teoria della formatività, Bompiani, Milano 1954 (nuova ed. 2010), p. 59; citato nel saggio di Bertinetto (p. 51).
[4] L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, Einaudi, Torino 2006, p. 56; citato nel saggio di Bertinetto (p. 269).
[5] H.-G. Gadamer, Verità e metodo, Bompiani, Milano 1990, p. 350 ss; cit. nel saggio di Bertinetto (p. 306).
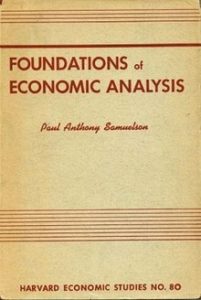 Secondo la ben nota, non solo tra i filosofi, “fallacia naturalistica” di Hume, è illecito dedurre dall’essere il dover essere, dai fatti i valori, dalle spiegazioni i desideri, dal vero il bene. Allo studio dell’essere, dei fatti, delle spiegazioni e della verità si sono da sempre dedicate le scienze “dure”, cioè le scienze naturali, che hanno carattere descrittivo, e mai normativo. L’economia, almeno nella sua accezione mainstream, è la scienza sociale generalmente ritenuta più vicina, nei suoi metodi, alle scienze naturali: a tale indirizzo “scientista” ha dato lustro l’opera di Paul Samuelson. Nel 1947 egli diede alle stampe un’opera fondamentale, dal titolo Foundations of Economic Analysis, in cui, tramite l’applicazione dei principi dell’equilibrio termodinamico alla teoria neoclassica dell’equilibrio, delineava un modello elegante ed efficace per una teoria generale dell’equilibrio economico: secondo Samuelson, così come fanno i sistemi fisici, anche i sistemi economici reagiscono alle modifiche esterne, minimizzandone l’impatto e preservando il loro stato di equilibrio. L’opera di Samuelson è rilevante anche per gli scopi teorici che si prefigge dal punto di vista metodologico: l’autore si propone infatti di procedere ad un lavoro di unificazione, attraverso il linguaggio della matematica, dei fondamenti della teoria neoclassica micro e macroeconomica. Nel 1970, egli fu il primo economista americano ed essere insignito del premio Nobel: i suoi meriti scientifici consistono nel progetto di formalizzazione matematica delle tesi elaborate dagli economisti neoclassici, operazione che permise di elevare il livello di analisi della scienza economica.
Secondo la ben nota, non solo tra i filosofi, “fallacia naturalistica” di Hume, è illecito dedurre dall’essere il dover essere, dai fatti i valori, dalle spiegazioni i desideri, dal vero il bene. Allo studio dell’essere, dei fatti, delle spiegazioni e della verità si sono da sempre dedicate le scienze “dure”, cioè le scienze naturali, che hanno carattere descrittivo, e mai normativo. L’economia, almeno nella sua accezione mainstream, è la scienza sociale generalmente ritenuta più vicina, nei suoi metodi, alle scienze naturali: a tale indirizzo “scientista” ha dato lustro l’opera di Paul Samuelson. Nel 1947 egli diede alle stampe un’opera fondamentale, dal titolo Foundations of Economic Analysis, in cui, tramite l’applicazione dei principi dell’equilibrio termodinamico alla teoria neoclassica dell’equilibrio, delineava un modello elegante ed efficace per una teoria generale dell’equilibrio economico: secondo Samuelson, così come fanno i sistemi fisici, anche i sistemi economici reagiscono alle modifiche esterne, minimizzandone l’impatto e preservando il loro stato di equilibrio. L’opera di Samuelson è rilevante anche per gli scopi teorici che si prefigge dal punto di vista metodologico: l’autore si propone infatti di procedere ad un lavoro di unificazione, attraverso il linguaggio della matematica, dei fondamenti della teoria neoclassica micro e macroeconomica. Nel 1970, egli fu il primo economista americano ed essere insignito del premio Nobel: i suoi meriti scientifici consistono nel progetto di formalizzazione matematica delle tesi elaborate dagli economisti neoclassici, operazione che permise di elevare il livello di analisi della scienza economica.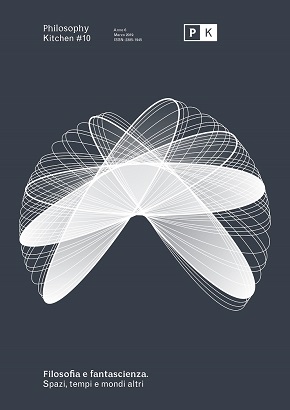

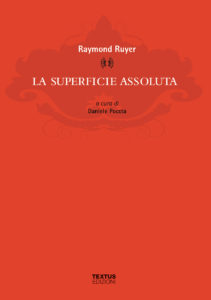

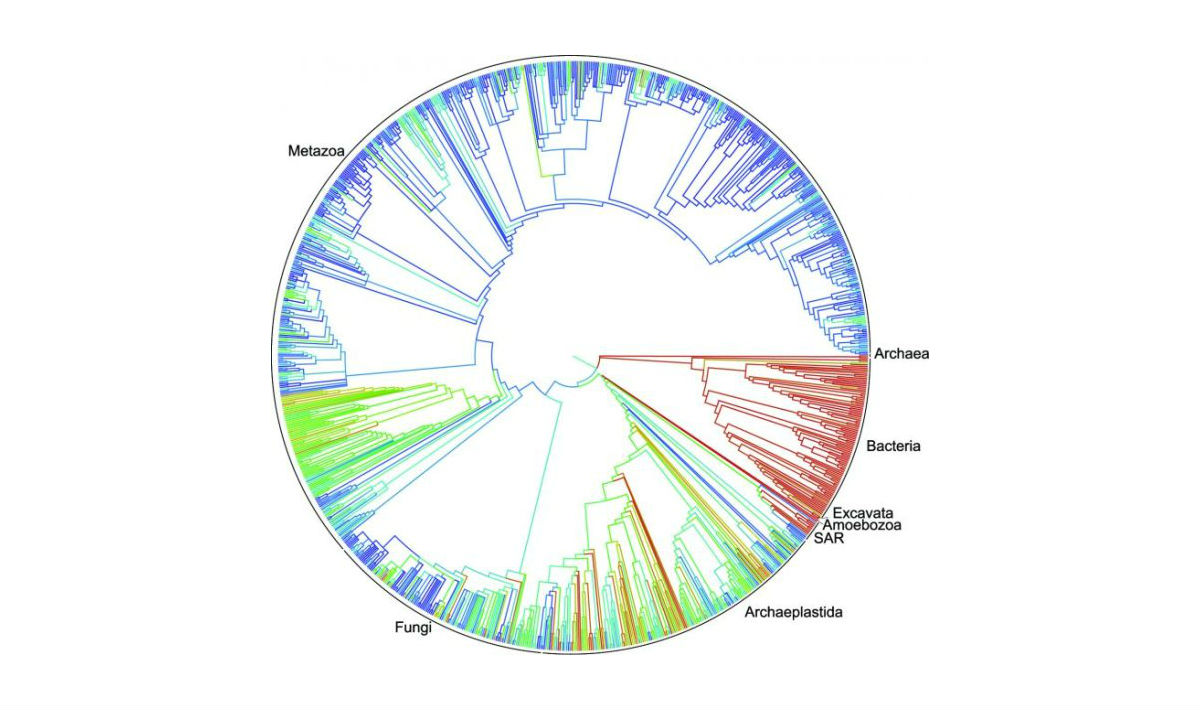
 Quanta confusione nel cielo della politica. Da alcuni anni a questa parte, dalla televisione ai giornali, passando per i social network, espressioni come ‘establishment’, ‘élite’ e ‘casta’ hanno ormai monopolizzato il dibattito pubblico. L’elenco potrebbe forse continuare, fino a comprendere le più elaborate ‘classe politica’, ‘classe dirigente’ e ‘classe dominante’. Sono le parole con cui siamo soliti etichettare i potenti, spesso con intento polemico, parole che tendiamo a confondere le une con le altre, quasi avessero lo stesso significato. Una simile superficialità sarebbe scusabile, non fosse che le categorie che utilizziamo sono le lenti con cui guardiamo la realtà: se non le ripuliamo con cura, potremmo non essere in grado di cogliere tutte le sfumature, o addirittura finire per vedere una cosa per un’altra.
Quanta confusione nel cielo della politica. Da alcuni anni a questa parte, dalla televisione ai giornali, passando per i social network, espressioni come ‘establishment’, ‘élite’ e ‘casta’ hanno ormai monopolizzato il dibattito pubblico. L’elenco potrebbe forse continuare, fino a comprendere le più elaborate ‘classe politica’, ‘classe dirigente’ e ‘classe dominante’. Sono le parole con cui siamo soliti etichettare i potenti, spesso con intento polemico, parole che tendiamo a confondere le une con le altre, quasi avessero lo stesso significato. Una simile superficialità sarebbe scusabile, non fosse che le categorie che utilizziamo sono le lenti con cui guardiamo la realtà: se non le ripuliamo con cura, potremmo non essere in grado di cogliere tutte le sfumature, o addirittura finire per vedere una cosa per un’altra.

 Marginalità come predisposizione di vicinanza ai confini, a quei limiti che toccandosi fra loro, si intersecano: contaminandosi. Ed ecco che non esistono più nette separazioni, ma avvolgimenti continui che spaziano aldilà dei bordi. Si sceglie di stare in disparte per abbracciare la globalità. Si sceglie di mettersi in angolo per assumere una visione completa. Non è passato molto tempo da quando Eugenio Barba, fondatore dell’ISTA (International School of Theatre Anthropology) e dell’Odin Theatre, compagnia precorritrice del Terzo Teatro, propose una teatralità che piantava le proprie radici in uno spazio altro, esterno, quasi nascosto, in cui venivano annullate le dinamiche tradizionali e gli assiomi classici dell’arte teatrale accademica; creando così una spinta alternativa che condusse la pratica drammaturgica verso lidi inesplorati e che provocarono, letteralmente, una scossa negli ambienti artistici degli anni 60. La nascita del terzo teatro segnò il passaggio da una concezione di teatro unico, teatrocentrico (verrebbe quasi da dire), verso l’apertura a tecniche e modalità provenienti da contesti periferici ed extra europei, in cui ad essere fondamentale non era la rappresentazione in sé, l’atto drammatico tanto per intenderci, ma lo sviluppo di una corporeità rigenerata, oltre che il superamento delle barriere tra attori e spettatori, agevolando così l’incontro tra questi due poli e creando un nuovo modo di stare a teatro. Il Terzo Teatro provocò un differente atteggiamento di guardare all’arte teatrale, venne demolita infatti l’idea di teatro come merce di scambio e istituzione, allontanandosi dai preconcetti classici ed occidentali che, secondo Barba, limitavano la pratica drammaturgica ad una mera riproduzione di situazioni fittizie che costringevano l’attore alla menzogna. Deviando da tale concezione, egli protese verso un’alternativa lettura dell’arte drammatica, cercando di individuare le caratteristiche fondanti non su ciò che succedeva sul palco, ma su ciò che accadeva dietro le quinte e durante il dialogo tra palco e platea, ossia nel momento in cui il teatrante, metaforicamente, si toglieva la maschera per ridiventare uomo. Il terzo teatro, in sintesi, può essere definito come la realizzazione dell’incontro tra uomini.
Marginalità come predisposizione di vicinanza ai confini, a quei limiti che toccandosi fra loro, si intersecano: contaminandosi. Ed ecco che non esistono più nette separazioni, ma avvolgimenti continui che spaziano aldilà dei bordi. Si sceglie di stare in disparte per abbracciare la globalità. Si sceglie di mettersi in angolo per assumere una visione completa. Non è passato molto tempo da quando Eugenio Barba, fondatore dell’ISTA (International School of Theatre Anthropology) e dell’Odin Theatre, compagnia precorritrice del Terzo Teatro, propose una teatralità che piantava le proprie radici in uno spazio altro, esterno, quasi nascosto, in cui venivano annullate le dinamiche tradizionali e gli assiomi classici dell’arte teatrale accademica; creando così una spinta alternativa che condusse la pratica drammaturgica verso lidi inesplorati e che provocarono, letteralmente, una scossa negli ambienti artistici degli anni 60. La nascita del terzo teatro segnò il passaggio da una concezione di teatro unico, teatrocentrico (verrebbe quasi da dire), verso l’apertura a tecniche e modalità provenienti da contesti periferici ed extra europei, in cui ad essere fondamentale non era la rappresentazione in sé, l’atto drammatico tanto per intenderci, ma lo sviluppo di una corporeità rigenerata, oltre che il superamento delle barriere tra attori e spettatori, agevolando così l’incontro tra questi due poli e creando un nuovo modo di stare a teatro. Il Terzo Teatro provocò un differente atteggiamento di guardare all’arte teatrale, venne demolita infatti l’idea di teatro come merce di scambio e istituzione, allontanandosi dai preconcetti classici ed occidentali che, secondo Barba, limitavano la pratica drammaturgica ad una mera riproduzione di situazioni fittizie che costringevano l’attore alla menzogna. Deviando da tale concezione, egli protese verso un’alternativa lettura dell’arte drammatica, cercando di individuare le caratteristiche fondanti non su ciò che succedeva sul palco, ma su ciò che accadeva dietro le quinte e durante il dialogo tra palco e platea, ossia nel momento in cui il teatrante, metaforicamente, si toglieva la maschera per ridiventare uomo. Il terzo teatro, in sintesi, può essere definito come la realizzazione dell’incontro tra uomini.



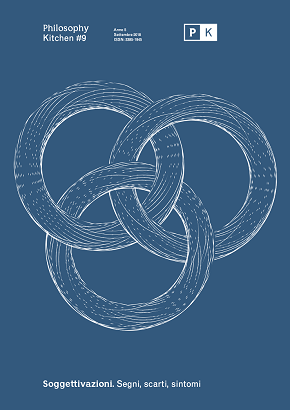

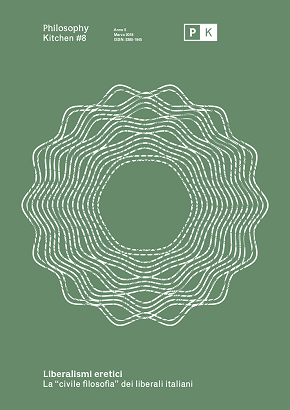
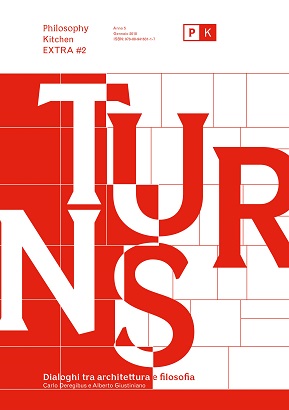
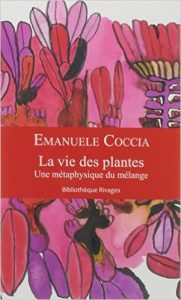 La problematizzazione dell’antropocentrismo è ormai uno dei topoi più frequentati della letteratura filosofica (come culturale, sociologica, ecologica, ecc.) contemporanea, al punto che – facendo il verso al noto Linguistic Turn del Novecento – si è recentemente preso a parlare in modo esplicito di un Non-Human Turn (R. Grusin). Non è questa l’occasione per discutere portata e natura di una simile “svolta”, né tantomeno per valutare il modo in cui è stata tradotta e soprattutto gli slogan che appare avere generato: bisogna comunque notare che, di fatto, si è giunti a una situazione in cui l’anti-antropocentrismo si è declinato pressoché univocamente in una forma di zoocentrismo, o – se si preferisce – in un vitalismo pensato a partire dall’equazione “vita = organismo (animale)”.
La problematizzazione dell’antropocentrismo è ormai uno dei topoi più frequentati della letteratura filosofica (come culturale, sociologica, ecologica, ecc.) contemporanea, al punto che – facendo il verso al noto Linguistic Turn del Novecento – si è recentemente preso a parlare in modo esplicito di un Non-Human Turn (R. Grusin). Non è questa l’occasione per discutere portata e natura di una simile “svolta”, né tantomeno per valutare il modo in cui è stata tradotta e soprattutto gli slogan che appare avere generato: bisogna comunque notare che, di fatto, si è giunti a una situazione in cui l’anti-antropocentrismo si è declinato pressoché univocamente in una forma di zoocentrismo, o – se si preferisce – in un vitalismo pensato a partire dall’equazione “vita = organismo (animale)”.