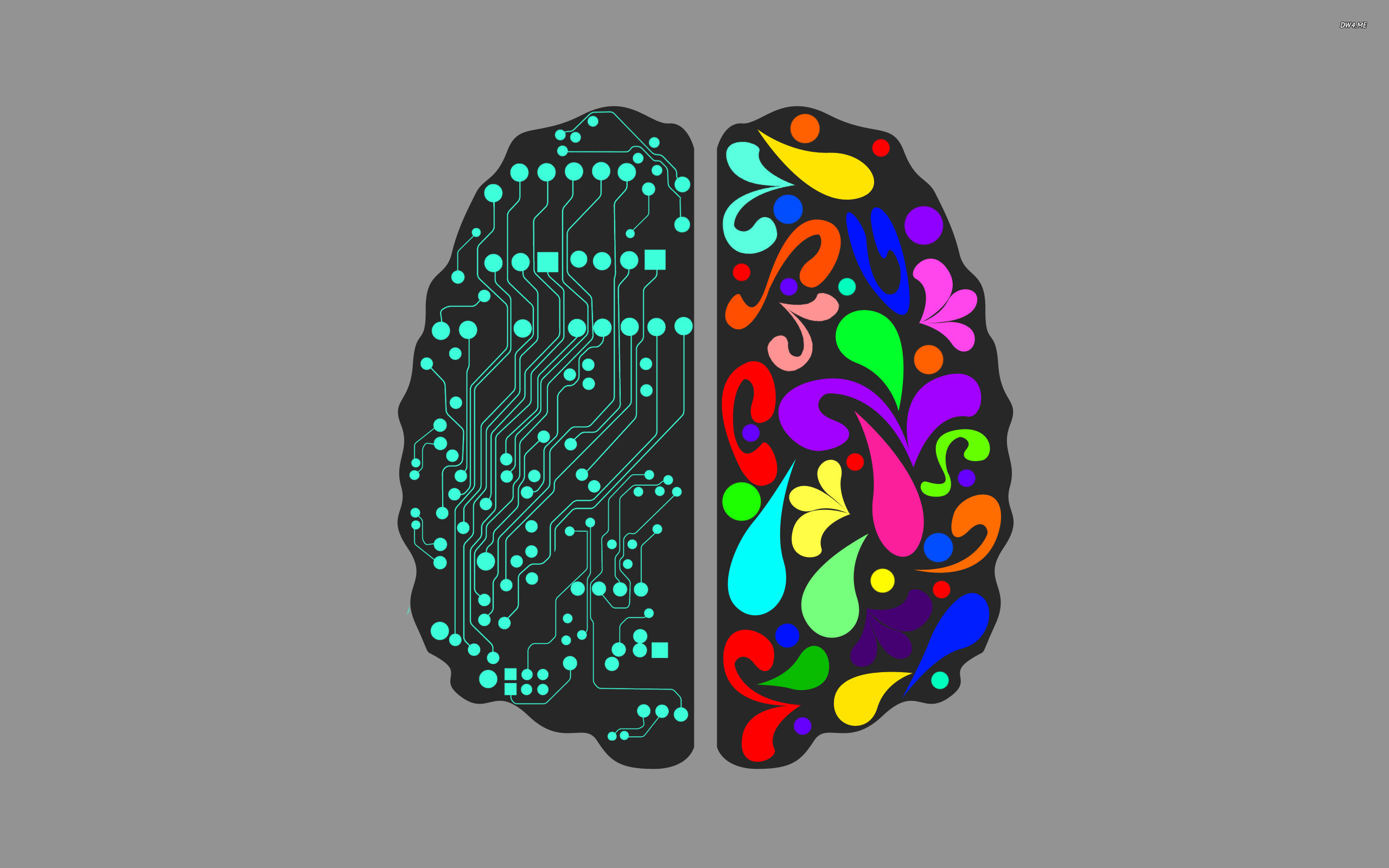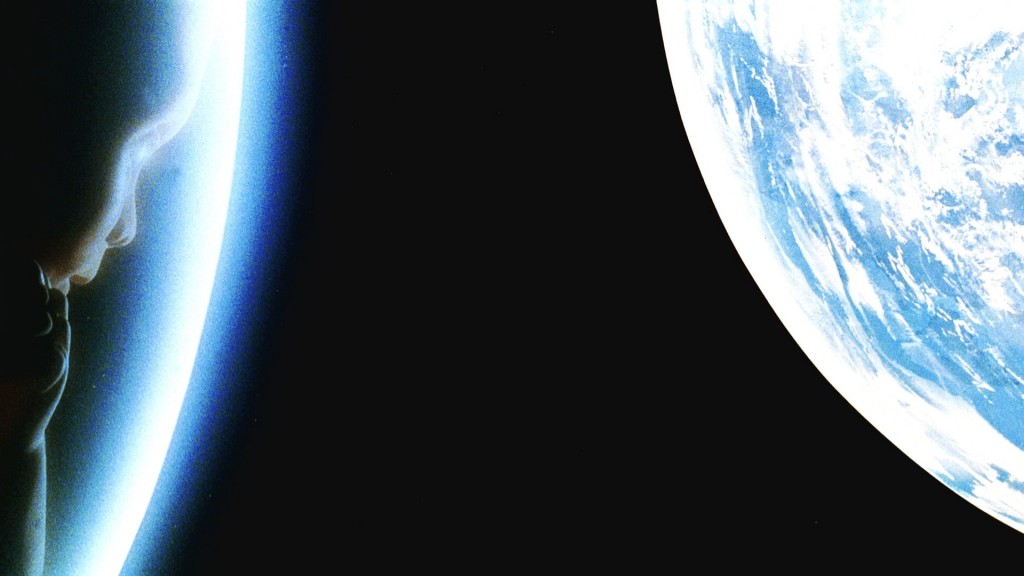-
-
“Sulla pittura” di Gilles Deleuze
Recensioni / Ottobre 2024Le immagini pensano senza parole, attirando coloro che le guardano in una sospensione silenziosa carica di pensieri e storie. Ci invitano non solamente a osservarle ma ad ascoltarle, esplorarle e analizzarle. Ma che cosa dicono e in quale forma ci parlano? Lo storico dell’arte Daniel Arasse, nel celebre In dettaglio. La pittura vista da vicino, sostiene che la vera esperienza del piacere visivo di un’opera pittorica necessita di uno sguardo acuto e prossimo. Smontando il principio tradizionale della distanza classica in pittura, secondo cui un quadro debba esser visto da una lontananza tale da apprezzarne compiutamente la bellezza e l’armonia dell’insieme, Arasse dimostra che dentro l’ordine generale di ogni quadro s’annidano dettagli che sfuggono a quest’ordine, e che arrivano a sovvertirlo e ad annullarlo. Queste apparenti zone d’ombra vengono percepite soltanto se si guarda da vicino. Dalla distanza ravvicinata si colgono gli elementi “segreti” del quadro, quelli a cui il pittore ha affidato il suo messaggio e che riservano le vere occasioni di Einfühlung, l’empatia che si prova davanti a un’opera pittorica e fonte del godimento estetico. Da questa visione ravvicinata molti capolavori a tutti noti si scoprono come “inediti”, visti per la prima volta.
Ma che cosa succede quando a osservare la pittura da così vicino è uno sguardo che esce dai confini battuti e approda alla disciplina del concetto? Che cosa può cogliere la filosofia in un Turner o un Pollock che la pittura stessa non è in grado di vedere? Detto altrimenti, è possibile produrre un discorso filosofico a partire dalla pittura?
Sulla pittura di Gilles Deleuze, edito dalla celebre casa editrice Les Editions de Minuit, è una raccolta di otto lezioni che il filosofo ha tenuto dal marzo al giugno 1981 all’università di Saint-Denis, interamente consacrate alla questione della pittura. Con lo stile che lo contraddistingue, Deleuze getta una nuova luce sull’attività creatrice del singolo pittore e della pittura in generale, interrogandosi sul rapporto e sul gioco di forze tra l’artista, le forme, la tela e i colori. La tesi che fa da fil rouge all’intero corso è l’idea secondo cui la pittura sia una pratica di ricerca filosofica in quanto capace di produrre e fornire concetti nuovi alla filosofia stessa. I pittori - ci si chiede - possono dirci qualcosa su delle esperienze come il vedere, il colore, le linee e le forme? Nel tentativo di instaurare un legame di tipo concettuale tra le due discipline, si tratta di «costruire concetti che sono in rapporto diretto con la pittura, e con la pittura solamente» (p. 18).
Deleuze parte da un’ipotesi, o sarebbe più corretto dire un’impressione: ciò che ci colpisce in un quadro, quando lo osserviamo, è la sensazione di squilibrio, caduta e instabilità che anima la tela e che egli, non a caso, chiama catastrofe (catastrophe). Legando strutturalmente tale nozione all’atto pitturale, il filosofo ipotizza che al di qua del quadro, in una dimensione spazio-temporale che potremmo definire “virtuale”, esiste un momento che il pittore vive necessariamente come distruttivo. Il quadro è dunque il prodotto di una distruzione a cui l’artista non può sfuggire e che gli si manifesta nella forma di un crollo e collasso del mondo visivo; un’interferenza, un disturbo e accecamento delle coordinate visuali; un generale stato di disequilibrio. La catastrofe non è né la pittura in sé né il quadro ma una struttura di carattere ontologico che pregiudica l’atto di dipingere, senza cui quest’ultimo non potrebbe darsi (p.21). Deleuze suppone dunque che l’atto pitturale rinvii a un momento pre-pitturale in cui l’artista, passando per la catastrofe, fa uscire qualcosa: la propria opera. Tutto questo non è nella mente del pittore ma nel quadro; è il tempo del quadro. Mettendo in rapporto la pittura con la dimensione spaziale e temporale, lo sguardo non esce dai confini della tela: essa, per la sua semplice cosalità, chiama in causa una spazialità che le è propria e che varia secondo i diversi stili di pittura - la tecnica su cavalletto tipica dell’epoca classica presuppone un uso e una concezione dello spazio ben differente dalle pitture all over, in cui gli elementi pitturali “fuoriescono” dai bordi del quadro (p. 125). Accanto alla componente spaziale, con gesto innovante, il filosofo individua anche quella temporale: la pittura non entra in rapporto solo con lo spazio ma anche con il tempo - un tempo proprio a essa. Il quadro viene così concepito come se fosse una sintesi temporale: c’è un tempo propriamente pitturale che coincide con l’atto stesso di dipingere. Ma, ci si chiederà a ragione, se la catastrofe rappresenta il passaggio obbligato e necessario perché ci sia il quadro, che cosa produce esattamente? La catastrofe fa nascere il colore: esso altro non è che il prodotto dell’evento catastrofico. L’esempio tipico e fondamentale è Turner, nelle cui opere Deleuze vede tutta la potenza catastrofica del colore: in esso «si passa da un quadro che rappresenta in alcuni casi catastrofi come valanghe e tempeste a una catastrofe infinitamente più profonda che concerne l’atto di dipingere […] E questa catastrofe è inseparabile da una nascita. Nascita di cosa? Del colore» (p. 23).
Posti i presupposti della ricerca, si tratta dunque di analizzare il rapporto profondo tra l’atto pitturale e la catastrofe. Pervenirvi significa riuscire a rispondere a una domanda specificatamente filosofica: esiste un concetto pitturale? Il concetto che Deleuze sente più vicino alla pittura è quello di diagramma (diagramme). Chi ha una certa familiarità con i testi deleuziani percepirà che non si tratta di una nozione del tutto nuova: essa infatti appare per la prima volta in Mille Piani e, come lo stesso filosofo suggerisce (Deleuze 2017, p. 177 e p. 265), si ispira alla teoria dei diagrammi di Pierce e al diagramma foucaultiano di Sorvegliare e Punire. Tuttavia, occorre liberare il campo da eventuali influenze e conoscenze anteriori poiché il diagramma qui inteso è pensato esclusivamente in funzione alla pittura. Se si volesse dare una prima e sommaria definizione si potrebbe definire il diagramma come la pura concettualizzazione della catastrofe; esso altro non è che la maniera attraverso cui il pittore affronta la catastrofe creando la propria opera. Per entrare nel dettaglio e capirne il senso profondo, bisogna mobilitare un secondo concetto, che Deleuze prende in prestito da Klee e Cézanne, ossia la nozione di caos (chaos). Quest’ultimo traduce la condizione pre-pitturale di crollo e collasso del mondo visivo che necessariamente l’artista affronta. Ogni quadro conserva virtualmente un rapporto con una forma caotica di vitalità percepibile secondo una logica irrazionale che rompe con la razionalità classica. «Il caos non è relativo a niente. Non è l’opposto di niente, prende tutto. Mette quindi in discussione fin dall’inizio ogni pensiero logico del caos» (p. 38). Citando Klee, il filosofo aggiungerà che il caos è esattamente «il concetto non concettuale della non-contraddizione. Il caos è l’assoluto» (Ivi). Ora, dinanzi a questa disturbante e accecante irruzione caotica entra in azione il diagramma, disvelandosi agli occhi del pittore come una forza creatrice da modellare e filtrare in una forma unica e singolare che sarà poi quella dell’opera. In altre parole, il diagramma è il modo attraverso cui il caos viene “filtrato” dal pittore per accedere allo stile che lo contraddistingue; esso permette di trasformare, modellare il caos per farne un’espressione visibile. Di conseguenza il collasso è necessario per spazzar via, cancellare tutte le immagini pre-esistenti, i clichés, i simulacri che incombono e condizionano l’immaginazione di colui che dipinge. «Il pittore è come se si mettesse nella situazione di una creazione del mondo o di un cominciamento del mondo. Il mondo della luce-colore» (p.51). Lo scopo del diagramma sarà dunque di annullare ogni tipo di narrazione e figurazione, che virtualmente pregiudica già il quadro, per far uscire qualcosa di completamente diverso: il fatto pitturale. Mostrando che esiste un specie di logica interna alla pittura, Deleuze individua tre momenti precisi e distinti condizionanti la dimensione pre-pitturale: il primo è quello che abbiamo chiamato caos-catastrofe, ossia la lotta necessaria per sopprimere ogni dato figurativo pregiudicante; il secondo è l’instaurazione del diagramma che permette di filtrare e cristallizzare i clichés e il terzo è l’insorgenza del fatto pitturale. L’idea che vi siano tre tempi che scandiscono l’attività creatrice dei pittori disvela una particolare sintesi temporale in cui il prima è inseparabile dal dopo e dal durante: «Ancora una volta è l’avventura temporale del quadro che provo a fare. Non vivo il quadro come una realtà spaziale. Lo vivo temporalmente, questa specie di sintesi del tempo esclusivamente della pittura: il prima, il diagramma e il dopo» (p. 113).
Una volta individuati la natura e lo scopo del diagramma, si tratta di capire in quale forma e secondo quale stile esso viene modellato dai pittori stessi. Tessendo una cartografia pittorica del concetto di diagramma, Deleuze individua tre correnti artistiche, ad ognuna delle quali corrisponde una particolare categoria estetica: l’espressionismo astratto, l’astrattismo e la pittura figurativa. Questi ultimi non sono pensati secondo un criterio storico ma come delle vere e proprie posizioni che i pittori occupano rispetto al diagramma. La prima posizione diagrammatica che il filosofo prende in esame è l’espressionismo astratto della scuola americana (Jackson Pollock, Kenneth Noland, Morris Louis) in cui il diagramma emerge in tutta la sua potenza estrema e disturbante senza mai appiattirsi e scomparire del tutto. Gli espressionisti, osserva Deleuze, sfiorano il caso: il diagramma prende tutto pur restando produttore di qualcosa di fantastico; «la tendenza dell’espressionismo astratto è di avvicinare il diagramma al caos, ma mi sembra ovvio che non cadono mai nel caos» (p. 116). Guardando un Pollock, ciò che ci colpisce è il fatto che vi sia una negazione completa dell’esistenza organica della tela sul cavalletto (p. 125). Nei suoi quadri, tipici delle pitture all over, si assiste a una conversione totale dello spazio: la linea comincia già prima del quadro; essa è già virtualmente presente ancor prima di essere tracciata. Il quadro capta solamente ciò che riesce della linea che non ha né inizio né fine. Pollock converte l’orizzonte (ottico) in suolo (tattile) e il diagramma pitturale è uno spazio puramente ottico (p. 148-149).
La seconda posizione diagrammatica, che rinvia alla corrente dell’arte astratta, affronta il diagramma con un approccio diametralmente opposto rispetto a quello dell’espressionismo. I pittori astratti, per evitare lo scivolamento nel caos, sostituiscono il diagramma con un codice propriamente pitturale. Essi affrontano il diagramma traducendolo in elementi di codificazione che siano anche pitturali. Chi riuscirebbe a distinguere, osserva Deleuze, un triangolo di Wassily Kandinsky da uno geometrico? Ogni pittore inventa un codice immanente alla pittura secondo delle unità significative scelte solo ed esclusivamente dall’artista, come le linee geometriche di Kandinsky o l’alfabeto plastico di Auguste Herbin (p. 152-154). Se, dunque, l’espressionismo astratto affronta al massimo il caos fino al punto di invadere il quadro senza mai riuscirci, al contrario, l’astrattismo lo affronta al minimo, comprimendo tutto l’oscuro, l’inconscio e l’involontario presente nel diagramma con l’applicazione di un codice pitturale. Entrambe le posizioni, per un verso o per un altro, sfiorano la catastrofe.
La terza categoria estetica è quella dell’arte figurativa di Paul Cézanne, Vincent Van Gogh e Paul Gauguin ed è, contrariamente alle altre, “la più moderata” in quanto capace di moderare il caos. Il diagramma, infatti, non viene né massimizzato né minimizzato ma agisce come tale: dal caos emerge la figura che non è semplice riproduzione ma immagine senza somiglianza. Prendendo in prestito un’espressione di Jean-François Lyotard, Deleuze non parla di pittori figurativi ma “figurali” (peintres figuraux, non pas figuratifs [p. 123]) poiché ciò che insorge dal diagramma non rinvia a nient’altro se non alla pura potenza del diagramma. Il diagramma produce il puro figurale, la Figura. Rompendo con qualsiasi forma di soggettività o riferimento astratto, i pittori affrontano lentamente il caos presente nella tela abitando, a modo proprio, una delle tre dimensioni diagrammatiche. Da Turner, Michelangelo, passando per Van Gogh, Bacon e molti altri, il gesto deleuziano è rivelatore: l’arte, e più specificatamente la pittura, è là per rendere visibile l’invisibile.
Laura Ercoli
Riferimenti bibliografici
Arasse, D. (2023), Il dettaglio. La pittura vista da vicino, tr. it. di Pino A., Milano: Il saggiatore.
Deleuze, G. (2004), Francis Bacon. Logica della sensazione, tr. it. di Verdicchio S., Macerata: Quodlibet.
Deleuze, G. (2017), Mille piani. Capitalismo e schizofrenia, tr. it. di Passerone G., Napoli: Orthotes.
-
La narratologia oggi, almeno nelle Università italiane e francesi – ma la situazione non è migliore in altri paesi –, soffre anzitutto della mancanza di una chiara identità istituzionale: non dà nome a un settore disciplinare né – se non in casi eccezionali – a insegnamenti curriculari [1]. Per molti la narratologia è morta negli anni Ottanta, con l’esaurirsi dello strutturalismo, ovvero con la corrente critica che per la prima volta le ha dato un nome: narratologie è infatti un neologismo francese coniato da Tzvetan Todorov nel 1969 per indicare una «science du récit» applicabile tanto alla letteratura quanto a tutti gli altri generi discorsivi il cui baricentro è il racconto di una storia («contes populaires, mythes, films, rêves, etc», ); una «théorie de la narration» transdisciplinare (Todorov 1969, p. 10).
Eppure, una teoria della narrazione esiste da ben prima che Todorov le desse un nome consacrandone l’esistenza e la fortuna negli anni Settanta – gli anni di S/Z di Barthes (1970), di Figures III di Genette (1972) e di Logique du récit di Claude Bremond (1973), per limitarci al panorama francese [2]. Nel mondo occidentale, l’archetipo della teoria della narrazione è la Poetica di Aristotele. Si tratta di un fatto noto che troppo spesso viene dato per scontato, al punto che l’invocazione di questo modello è diventata negli anni quasi un luogo comune, un rituale d’obbligo che non necessariamente richiede riflessioni o spiegazioni.
Il libro di Antonino Sorci, La Condition narrative. La fable de l’aristotélisme, uscito per i Classiques Garnier nel 2023, costituisce precisamente un tentativo di rintracciare le radici di questo modello narratologico, di riflettere sulle sue ragioni e, in parte, di interrogarsi sul suo destino: «ce travail se propose de décrire, d’un point de vue nietzschéen, le réseau de concepts et de relations qui s’est formé, au sein de la théorie narrative, autour d’une interprétation partagée de la Poétique d’Aristote» (p. 11). Questa rete di concetti e relazioni che si è formata a partire da una interpretazione condivisa della Poetica viene giustamente battezzata aristotelismo narrativo e l’obiettivo del volume è anzitutto dispiegarla individuandone i punti fermi. Il libro è infatti diviso in due parti: la prima è dedicata alle ragioni storiche che hanno determinato la nascita dell’aristotelismo narrativo e a un suo inquadramento generale; la seconda consiste nell’individuazione e nel dispiegamento di quelli che vengono chiamati «i cinque concetti fondamentali» dell’aristotelismo narrativo: mimesis, mythos, telos, anagnorisis, catharsis. Infine (ma ci torneremo), la prospettiva dalla quale questa storia viene osservata è definita «nietzschiana» perché l’autore stesso non condivide sino in fondo la «favola» dell’aristotelismo cui dedica un intero libro: una prospettiva nietzschiana, dunque, sia perché critica e relativistica nei confronti del suo oggetto di indagine sia perché sorretta dalle critiche che lo stesso Nietzsche fa ad Aristotele nella Nascita della tragedia.
Anzitutto, dunque, nella prima parte del volume Sorci individua tre tappe fondamentali nella costituzione dell’aristotelismo narrativo:
1. La prima è l’esperienza della cosiddetta “scuola di Chicago”, espressione con la quale si indica di solito un gruppo di studiosi riunitisi attorno all’Università di Chicago a partire dal 1930, e a seguire i loro eredi di almeno due generazioni successive. Il manifesto di questa scuola è Critics and Criticism (1952) di Ronald Crane, mentre l’esito più noto e rilevante è The Rhetoric of Fiction (1961) di Wayne Booth: in entrambi, l’esplicito richiamo ad Aristotele serve ad avallare un’idea retorica dell’atto narrativo. Il plot (mythos) non è qui semplicemente una sequenza di eventi, ma un’arte della comunicazione in cui un autore con una precisa intenzione produce sul lettore determinati effetti.
2. La seconda tappa è lo strutturalismo francese degli anni Sessanta e Settanta, dove invece il centro è il mythos in sé, inteso come sequenza di eventi autosufficiente, sia perché autonoma dall’autore che la produce e dal lettore che la fruisce, sia perché indipendente dal vincolo di referenzialità (secondo un’interpretazione parziale del concetto di vraisemblable). Todorov, Barthes e Genette si rifanno continuamente ad Aristotele, ma il momento di consacrazione dell’aristotelismo strutturalista è la pubblicazione della nuova edizione francese della Poetica (Seuil 1980) curata dai filologi Roselyne Dupont-Roc e Jean Lallot e nata dalla loro collaborazione con Todorov e Genette. Traducendo mimesis «rappresentazione» anziché «imitazione», il legame tra mimesis e mythos viene rafforzato, con un gesto di appropriazione della Poetica che offre alla neonata narratologia una radice storica millenaria.
3. La terza tappa è la più recente e consiste nella valorizzazione della dimensione cognitiva ed etica della Poetica compiuta tanto da teorici cognitivisti come Monika Fludernik quanto da filosofe neo-aristoteliche come Martha Nussbaum. Il baricentro si sposta qui sul lettore, sollecitato al contempo nel processo cognitivo dell’esperienza estetica e in quello emotivo di purificazione delle passioni.
Questi orientamenti critici, pur nella diversità a volte anche radicale delle loro posizioni, sono accumunati dalla condivisione dei cinque concetti fondamentali dell’aristotelismo narrativo: mimesis, mythos, telos, anagnorisis, catharsis. Ovviamente, a seconda che l’accento sia posto sull’autore (approccio retorico), sul testo (approccio strutturalista) o sul lettore (approcci cognitivo ed etico), questi concetti chiave possono essere anche profondamente ripensati (l’idea di telos, per esempio, diventerà di volta in volta il telos dell’autore che scrive l’opera, il telos delle funzioni interne al testo, il telos che muove il lettore). Ma non vengono mai meno. La narrazione è una rappresentazione di azioni umane (mimesis) che si dà nella forma di un intrigo (mythos) dotato di un inizio, di un mezzo e di una fine (o meglio, di un fine, un telos); questa rappresentazione, attraverso diversi meccanismi di conoscenza e riconoscimento (anagnorisis), suscita delle emozioni, come la pietà e la paura, e ne garantisce la purificazione (catharsis).
Per Sorci, dei cinque concetti, la catarsi è insieme il più importante e il più problematico. È il più importante perché è quello che più chiaramente ha garantito nei secoli l’efficacia e il valore sociale dell’atto narrativo: è la risposta aristotelica alla condanna platonica della poesia imitativa, bandita dalla Città ideale perché inutile e pericolosa. Il potere catartico delle narrazioni è la garanzia della loro utilità, di qui «l’acquis le plus important de la tradition néo-aristotélicienne de la narrativité : le questionnement des narratologues au sujet des pouvoirs des récits permet de comprendre ceux-ci comme des instruments capables d’éclairer le sens de la condition humaine et du monde dans lequel nous vivons» (p. 288). Se oggi nelle scienze umane e sociali si parla di «svolta narrativa» è anche perché l’aristotelismo ha posto le basi filosofiche per pensare la narrazione come un fenomeno in grado di riconfigurare la nostra esperienza umana (secondo la rilettura della Poetica offerta da Paul Ricoeur in Tempo e racconto). La narratologia diventa così un mezzo per pensare il nostro essere nel mondo. «Le modèle néo-aristotélicien représente de nos jours l’ancre de sauvetage qui a empêché au navire de la recherche narratologique de couler définitivement face à un situation à l’intérieur de laquelle des auteurs n’ont pas hésité à dresser son acte de décès» (p. 12). È solo rivendicando la sua vocazione filosofica che la narratologia ha potuto sopravvivere, uscendo dall’ambito ristretto della critica testuale e dell’analisi del discorso per essere recuperata da altre discipline, come la psicoanalisi, l’antropologia e la sociologia.
Ma a che prezzo? Anzitutto, come ricordavo all’inizio, al prezzo di perdere l’identità e il prestigio che aveva avuto negli anni del suo apogeo in Francia (Baroni 2016, pp. 226-230). In secondo luogo – ed è il punto che spinge Sorci a guardare con sospetto alle proposte fondate sul potere catartico delle narrazioni –, al prezzo di servire da ancoraggio teorico a una visione conciliante ed ecumenica del fenomeno narrativo, secondo l’idea nussbaumiana di una letteratura educatrice e riparatrice, fondata sul caring e sulla reparation (si pensi, in ambito francese, a Réparer le monde di Alexandre Gefen).
Il capitolo sulla catarsi è il più critico ed è l’ultimo del libro prima delle Conclusioni, dove finalmente diventa chiaro quello cui nell’Introduzione Sorci aveva solo accennato: questo è un libro sull’aristotelismo narrativo suo malgrado, perché chi scrive non condivide l’idea della catarsi tragica e preferisce opporgli una visione dionisiaca del fenomeno estetico, fondata non tanto sul piacere del mythos quanto su quello della musica e dello spettacolo, secondo la prospettiva proposta da Nietzsche nella Nascita della tragedia. «Une narratologie non-aristotélicienne me semble nécessaire afin d’explorer toute appréhension du texte qui ne se fonde pas sur la clarification du sens et des émotions. Sans nier la capacité de certains récits à nous éduquer et à nous faire progresser, une narratologie non-aristotélicienne pourrait être utile afin d’explorer les formes d’interaction qui ne sont pas orientées vers le perfectionnement moral des citoyens» (p. 289).
La pars destruens è chiara. Ma la pars construens? Cosa significa sostituire l’aristotelismo narrativo con una visione nietzschiana del fenomeno estetico? Per esempio, cosa vuol dire, concretamente, quando si parla di un un’opera letteraria, preferire a una visione interessata alla coerenza del mythos un approccio che guardi alla musica e allo spettacolo? Aristotele e Nietzsche pensavano alla tragedia come a qualcosa che doveva essere messo in scena, ma di fronte a un racconto scritto, come dobbiamo pensare le idee di musica e spettacolo? Ancora, in che senso il riso è un’emozione non catartica da preferire alla pietà e alla paura?
La brevissima conclusione della Condition narrative lascia aperti troppi interrogativi, abbozza una proposta di cui non si ha però modo di vedere i contorni e, soprattutto, getta una luce negativa su una «favola» che per pagine e pagine ci è stata narrata senza chiederci di sospendere la nostra incredulità (i dubbi di Sorci nei confronti del modello aristotelico sembrano cioè minori delle sue certezze). Ma, appunto, si tratta di una luce troppo flebile per oscurare ciò che l’ha preceduta, perché probabilmente una favola alternativa a quella aristotelica ancora non ci è stata raccontata – e chissà se questa favola sarebbe un mythos auspicabile.
Gloria Scarfone
Note
[1] Su questo problema riflette Baroni 2016.
[2] Negli Stati Uniti sono per esempio gli anni di Cohn 1978.
Bibliografia
Baroni, R. (2016). L’empire de la narratologie, ses défis et ses faiblesses. Questions de communication, 30, pp. 219-238
Todorov, T. (1969). Grammaire du Décaméron. Mouton: La Haye.
Cohn, D. (1978). Transparent Minds. Narratives Modes for Presenting Consciousness in Fiction. Princeton University Press: Princeton.
-
Strani strumenti
Recensioni / Maggio 2024Strani strumenti. L'arte e la natura umana è un libro che tratta di arte, scritto da un filosofo. Eppure, non è un libro di filosofia dell’arte, o quantomeno non negli intenti del suo autore. Secondo Noë, l’arte non è un fenomeno da analizzare, come può esserlo invece un rito d’iniziazione, o la riproduzione cellulare. Di cosa si tratta allora? La tesi principale di Noë è che l’arte, proprio come la filosofia, sia piuttosto una pratica di ricerca. Gli oggetti artistici, in quest’ottica, non valgono propriamente come oggetti, ma come strumenti—strumenti dotati di una natura peculiare—attraverso cui è possibile fare luce sulla natura umana, tanto da chi li produce, quanto da chi ne fruisce.
Pubblicato nel 2015 da Hill & Wang, e tradotto da Vincenzo Santarcangelo per Einaudi nel 2022, Strani strumenti propone una riflessione sui rapporti—solo in apparenza superficiali—tra arte e filosofia. Noë intende infatti queste due discipline come specie diverse di un genere comune: pratiche di ricerca «assillate dalla volontà di comprendere in che modo gli esseri umani sono organizzati e quali possibilità di riorganizzazione possiedono» (p. ix). L’analisi delle relazioni che intercorrono tra organizzazione e pratiche riorganizzative costituisce il cuore teorico della proposta di Noë. Cerchiamo di ricostruirne brevemente le dinamiche.
Innanzitutto, Noë osserva che il tratto fondamentale della vita umana e delle attività in cui essa si dispiega è l’organizzazione. «Parlare, camminare, mangiare, percepire, guidare: siamo costantemente catturati in strutture organizzative. È la nostra condizione naturale, anzi biologica. È ciò che ci rende esseri umani» (p. 13). Siamo dunque organizzati per natura—ed è questo un punto su cui sarebbe difficile non convenire. Il vero nocciolo della questione è piuttosto cercare di comprendere l’estensione del concetto di natura, e il suo rapporto con la sfera della cultura. Rispetto a questo tema, Noë sposa la tesi—sostenuta, nella sua veste più contemporanea, da Andy Clark e David Chalmers—della mente estesa. In breve, noi non siamo il nostro cervello: «Le nostre menti sgorgano dalle nostre teste e vanno a finire sulla carta, nel mondo» (p. 34). Da una parte, il livello cognitivo dipende costitutivamente dall’ambiente (naturale e sociale) in cui siamo inseriti, dall’altra, le nostre pratiche tecnologiche—ad esempio, scrivere, o disegnare su un pezzo di carta—sono parte integrante del livello cognitivo. Con le parole di Noë: «Il fatto è che noi non ci limitiamo a usare strumenti; noi pensiamo con essi» (p. 27).
L’attenzione di Strani strumenti si dirige soprattutto su quest’ultimo punto. Noë sostiene che gli esseri umani sono designer per natura. Le pratiche tecnologiche, come la scrittura, la produzione di immagini o di artefatti dotati di funzioni specifiche, sono fenomeno naturali che organizzano la vita umana: «Le persone usano gli strumenti in modo naturale, come fossero api che costruiscono alveari o uccelli che nidificano» (p. 25). Non vi è dunque soluzione di continuità tra natura e cultura, tra organizzazione biologica e organizzazione tecnologica. Gli strumenti tecnologici non sono che «l’armamentario grazie al quale svolgiamo le nostre attività organizzate» (p. 24), e dunque grazie al quale gli esseri umani esprimono le loro potenzialità.
Tuttavia, le nostre attività organizzate non sono di per loro autoriflessive, o autocritiche. In un certo senso, tali attività semplicemente si dispiegano. L’arte (come la filosofia) fa invece di più, poiché, secondo Noë, è una pratica di ricerca che si sostanzia di tali attività, che riflette sulla loro organizzazione e che così facendo è in grado di riorganizzarle, e dunque di riorganizzarci. Noë propone di individuare «due livelli: il livello 1 è quello dell’attività organizzata o della tecnologia; il livello 2 è quello in cui questa organizzazione di più basso livello è esposta e indagata» (p. 36). Al livello 2 troviamo così le diverse arti (pittura, musica, letteratura, ecc.) e la filosofia. La coreografia, per riprendere uno degli esempi più ricorrenti del libro, è una pratica che mette a tema l’attività della danza e ne riscrive le regole, la riorganizza. La pittura fa lo stesso con la produzione di immagini, mentre la filosofia con le idee, i concetti e le credenze.
La separazione tra il primo e il secondo livello non è netta. Vi è infatti una costante retroazione delle pratiche riorganizzative sulle attività organizzate. La coreografia riorganizza l’attività del ballo, e così facendo questa attività non sarà più la stessa di prima: «In un mondo in cui il ballo è stato già rappresentato, non sarà più possibile ballare prescindendo dall’immagine di tale attività» (p. 36). La danza ri-organizzata costituirà così il materiale per le coreografie a venire. La sfera delle attività di livello 1 e la sfera delle pratiche di livello 2 risultano dunque separabili solo analiticamente; di fatto, secondo Noë, sarebbe fuorviante pretendere di pensare a un modo di ballare che prescinde dalla rappresentazione del ballo (coreografia), e altrettanto impossibile sarebbe tornare a un vedere o a un modo di produrre immagini che precede la pittura.
Come si può allora distinguere tra il ballo per così dire spontaneo, irriflesso, e una rappresentazione coreografica, oppure tra un’immagine pubblicitaria e un’opera d’arte conclamata? Una distinzione fondata sul loro modo di apparire risulterebbe inefficace. Noë sostiene infatti che «l’arte tenderà sempre a essere materialmente indistinguibile dalle sue fonti tecnologiche» (p. 75), dalle attività di livello 1 da cui attinge. Una pubblicità che mostra un paesaggio montano per spingerci a prenotare una vacanza e una fotografia artistica che raffigura la stessa scena sono materialmente indistinguibili; si basano sulla stessa tecnologia. La distinzione tra il livello delle arti e il livello delle attività organizzate e della tecnologia passa invece attraverso la nozione di funzionalità. Gli oggetti tecnologici sono propriamente degli strumenti che utilizziamo per ottenere determinati risultati. Gli oggetti artistici sono invece oggetti inutili, spogliati delle loro funzioni: «L’arte è nemica della funzionalità, è il sovvertimento della tecnologia» (p. 115). Ed è proprio per questo che gli oggetti d’arte si rivelano come strumenti anomali, ossia strumenti cui è stata sottratta la loro funzione.
Noë porta avanti le sue tesi attingendo ampiamente dal panorama delle avanguardie artistiche. E non è certo un caso: le opere d’arte concettuale di Marcel Duchamp, le tele di Barnett Newman, le sculture di Robert Lazzarini e le installazioni di Robert Irwin—per ricordare alcuni degli artisti discussi in Strani strumenti—esemplificano perfettamente l’idea che l’arte sia una pratica che «interrompe, rende strano, e dunque sovverte» (p. 135) le nostre abitudini e attività organizzate. L’orinatoio Fontana di Duchamp è visibilmente un oggetto tecnologicamente elaborato spogliato della sua funzione originaria; il fatto che sia capovolto sottolinea il sovvertimento della sua funzione, e dunque un’operazione di straniamento rispetto al suo utilizzo abituale. Resta tuttavia da capire se tale concezione sia davvero in grado di abbracciare l’intero mondo dell’arte, attraverso le diverse epoche e latitudini, e se non sia invece una concezione troppo intellettualistica. In che senso—verrebbe spontaneo domandarsi—un dipinto rinascimentale o una statua greca dovrebbe essere uno strano strumento? Noë anticipa in realtà perplessità di questo genere, e riconosce che la carica sovversiva dei capolavori dei maestri del passato potrebbe non risultarci più perspicua, soprattutto se li osserviamo con il nostro sguardo contemporaneo. Si tratterà allora di guardarli di nuovo, di guardarli più a fondo per cercare di riattivarne il senso e riportare alla luce gli interrogativi e il potere sovversivo che rende quegli oggetti strani strumenti.
Ora, non vi è dubbio che si possa ripercorrere la storia dell’arte per trovare illustri esempi di opere capaci di mettere in crisi la nozione di rappresentazione, o di sovvertire le abitudini estetiche dei loro fruitori; ed è questa un’operazione assolutamente valida. Dei dubbi sorgono invece se si pensa che questa concezione dell’arte debba valere incondizionatamente. In altre parole, l’arte deve sovvertire per essere tale? Noë sembra piuttosto assertivo sulla questione, ma sarebbe forse più prudente rimodulare questa tesi e intendere la sovversione come una delle modalità dell’arte. In seguito, ci si potrebbe chiedere se questa modalità goda di uno statuto speciale, se sia la più nobile, e, nel caso, per quali ragioni. Forse quelle opere che lasciano il segno devono davvero essere sovversive. Ma è altrettanto chiaro che non tutti gli oggetti che, per motivi diversi, fanno parte del mondo dell’arte posseggono una carica sovversiva o sono in grado di sollevare questioni sostanziali. Il mercato dell’arte sembra spesso meno esigente, e i suoi oggetti meno strani (nel senso delineato in Strani strumenti), di quanto Noë probabilmente si auspicherebbe.
È dunque possibile che Strani strumenti non riesca a catturare il senso ultimo del fare arte; ed è del resto dubbio che una teoria possa riuscirci. In compenso, sulla base dei suoi lavori di filosofo e scienziato cognitivo, Noë riesce a metterci efficacemente in guardia da un approccio che una simile pretesa la ha, e che cerca risposte sul senso dell’arte nel posto sbagliato: il cervello. Vi è infatti, secondo Noë, una tendenza diffusa in campo scientifico a voler spiegare che cos’è l’arte facendo appello alle neuroscienze. Questo approccio accetterebbe acriticamente una tesi riduzionista, di provenienza cartesiana, secondo cui per comprendere un dato fenomeno bisogna guardare a quello che accade nel cervello. La neuroscienza dell’arte, ossia la neuroestetica, assume che gli oggetti d’arte siano «triggers per eventi che si producono nel sistema nervoso» (p. 149). Per Noë si tratta tuttavia di un approccio fallimentare: cercare il senso e il valore dell’arte dentro al cervello «sarebbe come cercare il valore dei soldi nella carta su cui sono stampate le banconote» (p. 114). Credo che la posizione di Noë su questo tema sia condivisibile; le ragioni a suo favore non vengono però sviluppate in modo perspicuo in Strani strumenti.
Vale forse la pena spendere qualche parola in più su questo punto. In linea con le argomentazioni presentate da Noë, si potrebbe sostenere che una disciplina come la neuroestetica non può in alcun modo dirci che cosa sia l’arte. La ragione non è difficile da scorgere. La neuroestetica studia i correlati neurali delle nostre esperienze di fronte alle opere d’arte o durante i processi creativi. Un approccio di questo tipo potrà dunque essere altamente informativo su quello che accade nel cervello, ma dovrà tuttavia dare per presupposto che le esperienze prese in esame riguardino oggetti artistici, e non altro. In altre parole, la ripartizione degli oggetti del mondo in oggetti artistici e oggetti non artistici è un’operazione che precede l’attivazione di determinati correlati neurali, e non potrà dunque essere spiegata da essi. Un neuroscienziato che si accinge a studiare l’esperienza di un soggetto di fronte ad alcune opere d’arte dovrà già sapere—ancor prima di iniziare l’esperimento—che cosa vale come arte, e non potrà scoprirlo dopo aver compiuto la sua indagine. La domanda è allora la seguente: da dove proviene questa consapevolezza?
Noë ci mette qui sulla buona strada. Nessuno intende negare che l’arte interagisca con il sistema nervoso, ed è del tutto sensato affermare che senza un sistema nervoso non ci sarebbe alcuna esperienza dell’arte (né alcuna esperienza in generale). Tuttavia, il nesso causale che sussiste tra eventi neurali ed esperienza dell’arte non ci dice niente di significativo su quest’ultima. Il suo senso e il suo valore emergono altrove: «le opere d’arte sono atti comunicativi, transazioni che avvengono in una certa comunità, mosse nel contesto di un paesaggio fatto di nozioni e conoscenze condivise» (p. 114). In conclusione, il libro di Noë si rivela un valido strumento per ripensare il senso del fare arte, ma anche per smorzare le pretese di alcuni approcci riduzionistici contemporanei.
Federico Fantelli
-
Maurice Merleau-Ponty: l’apparire del senso
Recensioni / Febbraio 2024Se, solitamente, le frasi scelte ad epigrafe di una monografia servono più a ringraziare qualcuno di caro o a restituire il senso più generale del testo che ci si approccia a leggere, le parole tratte da Nietzsche con cui Taddio dà il via al suo nuovo lavoro su Merleau-Ponty - Maurice Merleau-Ponty. L'apparire del senso - sono invece programmatiche e ci offrono un ottimo punto di inizio per analizzare il contenuto del libro. Dalla Nascita della tragedia Taddio estrapola questo passaggio essenziale: “Solo come fenomeno estetico l’esistenza e il mondo sono eternamente giustificati”. Il termine per noi fondamentale è “estetico”, che utilizzeremo (secondo l’accezione che a breve chiariremo) per leggere tutto il lavoro di Taddio. Com’è noto la parola può essere interpretata e usata in più modi, sia per indicare la filosofia dell’arte, sia - sfruttando la radice greca del termine - per includere il campo di indagine che analizza la dinamica tramite cui le cose ci appaiono, ovvero la fenomenologia. “Estetico” è il senso stesso della presenza dei fenomeni, che manifestandosi chiamano in causa il nostro sistema percettivo. In Nietzsche, tuttavia, il termine viene utilizzato in una terza accezione, per indicare un nuovo modo di interpretare la realtà senza il bisogno né di dividerla in due parti (fenomeno e noumeno) né di giudicarla a partire da degli assiomi eterni (il bene e il male). Tutto si gioca sul piano dell’apparire, del fenomeno, della pellicola che stimola i nostri sensi, e tutto – di conseguenza – si gioca e trova spazio unicamente sul piano dell’esperienza, che come tale è assoluta e illimitata e non può venire spartita in verità e illusioni. In questo senso, Nietzsche ci propone una lettura della natura del reale come effetto di superficie, come puro gioco di forme, o, per dirla altrimenti, ci permette di pensare a un significato ontologico del termine estetica.
Ed è proprio questa accezione radicale del concetto di estetico che permette di cogliere la tesi sostenuta dal libro di Taddio. Il quale, pur riconoscendo l’importanza delle arti e della pittura (quindi del primo significato del termine) nel pensiero di Merleau-Ponty, e pur dichiarando di voler «riscoprire il pensiero del filosofo come luogo ove far vibrare in modo inedito le corde della fenomenologia» (p. 13), ovvero rimanendo fedeli al secondo significato della parola “estetica”, propone una versione ontologica del pensiero di questo maestro del Novecento basandosi sugli ultimi scritti – incompleti e postumi – che questi ci ha lasciato. Il risultato è che Merleau-Ponty ci viene offerto in una veste classica e insolita al tempo stesso, perché se da un lato ne viene evidenziata la matrice già ampiamente studiata dalla letteratura secondaria di continuatore e critico della fenomenologia di Husserl, nonché di grande esperto di arte e letteratura, dall’altro il testo di Taddio lo installa su una prospettiva ontologica radicale da cui è possibile trarre degli spunti per trascinare gli strumenti classici merleau-pontiani in territori nuovi, come quelli della trasformazione digitale che stiamo tutti vivendo. Il libro, quindi, si pone come obiettivo quello di ripercorrere le vie più note del pensiero di Merleau-Ponty, ma di farlo secondo un orientamento differente e apertamente ontologico, utilizzando le pagine di Merleau-Ponty come i prolegomeni a un’ontologia delle relazioni pure di cui nel corso del libro viene, non a caso, delineato il profilo.
I primi cinque capitoli mettono in chiaro tutti gli elementi fondamentali per comprendere la portata generale del pensiero di Merleau-Ponty. Taddio costruisce un dialogo tra l’arte, la filosofia e le scienze così come Merleau-Ponty stesso ha inteso fare, ovvero intrecciandole tra loro in un movimento perpetuo ed ermeneutico che impedisca, da un lato, un irrigidimento soffocante in categorie troppo vincolanti (per la scienza) e, dall’altro, la ricaduta in un solipsismo esasperato e relativizzante (per la filosofia). Merleau-Ponty è stato in grado di proporre un movimento per cui l’arte accorre a sfumare i contorni della scienza moderna, mentre il linguaggio delle scienze (contemporanee) serve alla filosofia e, in particolare, alla fenomenologia, come ricettacolo di esempi, prove e dimostrazioni utili per ancorare la riflessione teoretica a un fondamento stabile. Merleau-Ponty ha però un indubbio bersaglio polemico, che Taddio chiarisce sin dalle prime pagine del libro: non la scienza in generale, ma la scienza moderna che ha poi trovato in Cartesio la sua nobilitazione filosofica. La modernità ha infatti prodotto un’interpretazione algebrica, geometrizzante e standardizzata della realtà, organizzandola – sul piano scientifico – all’interno di due contenitori assoluti e neutrali (lo spazio e il tempo) dentro cui ogni singolarità e specificità scompaiono, mentre – sul piano della filosofia – dividendo l’oggetto percepito dal soggetto percipiente come se fossero due mondi e sostanze distinte. Come Taddio riassume, «con l’inizio della modernità, possiamo assegnare alla scienza sperimentale il compito di indagare la realtà sottostante l’esperienza» (p. 26, corsivo nostro); in altre parole, con la modernità si configura una distinzione tra ciò che è percepito e chi percepisce, e tra ciò che i sensi offrono e ciò che le cose realmente sono al di là, o al di sotto, di questi. Riassumendo, possiamo dire che la modernità installa sulle precedenti categorie greche la distinzione tra ciò che è apparente e ciò che è reale, conferendo a questi due poli non soltanto un carattere distintivo, ma marcatamente rivale. Il risultato è che il mondo dei sensi viene derubricato a un ruolo passivo o scarsamente rilevante dal punto di vista teoretico, non possedendo mai in sé la propria stessa verità.
Per uscire da questa impasse costruita dalla complicità tra la filosofia e un sapere matematico-geometrizzante, Merleau-Ponty si rivolge all’arte: è l’arte che «ci conduce alle cose stesse. Per Merleau-Ponty i pittori e, più in generale, gli artisti hanno in effetti qualcosa da insegnare ai filosofi: innanzitutto, spiegano come guardare il mondo e le cose» (p. 19). L’arte pittorica, in particolare quella di Cézanne, è lo strumento per eccezione con cui Merleau-Ponty si imbarca nell’impresa di rieducare lo sguardo a non essere esclusivamente un occhio contemplativo che sbircia il mondo dal riparo di un guscio privilegiato e chiuso (la soggettività). La pittura, infatti, insegna all’uomo contemporaneo ad analizzare lo spazio che lo circonda come un mondo in divenire attraversato da «forze invisibili-visibili che agiscono nel campo fenomenico» (p. 20). L’arte è ciò che permette di ritornare alle cose stesse perché è ciò che permette la riscoperta di quell’intrinseco scambio dinamico e attivo che da sempre coinvolge chi percepisce e la cosa che viene percepita; uno scambio in cui il soggetto non è un punto privilegiato, ma è il nodo di una relazione più originaria e “orizzontale” con gli altri elementi che costituiscono l’esperienza. L’arte è dunque, in conclusione, secondo Merleau-Ponty, la cura alla modernità perché dissolve le gerarchie tra un sopra e un sotto, tra un alto e un basso, e restituisce all’esperienza lo statuto di una dinamica relazionale tra diversi livelli costantemente implicati gli uni negli altri, tra cui quelli del soggetto e dell’oggetto. La fenomenologia deve quindi partire da qui: da una dose di anti-modernità che le permetta di superare la distinzione tra apparenza e realtà e di divenire una scienza delle relazioni percettive pure.
In questo senso è chiaro che il bersaglio polemico di Merleau-Ponty non è la scienza tout court, bensì quello specifico sapere tecnico-organizzativo che si trova riassunto nel termine “modernità”. Questo dettaglio è, a nostro avviso, il contributo principale del libro di Taddio, che permette di lasciarsi alle spalle un’immagine antiquata del filosofo francese e ci porta a pensare con lui un rapporto nuovo, più ampio e solidale, sebbene non per questo meno critico, tra scienza, filosofia e arte. I capitoli che vanno dal sesto al sedicesimo sono infatti dedicati da Taddio a dimostrare quanto Merleu-Ponty fosse influenzato e apprezzasse le scienze a lui contemporanee, in particolar modo la Psicologia della Gestalt. Analizzando l’illusione di Müller-Lyer, di Zöllner, l’esperimento di Ternus e il movimento stroboscopico di Wertheimer, Taddio ci mostra non soltanto quanto la psicologia della Gestalt e una fenomenologia ad essa ispirata possano introdurci a un mondo fatto di costanti relazioni reciproche tra le parti, ma anche come Merleau-Ponty conoscesse a fondo queste teorie e che, proprio a partire dai loro risultati, formulò l’idea di una fenomenologia intesa come l’approccio più efficace per « indicare una via alternativa sia alla tradizione “empirista” sia a quella “intellettualista”» (p. 107). La fenomenologia intesa da Merleau-Ponty permette quindi di scappare sia dalle trappole di un riduzionismo spicciolo e “moderno” degli enti a cose, sia dal rischio – anche questo squisitamente moderno – di precipitare in un solipsismo in cui è il soggetto l’unico perno che garantisce l’oggettività e il senso del mondo. Questa mossa merleau-pontiana ha due effetti importanti. Il primo è quello di predisporre un’idea innovativa, che Taddio sembra condividere, di fenomenologia, la quale separandosi in parte dal solco husserliano si caratterizza per un movimento doppio: è sia la scienza delle essenze, ma è anche «quel metodo che ci consente di ricondurre le essenze al piano dell’esistenza, ovvero a quel piano che ci permette di comprendere il senso stesso dell’uomo e del mondo» (p. 74). In altre parole, per Merleau-Ponty la fenomenologia «non fonda il proprio sapere su essenze (eidos) concepite come modelli eterni e immutabili», perché questo rischierebbe di rimettere in campo tutte le “storture moderne” che Merleau-Ponty stesso vuole superare, in primis l’idea che ci sia una realtà più vera e oggettiva di quella che costituisce la nostra esperienza. Ne consegue che il principio epistemologico per il quale esisterebbe un velo tra apparenza e realtà, oppure una differenza ontologica tra un mondo superiore e un mondo inferiore, non è più applicabile. Piuttosto, in maniera profondamente nietzscheana, secondo questa “nuova” fenomenologia ogni «trascendenza si genera nell’immanenza» (p. 75), ovvero ogni diverso livello della realtà si genera dentro e a partire dalla realtà stessa; inclusi il soggetto e l’oggetto. Per mostrare questo punto, Taddio fa un esempio a nostro avviso efficace utilizzando il gioco degli scacchi (p. 155). Negli scacchi, le regole d’azione non sono tutte equivalenti, ma ottengono un senso preciso all’interno della partita specifica che si sta giocando: muovere un alfiere invece che il cavallo, in questa partita, assume un senso differente che farlo in un’altra, dove ci sono altre disposizioni dei pezzi nello spazio. Ne consegue che non esiste La Partita Perfetta, bensì una griglia di senso che si concretizza e muta nella dinamica composta dalle mosse possibili, dai movimenti scelti e dalla disposizione dei pezzi. In altre parole, «non esiste un modello atemporale e trascendente» (p. 155): è l’immanenza costituita da relazioni tra parti a concretizzare le proprie strutture durante il suo stesso svolgersi.
Avevamo detto, però, che le conseguenze di questo approccio erano due. Questa nuova idea di fenomenologia si trova, infatti, ad avere un alleato forse insperato in un pensatore che, pochi decenni prima rispetto a Merleau-Ponty, aveva già tentato di superare la distinzione tra intellettualismo e empirismo, formulando un concetto specifico. Il pensatore è Henri Bergson, che nel capitolo IV di Materia e Memoria introduce il concetto di virtuale per proporre un’ontologia immanente alle forme stesse (che lui chiama «immagini») che costituiscono la nostra esperienza, senza però far sì né che queste forme siano pensate come prestabilite da modelli già inscritti nel virtuale (ovvero non sono delle mere possibilità che concretizzano delle essenze già note) né, tantomeno, senza che il virtuale si riduca esclusivamente alle forme stesse in cui si attualizza, cosa che provocherebbe un arrestarsi del movimento del divenire per esaustione. Il virtuale di Bergson è il nuovo termine ontologico capace di sostituire l’ontologia essenzialistica di Cartesio, ovvero di compiere un passo radicalmente anti-moderno, come Manuel DeLanda (un realista, come Taddio stesso si dichiara essere nel corso del libro) ha ampiamente dimostrato nel suo Scienza intensiva e filosofia del virtuale, ricostruendo l’importanza di questo concetto nel pensiero di un altro filosofo francese assimilabile per certi versi a Merleau-Ponty stesso, ovvero Gilles Deleuze . Il virtuale, in altre parole, è l’idea che la realtà sia costitutivamente un flusso di divenire che si auto-genera e auto-struttura in un equilibrio semi-permanente, meta-stabile, e secondo cui il «mondo emerge con le proprietà fenomeniche che conosciamo nell’esperienza immediata» (p. 163) senza il bisogno di convocare un principio trascendente o esterno. Nietzscheanamente, non serve andare oltre la realtà creando un’apparenza da superare: il piano dell’esperienza immediata è sufficiente a spiegare, anche scientificamente, se stesso. Leggere dunque Merleau-Ponty secondo questa prospettiva permette di inserirlo in un contesto più ampio interno alla storia della filosofia francese contemporanea, in un arco che va da Bergson, Simondon, Thom, e corre fino a Deleuze.
Da questo quadro Taddio trae alcuni fondamenti epistemologici per una nuova fenomenologia delle relazioni basata sulle intuizioni di Merleau-Ponty, dove è possibile pensare a mondi distinti che però restano allacciati dallo stesso e unico piano di realtà. La filosofia e l’arte indagano il senso che questa configurazione delle cose si trova continuamente a generare, mentre la scienza studia e analizza il fondamento stesso della realtà in cui i mondi si trovano, col risultato che arte, scienza e filosofia (intesa, principalmente, come fenomenologia) si trovano a collaborare senza rivalità e senza sovrapposizioni in un unico piano ontologico che costantemente produce senso e costantemente si svolge e differenzia. La prospettiva ontologica del virtuale, che secondo Taddio Merleau-Ponty ha cominciato a delineare soprattutto a partire dagli ultimi scritti e dalle lezioni tenute al Collège de France dedicate al concetto di natura, può, alleggerita dal penso di una dualità insanabile tra soggetto e oggetto, aiutarci a descrivere ciò che oggi sta accadendo. In particolare, il libro propone un’analisi poco scontata dell’evoluzione tecnologica che i nostri corpi e le nostre società stanno subendo, invitando a considerare il digitale non come una mera illusione, una falsa realtà, un’apparenza, ma come un mondo interno alla realtà dentro cui stanno emergendo nuove strutture, come tali né negative né positive di principio. Solamente se analizzate senza dicotomie pregiudiziali (artificiale/naturale, umano/animale, falso/vero), quindi attraverso le lenti di questa fenomenologia “eretica” pensata da e a partire da Merleau-Ponty, le rivoluzioni in cui ci troviamo immersi si offrono nelle loro logiche di base, da cui poi è possibile prendere delle decisioni politiche accorte e efficaci. Il Merleau-Ponty di Taddio è un pensatore realista, anti-moderno ma non per questo anti-scientifico: un fenomenologo dell’immanenza che la sua morte avvenuta a soli cinquantatré anni, nel 1951, non ha forse permesso di vedere chiaramente.
Andrea Colombo
Bibliografia
Bergson, H. Materia e Memoria. Saggio sulla relazione tra il corpo e lo spirito, Laterza, Roma-Bari, 2014.
DeLanda, M. Scienza intensiva e filosofia virtuale, Meltemi, Milano, 2022.
Nietzsche, F. La nascita della tragedia, Adelphi, Milano, 1972.
-
PK#21 \ settembre 2024
a cura di Carlo Deregibus e Aurosa Alison
Siamo abituati a guardare alle forme dell’architettura come portatrici di significati. Quello tra forma e significato era un nesso così ovvio, così connaturato alla costruzione e alla realtà sociale, da rimanere perlopiù implicito, premessa a qualsiasi discorso e trattato. Valeva nell’architettura classica come in quella medievale, in quella egizia come in quella barocca, in quella moderna come, persino, in quella propriamente detta postmoderna. Solo in tempi relativamente recenti, quando il postmodernismo fa vacillare non tanto quel legame, quanto la la sua univocità, il significato diventa un problema per l’architettura. Da un lato, perché la missione del Moderno, così assoluta da polarizzare qualsiasi dibattito, si rivela alla prova del tempo quantomeno aleatoria. Dall’altro, perché si avvertono i primi sentori di quel cambiamento, fatto di globalizzazione e moltiplicazione del pensiero che diverrà travolgente nel nuovo millennio. Nasce cioè l’idea che la forma sia parte di un sistema di comunicazione di significati, più che la latrice di un univoco messaggio.
In questo contesto usciva in Italia, ormai 50 anni fa, Il significato in architettura, curato da Charles Jencks e Georges Baird e pubblicato a Londra cinque anni prima. Raccoglieva una quindicina di testi tra loro spesso in contrasto, editati e commentati, che indagavano il significato da vari punti di vista: secondo approcci semiotici o fenomenologici, con accenti teoretici od operativi, con critiche o proposte, i testi tracciano una storia del significato possibile. Tanto che proprio il contrasto, a volte violento ed esplicitamente sobillato dai curatori, diventa il tratto più distintivo del volume: un contrasto reso possibile dalla convinzione, vana, che fosse ancora possibile definire il rapporto tra significato e forme.
Cosa resta, cinquant’anni dopo, di quel dibattito? Poco, in effetti. Lungi dall’essere sparito dai radar degli architetti, in questi decenni il significato si è moltiplicato in rivoli talmente frammentati da non permettere più una geografia culturale precisa. Nuovi significati - la globalizzazione appunto, ma anche i temi dell’antropocene, della gentrification, delle ecologie, della resilienza, dei gender studies, e così via - offrono infinite possibilità di teorizzazione, sempre legate a pratiche tra loro distinte, separate e che non comunicano. Ma che si considerano tutte Architettura. È uno sfilacciamento riflesso anche dalle teorie sull’arte e dalla crescente distanza tra arte e mercato, tra significato e esperienza, tra percezione e comprensione. Eppure, continuiamo a progettare, a produrre e a criticare l’Architettura, continuamente attribuendo alle sue forme significati, e rivestendola di intenzioni e speranze.
Così, questo numero di PK esplora, una volta di più, questa sfuggente ma insieme ineludibile relazione tra significato e architettura. Lo fa secondo tre assunti metodologici. Il primo è che, lungi dall’essere scomparso, il significato oggi ecceda, e largamente, la forma, e dunque sia sempre e di nuovo possibile riscoprire e riprogettare la loro relazione: certo quel legame muta a velocità variabili, secondo sistemi diversi la cui reciproca irritazione produce cambiamenti spesso imprevedibili, ma tuttavia esiste. Il secondo è che le dimensioni teoretica e pratica dell’architettura non siano pensabili separatamente, se non come coppia oppositiva derridiana: il progetto dell’architettura deve essere sempre inteso nella sua dimensione performativa e secondo gli effetti che questo produce, e la distinzione tra progetto e progetto di architettura è ad essi strettamente quanto problematicamente legata. Il terzo è la dimensione sistemica dell’architettura, che deve essere intesa nelle sue condizioni socio-tecnico-economiche: questo vale sempre, storicamente, e oggi implica una relazione costitutiva con un pervasivo sistema neoliberale, un confronto con una dimensione produttiva che cancella le tensioni artigianali, e la modifica delle modalità di produzione del progetto che, circolarmente, ne stravolgono concezione e quindi significato. Le connessioni tra i tre assunti - ad esempio nella tensione tra agire individuale e dimensione sistemica, da cui emerge una valenza tattica e strategica del progetto - sono altrettanto decisive.
Le proposte possono affrontare il tema del significato in architettura da una prospettiva ontologica ed epistemologica, anche con una prospettiva storico-critica, oppure rientrare in uno dei quattro nuclei tematici qui enucleati, anche esplorandone connessioni e interrelazioni e trattandoli da diversi punti di vista - storico, teoretico, critico:
- Nuove forme del significato. I luoghi sono sempre stati collettori del senso di comunità, sia in senso simbolico sia in senso esperienziale. Come coordinare il continuo moltiplicarsi di forme di socializzazione reale e digitale (dal metaversale alla visual turn) con l'aspetto ontologico e reale della progettazione? Sulla scorta della retorica di una democratizzazione dei processi comunicativi, sociali e relazionali, è davvero possibile innestare un significato nello spazio pubblico, o questi progetti non fanno altro che illudere i partecipanti di farlo? È il processo, o il programma, a dare un significato a un’architettura in cui le forme non hanno rilevanza alcuna se non come trasposizione tecnica o, al contrario, l’architettura va considerata e trattata come un palinsesto che vive persino indifferentemente dagli usi, diventandone uno sfondo neutrale? Nel mezzo, un’infinita sfumatura di pratiche e approcci.
- Nuovi significati delle forme. Vorremmo riflettere su quei significati che più sembrano trasversali e sostanziali nell’impattare l’architettura. Il primo è ascrivibile al tema della sostenibilità: ad esempio, come superare pratiche estetizzanti e approcci puramente prestazionali e sviluppare una dimensione autenticamente ecologica del progettare? È un tema di norme, di cultura, di azioni, di tecniche, di approcci, di forme, di strategie, o ancora di altro tipo? Il secondo è il cosiddetto design for all, che raccoglie questioni pratiche - come l’accessibilità - e culturali - come l’urbanistica di genere - e che però, curiosamente, si sostanzia in limitazioni burocratiche variamente normate: quasi che il progetto non definisse, ontologicamente, i limiti di qualche libertà. Come superare questa visione, aggrappata a una logica di tutela dei gruppi di minoranza, per sviluppare il tema della libertà nel progetto e nelle forme?
- Resilienza dei significati. C’è Architettura e architettura. Gran parte dei progettisti nel mondo non si occupano di quelle rare opere “straordinarie” (auditorium, chiese, musei), cioè i tradizionali portatori di significati condivisi: bensì di ordinarie, comuni, quotidiane costruzioni. Non parliamo dell’ordinario sperimentale e d’élite esplorato dagli architetti di punta, ma proprio della pratica comune, di quel significato che nasce e si sostanzia in una continua variazione e ripetizione, nel real estate come negli slum. Spogliata dalle stratificazione semantiche dell’Architettura, resta cioè un’architettura: lontana dalle accademie e dalle pagine patinate, ma che traccia il nostro mondo. A livello ontologico e pratico, il progetto di questa architettura è diverso da quello di Architettura? E in che modo si evolve, ad esempio guardando all’ascesa impressionante dei software basati sull’Intelligenza Artificiale?
- Resilienza delle forme. Il costruito ha una immensa capacità resiliente. Certo, non sempre questa va d’accordo con gli usi, e i significati di quelle forme. Il caso italiano è emblematico, tra tensioni verso la rigenerazione e l’esigenza di tutela e conservazione del patrimonio. Casi come Palazzo dei Diamanti a Ferrara o lo stadio Meazza a Miano sono solo le evidenze mediatiche di un problema diffuso e in inevitabile crescita: lo scontro tra valori e significati diversi, che si sovrappongono nelle forme. La risposta è nella qualità del progetto? Oppure in quella del processo? È un problema di procedure e soggetti decisori, oppure di proposte e gestione? In che modo significati sempre più essenziali e inconciliabili - ad esempio la fruizione dei beni storici, la sicurezza in caso di sisma, il risparmio energetico, il costo degli interventi, vincoli antincendio, di accessibilità e così via - si intersecano nelle forme?
È nostra intenzione, in omaggio al tratto più distintivo de Il significato in architettura, promuovere una circolazione dei contributi tra gli autori prima della pubblicazione, in modo da raccogliere commenti specifici da parte di tutti gli autori e offrire una possibilità di controreplica ai commenti da parte degli autori stessi. Un dibattito interno al volume, unico quanto prezioso.
Bibliografia:
Ando, T., (1990), Complete Works, Taschen
Armando, A. & Durbiano, G. (2017). Teoria del progetto architettonico. Dai disegni agli effetti. Roma: Carocci.
Aureli P.V. (2008). The Project of Autonomy: Politics and Architecture Within and Against Capitalism. Hudson: Princeton Architectural Press.
Berlin, I. (1969). Four Essays on Liberty. Oxford: Oxford University Press
Booth C., Darke J. & Yeandle S. (edi) Changing Places: Women’s Lives in the City. London: Paul Chapman Publishing Ltd.
Boudon, R. (1984). La place du désordre. Critique des théories du changement sociale. Paris: Presses Universitaires de France.
Chia, R. & Holt, R. (2011). Strategy without Design: The Silent Efficacy of Indirect Action, Cambridge: Cambridge University Press.
Deregibus, C. (2016). Intention and Responsibility. Milano: IPOC.
Derrida, J. (2008). Adesso l’architettura. Milano: Scheiwiller, 2008.
Haraway, D. (1985). Manifesto for cyborgs: science, technology, and socialist feminism in the 1980s. Socialist Review, no. 80, 65-108.
Holl, S., Pallasmaa, J. & Perez-Gomez (2007). A. Questions of Perception: Phenomenology of Architecture. San Francisco: William K Stout Pub.
Jencks, C. & Baird, G. (ed) (1974). Il significato in architettura. Bari: Dedalo.
Jullien, F. (2004). A Treatise on Efficacy. Between Western and Chinese Thinking. Honolulu: University of Hawai Press.
Koolhaas, R. (1978). Delirious New York. A Retrospective Manifesto for Manhattan. New York: Oxford University Press.
Luhmann, N (2012). Introduction to Systems Theory. Cambridge: Polity Press.
Moneo, R. (1989). “The Solitude of Buildings”, A+U: architecture and urbanism, 227.
Norberg-Schulz, C. (1967). Intentions in Architecture. Cambridge & London: The MIT Press.
Norberg-Schulz, C. (1975). Meaning in Western Architecture. New York: Praeger Publisher.
Norberg-Schulz, C. (1979), Genius Loci. Paesaggio, Ambiente, Architettura. Milano: Electa.
Paci, E. (1961). Tempo e verità nella fenomenologia di Husserl. Roma-Bari: Laterza.
Paci, E. (1965). Relazioni e significati. Milano: Lampugnani Nigri.
Pallasmaa, J. (1996). The Eyes of the Skin. Architecture and the Senses. New York: John Wiley & Sons.
Pareyson, L. (1954). Estetica. Teoria della formatività. Torino: Edizioni di Filosofia.
Ponti, G. (1957). Amate l’architettura. Genova: Società Editrice Vitali e Ghianda (Quodlibet, 2022).
Preciado, P. B. (2020). Un appartamento su Urano. Cronache del transito. Roma: Fandango libri.
Preciado, P. B. (2022). Dysphoria Mundi, Paris: Grasset.
Rogers, E. N. (1958). Esperienza dell’architettura. Torino: Einaudi (Skira, 2002).
Rogers, E. N. (1961). Gli elementi del fenomeno architettonico. Roma-Bari: Laterza (Marinotti, 2006).
Rowe, C. (1994). The Architecture of Good Intentions. Towards a Possible Retrospect. London: Academy.
Vitali, W. (Ed.). Un'Agenda per le città. Nuove visioni per lo sviluppo urbano. Bologna: Il Mulino.
Ward, C. (1973). Anarchy in Action. London: Freedom Press.
Windhoff-Héritier, A. (1992). City of the Poor, City of the Rich: Politics and Policy in New York City. Berlin: de Gruyter.
Procedura:
Per partecipare alla call, inviare all'indirizzo redazione@philosophykitchen.com, entro il 16 luglio 2023, un abstract di massimo 4.000 caratteri, indicando il titolo della proposta, illustrando la strutturazione del contributo e i suoi contributi significativi, e inserendo una bibliografia nonché una breve biografia dell’autore o dell’autrice.
L'abstract dovrà essere redatto secondo i criteri scaricabili qui [Template Abstract], pena esclusione.
Le proposte verranno valutate dai curatori e dalla redazione. I contributi selezionati, che saranno sottoposti a double-blind peer review.
Lingue accettate: italiano, inglese, francese.
Calendario:
- 16 luglio 2023: consegna degli abstract
- 03 settembre 2023: comunicazione degli esiti
- 17 dicembre 2023: consegna dei contributi selezionati
- 03 luglio 2023: comunicazione degli esiti della selezione
- Primavera 2024: circolazione dei pezzi tra gli autori
- Settembre 2024: pubblicazione del volume
-
Non è certo facile restituire la complessità e la densità del volume di Maurice Merleau-Ponty, Il mondo sensibile e il mondo dell’espressione (Mimesis 2021), recentemente tradotto e curato per il pubblico italiano da Anna Caterina Dalmasso, senza dubbio una delle studiose più autorevoli del pensiero del filosofo francese (suo l’importante saggio di Introduzione, pp. 17-52). Non è facile innanzitutto per la stessa natura di questo (non) libro, che raccoglie il materiale del filosofo prodotto in vista del suo primo corso al Collège de France dell’a.a. 1952-53. Il volume contiene tanto l’effettivo materiale utilizzato dal filosofo nelle sue esposizioni orali, quanto appunti che ne ampliano e approfondiscono l’orizzonte teoretico.
L’opportunità per il pubblico italiano di studiare e apprezzare il pensiero di Merleau-Ponty svolto al Collège si amplia così, dopo la traduzione di altri corsi avvenuta a cavallo tra la fine del secolo scorso e l’inizio del millennio: La nature (Seuil, 1995, tr. it. Cortina, 1996) e Notes de Cours 1959-1961 (Gallimard, 1996; tr. it. Cortina, 2003). Quello che qui discuteremo è stato pubblicato nel 2011 dall’editore svizzero MētisPresses[1] sotto la direzione scientifica di E. de Saint Aubert e di S. Kristensen e la traduzione italiana permette di accedere a un materiale teorico molto fecondo, sia per chi si occupa direttamente di Merleau-Ponty sia per chi sia interessato al pensiero francese del Novecento. In queste quattordici lezioni, infatti, si anticipano o si sviluppano in modi originali piste che attraversano, carsicamente a volte, altre in superficie, una tradizione di pensiero gravida ancora oggi di ampi sviluppi teorici. Lungi dall’essere una pubblicazione per soli addetti ai lavori, questo volume può essere di grande aiuto a chi volesse comprendere meglio alcuni intrecci - sia detto solo a titolo di esempio non esaustivo — tra Gestaltpsychologie e filosofia dell’esistenza, tra bergsonismo e fenomenologia, nonché — come segnala la Prefazione di Mauro Carbone (pp. 9-16) foriera di stimolanti riflessioni sull’arte e l’estetica. Insomma, pur non essendo di facile accesso — e tuttavia l’ottimo lavoro di Dalmasso aiuta chi non fosse specialista — il volume non potrà che trovare interesse in molti ambiti degli studi filosofici contemporanei.
Qui ci proponiamo di tracciare una possibile via d’accesso in questo universo filosofico ancora da esplorare anche da parte di chi, da molti anni, vi si dedica con studio attento. Come ogni pista d’accesso, non ne impedisce di altre e non può essere pienamente esaustiva della ricchezza contenuta nelle quasi trecento pagine del volume. Tuttavia, può essere utile a meglio orientarvisi. Come segnala la curatrice, il volume ha il merito di offrire «un punto di vista privilegiato» (p. 17) sul back-office della produzione di Merleau-Ponty, un vero e proprio laboratorio artigianale di concetti situato al fondo del lavoro pubblicato in vita dall’autore.
A differenza degli altri corsi già tradotti per il lettore italiano, la peculiarità de Il mondo sensibile e il mondo dell’espressione consiste nel fatto che esso ci mostra un Merleau-Ponty sul punto di farsi, che non è più quello della Fenomenologia della percezione e non è ancora quello de Le avventure della dialettica, un Merleau-Ponty per così dire “intermedio”, in divenire (Lanfredini 2011): «Le note del corso del ’53 — continua Dalmasso — offrono un insieme di argomentazioni e di fonti in grado di gettare luce su alcuni punti più oscuri o anelli mancanti della riflessione merleau-pontiana successiva» (p. 18). Insomma, il corpus magmatico di questo volume permette, a chi voglia avventurarvisi, di «cogliere “un filosofo al lavoro” e di “accompagnare Merleau-Ponty” nel farsi del suo lavoro» (p. 20). Una vera e propria avventura filosofica che permette al lettore di oggi di risemantizzare molte antinomie che nel nostro presente appaiono ovvi se non addirittura vetusti. Del resto, non siamo noi oggi figli di quella temperie culturale che genericamente potremmo definire post-moderna e che ha fatto della lotta al manicheismo dualistico la sua pars destruens ? È un pensiero non dualistico, senza per questo, vedremo, rinunciare alla duplicità, quello che l’autore — che ovviamente di post-moderno non sapeva nulla — prova a mettere in forma, e che noi abbiamo occasione di studiare proprio nell’atto del suo generarsi.
Mondo sensibile e mondo dell’espressione definiscono un’antinomia che trova le proprie radici, a voler estremizzare, quanto meno nella distinzione platonica tra mondo ideale e mondo sensibile. Se si volessero fissare delle tappe a noi più vicine — come sempre troppo semplicistiche, ma utili a orientarsi — sensibile ed espressione rimandando alle distinzioni moderne di Descartes (quella tra materia estesa e pensiero inesteso) e di Kant (mondo sensibile della natura e mondo intelligibile dei valori) generalizzabile nella distinzione del pensiero antropologico tra natura e cultura (Lévi-Strauss 1969 pp. 39-52; Descola 2005). Già dunque nel tema stesso delle lezioni contenute in questo volume si comprende lo sforzo teorico che le sottende, un lavoro filosofico e fenomenologico che chiama in causa le principali architravi del nostro sensus communis moderno.
Potrebbe essere utile contestualizzare brevemente queste note di corso (si rimanda all’introduzionedella curatrice per i dettagli). L’anno accademico, come detto, è il 1952-53 ed è l’esordio di Merleau-Ponty al Collège de France, dopo che ha già tenuto il suo Elogio della filosofia nella lezione inaugurale (Merleau-Ponty, 2008) e mentre sta aprendo il cammino che lo consacra ai livelli più alti della cultura e della filosofia francese e forse mondiale. Non sono anni facili, gli anni Cinquanta, sia a livello storico (sono gli anni della guerra fredda, delle prime notizie in occidente del regime staliniano, della guerra di Corea, ecc.) sia a livello personale (Merleau-Ponty ha in cantiere La prosa del mondo che resterà incompiuto, sta rivedendo le sue posizioni rispetto all’URSS espresse in Umanismo e terrore del 1948, ma, soprattutto, sta per rompere il grande sodalizio filosofico e affettivo con J.-P. Sartre). Sul piano scientifico ha qualche sassolino nelle scarpe dopo la conferenza del 1946 presso la Société de philosophie dal titolo Il primato della percezione e le sue conseguenze filosofiche (Merleau-Ponty2004) nella quale presentava davanti a un pubblico composto dalle migliori menti filosofiche del tempo i risultati conseguiti con Fenomenologia della percezione. Amici e colleghi (Hyppolite, Bréhier, Lachièze-Rey per citarne alcuni) accolgono in maniera polemica e critica la tesi di fondo di quel libro accusandolo in alcuni casi di sensismo e positivismo. La sensazione di non essere stato compreso si radica nel filosofo e sette anni dopo è proprio da quella discussione che, con certosina attenzione, riparte (p. 61). Il primato della percezione diventa un punto di partenza ottimale per penetrare nel fitto bosco del sensibile e dell’espressione.
Sin dalla prima lezione, quasi un brevissimo compendio di Fenomenologia della percezione, emerge il tema cruciale con un gusto programmatico. Si tratta, cioè, di pensare l’unità del mondo percepito tale che questa unione non sia la “sintesi determinante”, la sintesi intellettuale, cioè, di una molteplicità sensoriale di stimoli empirici. L’unità cercata nella sua opera principale (ma anche in La struttura del comportamento del 1942) non era una sintesi del giudizio, ma di ordine “percettivo”. Si può dunque capire come qui emergano molte ambiguità che il filosofo dovrà in qualche modo dipanare.
Primato della percezione non significa postulare l’esistenza delle cose fuori di me o la corrispondenza oggettiva di mondo e conoscenza né di opporre a una filosofia intellettualista un empirismo sensista à la Hume, bensì di «fare una teoria concreta dello spirito» (p. 59). Il primato della percezione non postula «un primato del sensoriale, del dato naturale» (p. 60), ma è ricerca di un piano originario che non sia né empirico né trascendentale in cui il sensibile e l’espressione possano divenire indiscernibili: è lo statuto stesso della fenomenologia a modificarsi con questo primato. Fenomenologia della percezione non sta ad indicare solo che è possibile trattare la percezione come “noema”, ma che nel farlo si segue il divenire della percezione nel suo stesso attuarsi, ossia che la percezione indica un piano ontologico intermedio tra l’essere oggettivo e l’essere soggettivo. Si può trattare fenomenologicamente la percezione solo se essa non è né l’oggetto di un sapere né il soggetto della sensazione. È questo né né a non essere stato compreso alla Société nel ’46 (pp. 61-62). Il punto è che la percezione non rimanda solo al mondo del sensibile, ma implica anche un carattere espressivo: «Intenderemo qui per espressione o espressività la proprietà che ha un fenomeno, per la sua organizzazione interna, di farne conoscere un altro che non è dato o che non è mai stato dato. […] È in questo […] senso che la percezione è espressione, espressione del mondo» (pp. 62-63).
Fare una fenomenologia della percezione è studiare il farsi del mondo, una fenomenologia che acquista sempre più caratteristiche “hegeliane” (Vuillerod, 2018) risemantizzando il concetto di coscienza. Se c’è percezione, infatti, non è detto che vi sia necessariamente soggetto (nel senso del Cogito trascendentale che accompagna ogni io empirico), ma vi è senz’altro coscienza, che non è il pieno possesso di sé che la tradizione cartesiana e kantiana ci ha consegnato. La coscienza percettiva non è esterna alle cose, si situa tra di esse, ma non è cosa estesa tra cose estese: essa si fa negli scarti, nelle differenze (cromatiche, uditive, sensibili…) tra le cose, è trans-individuale (Ruyer 2018; Simondon 2011), passività creativa (Ménasé 2003). A differenza di quella trascendentale, essa «non ha a che fare con valori […], ma con esseri esistenti» (p. 64). Potremmo dire, cioè, che attraverso il primato della percezione Merleau-Ponty intraveda la possibilità di emancipare la coscienza percettiva dalla sovranità dell’intelletto dell’estetica trascendentale e di riscoprire nella materialità il suo proprio valore/valere.
L’espressività della percezione — il suo “primato” — è dunque ontogenetico, essa non è la facoltà inferiore della coscienza — come all’origine dell’estetica riteneva, ad esempio, A.G. Baumgarten (1993: 41) — ma la sua espressione “sensibile”, è «configurazione, struttura» (p. 65). Ecco un secondo termine fondamentale nel lessico merleau-pontiano che richiama il suo primo grande libro, La struttura del comportamento. Il primato della percezione implica una materialità della coscienza percettiva da intendersi come processo di strutturazione. Se la percezione non è (solo) la passività di un soggetto empirico, ma l’attività — quantunque “passiva” — di una coscienza “materiale”, allora essa è a tutti gli effetti concepibile nei termini di un comportamento (nel senso, ad esempio, in cui quantisticamente una particella ha un comportamento), un’attività vincolata ad un mondo-ambiente. L’espressione percettiva non è un atto puro, ma una prassi “situata” in uno “sfondo” di passività. Il richiamo è qui alla Gestaltpsychologie, che Merleau-Ponty aveva studiato attentamente nel libro del 1942 (e che nel corso affronta tra la settima e la nona lezione). Ogni coscienza percettiva è una figura (Gestalt) che emerge da uno sfondo e «vi è sempre qualcosa di inarticolato e di sottinteso in ciò di cui vi è coscienza» (p. 67). Lungi dall’essere un’astratta sensazione senza soggetto, l’espressione sensibile è un processo di figurazione (Gestaltung) e la coscienza percettiva è una figura o forma materiale. La coscienza percettiva non è un cogito ma un corpo, non un’anima che emerge e s’innalza dalla materia, ma l’individuazione, l’attività immanente, la configurazione sensibile e materiale di un corpo. Il primato della percezione è il primato del corpo sull’anima, non nel senso “empiristico-naturalistico” di un primato dell’esteso sull’inesteso, ma di una indiscernibilità tra il mondo sensibile della corporeità e la sua espressione animale.
Allora fenomenologia diviene sinonimo di strutturazione ontologica — «non vi è differenza tra ontologia e fenomenologia» (p. 61) — e il primato della percezione conduce a una ontologia dinamica e processuale (Vanzago, 2001). Il mondo dell’espressione non è riducibile a un mondo formale, ha una sua materialità; il sensibile non è inerte o passivo. C’è espressività sensibile tanto quanto vi è sensibilità “spirituale”. Né inerte né formale: l’espressività del sensibile è movimento e la fenomenologia della percezione è manifestazione non richiudibile negli steccati formali dell’estetica trascendentale, poiché non vi è più un primato del formale estetico (dello spazio e del tempo formali). Si avvia qui quello che con Husserl (1991) potremmo chiamare rovesciamento della rivoluzione copernicana: è il movimento a determinare le forme del tempo e dello spazio, non il contrario. Anzi: spazio e tempo non sono più forme, ma figure (Gestalten). Il movimento (si veda in particolare la sesta lezione) è il fenomeno espressivo per eccellenza, tutt’altro dunque che l’esito di una rappresentazione soggettiva. Come la percezione, esso non è l’oggetto di un sapere né l’attributo di un cogito (p. 99), ma è qualcosa che può essere solo sentito, in cui si manifesta il movente. Non è neppure un mero accidente che capita a un oggetto empirico, non è, cioè, la variazione di luogo nel tempo di una “cosa” (Sache), ma il fenomeno per il quale “qualcosa” (Ding) si esprime, emerge spazialmente e temporalmente (geograficamente e storicamente) in quanto figura su sfondo.
Il movimento espressivo è l’installazione sensibile di una coscienza percettiva nel cuore dello spazio e del tempo, il suo modo di abitare lo spazio e il tempo (p. 103), i quali non sono relazioni formali né empiriche, bensì modali. C’è movimento, ovvero qualche cosa appare, c’è della percezione, c’è del comportamento, c’è della coscienza, c’è figurazione: espressione di un’immagine materiale. Il movimento espressivo (siamo alla quarta lezione del corso) è «spirito che si fa corpo e corpo che si fa spirito […] una logica del funzionamento percettivo» (p. 105). Rovesciamento della fenomenologia hegeliana: fenomenologia e logica della percezione; il corpo è lo spirito, il mondo sensibile esprime il mondo spirituale; l’unione non è sintesi assoluta, ma l’affinità trascendentale (p. 107) dello spirito col sensibile in sopravanzamento (overlapping) l’uno sull’altro, «sintesi di enjambement» (p. 109).
Il movimento espressivo è la sintesi senza concetto di spazio e tempo. La mente va a Bergson che più di chiunque altro nel Novecento si è sforzato di pensare il soggetto implicato nel movimento (pp. 119-125). Dopo aver esposto, all’inizio della sesta lezione, gli «argomenti di Zenone» (p. 118) sull’impossibilità ontologica del movimento, Merleau-Ponty vi si richiama: «Per lui quello che rende impossibile il movimento nel pensiero di Zenone è la divisione infinita e attuale del tempo e dello spazio, […] per rendere possibile il movimento occorre che il tempo e lo spazio siano divisibili, ma non divisi, che, posti a partire dal tutto, ammettano uno spazio “tra” le posizioni e gli istanti, cosa che non è possibile nell’in sé. È quindi necessario che il movimento , che è fatto del mondo, sconfini su di me come durata, sia anche fatto di coscienza» (p. 119). Tuttavia, Bergson nel cercare un tout indivisé del movimento è ancora troppo intellettualista, «resta coscienziale» (p. 121). Occorre essere, si legge tra le righe delle note di lavoro, più bergsoniani di Bergson, il quale «trionfa su Zenone mostrando che il tempo non è fatto di istanti né lo spazio di limiti di spazio, ed è vero. Ma resta da esplicitare la conseguenza […] crede che il problema sia concluso» (p. 239). Diventa necessaria «una teoria del corpo percipiente» (p. 240), un paradigma del corpo (Iofrida 2019) che troviamo tra l’undicesima e la tredicesima lezione (nel cuore, dunque, del corso): il movimento è sì un dato immediato della coscienza, ma di una coscienza percettiva, una coscienza-immagine che sia la sintesi esistenziale (materiale) della durata, la quale viene così reinterpretata come espressione sensibile, immagine-spaziotempo, figurazione espressiva.
La durata bergsoniana è “astratta” e manca, agli occhi di Merleau-Ponty, la “e”tra sensibilità ed espressività, una unità (dodicesima lezione) non teoretica, ma pratica, «unità dello schema corporeo […] unità di un’azione sul mondo, di una prassi» (p. 187), non nel senso di un pragmatismo utilitaristico (che per Merleau-Ponty manterrebbe la sussunzione dell’azione sensibile a uno scopo sovrasensibile), ma come attività passiva di creazione di immagini, una prassi che «comporta una teoria [Theoria] o gnosis che ne è lo sfondo, che essa modifica e che a sua volta la modifica» (ibidem). La durata espressiva è unità di teoria e di prassi, una praktognosia che non è un pragmatismo — esiste una materialità dei valori — né un empirismo — c’è, come rileva Dalmasso, una intenzionalità del sensibile (pp. 46-52). La durata come congiunzione del mondo sensibile e del mondo dell’espressione, una unità che si può a buon diritto definire estetica (se con Kant intendiamo “estetica” l’unità senza concetto, pre-logica).
Non è un caso che i corsi del ’53 si chiudano (quattordicesima lezione) con delle considerazioni sull’Arte in generale, e sul cinema in particolare. Le considerazioni estetiche di Merleau-Ponty sul cinema meriterebbero ben altre analisi (si rimanda ai lavori di Carbone e di Dalmasso), qui ci limitiamo solo a trarre una brevissima conclusione. Il cinema è la “prova ontologica” del primato della percezione e del movimento espressivo. Esso è una ritmologia della durata dell’immagine, un contrappunto di punti di vista, di immagini che sopravanzano l’una sull’altra. Nell’arte cinematografica si realizza l’unità di sensibile ed espressione, il vinculum substantiale di una molteplicità di immagini sensibili senza sussunzione entro i decreti formali dell’intelletto trascendentale. Nel movimento cinematografico appare una vera e propria monadologia sensibile (p. 64) che si insinua nel mezzo dei due mondi, che sono “separabili” ma non separati e nelle cui pieghe emergono molteplici mondi intermedi. Come scrive Carbone, nel cinema «si celebra il venire ad espressione […] del mondo sensibile» (p. 16).
Questi mondi intermedi sono il legame tra mondo sensibile e mondo dell’espressione e costituiscono l’ambiente originario nel quale la nostra capacità creativa di corpi animali o anime materiali riesce a trovare spazio per esprimersi e manifestarsi attraverso un’inaspettata fenomenologia dello spirito-carne che solo un primato della percezione può rendere visibile. Già solo questa breve conclusione a cui perviene Merleau-Ponty nei corsi dedicati alla duplicità sensibile/espressione, forse, vale da sola lo studio attento di questo volume.
di Gianluca De Fazio
[1] L’editore continua ancora oggi il suo lavoro di pubblicazione dei corsi al Collège de France di Merleau-Ponty. Si segnala il numero monografico dedicato al Mondo sensibile e mondo dell’espressione della rivista Chiasmi International (n. s. 12-2010).
Bibliografia
Baumgartem, A.G. (1993), Progetto dell’estetica, in A.G. Baumgarten, I. Kant, Il battesimo dell’estetica, a cura di L. Amoroso, ETS, Pisa.
Descola, P. (2005), Par-delà nature et culture, Gallimard, Paris.
Husserl, E. (1991), Rovesciamento della dottrina copernicana della corrente visione del mondo, «Aut-Aut», 245, pp. 3-18.
Iofrida, M. (2019), Per un paradigma del corpo: una rifondazione filosofica dell’ecologia, Quodlibet, Macerata.
Lanfredini, R. (2011, a cura di), Divenire di Merleau-Ponty. Filosofia di un soggetto incarnato, Guerini, Milano.
Lévi-Strauss, C. (1969), La struttura elementare della parentela, a cura di A.M. Cirese, Feltrinelli, Milano.
Ménasé, S. (2003), Passivité et création. Merleau-Ponty et l’art moderne, PUF, Paris.
Merleau-Ponty, M. (2004), Il primato della percezione e le sue conseguenze filosofiche, a cura di R. Prezzo, F. Negri Medusa, Milano.
Merleau-Ponty, M. (2008), Elogio della filosofia, a cura di C. Sini, SE, Milano.
Ruyer, R. (2018), Neofinalismo, a cura di U. Ugazio, V. Cavedagna, G. Vissio, Mimesis, Milano-Udine.
Simondon, G. (2011), L’individuazione alla luce delle nozioni di forma e d’informazione, a cura di G. Carrozzini, Mimesis, Milano-Udine.
Vanzago, L. (2001), Modi del tempo: simultaneità, processualità e relazionalità tra Whitehead e Merleau-Ponty, Mimesis, Milano-Udine.
Vuillerod, J.B. (2018), Merleau-Ponty hégélien?, «Chiasmi International», n.s. 19, pp. 101-114.
-
Alexandre Gefen: l’idea di letteratura in Francia
Recensioni / Aprile 2022L'Idée de littérature. De l'art pour l'art aux écritures d'intervention (éditions Corti, 2021) propone un’analisi dei tratti costitutivi dell’idea di letteratura attualmente diffusa in Francia, cogliendone l’evoluzione dal punto di vista storico, geografico, tematico e generico. Particolare attenzione è riservata al panorama critico francese e alle influenze dal mondo anglosassone (studi postcoloniali, studi culturali, studi areali), nonché all’apporto di aree come le neuroscienze, l’antropologia e la sociologia. Vengono infine esaminate le attuali pratiche di scrittura, anche non professionale, nel quadro della diffusione delle nuove tecnologie.
Partendo dall’osservazione dei più recenti fenomeni del mondo letterario, come il dibattito suscitato dal conferimento del premio Nobel per la letteratura a Bob Dylan nel 2016, la scelta di Svetlana Aleksievič per il precedente o le reazioni del movimento #Metoo, l’autore riflette sulla crisi teorica attualmente in corso, che si realizza con il passaggio da una concezione di letteratura come sfera autonoma a una littérature-monde (p. 37), inclusiva e democratica, consapevole del proprio ruolo nella formazione delle coscienze, incline a dar voce alle minoranze e rivolta a un pubblico ampio, libera dai formalismi e dai generi tradizionali e aperta alle contaminazioni con altre arti e discipline. Per Gefen, tale concezione si realizza grazie al superamento di una visione idealista, estetica ed estetizzante della letteratura, nata con il Romanticismo e basata sull’ordine soggettivo, qualificata dalla forma e comprensibile unicamente attraverso una disciplina endogena (la stilistica) o connessa al proprio campo (linguistica, semiologia o narratologia).
Per comprendere questa “rivoluzione silenziosa” (p. 37), l’autore ripercorre l’evoluzione dell’idea di letteratura nella sua accezione moderna a partire dal XIX secolo e dal Romanticismo, periodo del quale la concezione contemporanea è ancora ampiamente tributaria. A partire da questo momento, come noto, la letteratura acquisisce la propria autonomia inserendosi nello spazio dell’estetica, andando incontro alla disgiunzione del concetto di bello dall’oggetto rappresentato e alla liberazione dai canoni classici. La concezione dell’Art pour l’art, con il rifiuto dell’idea di utilità o utilitarismo, costituisce una tappa fondamentale di tale evoluzione. Nel corso del Novecento fino a oggi, l’idea estetica della letteratura ha configurato il campo letterario, determinandone la storia e la geografia, tracciandone la sociologia e influenzando la teoria dei generi e l’analisi delle pratiche di scrittura. Secondo l’autore, la riformulazione di tale paradigma, a cui tendono le opere, le pratiche e le teorie contemporanee, dovrebbe indurre a riconsiderare il progetto di autonomia estetica, riconducendolo a una semplice parentesi nella storia. Dal processo in corso, emerge una concezione dell’opera d’arte come oggetto culturale, nonché un maggiore interesse per le istituzioni e le relazioni di potere. In questo quadro, la critica postcoloniale mette in discussione l’universalità del giudizio estetico, chiedendo la sostituzione di categorie astratte con criteri locali e relativi e contestualizzando le produzioni.
Il secondo capitolo, dedicato all’estensione geografica della letteratura, ripercorre le principali tappe della formazione di un modello storicamente teleologico, elaborato a partire dal XIX secolo e legato alla formazione di nazionalismi letterari, estetici e linguistici. La nascita degli studi di comparatistica e la fabbricazione di un’idea occidentale dell’oriente conducono a un’apertura che resta però tendenzialmente eurocentrica, con metodi difficilmente applicabili in aree culturali lontane e variegate dal punto di vista antropologico. Da questo punto di vista, Gefen sottolinea la necessità odierna di ripensare la letteratura, privandola di modelli unidimensionali, con una temporalità policronologica e multidirezionale, relativizzando la struttura moderna del soggetto e il quadro occidentale in cui esso si esprime.
Sul piano tematico, l’autore individua nella letteratura contemporanea la realizzazione di un nuovo stadio del Realismo delle rappresentazioni, come già Auerbach aveva descritto nel fondamentale saggio Mimesis, qui rievocato (p. 109). Se il XIX e il XX secolo erano incentrati sull’esplorazione dell’esperienza umana nelle sue diverse sfaccettature, il XXI secolo si espande alla sfera dell’agentività non umana. A partire dagli anni 2000, con la globalizzazione e la presa di coscienza ecologica su scala mondiale, il potere di rappresentazione della letteratura viene riattivato per descrivere le forze socio-economiche. Inoltre, la funzione di critica sociopolitica si estende alla questione ambientale e i nuovi temi della letteratura relativizzano l’antropocentrismo precedentemente dominante. Con il rimescolamento ontologico causato dalla rivoluzione digitale, l’estensione del campo mimetico oltre la sfera dell’umano e l’attenzione al mondo della natura e agli oggetti, il campo della letteratura contemporanea si trova ormai di fronte a un “multirealismo”, concetto di Bruno Latour qui ripreso (p. 143). Il fenomeno porta all’indebolimento delle frontiere che separano i diversi generi letterari che, come categorie della percezione estetica, entrano in crisi. A caratterizzare le opere sono le finalità dei dispositivi, la maniera di produrre senso o la specificità cognitiva, i nuovi supporti digitali e l’esplorazione di regimi semiotici originali. Un tale movimento di decomposizione dei generi ha effetto anche sulle frontiere esterne della letteratura, sfumando la linea di demarcazione tra letterario e non letterario. Come sottolinea l’autore, le recenti etichette di neoletteratura (Nachtergael 2017), non-letteratura (Théval 2018) o di mondo postletterario (Colard 2018), testimoniano questo cambiamento.
Il capitolo dedicato all’estensione politica sottolinea come la concezione della letteratura come campo autonomo registri attualmente una perdita di rigidità a favore della nozione di relazione e dell’esigenza di intervento nel mondo. La fecondità morale e l’utilità cognitiva che contraddistinguevano le Belles Lettres in epoca classica rinascono in maniera eclatante nel mondo contemporaneo. Nella genealogia dell’Art pour l’art, le nozioni di désengagement e il principio di inutilità erano centrali per il principio moderno di autonomia della creazione. L’inutilità costituiva una qualità essenziale del campo estetico e lo scrittore era visto come una personalità in rottura con il mondo. Come sottolinea l’autore, la nostra epoca rinnova il legame con un’arte più politica e invita a relativizzare retrospettivamente la portata delle teorie insulari dell’arte. Dietro alla semplice nozione di utilità sociale, rinasce l’idea di una funzione cognitiva, antropologica e politica. Si parla nuovamente di poteri, di virtù, di ruoli, del posto della letteratura nelle questioni del mondo. Gli approcci cognitivisti, che sottolineano la funzione sociale della letteratura, permettono di reintrodurre la psicologia dei personaggi e dell’autore e propongono una descrizione cognitivista degli stili e delle forme. Altro segno dell’evoluzione, secondo Gefen, è l’impegno ritrovato degli scrittori contemporanei, in particolare sul piano dell’analisi del discorso, con lavori d’inventario sociale a favore della democrazia e della difesa delle minoranze. Gli scrittori percepiscono il loro lavoro come un dispositivo performativo che influenza la costruzione della realtà sociale e come un gioco ermeneutico, centrato sul testo e sulla sua enigmaticità. La descrizione a distanza della realtà si riappropria così dell’esigenza di dévoilement assegnatale da Sartre. Gli autori contemporanei si interessano alla questione dei migranti, all’evocazione dei crimini coloniali e delle tensioni sociali contemporanee e mirano ad allontanare i pericoli di un’identità percepita come essenza eterna. Al romanzo viene riconosciuto non solo il potere di riflettere, ma anche quello di informare e di costruire realtà sociali. La nuova fase di democratizzazione della letteratura, che subentra con la fine dell’elitismo, rivede inoltre la questione della responsabilità dell’autore, mentre le figure del dandy e dello scrittore invisibile tendono simultaneamente a scomparire, con la dissoluzione dell’opposizione proustiana tra l’“io sociale” e l’“io profondo” (p. 241).
Per quanto riguarda i più recenti mutamenti che investono le pratiche di scrittura, su cui l’autore si sofferma, si assiste a un processo di democratizzazione, caratterizzato dalla pubblicazione di testi online e dall’emergenza di autori non professionisti, fenomeni che la critica francese tarda a cogliere. L’estensione del campo si scontra con un riflesso culturale di protezione di una letteratura vista come ristretta e fondata sulla padronanza della forma, nella quale qualità e quantità si oppongono strutturalmente. Secondo questa visione, l’arte è concepibile unicamente secondo un regime maltusiano, con un canone di opere selezionate che si distingue da una produzione di consumo e da forme di espressione ordinarie (p. 255).
Il volume si chiude con considerazioni legate alle conseguenze che i fenomeni descritti esercitano sulla critica letteraria. L’autore sottolinea la necessità di adottare approcci idonei ai nuovi oggetti di analisi, con una presa di consapevolezza dei limiti del vocabolario della retorica e della linguistica e l’adozione di una terminologia descrittiva nuova, ad esempio attingendo dall’antropologia come nel caso di “densità” per definire la bellezza. Per rispondere all’estensione del concetto di letteratura e all’interdisciplinarietà che lega gli studi contemporanei e i diversi settori accademici, viene sottolineata la necessità di mobilitare conoscenze e metodi nuovi, come avviene nel passaggio dall’intertestualità di Julia Kristeva all’intermedialità di Jürgen Ernst Müller (p. 283). L’autore promuove una maggiore apertura degli studi letterari, con l’avvicinamento alle scienze sociali, alla teoria dei media, alla filosofia, agli studi culturali, alle scienze cognitive e alla teoria dell’informazione.
L’idée de littérature si presenta come un lavoro originale per la quantità e la qualità delle fonti citate nonché per le riflessioni di natura globale sull’idea di letteratura. L’apertura ad altre discipline, che l’autore condivide, si riflette nell’estensione della ricerca ad aree meno comuni, rievocando, come già sottolineato, metodi e approcci di aree quali la sociologia, la psicologia cognitiva e l’antropologia. Il vasto panorama critico considerato include lavori di ricerca europei e americani, proponendo un fruttuoso canale comunicativo. Attraverso il confronto con gli studi culturali e postcoloniali, lo scritto partecipa al difficile percorso di integrazione di queste correnti in una Francia ancora largamente incentrata sul concetto di francofonia, categoria secondo alcuni da superare in quanto espressione di una visione colonialista (p. 100; Forsdick e Murphy 2003 p.7-8; Moura 2008, pp. 55-61; Genin 2006, pp. 43-55). Con il riferimento alla letteratura mondiale, l’autore si inserisce in un dibattito che da più di due secoli (Goethe, Moretti, Casanova, Spivak, Damrosch) ruota attorno a questo concetto, come descritto da Pradeau, Samoyault (2005) e da David (2011). Gefen rievoca le critiche rivolte all’idea di letteratura universale proposta da Goethe, accusata di eurocentrismo o dominocentrismo ad esempio da Jérôme David (p. 92), e ripropone il dibattito che ha preso forma attorno alla pubblicazione del manifesto “Pour une littérature-monde en français” nel 2007, documento per la liberazione della letteratura dal patto esclusivo con la nazione che rischiava secondo alcuni di promuovere un paradigma unico e una prospettiva americana ed egemonica (p. 100). L’autore si esprime a favore del concetto letteratura mondiale, in grado, come afferma, di liberare la storia letteraria dal suo percorso teleologico (p. 102).
Le riflessioni sul ruolo dello scrittore nella società, sulla transitività e sulla funzione dell’opera letteraria, nonché sulla responsabilità dello scrittore si inseriscono nella ricerca che indaga il rapporto tra il testo narrativo e le idee politiche, le diverse concezioni di engagement e le modalità con le quali esso si esprime nel testo letterario (Suleiman 1983; Denis 2000; Sapiro 2011). Gefen aveva precedentemente esaminato la complessità delle strategie moderne di impegno e individuato alcune tendenze che contraddistinguono l’engagement contemporaneo (2005 p. 75-84). L’idée de littérature affronta il discorso della responsabilità e del ruolo dello scrittore nella società, mostrando come la concezione contemporanea della letteratura inauguri una nuova fase in cui mondo letterario e mondo civile, istituzioni letterarie e vita della comunità politica, economia letteraria ed economia comune cessano di opporsi (p. 241).
Il capitolo sull’estensione sociologica e istituzionale della letteratura si inserisce negli studi sul rapporto con le nuove tecnologie, dalla narratologia transmediale (Ryan 2002, 2018) alle recenti pratiche di scrittura in ambiente digitale, anche ad opera di scrittori non professionisti (Goldsmith 2018; Price e Siemens 2013). Il lavoro si basa su un’osservazione diretta di tali ambienti e pratiche, con particolare attenzione alla piattaforma Wattpad, alla quale l’autore si è ulteriormente interessato («Wattpad et la démocratisation de la littérature par Internet », in corso di pubblicazione). Per gli studi sui temi e sui generi e i contributi sull’apporto di discipline come la sociologia, la psicologia cognitiva e l’antropologia, rimandiamo alla bibliografia a fine volume, che mostra il ricco lavoro di documentazione e costituisce un valido punto di partenza per ricerche aperte al panorama critico internazionale.
di Virginia Melotto
BIBLIOGRAFIA
Colard, J.-M. (2018), «Bienvenue dans un monde post-littéraire», AOC, 6 septembre 2018, disponibile online: https://aoc.media/critique/2018/09/06/bienvenue-monde-post-litteraire/
David, J. (2011), Spectres de Goethe, Les métamorphoses de la "littérature mondiale", Paris, Les prairies ordinaires.
Denis, B. (2000), Littérature et engagement : de Pascal à Sartre, Paris, Éd. du Seuil, coll. « Points Essais ».
Forsdick, C. & Murphy D. (2003), Francophone Postcolonial Studies. A Critical Introduction, Oxford University Press Inc.
Gefen, A. (2005), « Responsabilités de la forme. Voies et détours de l’engagement littéraire contemporain », in Bouju, E., (dir.), L’Engagement littéraire, Rennes, PUR, coll. « Interférences ».
Id. (in corso di pubblicazione), «Wattpad et la démocratisation de la littérature par Internet », in La Démocratisation de la littérature, Paris, Gallimard, « Cahiers de la NRF ».
Genin, C.(2006), « Les études culturelles: une résistance française ? », MEI, no 24-25 (« Études culturelles / Cultural Studies »), pp. 43-55.
Goldsmith, K. (2018), L’Écriture sans écriture : du langage à l’âge numérique [Uncreative Writing : Managing Language in the Digital Age, 2011], Paris, Jean Boîte éditions.
Moura, J.-M. (2008), Sur la situation des études postcoloniales francophones, «Neohelicon».
Nachtergael, M. (2017), « Le devenir-image de la littérature : peut-on parler de “néo-littérature” ? », in Mougin, P. (dir.), La Tentation littéraire de l’art contemporain, Dijon, Les Presses du Réel, coll. « Figures », pp. 139-152.
Pradeau, C. & Samoyault, T. (dir.) (2005), Où est la littérature mondiale ?, PU Vincennes, coll. «Essais et savoirs».
Price, K. M. & Siemens, R. (dir.) (2013), Literary Studies in the Digital Age : An Evolving Anthology, disponibile online : https://dlsanthology.mla.hcommons.org/
Ryan, M.-L. (2002), « Beyond Myth and Metaphor : Narrative in Digital Media », «Poetics Today», vol. 23, n° 4, pp. 581-609, disponibile online : https://read.dukeupress.edu/poetics-today/article/23/4/581/20743/Beyond-Myth-and-Metaphor-Narrative-in-Digital
Id. (2018), « Sur les fondements théoriques de la narratologie transmédiale », in Patron, S. (dir.), Introduction à la narratologie postclassique : les nouvelles directions de la recherche sur le récit, Ville-neuve-d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, pp. 147-166.
Sapiro, G. (2011), La responsabilité de l’écrivain. Littérature, droit et morale en France (XIXe-XXIe siècle), Paris, Seuil.
Suleiman, S. R. (1983), Le Roman à thèse ou l’autorité fictive, Paris, PUF, coll. « Écriture ».
Théval, G. (2018), « Non-littérature ? », Itinéraires. Littérature textes cultures, 2017-3 | 2018 (« Littératures expérimentales »), disponibile online : https:// journals.openedition.org/itineraires/3900
Id. (2015), Poésies ready-mades, xxe- xxie siècles, Paris, L’Harmattan, coll. « Arts et médias ».
-

Nel presente contributo cercheremo di analizzare lo strano caso del Random Darknet Shopper, opera d’arte che, avendo come perno un meccanismo aleatorio, mette in discussione il concetto di soggetto, inteso questo nella sua accezione filosofica, a partire dalle sue risonanze giuridiche. Software programmato ad acquistare casualmente merce sul darknet, ha avuto in sorte lo scontro con alcune antinomie giuridiche. Vedremo infatti come (§1) il principio di colpevolezza alla base del regime di discorso giuridico in cui l’opera si innesta si ritrova innanzitutto sul problema dell’individuazione: cos’è (oppure – forse meglio: quale parte è) il soggetto in causa? Il software? La mostra, intesa come luogo fisico? Oppure la mostra intesa come organizzazione di eventi? Già in quest’ambiguità iniziale possiamo rinvenire il fine primo e ultimo dell’“opera” in questione, quella di perturbare. In secondo luogo, il problema filosofico sollevato è se e come è possibile ritenere l’alea (come se fosse) un soggetto. Questa necessità giuridica non può non confliggere con il carattere meramente finzionale dell’attribuzione di una volontà a qualcosa di assolutamente caotico. Così facendo, il regime giuridico non può che ritrovare il suo ‘oggetto’ al di là o al di qua dell’evento stesso, ovvero nelle istanze enuncianti o enunciate individuabili del dispositivo stesso. Ad onor del vero, questo processo è sotteso a qualsiasi giudizio e l’interruzione discorsiva, l’individuazione di un’istanza, è proprio l’effetto che il discorso giuridico produce, non ciò su cui si articola. In modo eclatante, l’opera che andremo ad analizzare non fa altro che rendere manifesto questa dinamica. Attraversandone la storia, dalle sue esibizioni (§2) alla ricezione sui rotocalchi (§3), andremo ad esaurire la bibliografia filosofico-giuridica che vi si è interessata, mostrando i tentativi e le proposte risolutive di richiudere in un discorso morale lo scandalo aperto da questo paradossale “soggetto caotico”(§4).
.
.
1. L’opera
Random Darknet Shopper (abbr. RDS) è un progetto di computer art del duo svizzero !Mediengruppe Bitnik (al secolo Carmen Weisskopf e Domagoj Smoljo) svoltosi tra il settembre 2014 e il 2016. Come anticipato, l’“opera” è costituita da un software finalizzato a selezionare sul darknet in modo casuale, quindi ad comperare, merce del valore massimo di 100$ in bitcoin. Durante le mostre, il software procede a un acquisto a settimana. Gli articoli vengono così spediti direttamente sul luogo d’esposizione e collocati in apposite teche, che si riempiono progressivamente fino al termine della mostra. Come spiegato dagli autori sul loro sito, «Once the items arrive they are unpacked and displayed, each new object adding to a landscape of traded goods from the Darknet» (https://wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.bitnik.org/r/).
Evidenziamo fin da subito un’ambiguità relativa all’identità del progetto. Con ‘RDS’ si intende, infatti, a seconda dell’aspettualizzazione: (1) l’oggetto, ovvero il software (secondo l’attorializzazione), (2) il luogo dell’esposizione e la collezione dei vari oggetti progressivamente acquistati (per spazializzazione e temporalizzazione terminativa) e (3) le sue performance, le varie acquisizioni avvenute nelle cosiddette editions (qui temporalizzazione incoativa). Poiché ogni edition è indipendente dalle altre, la raccolta del materiale inizia di volta in volta daccapo, l’acquisto degli oggetti è, come detto, casuale e il riempimento delle teche è durativo nel tempo. In breve RDS si presenta, proprio per la sua «capacità di assumere diverse impreviste strutture fisicamente inattuate», come un’opera in movimento (Eco 1980: 44).
In secondo luogo, notiamo che, se da un lato RDS è un dispositivo situato, occupando specifici punti dello spazio (il PC che gli fa da hardware e la merce esposta), dall’altro la relazione tra il suo discorso e l’ambiente rende il dispositivo sia pervasivo che – coniando un termine da aggiungere a quelli di Eugeni (2010: §3.2) – esclusivo. Infatti l’articolazione del senso di RDS gioca sul fatto che il suo automatismo non permette in alcun modo di essere partecipi dei criteri d’acquisto. Non si sa quale prossima chincaglieria troverà sul web, se non quando questa verrà direttamente portata sul luogo via posta. Si comprende allora come i !Mediengruppe Bitnik abbiamo potuto concepire RDS come «a landscape of traded goods» provenienti dal darknet cui si aggiungono nuovi elementi una volta «unpacked and displayed».
Una pervasione, dunque, dovuta a una collezione che riempie gradualmente l’intera sala dedicata. Wunderkammer contemporanea, RDS ostenta il privato e il proibito nel pubblico, funzionando così da dispositivo di sacrificio (Agamben 2005: 84).
Inoltre, l’aspettualizzazione temporale presenta RDS come una performarce artistica, confermando in questo modo l’«ipotesi» di lettura secondo la quale le avanguardie siano la «lucida e spesso consapevole ripresa di un paradigma essenzialmente liturgico», da leitourgia: «‘opera, prestazione pubblica’» (Id. 2017: 24 e 21). Si spiega dunque il motivo per il quale il duo svizzero possano definire RDS «a live Mail Art piece».
Ma “live piece” tematizza chiaramente l’Unheimlichkeit di Freud (1919), condizione – banalizziamo – in cui si ha terrore che prenda vita un oggetto inanimato, che gli oggetti rimossi possano (ri)attivarsi e (ri)entrare nella nostra vita cosciente. Era questo un meccanismo già presente nelle Wunderkammern: qui «lo statuto dell’esperienza museale attuale» vacilla, avendo davanti un «processo di accumulo quasi automatico di cui si fa fatica a comprendere la logica» cui deriva quell’«effetto di senso particolare, quello della meraviglia» da cui il nome (Donatiello 2016: 64). In breve, RDS è una macchina enunciativa automatica di un contenuto oscuro come il darknet, dispositivo hauntologico (Derrida 1994) grazie al quale il fantasma di una parte remota della rete si manifesta nella “casa” infestandola di simulacri, a mostrare il caos che alberga ogni cosmos, come suo rovescio e suo fuori.
Considerando che non permette di anticipare nulla sui suoi acquisti, RDS presenta un «regime» di interazione «dell’incidente», nel quale l’alea si costituisce come soggetto. Da un lato !Mediengruppe Bitnik programmano RDS per fargli ottenere una «motivazione in qualche modo concessiva», poiché l’esecutore, il Destinatario, obbedisce ciecamente alla volontà del Destinante che l’ha programmato; dall’altro, però, la programmazione è assolutamente autoneutralizzante, poiché, come già detto, l’oggetto di valore cui deve tendere il bot è, al di là dei limiti materiali imposti, un oggetto qualunque (Landowski 2005: 43).
Il ‘soggetto’-RDS emerge come se marchiato da una perversione della massima agostiniana «Dilige et quod vis fac», “ama e fa' che vuoi” (In Io. Ep. tr. 7, 8), dimostrandosi vera e propria forma-di-vita (Agamben 2011 : 17). In altre parole, esso è un’attorializzazione dell’alea. La macchina randomica apre quindi alla «minaccia del rischio puro al di sopra di tutti i sistemi di sicurezza», installando serenamente l’«attesa dell’inatteso» (Landowski 2005: 74). Come «se all’origine tutto fosse [...] discontinuità», RDS «non consent[e] alcuna forma di comprensione, ci pon[e] davanti all’insensato; escludendo ogni possibilità di anticipazione, non ci offr[e] moralmente alcuna sicurezza» (Greimas 1987: 89 e 74-5). Questo regime è ciò cui tende la ricerca dei !Mediengruppe Bitnik: «Randomness implies a loss of control. Loss of control is something we intentionally seek in our works: we create situations and let them play out». In RDS, infatti, «loss of control is part of the concept by delegating the buying decision to a software bot» (2015: 41).
RDS, “soggettivando l’alea”, incarnandola come attore e riproponendone le dinamiche costitutive, apre a una serie di paradossi. Innanzitutto «è solo nella sua manifestazione, realizzandosi[,] che il caso si auto-istituisce, in atto [...] in quanto legge di se stesso», andando così a coinvolgere la responsabilità indiretta dei suoi Destinanti solo ad azione compiuta (Landowski 2005: 80). Allo stesso modo, è solo tramite l’ostensione dei suoi acquisti che RDS si autocostituisce, retroattivamente, come un tipo particolare di soggetto. O – meglio – ha avuto modo di autocostituirsi.
.
.
2. Il caso
Tre sono state le editions di RDS: alla galleria non profit Kunst Halle di San Gallo in Svizzera nella mostra “The Darknet – From Memes to Onionland. An Exploration” (14/10/2014-15/01/2015), alla Horatio Junior Gallery di Londra (11/12/2015-05/02/2016) e, infine, all’Aksioma Institute for Contemporary Art di Lubiana (24/02/2016-25/03/2016).
Ripercorrendo la prima edition attraverso l’ironico commento di Jon Lackman (2016), scopriamo che a san Gallo, «città svizzera dalle forti radici religiose» (ivi: 3), RDS si è collegato all’Agora shop, il più grande negozio illegale al mondo, dove ha acquistato ed esibito, nell’ordine: una chiave universale dei vigili del fuoco, 40$ di stecche di Chesterfield Blue provenienti dalla Romania, una borsa falsa di Louis Vuitton, la trilogia completa de Il Signore degli Anelli in ebook, altre 200 sigarette, una carta di credito VISA dorata, 120 mg di ecstasy in pillole dalla Germania prese a soli 48$, delle sneakers (false) della Nike firmate da Kanye West comprate a 75$ (le originali andavano sui 245$), un cappello da baseball con telecamera nascosta, una lettera di richiamo, un contenitore per farmaci a forma di lattina di Sprite, dei jeans, e infine la scannerizzazione di un passaporto.
La pietra dello scandalo è stata certo la partita di droga. I !Mediengruppe Bitnik constatano con sorpresa, sul loro sito, come «The parcel was sent from Germany and crossed the border and customs to Switzerland without any problems», problemi giunti solo il 12 gennaio 2015, a mostra appena conclusa, quando la polizia svizzera sequestra il bot e tutta la merce esposta.
Soltanto il 15 aprile, dopo aver testato che le pillole contengono MDMA (90 mg, non i 120 promessi), la polizia le distruggerà – così ha dichiarato –, restituendo invece tutto il resto. I !Mediengruppe Bitnik hanno così esultato sul loro sito:
At the same time we also received the order for withdrawal of prosecution. [In it] the public prosecutor states that the possession of Ecstasy was indeed a reasonable means for the purpose of sparking public debate about questions related to the exhibition. The public prosecution also asserts that the overweighing interest in the questions raised by the art work [RDS] justify the exhibition of the drugs as artefacts, even if the exhibition does hold a small risk of endangerment of third parties through the drugs exhibited. We as well as the [RDS] have been cleared of all charges. This is a great day for the bot, for us and for freedom of art!
Sebbene ci sia stato un acquisto di droga, questo non è stato voluto. Sebbene ci sia stata detenzione di droga, ciò è avvenuto a fini artistici: RDS ha creato dunque un vuoto giuridico dove, generando un illecito come evento, non è stato possibile attribuirgli un autore come responsabile. Solo la cornice artistica ha potuto rendere impunibile l’ostensione di questo gesto. In questa sede ci soffermeremo analiticamente solo sulla prima mostra. Della seconda, i curiosi sappiano che RDS, connesso questa volta ad Alpha Bay, ha acquistato: una t-shirt Lacoste falsa, due devices per l’estrazione di Bitcoin comprati con 25$, una copia elettronica di un libro di cucina francese in inglese del 1961, un cellulare con distorsore vocale, 1.825.380 indirizzi email a 100$, la scannerizzazione di una bolletta del gas inglese, concludendo con un PDF su come Hacking a Coca Cola machine.
.
.
3. La ricezione
La notizia è salita subito agli onori della cronaca, dove si è scherzato sul fatto che il computer abbia una personalità umana e sia soggetto giuridico di diritti e doveri. Su The Guardian Kasperkevic balbetta che la polizia svizzera abbia «arrested – er, confiscated» un computer (2015); Kharpal le fa eco su CBSN (2015). Per Grey del Daily Mail RDS è addirittura un «cyber criminal!» che è stato «ARRESTED» (2015), mentre Grant dell’Indipendent sente l’imbarazzo di dover spiegare come «the consumer behind these purchases is not actually a human, though – it is an internet “bot”» (2015). RDS sembra quindi essere un soggetto pieno. Come «example of a nearly autonomous thing that bought things», esso desidera, acquista e commette crimini come tutti noi: questa è la novità su cui apre in modo clamoroso (Noto La Diega & Walden 2016: 4 nota 15).
Tant’è che a RDS si attribuisce un nome proprio, se non addirittura un genere. Come ha infatti raccontato Smoljo degli stessi !Mediengruppe Bitnik, «People also call him Randy. Normally, we try to give it a female name but this is what came out in this case» (https://exposingtheinvisible.org). Lackman invece, cercando inutilmente di non risultare sessista, attribuisce al bot il genere maschile: «For me [RDS] is not an /it /but a /he/.//Why not a /she/? I'm not sure. Only a sexist would assume an obsessive shopper is a she, right? Plus: men quail in stores, they choose stuff at random just to be done» (2016: 3). Ciò che vorremmo in ogni caso evidenziare è come la questione del soggetto giuridico comporti quella del genere e il binarismo sottesi, altrimenti non pertinenti.
.
.
4. L’anomia
Galati ha commentato l’episodio delle pasticche evidenziando come, al di là «del risvolto potenzialmente ironico, [RDS] genera evidentemente delle domande che segnalano dei buchi giuridici sulla responsabilità degli algoritmi» (2018). La questione etico-morale è stata da subito sollevata, a partire da Power (2014), fonte di tutta la bibliografia successiva su questo «provocative example of such a shopping bot» (Gal & Elkin-Koren 2017: 315).
Una risposta viene tentata da Alves de Lima Salge e Berente (2017). Rifacendosi al kantismo di Rawls, per valutare il valore morale di un algoritmo come RDS, essi propongono un algoritmo di livello logico superiore, ovvero un meta-algoritmo. È già chiaro il pericolo della regressione all’infinito (critica avanzata da subito da Shaw 2018). Rischio, quello della regressio, contro il quale la giuscibernetica, fin dalle sue prime teorizzazioni, ha sempre invocato la necessità di un limite (Losano 1969: 169 ss).
Alves de Lima Salge e Berente, in ogni caso, si chiedono: sebbene sia stata violata una legge di Stato (il bot ha acquistato della droga vietata sul mercato regolare e un passaporto falso), si può ritenere il suo comportamento «unethical»? Per questo motivo, gli autori ritengono necessario un giudizio sulla sua attività. Il meta-algoritmo che propongono si articola di tre domande: (1) l’azione del social bot ha infranto la legge?, (2) la sua azione è ingiustificabile? (3) è coinvolto qualche inganno? Un bot, ma più in generale qualsiasi soggetto morale, non si comporta eticamente se la sua azione risponde affermativamente in progressione alle tre domande. La conclusione e il fine cui vogliono tendere gli autori – vero e proprio imperativo categorico – è che i «Social bots should always act truthfully» (ivi: 30).
Poiché il fine era artistico e l’ecstasy «in this presentation was safe», come indicato dalla polizia, gli autori dell’articolo possono ritenere il comportamento del bot «not unethical» poiché giustificabile con la moralità diffusa della comunità. Qui, però, l’impasse: per i due studiosi, che si rifanno all’Etica Nicomachea (III, 1111a), un soggetto-bot etico emerge come tale se e solo se la sua azione è allo stesso tempo saputa e voluta. Come già evidenziato, RDS si comporta come l’alea, alla quale è assolutamente finzionale attribuire una qualunque consapevolezza della propria volontà. Il bot sembra quindi muoversi a latere del meta-algoritmo, nello spazio di un vuoto giuridico.
Sorge inoltre un ennesimo problema, sollevato da Turner, per il quale RDS sarebbe un “Case Study” sulla domanda: «Could a Robot Commit a Crime?» (2019: §4.5). Per il principio del habeas corpus, anche se si individuasse la volontà del bot, questa resterebbe un carattere di una mera ψυχή (RDS è un software), cui non sarebbe relato alcun corpo punibile di reato. È il motivo di clamore del Washington Times (2015) per il quale è sorprendente che sia stato arrestato un «moving conglomeration of bits and bolts, conceived and fashioned by flesh and blood men».
Non resta dunque che dare la colpa agli sviluppatori: «Therefore, culpability rests on the knowledge of the developers» (ivi: 31), ovvero i Destinanti. Ma, anche in questo caso, si tratta di una soluzione particolare, che solo a volte può essere attuata. Si attribuisce la sostanza di soggetto al firmatario, in quanto primo riferimento fisso della catena di enunciazioni che si è venuta a creare. Ma in questo caso non si tratta di una colpa, al massimo un dolo. Si mostra così un conflitto tra due regimi discorsivi, quello del Diritto che cerca un elemento primo cui ricondurre la catena di enunciazioni (Latour 1998: 92 ss), come ad esempio un firmatario che emerge retroattivamente dalla sua firma (Derrida 1997: 393-424), e il regime discorsivo della tecnica che si articola in débrayages attanziali dove ogni attore così proiettato vive di una sua autonomia (Latour 1998: 82). Allo stesso tempo, però sono proprio i diritti d’autore, correlati della responsabilità autoriale (Franceschelli 2019), a permettere al duo svizzero di rivendicare per sé la genesi dell’opera. In breve, la funzione-autore è un «oggetto di appropriazione» la cui forma è storicamente seconda, in rapporto a ciò che di potrebbe chiamare l’appropriazione penale. I testi , i libri, i discorsi hanno cominciato ad avere realmente degli autori […] nella misura in cui l'autore poteva essere punito, vale a dire nella misura in cui i discorsi potevano essere trasgressivi. Il discorso, nella nostra cultura (e in altre probabilmente) non era, all’origine, un prodotto, una cosa, un bene; era essenzialmente un atto – un atto posto nel campo bipolare del sacro e del profano, del lecito e dell’illecito, del religioso e del blasfemo (Foucault 1971: 9).
Abbandonando così l’ipotesi d’“accusare delle cose di un crimine”, la colpa è dei programmatori, in quanto si prendono la responsabilità delle azioni del loro bot che hanno previsto. Si darebbe colpa a un bot se e solo se si potesse dimostrare che questo abbia deviato volutamente dal proprio programma, ovvero dal volere dei propri destinanti: «In such absence of deviation, it is easier to prove human involvement in the AIS’ illegal conduct. In other words, the programmer of [RDS] may also be held liable because it creates an AI to shop in the illegal market» (Andrini 2018: 79). Per lo stesso motivo, «si tratta di un reato punibile a titolo di dolo» poiché il «bot non è stato progettato o impiegato con l’intenzione di commettere il reato, ma il programmatore e/o l’utente hanno irragionevolmente accettato una serie di rischi che hanno portato al verificarsi della condotta criminosa», motivo per il quale «l’utilizzatore e/o il programmatore saranno ritenuti penalmente responsabili per il reato commesso dal bot» (Lagioia 2016: 126 e 129).
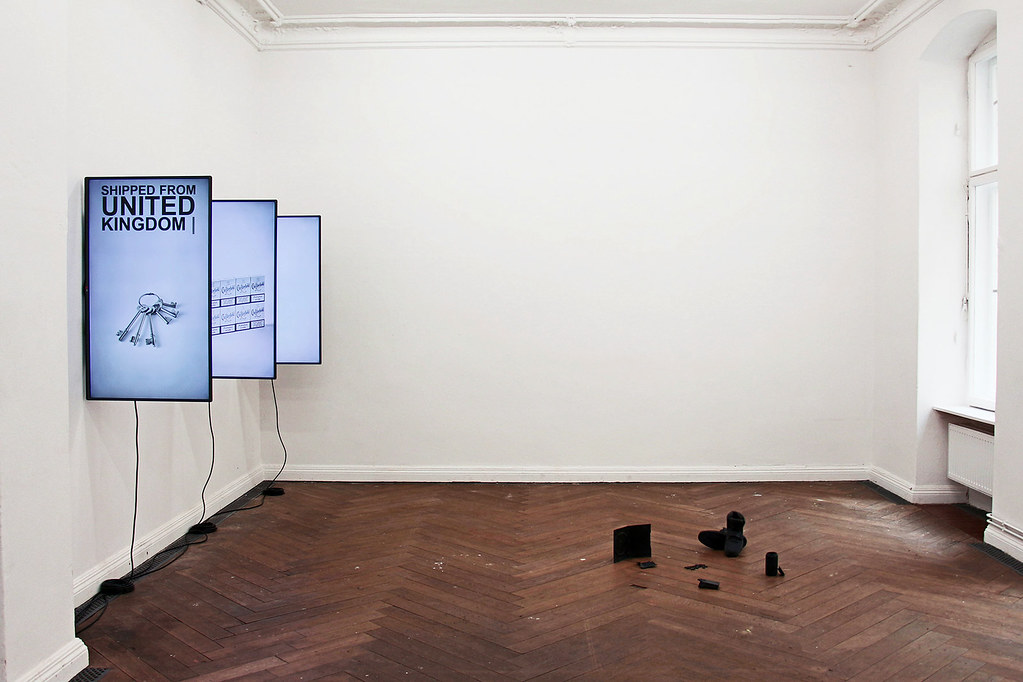
Ribadiamo: che siano colpevoli, gli artisti ne sono ben consci: «We are the legal owner of the drugs – we are responsible for everything the bot does, as we executed the code», ammette Smoljo. «But our lawyer and the Swiss constitution – continua – says art in the public interest is allowed to be free» (Power 2014).
È proprio il mondo dell’arte (Danto 1964) che infine si instaura come terzo discorso che permette di neutralizzare qualsiasi tipo di colpa da parte di RDS o dei suoi autori. I !Mediengruppe Bitnik infatti rivendicano di appartenervi.
.
.
Conclusione
Perniola (2015) aveva individuato nell’arte più recente una certa svolta fringe, secondo la quale «Nulla è di per se stesso arte» ma «lo diventa attraverso molti fattori» in un processo detto di «artistizzazione». Evidenziamo come RDS si muova nella direzione opposta, poiché esso è da sempre costituito come opera d’arte. È il vuoto giuridico che crea a far scoppiare un conflitto discorsivo tra il mondo dell’arte e quello legale. RDS non è un’opera fringe verso altri domini: sono gli altri domini ad implodere su di esso.
Coglie bene l’essenza di RDS Volkart Schmidt nell’inserire il progetto nella cosiddetta Ästhetik der Störung, «disturbo» dato nello specifico dalla «Kollision der Systeme». Abbiamo visto come questo progetto artistico utilizzi il proprio dominio per generare cortocircuiti in quelli altrui, innanzitutto giuridico e, conseguentemente, sociale. Ciò è stato possibile grazie alle possibilità offerte dalla rete, non intesa qui ingenuamente solo come «spazio libero dal diritto», a richiamare «vagamente le origini euforiche di Internet» (2015: 4). Come spiega Boris, «Aquella emancipación del ciberespacio [...] nos parece hoy un poco ridícula». La rete non è più – o, meglio, non è mai stata – quel grande spazio orizzontale di chissà quale regno dei cieli sulla terra. Si necessita dunque di «entender el horizonte digital como un campo fundamental de esta hipergeografía que estamos habitando», per stabilire così «Términos y Condiciones de una ontología digital libertaria» (2017).
In conclusione RDS si presenta come emblematico «example of hacktivist guerrilla communication» (Delmas 2018: 75), la cui sola ragione d’esistenza, «l'esecuzione dell’atto di semplice consumo» (Volkart Schmidt 2015: 4), è una «reflection on the shadowy parts of the Internet without calling for any specific legal change, or articulating any specific political claim» (Delmas 2018: 75). RDS non vuole portare al cambiamento in nessuna legge corrente, ma sollevare una riflessione sui limiti delle legislatura stessa. Considerando che «c’è arte solo se e quando (resiste)» (Carmagnola 2019: 156), RDS è arte proprio nella sua rivendicazione.
Derrida (1996: 14 nota 1) era convinto che «la democratizzazione effettiva si misura sempre con questo criterio essenziale: la partecipazione e l’accesso all’archivio, alla sua costituzione e alla interpretazione». Se ormai la rete è la sostanza esterna del nostro inconscio tecnologico, grande produzione archiviale costantemente riattualizzata (Galati 2017: §3), RDS ne è macchina da guerrilla semiotica (Eco 1967) che, a partire dal territorio specifico dell’arte, può portare a rimetterne in discussione confini e geografia.
di Francesco Di Maio
.
.
Bibliografia
!Mediengruppe Bitnik (2015). The Random Darknet Shopper wasting time on the darknet. In L. Catania et al. (a cura di). WTi2.0: Wasting Time on the Internet 2.0 (41). Düsseldorf: TFGC.
Agamben, G. (2005). Profanazioni. Roma: nottetempo.
Agamben, G. (2006). Che cos’è un dispositivo. Roma: nottetempo.
Agamben, G. (2011). Altissima povertà. Regole monastiche e forma di vita. Homo sacer, IV, I, Vicenza: Neri Pozza.
Agamben, G. (2017). Creazione e anarchia: L’opera d’arte nell’epoca della religione capitalistica. Vicenza: Neri Pozza.
Alves de Lima Salge, C. & Berente, N. (2017). Is That Social Bot Behaving Unethically?. Communications of the ACM, 60 (9), 29-31.
Andrini, L. (2018). Redesigning Indonesia Copyright Act to Accommodate Autonomous Intelligent System: Status Quo and Room for Improvement. Asian Journal of Law and Economics, 9 (3).
Boris (Mariano López Hermida) (2017). H.H.H: Una introducción a la hipergeografía y la dimensión política del horizonte digital. Estudios Curatoriales, 6 (4).
Carmagnola, F. (2019). Essere e gadget. La macchina del sentire. Milano: Meltemi.
Danto, A. (1964). The Artworld. Journal of Philosophy, 61 (19), 571-84.
Delmas, C. (2018). Is Hacktivism the New Civil Disobedience?. Raisons politiques, 69 (1), 63-81.
Derrida, J. (1994). Spettri di Marx: Stato del debito, lavoro del lutto e nuova Internazionale. Tr. It. di G. Chiurazzi. Milano: Raffaello Cortina.
Derrida, J. (1996). Mal d'archivio: Un’impressione freudiana. Tr. It. di G. Scibilia. Napoli: Filema.
Derrida, J. (1997). Margini – della filosofia. Tr. It. di M. Iofrida. Torino: Einaudi.
Donatiello, P. (2016). L’osservazione da un punto di vista etnosemiotico: Alcune osservazioni. INTRECCI d’arte, 5, 61-85.
Eco, U. (1973). Il costume di casa: Evidenze e misteri dell’ideologia italiana. Milano: Bompiani.
Eco, U. (1980). Opera aperta: Forma e indeterminazione nelle poetiche contemporanea. Milano: Bompiani.
Eugeni, R. (2010). Semiotica dei media: Le forme dell’esperienza. Roma: Carocci.
Eveleth, R. (2015). My Robot Bought Illegal Drugs. BBC, http://www.bbc.com/future/story/20150721-my-robot-bought-illegal-drugs.
Foucault, M. (1971). Scritti letterari, A cura di C. Milanese. Milano: Feltrinelli.
Franceschelli, G. (2019). I, Artist: Opere d’arte e intelligenza artificiale: il curioso caso del diritto d’autore, Senigallia: ventura.
Freud, S. (1919). Das Unheimliche. Imago. 5 (5-6), 297-324.
Gal, M.S. & Elkin-Koren, N. (2017). Algorithmic Consumers. Harvard Journal of Law & Technology, 30 (2), 309-53.
Galati, G. (2017). Duchamp Meets Turing: Arte, modernismo, postumano. Milano: postmedia•books.
Galati, G. (2018). Arte, modernismo e postumano. Cronache letterarie, http://cronacheletterarie.com/2018/04/07/arte-modernismo-e-postumano-intervista-a-gabriela-galati/
Grant, K. (2014). Random Darknet Shopper: Exhibition featuring automated dark web purchases opens in London. Indipendent, https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/random-darknet-shopper-exhibition-featuring-automated-dark-web-purchases-opens-in-london-a6770316.html
Greimas, A.J. (2004). Dell’imperfezione. Tr. It. di G. Marrone. Palermo: Sellerio.
Grey, R. (2015). Now that's a cyber criminal! Robot is ARRESTED by police for buying ecstasy on the dark net. Daily Mail, https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3047317/Now-s-cyber-criminal-Robot-ARRESTED-police-buying-ecstasy-dark-net.html
Kasperkevic, J. (2015). Swiss police release robot that bought ecstasy online. The Guardian, https://www.theguardian.com/world/2015/apr/22/swiss-police-release-robot-random-darknet-shopper-ecstasy-deep-web
Kharpal, A. (2015). Robot with $100 bitcoin buys drugs, gets arrested. CBSN, https://www.cnbc.com/2015/04/21/robot-with-100-bitcoin-buys-drugs-gets-arrested.html
Lackman, J. (2016). RANDOM DARKNET SHOPPER. Ljubljana: Aksioma – Institute for Contemporary Art.
Lagioia, F. (2016). Responsabilita Penale e Automazione nell’E-Health. Tesi di dottorato, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Bologna, Italia.
Landowski, E. (2010). Rischiare nelle interazioni. Tr. It. di M.C. Addis. Milano: FrancoAngeli.
Latour, B. (1998). Piccola filosofia dell’enunciazone. In Basso, P.L. & Corrain, L. (a cura di). Eloquio del senso: Dialoghi semiotici per Paolo Fabbri (71-94). Genova: Costa&Nolan.
Losano, M.G. (1969). Giuscibernetica. Macchine e modelli cibernetici nel diritto. Torino: Einaudi.
Noto La Diega, G. & Walden, I. (2016). Contracting for the “Internet of Things”: Looking into the Nest. Queen Mary School of Law Legal Studies Research Paper, 219.
Power, M. (2014). What happens when a software bot goes on a darknet shopping spree?. The Guardian, https://www.theguardian.com/technology/2014/dec/05/software-bot-darknet-shopping-spree-random-shopper
Perniola, M. (2015). L’arte espansa. Torino: Einaudi.
Shaw, J. (2018). Evil: The Science Behind Humanity's Dark Side. NY: Abrams.
Turner, J. (2019). Robot Rules: Regulating Artificial Intelligence. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Volkart Schmidt, Y. (2015). Sichtbarmachen, Verdunkeln, Materialisieren: Für eine Ästhetik der Störung. Springerin, 2, 4-5.
Washington Times, A ’bot with a rap sheet: Even if you're made of bits and bolts, selling drugs is not a good idea, https://www.washingtontimes.com/news/2015/apr/26/editorial-internet-robot-random-darknet-shopper-ar/
-
Se riconoscere il superamento del progetto artistico dall’alterità di cause determinanti benché inavvertite sembra ormai essere un luogo comune delle rappresentazioni del fare artistico (si pensi alle diverse teorie di ispirazione divina, a quelle di involontario condizionamento ideologico, alla postulazione dell'esistenza di una logica dell'inconscio), l'implicazione del caso quale causa della produzione artistica non consente di accedere a un'interpretazione dell'opera come manifestazione di determinazioni essenziali, sociali o psicoanalitiche. In altre parole, il riconoscimento di una parte di caso nel processo creativo implica modalità di significanza per le quali l'identificazione di un progetto diventa altamente problematica.
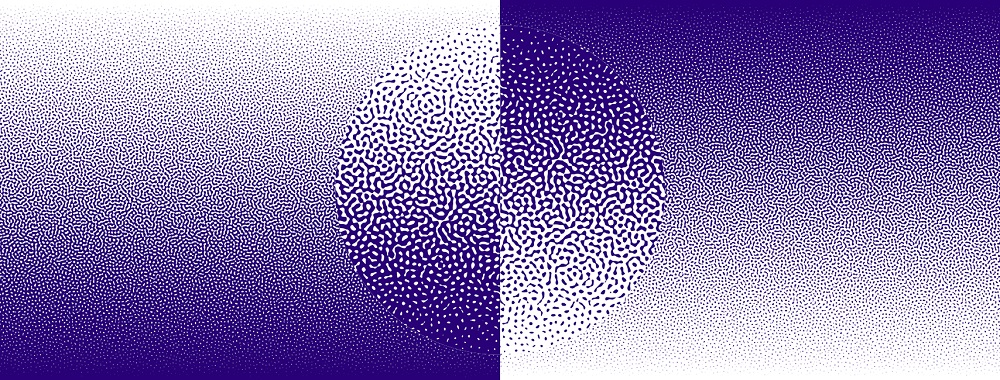
Although acknowledging that any artistic project is necessarily exceeded by the alterity of determining causes is quite a mundane way of representing the artistic fact (one thinks of the various theories of divine inspiration, of involuntary ideological conditioning, of the postulation of the existence of a logic of the unconscious, etc.), the implication of chance as the root cause of a work raises a critical issue since it rules out any interpretation of the work either as a manifestation of a truth that would have been pre-existing in god, or as a social or psychoanalytical determination of the forms produced and interpreted. In other words, the recognition or claiming of a measure of chance seems to imply modes of signifiance for which the identification of a project becomes problematic.
A cura di Benoît Monginot, Stefano Oliva e Sébastien Wit
Scarica PDF
English version
DOI: https://doi.org/10.13135/2385-1945/14.2021
Pubblicato: marzo 2021
Indice
INTRODUZIONE
Benoît Monginot, Stefano Oliva, Sébastien Wit - Tra caso e progetto: alea e forme di soggettivazione nelle pratiche artistiche [PDF It]
I. Forma e alea nelle arti performative
Alessandro Bertinetto - (Caso) per caso. La contingenza nell'improvvisazione artistica [PDF It]
Veronica Cavedagna, Alice Giarolo - Il movimento: tutto qui. L’ordine aleatorio delle macchine danzanti [PDF It]
Alberto Giustiniano, Carlo Deregibus - Progetto e ricerca della forma. Dall'aleatorio ai campi di validità [PDF It]
Daniela Angelucci - L’infallibilità dell’improbabile: dipingere, camminare, filmare [PDF It]
Mauro Folci, Stefano Oliva, Guido Baggio - Intervista a Mauro Folci [PDF It]
II. Toccare il codice: processi e alea
Sylvain Reynal - Entre processus stochastiques et métriques d’évaluation : l’IA-créatrice à l'épreuve de l'étrangeté [PDF Fr]
Rodolphe Olcèse - L’image du monde en son infinition. L’aléa dans la pratique filmique de Jacques Perconte [PDF Fr]
Alice Iacobone - The Strategy of Genesis. On the Productive Power of Artistic Iteration [PDF En]
III. Scritture contingenti - caso e letteratura nel Novecento
Jean-Pierre Zubiate - Face au hasard : ouvraisons poetiques au XXe siecle [PDF Fr]
Sibylle Orlandi - Coup de « dé » et « lois du hasard » dans les créations poétiques et plastiques de Ghérasim Luca [PDF Fr]
Sébastien Wit - Hasard et orient au XXe siecle. Les controverses artistiques Boulez / Cage et Queneau / Breton [PDF Fr]
Paulo Fernando Lévano - Decolonizzare la lettura. Indecidibilità nella prosa rioplatense (1960-1969) [PDF It]
IV. Coda: les jeux sont faits
Anne Duprat, Benoît Monginot, Sébastien Wit - « Le hasard ne fait rien au monde – que de se faire remarquer ». Entretien avec Anne Duprat [PDF Fr]
V. Varia: focus su Guillaume Artous Bouvet
Guillaume Artous-Bouvet - Lieu (Artaud, Jabès) [PDF Fr]
Benoît Monginot - Infondatezza di una pratica discorsiva. Su "Poésie et Autorité" di Guillaume Artous-Bouvet [PDF It]
-
Il corpo del pensiero. Derrida e Adami
Sconfinamenti, Serial / Marzo 2020È stato lo stesso Derrida a spiegare le circostanze che lo hanno condotto a incontrare Valerio Adami e ad avviare con lui un buon rapporto: «Un giorno, il mio amico Jacques Dupin, che lavorava per Maeght, mi propose di collaborare con un pittore a un’opera in comune, una serigrafia che mescolasse il tratto, la pittura e la scrittura. […] Qualche mese più tardi, Jacques ha avuto l’idea di associarmi a Valerio Adami. […] Nel 1975, Dupin mi ha portato dei cataloghi e io sono rimasto subito colpito dalla forza, dall’energia del tratto, ma anche da un richiamo nel disegno – e anche nella pittura – ad altri tipi di scritture: letteraria, politica, “storica”. Assai presto ho notato l’esistenza, nella sua opera, di un certo rapporto sincopato con l’evento letterario o politico, con gli scritti di Joyce o Benjamin, con le rivoluzioni europee di questo secolo, la rivoluzione russa, quella di Berlino, ecc. Il tutto colto in modo ellittico, sincopato, in un tratto dalla forma molto singolare»
..
SCARICA PDF
-
La danza delle immagini – Didi-Huberman
Sconfinamenti, Serial / Settembre 2018 Aperçues è uno dei libri più singolari di Georges Didi-Huberman. Raccoglie numerosi testi brevi (ognuno dei quali reca un proprio titolo e una precisa data di composizione) che riguardano immagini, non tanto analizzate per esteso quanto piuttosto «intraviste» (è questo il significato del titolo). Il medesimo concetto viene ribadito nell’epigrafe, tratta da un discorso del poeta tedesco Paul Celan: «E cosa sarebbero allora le immagini? Ciò che una volta, e ogni volta è l’unica volta, è soltanto qui e ora, viene intravisto e ha da essere percepito». Conviene parlare genericamente di immagini perché, nella sua vasta produzione saggistica, Didi-Huberman non si è interessato soltanto alle opere d’arte pittoriche o scultoree – antiche, moderne o contemporanee che siano –, ma ad ogni sorta di elementi visivi (stampe, manifesti, fotografie, video, film, ecc.). Egli potrebbe, come Baudelaire, definire le immagini «la mia grande, la mia unica, la mia primitiva passione, nel senso che le considera, oltre che come fonte di fascino, anche come oggetto di un’inesausta riflessione.
Aperçues è uno dei libri più singolari di Georges Didi-Huberman. Raccoglie numerosi testi brevi (ognuno dei quali reca un proprio titolo e una precisa data di composizione) che riguardano immagini, non tanto analizzate per esteso quanto piuttosto «intraviste» (è questo il significato del titolo). Il medesimo concetto viene ribadito nell’epigrafe, tratta da un discorso del poeta tedesco Paul Celan: «E cosa sarebbero allora le immagini? Ciò che una volta, e ogni volta è l’unica volta, è soltanto qui e ora, viene intravisto e ha da essere percepito». Conviene parlare genericamente di immagini perché, nella sua vasta produzione saggistica, Didi-Huberman non si è interessato soltanto alle opere d’arte pittoriche o scultoree – antiche, moderne o contemporanee che siano –, ma ad ogni sorta di elementi visivi (stampe, manifesti, fotografie, video, film, ecc.). Egli potrebbe, come Baudelaire, definire le immagini «la mia grande, la mia unica, la mia primitiva passione, nel senso che le considera, oltre che come fonte di fascino, anche come oggetto di un’inesausta riflessione.Scarica il PDF
A cura di
Giuseppe Zuccarino è critico e traduttore. Ha pubblicato vari saggi: La scrittura impossibile, Genova, Graphos, 1995; L’immagine e l’enigma, ivi, 1998; Critica e commento. Benjamin, Foucault, Derrida, ivi, 2000; Percorsi anomali, Udine, Campanotto, 2002; Il desiderio, la follia, la morte, ivi, 2005; Il dialogo e il silenzio, ivi, 2008; Da un’arte all’altra, Novi Ligure, Joker, 2009; Note al palinsesto, ivi, 2012; Il farsi della scrittura, Milano-Udine, Mimesis, 2012; Prospezioni. Foucault e Derrida, ivi, 2016. Tra i libri da lui tradotti figurano opere di Mallarmé, Bataille, Klossowski, Blanchot, Caillois e Barthes. Ha inoltre curato un fascicolo monografico della rivista «Riga» (n. 37, 2017) dedicato a Maurice Blanchot.
-
 «In principio era l’Azione». Se si dovesse scegliere una frase da porre in esergo al volume di Alessandro Bertinetto (Eseguire l’inatteso. Ontologia della musica e improvvisazione, Il glifo ebook, Roma 2016) dedicato alla pratica dell’improvvisazione musicale, non si potrebbe che scegliere il celebre verso goethiano (ripreso da Ludwig Wittgenstein nelle annotazioni raccolte sotto il titolo Della Certezza). Il lavoro di Bertinetto pone il fenomeno improvvisativo al centro dell’indagine e definisce le sue caratteristiche distintive seguendo le coordinate proprie dell’estetica analitica, riservando particolare attenzione agli aspetti ontologici della pratica artistica in cui «processo e prodotto coincidono» (p. 52). Ma l’analisi filosofica dell’improvvisazione musicale impone, alla fine dell’indagine, una complessiva rielaborazione delle determinazioni concettuali attraverso le quali l’estetica analitica ha finora pensato l’ontologia della musica: il caso dell’improvvisazione mostra cioè che le categorizzazioni abitualmente adottate dalla riflessione filosofica non sono sufficienti a rendere conto della complessità del fenomeno musicale, così come esso effettivamente si presenta. Come nota l’autore, il rischio che corre la filosofia è infatti quello di sostituire agli oggetti che intende studiare delle pure astrazioni, capaci forse di soddisfare i criteri che la riflessione arbitrariamente sceglie per sé ma non corrispondenti alla realtà dell’esperienza. Bertinetto non si limita dunque ad analizzare l’improvvisazione musicale, ma utilizza i risultati della ricerca per rimettere in discussione alcuni assunti di base dell’estetica analitica, come il primato dell’ontologia sull’estetica – vale a dire la priorità della risposta alle domande “che cosa c’è?” e “che cos’è quello che c’è’” rispetto all’indagine relativa alla concreta esperienza legata a una pratica artistica – e la relazione tra opera ed esecuzione (abitualmente intesa secondo il binomio type/token, modello/occorrenza).
«In principio era l’Azione». Se si dovesse scegliere una frase da porre in esergo al volume di Alessandro Bertinetto (Eseguire l’inatteso. Ontologia della musica e improvvisazione, Il glifo ebook, Roma 2016) dedicato alla pratica dell’improvvisazione musicale, non si potrebbe che scegliere il celebre verso goethiano (ripreso da Ludwig Wittgenstein nelle annotazioni raccolte sotto il titolo Della Certezza). Il lavoro di Bertinetto pone il fenomeno improvvisativo al centro dell’indagine e definisce le sue caratteristiche distintive seguendo le coordinate proprie dell’estetica analitica, riservando particolare attenzione agli aspetti ontologici della pratica artistica in cui «processo e prodotto coincidono» (p. 52). Ma l’analisi filosofica dell’improvvisazione musicale impone, alla fine dell’indagine, una complessiva rielaborazione delle determinazioni concettuali attraverso le quali l’estetica analitica ha finora pensato l’ontologia della musica: il caso dell’improvvisazione mostra cioè che le categorizzazioni abitualmente adottate dalla riflessione filosofica non sono sufficienti a rendere conto della complessità del fenomeno musicale, così come esso effettivamente si presenta. Come nota l’autore, il rischio che corre la filosofia è infatti quello di sostituire agli oggetti che intende studiare delle pure astrazioni, capaci forse di soddisfare i criteri che la riflessione arbitrariamente sceglie per sé ma non corrispondenti alla realtà dell’esperienza. Bertinetto non si limita dunque ad analizzare l’improvvisazione musicale, ma utilizza i risultati della ricerca per rimettere in discussione alcuni assunti di base dell’estetica analitica, come il primato dell’ontologia sull’estetica – vale a dire la priorità della risposta alle domande “che cosa c’è?” e “che cos’è quello che c’è’” rispetto all’indagine relativa alla concreta esperienza legata a una pratica artistica – e la relazione tra opera ed esecuzione (abitualmente intesa secondo il binomio type/token, modello/occorrenza).Per apprezzare la portata del lavoro che stiamo discutendo occorre però seguire il percorso scandito dai sette capitoli che compongono il saggio. Il lettore viene introdotto inizialmente nel dibattito dell’ontologia della musica, il cui orizzonte è caratterizzato dal dualismo tra opera ed esecuzione (cap. 1). Contro l’opinione (generalmente ammessa) secondo cui, per apprezzare una performance, dovremmo essere in grado di giudicarne l’appropriatezza rispetto al modello normativo rappresentato dall’opera, Bertinetto mette in luce il carattere processuale che determina l’attualizzazione dell’opera nelle diverse esecuzioni, preannunciando quella che sarà una delle tesi portanti del suo lavoro: l’opera stessa, attraverso le sue interpretazioni, viene modificata incessantemente, in un continuo processo formativo e trasformativo. Il mainstream dell’ontologia musicale si basa pertanto su un presupposto tacito ma non per questo neutrale:
A partire dall’assioma, assunto come indiscutibile, della ripetibilità dell’opera senza perdita d’identità, esse [le ontologie generalmente ammesse in ambito analitico] spiegano la relazione tra l’opera e le sue esecuzioni, dando per scontata la validità normativa dell’ideale della fedeltà (Treue) all’opera (Werk) (pp. 20-21).
Le ontologie della Werktreue, dettagliatamente analizzate e criticate da Bertinetto, sposano il modello basato sul dualismo tra opera ed esecuzione, proiettando il primo termine in un orizzonte normativo e atemporale e relegando il secondo in posizione subalterna. Ma, come detto in apertura, nell’ambito dell’esperienza musicale l’azione ha un’evidente priorità: è questo il punto su cui fa leva l’autore, proponendo all’ontologia della musica l’experimentum crucis dell’improvvisazione (capp. 2 e 3). Se infatti la musica – come argomentato da Bertinetto in un lavoro precedente[1] – è essenzialmente arte dei suoni, le concrete esperienze dell’ascolto e della pratica (strumentale e vocale) non possono essere relegate al ruolo di inessenziale “sonorizzazione” di una struttura ritmica, armonica e melodica precedentemente data. Il primato del suono e l’autonomia rispetto a modelli estrinseci divengono lampanti nell’esperienza dell’improvvisazione, in cui «il processo-prodotto accade contemporaneamente alla sua percezione da parte dell’ascoltatore» (p. 52). Bertinetto analizza il complesso rapporto che lega e distingue l’improvvisazione dalla composizione e individua successivamente alcune peculiarità di quel tipo di creatività in cui composizione e esecuzione coincidono. Irreversibilità, situazionalità, singolarità, presenza, autenticità definiscono l’improvvisazione come pratica paradossale: spontanea ma radicata in una continua frequentazione delle tecniche strumentali; intenzionale ma non predeterminata da decisioni prese in anticipo; fondata su abitudini ma portatrice di risultati imprevedibili. Viene dunque analizzato il rapporto tra improvvisazione e interpretazione, mettendo in luce il «carattere eminentemente auto-espressivo» (p. 101) della pratica improvvisativa, nella quale il soggetto musicale, così come l’opera, si costituisce e si sviluppa in concomitanza con l’esperienza del suono. L’improvvisazione diventa dunque il luogo di un’inedita soggettivazione, in cui trovano spazio nuove rappresentazioni di sé che possono coinvolgere e retroagire sulla collettività e sul contesto da cui pure hanno preso origine. Sulla scorta di queste analisi, Bertinetto può affermare l’inadeguatezza del modello type/token ai fini di una soddisfacente descrizione della pratica improvvisativa. Costituendo un caso limite in cui è impossibile distinguere tra opera ed esecuzione, così come tra strutture essenziali e coloriture contingenti, l’improvvisazione sfugge al modello della ripetibilità dell’opera ma non per questo deve essere “declassata” a mera performance; piuttosto, è il concetto stesso di “opera” a dover essere rimesso in discussione.
Dopo aver esaminato nel cap. 3 alcuni casi in cui i confini tra opera e improvvisazione tendono a sfumare (la composizione come risultato dell’improvvisazione, l’improvvisazione come determinazione di opere indeterminate, l’improvvisazione su opere), l’autore analizza dettagliatamente la relazione tra improvvisazione e musica registrata (andando a toccare un tema recentemente molto dibattuto nell’ambito dell’ontologia musicale[2]; cap. 4) e presenta il caso paradigmatico della contraffattura (cap. 6), pratica musicale di appropriazione e rielaborazione di temi, melodie, strutture armoniche attraverso cui si dà luogo a “nuove” opere.
Se i capp. 4 e 6 presentano dunque due possibili articolazioni del discorso sull’improvvisazione, il cuore teorico del saggio può essere invece individuato nei capp. 5 e 7, dedicati rispettivamente alla definizione della natura finzionale dell’opera e alla logica improvvisativa dell’ontologia musicale.
Nel cap. 5 Bertinetto afferma decisamente la natura culturalmente costruita dell’opera musicale e stabilisce il primato dell’esecuzione sul modello. Attraverso una mossa teorica che si potrebbe definire decostruttiva, l’autore sferra una critica decisiva alle ontologie della Werktreue notando come «la finzione dell’opera musicale che rimane identica attraverso le sue esecuzioni ha un’origine evidente nelle pratiche di scrittura potenziate dall’invenzione della stampa a caratteri mobili» (p. 203). Il singolare equilibrio di Bertinetto sta nel non liquidare però il riferimento all’opera come un richiamo inutile o insensato: affermando che l’opera vive nelle sue interpretazioni, viene ribadito il legame con una struttura normativa, intesa però non più come modello atemporale bensì come regola. Ma la logica che, wittgensteinianamente, sorregge il seguire una regola determina contemporaneamente un’apertura a diverse possibili esecuzioni e una incessante ridefinizione della regola stessa:

L’alterazione (anche minimale) o la violazione (anche radicale) della norma possono produrre nuove norme attraverso la modificazione della norma precedente, qualora venga seguita e dunque riconosciuta come tale dai partecipanti alla pratica. In ciò consiste il carattere formativo della normatività all’opera nell’improvvisazione (p. 268).
Il carattere ricorsivo e dinamico della normatività, esemplificato in modo paradigmatico dalla pratica dell’improvvisazione, può di fatto essere esteso all’intera pratica musicale, anche laddove si riconosca l’esistenza di opere, intese come entità finzionali, nel senso precedentemente specificato. Si può dunque pensare che il principio formante, presente in ogni composizione, non finisca di agire quando il compositore abbia tracciato la doppia stanghetta al termine dell’ultima battuta del pentagramma, ma che continui ad animare le diverse performances che nella partitura trovano la propria regola, la propria “ricetta” per preparare “piatti” diversi e innovativi. In definitiva, il modello type/token è da rifiutare perché mentre «l’esemplare non aggiunge nulla al tipo, semplicemente lo realizza», al contrario «la performance, realizzando l’opera, non la ripete identica. Altrimenti, tra l’altro, che senso avrebbe offrire più di un’esecuzione di un’opera musicale?» (p. 310). Quest’ultima riflessione, così come le sottili analisi dei capitoli precedenti, preparano un’ultima mossa teorica rilevante, vale a dire l’affermazione del primato dell’estetica sull’ontologia, che coincide con un posizionarsi nella «prospettiva dei partecipanti».
Data l’ampiezza del tema trattato e la ricchezza di informazioni, articolazioni, argomentazioni, non è facile rendere conto di un saggio come Eseguire l’inatteso. Una semplice constatazione, utile forse a contestualizzare il lavoro di Bertinetto, può essere l’individuazione di tre assi concettuali, tre linee argomentative che il lettore facilmente potrà ritrovare nelle pagine dedicate all’ontologia dell’improvvisazione. Per indicare questi tre assi faremo uso di altrettanti termini, ognuno legato a un autore esplicitamente richiamato nei capitoli del saggio. L’improvvisazione, intesa come paradigma capace di ristrutturare l’intera ontologia della musica, si situa dunque nel punto di intersezione tra formatività, regola e storia degli effetti, vale a dire in una ripresa di alcune tematiche legate alle riflessioni di Luigi Pareyson, Ludwig Wittgenstein e Hans Georg Gadamer.
Definendo l’arte come «un tal fare che, mentre fa, inventa il modo di fare»[3] Pareyson dà inavvertitamente una tra le più calzanti definizioni di “improvvisazione” e invita implicitamente a leggere l’intera attività formativa sotto la lente della pratica improvvisativa. La creazione artistica non implicherebbe dunque la realizzazione di un piano o di un progetto virtuale, ma si presenterebbe come un processo dinamico di scoperta, aperto tanto alla riuscita quanto al fallimento, sebbene non ordinato secondo norme preesistenti. Le regole dell’attività artistica seguono pertanto la massima con cui Wittgenstein definisce il funzionamento dei giochi linguistici: «We make up the rules as we go along»[4]. La norma che presiede all’improvvisazione coincide in realtà con quest’ultima e, al limite, è individuabile solamente ex post; estendendo questa riflessione all’intero ambito della creazione musicale, l’opera risulta non essere altro che l’insieme delle istruzioni rivolte dal compositore all’interprete, affinché nell’esecuzione (l’unica realtà che valga la pena di definire “musicale”) la composizione dispieghi la vita che le è propria. La vita dell’opera, infatti, continua in quella che Gadamer chiama Wirkungsgeschichte[5], storia degli effetti: in ambito musicale la performance, in quanto attualizzazione dell’opera e sua recezione, sviluppa in senso trasformativo il testo di partenza e mette in moto un processo retroattivo che va dall’esecuzione all’opera.
Il lavoro di Bertinetto ha il merito di rimettere in moto la riflessione sugli aspetti ontologici dell’esperienza musicale, determinando una problematizzazione dei modelli di riferimento abitualmente adottati. Ulteriore merito è quello di condurre la discussione fuori dalle secche dell’ontologia analitica senza rifiutarne aprioristicamente il quadro concettuale ma superandolo, per così dire, dall’interno, argomentando e rispondendo alle possibili obiezioni, ascrivibili alle voci più autorevoli dell’estetica musicale contemporanea, puntualmente citate e interrogate nel discorso. Un ultimo motivo di apprezzamento consiste nella reintroduzione nel dibattito di autori troppo spesso dimenticati nell’ambito della riflessione musicale: i tre esempi di Pareyson, Wittgenstein e Gadamer, poco presenti nella discussione analitica (su due dei tre nomi non ci dovrebbero essere dubbi, nel caso di Wittgenstein la questione della recezione analitica è di certo più complessa), comportano un ampliamento del panorama da cui la filosofia della musica non può che trarre giovamento.
di Stefano Oliva
[1] A. Bertinetto, Il pensiero dei suoni. Temi di filosofia della musica, Bruno Mondadori, Milano 2012.
[2] Cfr. Ontologie musicale. Perpectives et débats, sous la direction de A. Arbo, M. Ruta, Paris, Hermann 2014 (in partic. la sez. III, dedicata a Œuvres et enregistrements).
[3] L. Pareyson, Estetica. Teoria della formatività, Bompiani, Milano 1954 (nuova ed. 2010), p. 59; citato nel saggio di Bertinetto (p. 51).
[4] L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, Einaudi, Torino 2006, p. 56; citato nel saggio di Bertinetto (p. 269).
[5] H.-G. Gadamer, Verità e metodo, Bompiani, Milano 1990, p. 350 ss; cit. nel saggio di Bertinetto (p. 306).
-
Estesie #3 – Sul binario della deformazione
Estesie, Serial / Maggio 2016Nel senso più generico del termine, la deformazione consiste nell’alterazione, temporanea o definitiva, della configurazione originaria di un oggetto, e in pittura indica quel processo di alterazione delle forme naturali che porta a risultati spesso considerati mostruosi o aberranti. Attraverso le diverse riflessioni di artisti e filosofi, nel corso del Novecento la deformazione ha però subito una notevole evoluzione concettuale, passando dall’essere concepita come specifico fattore stilistico a processo genetico dello stile in quanto tale, fino a darsi addirittura come mediazione di più larghe operazioni estetiche o extra-pittoriche.

Untitled, Jannis Kounellis (1968)
A inizio Novecento, il simbolista francese Maurice Denis proponeva un’acuta distinzione tra deformazione “oggettiva” e deformazione “soggettiva”: la prima, accostabile alla coeva nozione worringeriana di abstraktion, si costituiva come principio regolatore delle tensioni formali interne all’immagine secondo quelle che Denis definisce le “leggi eterne della decorazione”; la seconda scaturiva dalla necessità di mediare la natura attraverso il proprio “temperamento” psichico. La nuova teoria della pittura di Denis si basa sull’espressione per “equivalenze” e non più per “mimesi”, individuando così le basi di quella che sarà la più valida e genuina pittura contemporanea. Alla luce di quanto si è visto nei decenni a venire, potremmo infatti intravedere in questa coppia polare il seme di due linee stilistiche dominanti nella cultura novecentesca: dalla prima la dipartenza dello sviluppo di tutti i decorativismi geometrici e delle ricerche di arte concreta, mentre dall’altra le contratture segniche e materiche degli espressionismi, manifestatisi nel corso del secolo a più riprese, fino agli esiti figurativi dell’Informale.
Il futurista Carlo Carrà, in un breve e puntuale scritto intitolato proprio La deformazione in pittura e pubblicato sulla rivista «Lacerba» del 15 marzo 1914, afferma che ormai non possa più sussistere opera senza l’intervento della deformazione, considerando questa soluzione non solo come “fattore predominante” nella costruzione del quadro, ma addirittura come un “altimetro” per misurare i vari gradi di espressione plastica di un’opera. Naturalmente, in piena fede futurista, Carrà vede la deformazione come conseguenza del movimento, della necessità di resa dinamistica della realtà e rivanga quel concetto riportato nel Manifesto tecnico della pittura futurista del 1910 secondo cui “per la persistenza dell’immagine nella retina, le cose si moltiplicano”, ma soprattutto “si deformano, susseguendosi, come vibrazioni, nello spazio che percorrono”. Le affermazioni di Carrà riguardano problematiche stilistiche ben precise e circoscritte al loro tempo, ma l’intuizione per cui la deformazione sia alla base di qualunque opera d’arte contemporanea è di una lungimiranza che solo anni dopo e in sede di riflessione estetica avrebbe trovato un più ampio sviluppo. Dovremo perciò aspettare la soglia degli anni Cinquanta perché il concetto di deformazione venga esteso da Maurice Merleau-Ponty fino ad assurgere a sinonimo di stile. Per il fenomenologo francese lo stile è un modo di ricreare i fenomeni e trovare per essi nuove modalità di essere nel mondo, perché solo il pittore riesce a percepire “le norme e le deviazioni dell’inaccessibile pienezza delle cose”. La sua dissertazione sullo stile muove dall’assorbimento sul piano fenomenologico del concetto di “deformazione coerente” formulato da André Malraux (autore esplicitamente richiamato nel titolo con le voci del silenzio), secondo il quale ogni pittore ha un proprio modo consapevole di deformare i dati visibili per risemantizzarli, investirli di nuovi significati. Quasi come in un lontano dialogo con Maurice Denis, anche Merleau-Ponty concepisce lo stile-deformazione come “sistema di equivalenze”, ma aggiunge che solo attraverso “l’indice universale della deformazione coerente” un artista “concentra il senso ancora sparso nella sua percezione e lo fa esistere espressamente”. Qui l’oggettivo e il soggettivo teorizzati da Denis sono come stati fusi in un unico canale di accesso alla realtà attraverso cui il pittore rielabora le qualità dei dati visivi nella più generale prospettiva di una propria definizione stilistica. A proposito di questa assimilazione del concetto di deformazione a quello di stile, andrebbe forse considerato il fatto che gli anni in cui scrive Merleau-Ponty sono anche i graffianti anni dell’Informale, rappresentato in Francia da maestri quali Jean Dubuffet e Jean Fautrier. Corrente pittorica di larga e capillare diffusione, incentrata su problematiche esistenziali affatto estranee al pensiero fenomenologico, essa ha, com’è noto, fervidamente applicato indici di deformazione estrema alle proprie figure, aspetto che può avere giocato un qualche ruolo nelle riflessioni del nostro filosofo.

Jean Dubuffet, Affluence (1961)
Il contributo più articolato sul concetto di deformazione arriva però da un filosofo italiano, sempre di scuola fenomenologica, Miro Martini, allievo di Antonio Banfi e autore di un ampio e complesso saggio intitolato La deformazione estetica, frutto di profonde riflessioni sull’atto estetico come atto deformante. Si tratta di un sistema che ingloba e sostiene la corrispondenza cara a Merleau-Ponty tra deformazione e stile, ma che va ben oltre i comuni processi di formalizzazione artistica per aprirsi al più generale piano dell’estetica. Martini estende tale concetto “all’intero mondo estetico nella varietà dei suoi piani fondamentali”, quasi intuendo che l’orizzonte mediale dell’arte si sarebbe a breve espanso enormemente fino a coincidere con quello della quotidianità; secondo Dino Formaggio, con questa “legge dell’esistere artistico in concreta esperienza” Martini intendeva sostenere che “l’arte compie un’opera di trans-valutazione dei momenti della vita, del vivere di ogni giorno”, una traslazione del mondano nell’artistico attraverso quella che oggi con Arthur Danto diremmo una trasfigurazione del banale. Si tratta di sottrarre quindi elementi concreti e dinamiche del quotidiano alla loro comune funzione pratico-utilitaristica per riscattarli esteticamente o, come rimarca Formaggio, “a dar forma compiuta e nobiltà di stile ad ogni esperienza del vivere”. Conferme pratiche alle idee di Martini sarebbero arrivate solo anni e anni dopo la sua scomparsa con fenomeni quali lo happening, la performance, l’Antiform o le poetiche del Concettuale; ma mi pare piuttosto significativo che nella Milano di metà anni Cinquanta, e poco dopo l’uscita (purtroppo postuma) del testo di Miro Martini, artisti spazialisti come Agostino Bonalumi o Enrico Castellani cominciassero a intervenire su delle tele monocrome per dilatarle, estrofletterle, alterandone la configurazione di base e sperimentando così la deformazione non più sul piano virtuale della figurazione, bensì su quello della piena materialità (pur rimanendo ancora legati a un supporto artistico tradizionale), producendo in definitiva una sorta di sinergia tra teorie e poetiche contemporanee, e riuscendo anzi a dare alle idee martiniane un’indiretta e probabilmente inconsapevole convalida.
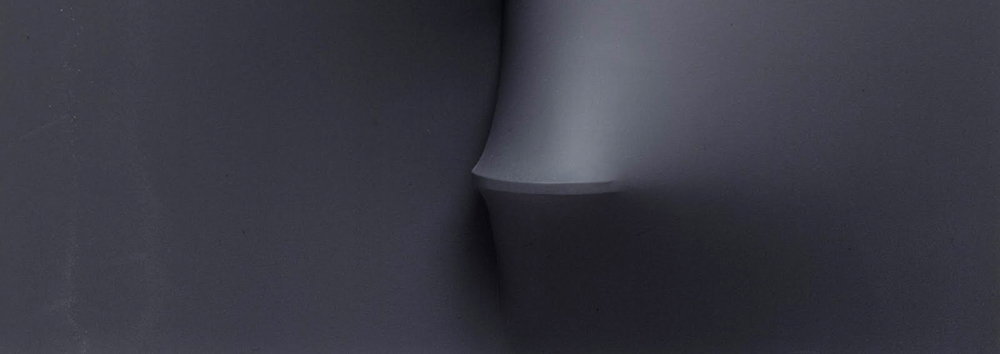
Agostino Bonalumi, Senza titolo - nero (1968)
Ecco dunque emerso lo status “bipolare” del concetto di deformazione nella cultura del Novecento, dove al primo polo, quello originario o dell’uso comune del termine e relativo a questioni plastico-formali (deformazione come alterazione di configurazione), se ne affianca un altro relativo a ridefinizioni artistiche dell’esperienza tramite mezzi, elementi e modalità dell’esperienza stessa (deformazione come stile e, solo dopo, come riformulazione estetica del quotidiano), ampliando così ad libitum le possibilità pratiche di stilizzazione. Quello tra deformazione plastica e deformazione estetica non è tuttavia un conflitto insolubile o un eterno scontro tra nemici giurati, ma al contrario una quieta e fruttuosa convivenza, spesso di reciproco supporto: le due istanze si incrociano e dialogano sempre più di frequente, e soprattutto oggi, nell’uso di mezzi come la fotografia o il video ormai divenuti imprescindibili per la ricerca contemporanea. La deformazione plastica, infatti, ha trovato in questi strumenti vie di aggiornamento oggi battutissime come l’uso delle distorsioni, delle alterazioni di segnale, e manipolazioni di ogni sorta, per le quali è proprio la deformazione estetica, lanciata nella prospettiva di una potenziale pan-artisticità dell’esperienza, a garantirne il valore espressivo. Da qui in poi, il concetto di deformazione in ambito artistico non potrà che vivere dunque di alternanze e distinzioni, ma questo suo bipolarismo lo manterrà, senza dubbio, fiamma di ogni dibattito sullo stile, sulle poetiche, sull’esistenza dell’arte. Attuale per sempre.
di Pasquale Fameli
Bibliografia
Carrà, C. (1978). La deformazione in pittura (1914). In M. Carrà (a cura di), Carlo Carrà. Tutti gli scritti (pp. 30-33). Milano: Feltrinelli.
Danto, A. (2008). La trasfigurazione del banale. Una filosofia dell’arte (1981). Bari: Laterza.
Denis, M. (1920). Théories 1890-1910. Du symbolisme et de Gauguin vers un nouvel ordre classique (1913). Paris: L. Rouart et J. Watelin Éditeurs; in particolare pp. 23, 268.
Martini, M. (2002). La deformazione estetica (1955). Milano: Unicopli; in particolare: pp. 55-57. Si veda inoltre la prefazione alla seconda edizione di Dino Formaggio, in particolare pp. 2-3.
Merleau-Ponty, M. (1967). “Il linguaggio indiretto e le voci del silenzio” (1952). In Id., Segni. Milano: Saggiatore; in particolare p. 81.
Worringer, W. (1976). Astrazione e empatia (1907). Torino: Einaudi.
-

Eliseo Mattiacci, Rifarsi (1973)
Ogni indagine che ponga il corpo al proprio centro implica spesso, quasi inevitabilmente, un’indagine sull’identità, e la performance italiana dei primi anni Settanta lo ha dimostrato in modo encomiabile. Le pratiche della modificazione somatica e della trasformazione facciale sono state infatti al centro di una stagione culturale che ha visto nella liberazione del corpo la possibilità di un superamento della società dei consumi attraverso una radicale ridefinizione estetica del comune comportamento. Il famoso verso «Je est un autre» di Arthur Rimbaud può essere perciò preso a vessillo di quella che, più che una stagione all’inferno, può essere intesa come una stagione all’interno della questione identitaria.
Quando si parla di mutazione e di modificazione del volto e del corpo in ambito artistico si pensa subito alle performance chirurgiche di Orlan: il suo è senza dubbio uno dei casi più emblematici, ma anche dei più estremi, di una ricerca genuinamente body che ha tuttavia i suoi inizi negli anni Settanta, con modi certamente meno invasivi ma non per questo meno rilevanti. Simili pratiche performative vanno senza dubbio ricondotte all’articolata vicenda di annichilimento dell’io in epoca postmoderna. Già a metà del Novecento, Ronald Laing aveva stabilito che la schizofrenia non fosse un semplice disturbo psichico, ma addirittura la malattia del nostro tempo: secondo lo psichiatra scozzese, infatti, gli uomini costruiscono tanti io falsi per corazzarsi e per difendersi dall’aggressione della realtà. È in questo modo che si giungerà alla minimizzazione dell’io, brillantemente analizzata da Christopher Lasch nei primi anni Ottanta, il quale insisterà proprio come Laing sull’idea che questa riduzione serva da corazza, sia cioè una protezione dai turbamenti del proprio tempo. Tra questi due poli sono molte le tappe che hanno segnato tale percorso, e un ruolo di prim’ordine va riconosciuto agli studi microsociologici di Erving Goffman il quale, considerando il self come maschera, ovvero come costruzione o simulazione di un’identità, ha contribuito in larga parte a mostrarne la fragilità e la precarietà, nonché l’ineludibile dipendenza dalla rete sociale e relazionale.È alle teorie di Goffman che Vito Acconci si è ispirato per le sue prime performance legate proprio alla questione identitaria ed è in questo stesso snodo che si possono collocare certe performance di alcuni artisti italiani dei primi anni Settanta quali Eliseo Mattiacci, Giorgio Ciam, Fernando De Filippi o Lamberto Calzolari, impegnatisi nel tentativo di riconfigurare o espellere il proprio io in sede performativa. Certe teorie e certe riflessioni internazionali su simili problematiche passavano già in Italia, e quindi era facile che questi artisti, come altri, ne fossero a conoscenza; nel Bel Paese tuttavia, la necessità di una riduzione dell’io aveva già trovato luogo nella poesia dei Novissimi, come acutamente rilevato da Alfredo Giuliani già sulla soglia degli anni Sessanta, ed era immaginabile che di lì a breve avrebbe trovato esiti anche con altre forme espressive. La fragilità dell’identità postmoderna, inoltre, ha in Italia una prima formulazione di tutto rispetto nella letteratura di Luigi Pirandello, teorico della nota dicotomia volto-maschera. Quello dei performer italiani è infatti il tentativo di essere uno, nessuno e centomila, e proprio come l’antieroe pirandelliano, ragionano sui difetti e sulle difformità che lo specchio restituisce loro, non certo per vuota vanità, ma per maturare una certa consapevolezza egoico-esistenziale.

Fernando De Filippi, Sostituzione (1974)
La più emblematica di queste azioni è Rifarsi di Eliseo Mattiacci, tenutasi presso la galleria Alexander Jolas di Milano nel 1973: qui l’artista marchigiano si ricopre il viso di argilla, manipolandola e plasmandola nel tentativo di rimodellare i propri tratti somatici. Il concetto del “rifarsi”, oggi molto in voga e legato solitamente alla volontà di migliorare il proprio aspetto oppure di adattarlo ai più correnti canoni estetici, viene posto al centro di un’operazione che va per il verso opposto, con effetto imbruttente. Già in Art Make-Up (1967) Bruce Nauman aveva proposto un ipotetico tentativo di abbellimento in virtù di una certa indagine sul corpo, un’indagine fenomenologica, ma nell’azione di Mattiacci l’esito è nettamente spinto sul versante peggiorativo, quasi a redarguire ogni tentativo di intervento plastico. Del resto, il corpo degli anni Settanta è un corpo da riscoprire in quanto carne dell’essere – chair avrebbe detto Maurice Merleau-Ponty – e non dell’apparire; ed è un corpo amoroso, come quello di Norman O. Brown, oppure un catalizzatore bioenergetico, secondo gli studi condotti da Alexander Lowen sulla scorta delle teorie di Wilhelm Reich, e quindi fremente di liberare senza più limiti le proprie pulsioni.
Sulla pratica del make-up è incentrata anche una performance del bolognese Lamberto Calzolari (fratello del più noto Pier Paolo, esponente di spicco dell’Arte Povera) tenutasi presso la Galleria 2000 di Bologna nel marzo 1974. Nel corso della sua azione Calzolari si sottopone a un lungo maquillage condotto dalla cognata Ginestra (figlia del pittore Vasco Bendini) che lo trucca come una donna, con tanto di cerone e rossetto. Viene infranto il tabù della separazione dei sessi e la liberazione pulsionale si fa esplicita: l’identità appare qui come un concetto da superare in virtù di una più onesta affermazione del corpo, ente detentore, secondo Freud, di componenti maschili e femminili che sono all’origine del processo di identificazione sessuale di ogni individuo. Al di là della problematica sessuale, il ricorso al make-up e il tentativo di “essere un altro” possono tuttavia assumere anche una connotazione politica: è il caso della Sostituzione compiuta dal leccese Fernando De Filippi il 14 marzo 1974 in cui l’artista si trucca per assomigliare a Lenin, già soggetto di molti suoi acrilici iperrealisti del 1971-72. Il lungo e lento processo di trasformazione è stato documentato fotograficamente nelle sue varie fasi, così da potersene mostrare i vari stadi secondo una progressione graduale.
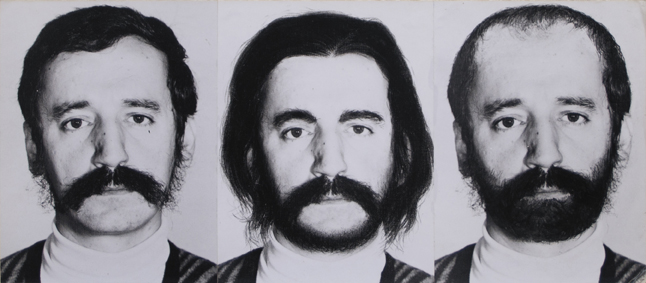
Giorgio Ciam, Sui peli (1972)
Simili operazioni di trasformismo, però lontane da problematiche politiche, sono state compiute in modo più sistematico dall’aostano Giorgio Ciam, attivo a Torino già dalla fine degli anni Sessanta; a differenza di De Filippi, però, l’aostano non interviene direttamente sul proprio volto, affidando piuttosto le sue mutazioni alla manipolazione fotografica. Qui l’identità è presa di mira in maniera diretta e sottoposta a una sorta di “verifica incerta”: sul volto di Ciam vengono di volta in volta applicati barba, baffi, capelli o frammenti di altri volti fino a renderlo completamente irriconoscibile. Mediante queste continue sostituzioni somatiche, Ciam riconfigura il sistema dell’identikit (inventato solo vent’anni prima e subito perfezionato dalla Smith & Wesson) come strumento estetico: negandone la comune funzione, l’aostano ne rovescia completamente il senso, trovando in esso non un mezzo di costruzione facciale ma, al contrario, una metafora della disgregazione identitaria. Le molte combinazioni testate da Ciam sulla propria immagine ripropongono e ribadiscono la volontà tutta novecentesca di “essere un altro” e, insieme alle azioni di Mattiacci, Calzolari e De Filippi, attestano indirettamente come la condizione dell’io in epoca postmoderna sia di continua negazione o di riformulazione, per un’identità dai mille volti.
di Pasquale Fameli
Bibliografia
Barilli, R. (1974). Cronache del comportamento: Lamberto Calzolari, in «NAC», 4, pp. 11-12.
De Filippi, F. (1974). Sostituzione. Milano: Edizioni Arte Borgogna.
Fameli, P. (2015). Vito Acconci e la sparizione dell’io, in «Figure», 2, pp. 71-78.
Giuliani, A. (a cura di) (1965). I Novissimi. Poesie per gli anni ’60 (1961). Milano: Rusconi e Paolazzi.
Goffman, E. (2002). La vita quotidiana come rappresentazione (1959). Bologna: il Mulino.
Laing, R.D. (1969). L’io diviso. Studio di psichiatria esistenziale (1955). Torino: Einaudi.
Lasch, C. (1985). L’io minimo. La mentalità della sopravvivenza in un’epoca di turbamenti (1984). Milano: Feltrinelli.
Pirandello, L. (1992). Uno, nessuno e centomila (1926). Milano: Mondadori.
Re, E. (a cura di) (2007). Giorgio Ciam. Dentro il sogno 1969-1995. Prato: Gli Ori.
Trini, T. (1973). Mattiacci. Milano: Galleria Alexander Iolas.
-
Estesie – A cura di Pasquale Fameli
Estesie, Serial / Marzo 2016Estesie. Forme e idee del Novecento è uno spazio di riflessione sui rapporti tra l’arte e la filosofia, un banco di prova dei loro possibili intrecci e un laboratorio in cui testarne le loro forze magnetiche. Tra i molti settori della cultura di una determinata epoca vengono infatti a stabilirsi delle connessioni spontanee, delle sintonie inattese o non necessariamente cercate, che contribuiscono tuttavia ad avvalorarne i tratti somatici e a farne emergere le peculiarità. Prendendo spunto dalle poetiche, dalle teorie o dai fatti artistici ed estetici più rilevanti del Novecento, nello spazio di Estesie vengono testate le loro molteplici aperture connettive, secondo una concezione rizomatica della cultura che vede nell’intersezione e nella trama reticolare le più efficaci forme di comprensione dell’oggi.
Pasquale Fameli (1986) è dottorando in Arti visive, performative e mediali presso l'Università di Bologna. Si occupa di ricerche extra-pittoriche del Novecento, con particolare attenzione ai fenomeni sonori e sinestetici.
-
Che cosa può motivare la scelta di dedicare un libro al problema del «precategoriale» in
 Husserl? Il libro di Federica Buongiorno, Logica delle forme sensibili. Sul precategoriale nel primo Husserl, è motivato dalla convinzione che il problema del precategoriale sia un tema inaggirabile della fenomenologia di Husserl, un problema del quale la fenomenologia husserliana può e deve rispondere. In un passo molto chiaro Buongiorno afferma che il «compito della fenomenologia […] è appunto quello di condurre l’anonimo (l’implicito) al categoriale e ricondurre poi quest’ultimo […] alle radici pre-categoriali» (p. 184). La difficoltà – a ragione valorizzata in questo libro – risiede nel fatto che la precedenza del precategoriale non rappresenta il momento iniziale di un processo conoscitivo, bensì quel tratto costitutivamente «anonimo» e «non tematico» dell’«esperienza fondante» (p. XVII). L’Autrice, dunque, evidenzia sin dall’inizio come la differenza tra «categoriale» e «precategoriale» non vada intesa, per così dire, in maniera lineare, cioè come una differenza tra due momenti di un medesimo processo conoscitivo, ma come il problematico opporsi di due livelli irriducibilmente distinti: il «tematico» e il «non tematico». Il precategoriale è un fenomeno rilevante proprio in quanto costituisce quella «esperienza fondante» che si sottrae alla tematizzazione e alla conoscenza tradizionale, e che impegna la fenomenologia nella sua specificità.
Husserl? Il libro di Federica Buongiorno, Logica delle forme sensibili. Sul precategoriale nel primo Husserl, è motivato dalla convinzione che il problema del precategoriale sia un tema inaggirabile della fenomenologia di Husserl, un problema del quale la fenomenologia husserliana può e deve rispondere. In un passo molto chiaro Buongiorno afferma che il «compito della fenomenologia […] è appunto quello di condurre l’anonimo (l’implicito) al categoriale e ricondurre poi quest’ultimo […] alle radici pre-categoriali» (p. 184). La difficoltà – a ragione valorizzata in questo libro – risiede nel fatto che la precedenza del precategoriale non rappresenta il momento iniziale di un processo conoscitivo, bensì quel tratto costitutivamente «anonimo» e «non tematico» dell’«esperienza fondante» (p. XVII). L’Autrice, dunque, evidenzia sin dall’inizio come la differenza tra «categoriale» e «precategoriale» non vada intesa, per così dire, in maniera lineare, cioè come una differenza tra due momenti di un medesimo processo conoscitivo, ma come il problematico opporsi di due livelli irriducibilmente distinti: il «tematico» e il «non tematico». Il precategoriale è un fenomeno rilevante proprio in quanto costituisce quella «esperienza fondante» che si sottrae alla tematizzazione e alla conoscenza tradizionale, e che impegna la fenomenologia nella sua specificità.Ma non è questo il tema specifico del libro, che tratta, come esplicita il sottotitolo, del precategoriale «nel primo Husserl». Questa restrizione tematica rende ancor più ambiziosa la sfida di questo testo. Mettere a tema il precategoriale nel primo Husserl significa infatti individuare e discutere tale questione al livello metodologico e problematico delle Ricerche Logiche, quindi, prima della «riduzione fenomenologica» delle Idee, prima delle analisi genetiche e prima che Husserl, nella Crisi delle scienze europee, affronti esplicitamente il problema del «mondo della vita». Ma è proprio questa la sfida del libro di Federica Buongiorno, che – sempre consapevole di queste difficoltà – cerca di pensare il precategoriale con Husserl (nello specifico, con il primo Husserl) ma anche oltre Husserl. Per ragioni di spazio, in questa recensione mi concentro su questi due aspetti principali del libro, sebbene esso affronti con precisione filologica moltissime altre questioni; mi limito a ricordare il rapporto con Brentano (cap. I), l’influenza di Bolzano (cap. II) e il confronto con Kant, che l’Autrice valorizza costantemente.
Innanzitutto, vorrei richiamare l’attenzione sul titolo del testo. Che il problema del precategoriale abbia a che fare con qualcosa come una «logica delle forme sensibili» può sembrare, soprattutto per lo studioso di fenomenologia, una cosa ovvia. In realtà questo legame, tutt’altro che pacifico, tra il precategoriale e la logica delle forme sensibili sintetizza la tesi centrale di questo libro. Si tratta dell’idea – lo dico con parole mie – che il problema del precategoriale conduca all’elaborazione di una radicale “logica del sensibile”, a una “logica” che, in quanto “dedotta” dalla sensibilità stessa, di “logico” in senso tradizionale conserva ben poco. Ci si deve innanzitutto chiedere in che misura il primo Husserl ci offra la possibilità di pensare questa “logica del sensibile”, e in che misura questa “logica” sia capace di restituire, nella sua ricchezza e originarietà, il fenomeno del precategoriale.
Nell’“Introduzione”, in un passo molto significativo sul quale tornerò in chiusura, si dice che il carattere «costitutivamente problematico» del precategoriale introduce una «tensione di carattere fondazionale all’interno della teoria husserliana». Il punto è che questa tensione non può «essere risolta richiamandosi alla predelineazione del categoriale nel suo fondamento ante-predicativo, sebbene sia questo il ragionevole orizzonte interpretativo nel quale disporre il problema» (p. XII, corsivo mio). Il problema del precategoriale comporta infatti una strutturale eccedenza rispetto a una certa idea di precategoriale, una idea già attiva a livello delle Ricerche Logiche e definibile come una «predelineazione del categoriale» nella sensibilità. Questa “eccedenza” rappresenta a mio avviso qualcosa di decisivo per questo libro, nel quale l’analisi filologica del testo husserliano, volta a individuare la presenza del precategoriale nel primo Husserl, è costantemente ravvivata dalla consapevolezza della portata filosofica e teoretica del problema. La discussione del problema del precategoriale nel primo Husserl trova il proprio centro nel concetto di «intuizione categoriale», di cui Federica Buongiorno rintraccia le origini (cap. III. 1,2) e di cui ricostruisce – inquadrando la nozione all’interno delle Ricerche Logiche – il contesto problematico (cap. III. 3), per offrirne poi una analisi mirata nella parte finale del libro (cap. IV).
A un primo livello si può dire che la rilevanza dell’intuizione categoriale per il problema del precategoriale risiede nel fatto che, come è noto, attraverso questa nozione diventa possibile pensare il categoriale come dato. Questa nozione – ecco la sfida lanciata a Kant – implica una «profonda riconsiderazione dei rapporti tra sensibilità e intelletto, tra base estetica (precategoriale) e operazioni logico-discorsive» (p. 148). Ma, a mio avviso, Buongiorno coglie un punto fondamentale quando parla di una «duplice vettorialità» dell’intuizione categoriale (p. 136). Questa espressione dà voce al duplice aspetto dell’intuizione categoriale, come atto fondato sull’intuizione sensibile e come atto che offre al tempo stesso un nuovo tipo di oggettualità, una oggettualità eccedente rispetto all’intuizione sensibile. È forse proprio questa duplice vettorialità dell’intuizione categoriale ciò che permette di preservare il carattere originario, sensibile e intuitivo del precategoriale, senza tuttavia ridurre la sensibilità (per dirla con Kant) a una “intuizione cieca”, o (con le parole dell’Autrice) a una “mera sensibilità”, con cui il precategoriale, come giustamente viene precisato, non deve essere mai confuso (p. XVII). È sempre in quest’ottica che nel testo ci si confronta con il concetto fenomenologico di intuizione «in senso ampio». L’intuizione categoriale – l’esempio della copula è emblematico – presuppone proprio la possibilità di intuire (in senso ampio) qualcosa di radicalmente non intuibile (in senso stretto). Come rileva Buongiorno, l’allargamento fenomenologico del concetto di intuizione va di pari passo con l’«ampliamento dell’esistenza alla sfera logico-ideale» (p. 115).
L’insistenza su questa duplice vettorialità dell’intuizione categoriale è inoltre coerente con una prima importante scelta metodologica del testo. Buongiorno individua infatti nella rielaborazione husserliana della teoria brentaniana delle «rappresentazioni improprie» una chiave di lettura per comprendere la specificità della concezione fenomenologica del rapporto tra «intuizione (riempimento)» e «intelletto (intenzione
 significante)». Se per Brentano «le rappresentazioni improprie e i giudizi su di esse fondati avevano carattere “pseudo-conoscitivo”, […] per Husserl è possibile cogliere intuitivamente gli oggetti ideali» (p. 52). L’Autrice mette in luce il fatto che le rappresentazioni simboliche (intese come rappresentazioni improprie) contengono in sé un rinvio al «pre-logico». È proprio in virtù di questo «presupposto pre-logico» che il rappresentare simbolico, sebbene improprio, non si vede precluso un orizzonte di possibile datità. L’intuizione categoriale viene poi tematizzata in maniera analitica nell’ultimo capitolo del libro, di cui posso ricordare solo alcune pagine. L’Autrice, richiamandosi a Lohmar, distingue tre diversi livelli dell’intuizione categoriale (p. 173). In primis, la percezione semplice o «percezione complessiva» (Gesamtwahrnehmung), che offre un oggetto sensibile «unitario» (per esempio una porta rossa). Successivamente, la «percezione specifica» o «intenzione esplicitante», che è «ancora percezione, dunque un atto semplice», anche se «non ha più un carattere complessivo»; a questo livello «l’atto non è ancora mutato: ci limitiamo a concentrare il nostro interesse percettivo su un momento dell’intero» (nell’esempio, il rosso della porta). Infine, l’intuizione categoriale, dove «le parti esplicitate della Sonderwahrnehmung vengono ricombinate e connesse da un atto categoriale e sintetico» (l’esser-rossa-della-porta, il giudizio ‘la porta è rossa’). Secondo l’Autrice – e qui veniamo a uno snodo fondamentale del testo – il «fenomeno decisivo, sul piano categoriale, avviene già nel passaggio dalla Gesamtwahrnehmung alla Sonderwahrnhemung, le quali rientrano ancora nella modalità intuitiva semplice, sensibile». In questo livello intermedio si mostrerebbe dunque una strutturale e positiva ambiguità dell’intuizione: il momento esplicitante si configura come una «sintesi della coincidenza» che «non è ancora una formazione categoriale, ma non è neppure più o soltanto un contenuto sensibile. […] È proprio in questo discrimine interno alla sensibilità ma già aperto sul categoriale, in questo tratto di scivolosa commistione tra intuizione primaria e secondaria che il precategoriale fa valere il proprio impatto problematico all’interno della Sesta Ricerca» (pp. 175-176, corsivo mio).
significante)». Se per Brentano «le rappresentazioni improprie e i giudizi su di esse fondati avevano carattere “pseudo-conoscitivo”, […] per Husserl è possibile cogliere intuitivamente gli oggetti ideali» (p. 52). L’Autrice mette in luce il fatto che le rappresentazioni simboliche (intese come rappresentazioni improprie) contengono in sé un rinvio al «pre-logico». È proprio in virtù di questo «presupposto pre-logico» che il rappresentare simbolico, sebbene improprio, non si vede precluso un orizzonte di possibile datità. L’intuizione categoriale viene poi tematizzata in maniera analitica nell’ultimo capitolo del libro, di cui posso ricordare solo alcune pagine. L’Autrice, richiamandosi a Lohmar, distingue tre diversi livelli dell’intuizione categoriale (p. 173). In primis, la percezione semplice o «percezione complessiva» (Gesamtwahrnehmung), che offre un oggetto sensibile «unitario» (per esempio una porta rossa). Successivamente, la «percezione specifica» o «intenzione esplicitante», che è «ancora percezione, dunque un atto semplice», anche se «non ha più un carattere complessivo»; a questo livello «l’atto non è ancora mutato: ci limitiamo a concentrare il nostro interesse percettivo su un momento dell’intero» (nell’esempio, il rosso della porta). Infine, l’intuizione categoriale, dove «le parti esplicitate della Sonderwahrnehmung vengono ricombinate e connesse da un atto categoriale e sintetico» (l’esser-rossa-della-porta, il giudizio ‘la porta è rossa’). Secondo l’Autrice – e qui veniamo a uno snodo fondamentale del testo – il «fenomeno decisivo, sul piano categoriale, avviene già nel passaggio dalla Gesamtwahrnehmung alla Sonderwahrnhemung, le quali rientrano ancora nella modalità intuitiva semplice, sensibile». In questo livello intermedio si mostrerebbe dunque una strutturale e positiva ambiguità dell’intuizione: il momento esplicitante si configura come una «sintesi della coincidenza» che «non è ancora una formazione categoriale, ma non è neppure più o soltanto un contenuto sensibile. […] È proprio in questo discrimine interno alla sensibilità ma già aperto sul categoriale, in questo tratto di scivolosa commistione tra intuizione primaria e secondaria che il precategoriale fa valere il proprio impatto problematico all’interno della Sesta Ricerca» (pp. 175-176, corsivo mio).Federica Buongiorno può dunque affermare che il precategoriale, costituendo la “radice sensibile” dell’intuizione categoriale, è implicitamente presente nella Sesta Ricerca. Questa tesi non è affatto ovvia. L’Autrice, infatti, riconosce con Lohmar che a livello di quest’opera (nelle quale le analisi genetiche sono lasciate da parte) la percezione è assunta «a-problematicamente». Del resto, già nell’“Introduzione” si legge che il tentativo di tematizzare il precategoriale nel primo Husserl si scontra con un dato innegabile: il carattere statico e non genetico delle analisi delle Ricerche Logiche. Eppure il problema può e deve essere posto, perché tanto il carattere «complessivo» della percezione quanto la «sintesi della coincidenza» risulterebbero difficilmente spiegabili senza presupporre questo riferimento al precategoriale. Ci si può infatti chiedere: «come fa la percezione ad afferrare A come un intero?» (p. 206). È per rispondere a domande come questa che l’Autrice richiama, come «supplemento concettuale indispensabile» (p. 180), la nozione di Typus, che Husserl guadagnerà successivamente, nella quale è possibile individuare quella forma di «schematismo fenomenologico» che costituisce un presupposto implicito dell’intuizione categoriale. Proprio a partire da questo schematismo fenomenologico si rende inoltre apprezzabile la differenza tra Husserl e Kant, sulla quale l’Autrice insiste in vari luoghi ma che emerge molto incisivamente dalla considerazione della Terza ricerca. La «riconsiderazione dei rapporti tra sfera analitica e sintetica» – rendendo pensabile un rapporto che ha carattere essenziale e analitico, pur implicando una sintesi (è il caso del legame essenziale tra qualità e intensità) – permette ad Husserl di «fondare esteticamente l’apriori» (p. 120). Attraverso l’apriori materiale Husserl riferisce la forma «“alle cose stesse”» (p. 125), «sono gli oggetti a fornire il Leitfaden della conoscenza» (p. 127).
Il radicamento dell’intuizione categoriale in una sensibilità “ibrida” e “già aperta al categoriale”, e così l’idea secondo la quale la sensibilità racchiude una “logica degli oggetti”, sono aspetti particolarmente emblematici del modo in cui il primo Husserl pensa il precategoriale. Ma è forse proprio in questa logica degli oggetti che il tentativo husserliano sembra essere attraversato da quella problematicità che rappresenta un aspetto essenziale del fenomeno del precategoriale, il contrassegno della sua “eccedenza” rispetto al categoriale. Si può infatti dire che se da un lato l’intuizione categoriale, esibendo il necessario radicamento del categoriale nella sensibilità, è una condizione per porre il problema del precategoriale, dall’altro si ha l’impressione che in Husserl l’“anteriorità originaria” del precategoriale rimanga limitata a questa predelineazione delle categorie nella sensibilità. Ciò è del resto riconosciuto dall’Autrice in un passo dell’“Introduzione” che ho già citato, ma che voglio richiamare di nuovo. Vi si dice, per l’appunto, che la «tensione» provocata dal precategoriale non può «essere risolta richiamandosi alla predelineazione del categoriale nel suo fondamento ante-predicativo, sebbene sia questo il ragionevole orizzonte interpretativo nel quale disporre il problema» (corsivo mio). Per questo motivo il libro di Federica Buongiorno suggerisce la necessità di pensare il precategoriale non solo «con» Husserl, ma anche «oltre» Husserl.
A mio avviso, le ultime pagine di questo testo possono essere lette come una ripresa e una radicalizzazione della situazione problematica presentata nell’“Introduzione”, dove il precategoriale è indicato come un fenomeno situato «nello scivoloso discrimine tra originarietà e descrittività» (p. XII). Questa radicalizzazione è operata facendo riferimento alla «paradossalità» fenomenologica del soggetto (come soggetto e come oggetto, come costituente e costituito), che rappresenta secondo l’Autrice «la cifra stessa della fenomenologia». In effetti, lo statuto paradossale del soggetto comporta una difficoltà teoretica analoga alla più volte segnalata “problematica anteriorità” del precategoriale. Ma in che senso si può dire che la domanda sul soggetto costituisce una radicalizzazione della domanda sul precategoriale? Leggendo queste ultime pagine la risposta sembra essere la seguente: la commistione tra «passività» e «attività» oppure tra «intuizione» e «pensiero», fin qui affrontata in stretto rapporto all’intuizione categoriale, viene ora pensata come essenzialmente appartenente alla struttura del soggetto. Da questo punto di vista, a essere ambigua non è innanzitutto la sensibilità, come mostra l’analisi dell’intuizione categoriale, ma la stessa soggettività umana. La questione del precategoriale, dunque, comporta non soltanto un abbandono del presupposto antropologico kantiano (la divisione della capacità conoscitiva in sensibilità e intelletto) ma mette la fenomenologia di fronte alla domanda «come è l’uomo?», domanda che secondo l’Autrice è presente nel pensiero di Husserl, pur restando «difficilmente dipanabile» al suo interno.
Per concludere, questo libro, nel suo lato più strettamente husserliano, mostra in maniera filologicamente dettagliata come il problema del precategoriale conduca all’elaborazione di una logica delle forme sensibili che trova – diversamente che in Kant – negli oggetti stessi il proprio filo guida. D’altro canto, le ultime pagine di questo testo, rivendicando una aspirazione teoretica che va oltre il testo husserliano, indicano nella domanda antropologica «come è l’uomo?» una via più radicale per pensare il precategoriale.
di Fabio Pellizzer
-
Ne Il suono e l’immagine Ramaglia si propone di analizzare in modo esauriente il rapporto tra immagine e suono nel film sonoro narrativo, ponendo particolare attenzione al contributo di questa seconda componente nei confronti della prima e seguendone l’evoluzione per arrivare fino alle sperimentazioni moderne e contemporanee.
Il sottotitolo espone già chiaramente ciò che si intende per suono in ambito cinematografico: gli elementi che compongono la colonna sonora di un film, infatti, non sono solo la musica e la voce, ma anche e con altrettanta importanza il rumore e l'assenza di suono, vale a dire il silenzio. È a partire da questa suddivisione che il testo di Ramaglia si sviluppa, in modo conciso, ben strutturato e tramite l'analisi di numerose sequenze filmiche.
I primi due capitoli illustrano i diversi approcci che si possono avere nell'analisi audiovisiva: quello diegetico (dal greco diéghesis, racconto), relativo all'insieme di suoni che appartengono all'universo narrativo del film; quello sincronico e quello diacronico, che analizzano il rapporto tra suono ed immagine rispettivamente all'interno di una singola sequenza o dell'intero film.
Se nei film muti l'aspetto visivo aveva sempre prevalso su quello uditivo (che consisteva, al massimo, nell'accompagnamento musicale dal vivo di quello che poi diventerà il “golfo mistico invisibile” (p. 9)), con l'avvento del sonoro le dinamiche variano notevolmente e si sviluppano tra le due componenti diversi tipi di legame: il parallelismo, più convenzionale, spontaneo ed affine all'anima umana; il contrappunto, che «suggerisce elementi di senso» (p. 31) nuovi rispetto all'immagine; l'indifferenza, in cui immagine e suono si sviluppano in modo indipendente.
I primi due stili usano principalmente i suoni over, extradiegetici, generando empatia nello spettatore, mentre il terzo tende ad usare i suoni diegetici in ed off, a seconda che la sorgente sonora sia o meno individuata, provocando nello spettatore un “effetto anempatico”, a cui è dedicato l'intero terzo capitolo. Esso sta alla base dell'idea di “rumore”: la maggiore ambizione del cinema è ed è sempre stata quella dell'illusione di realtà, di far sembrare vero ciò che si vede sullo schermo; per realizzare ciò, soprattutto nelle sequenze in cui i suoni non sono unicamente extradiegetici, il cinema ha bisogno di poter ricreare la realtà così come la si vive nel concreto, a partire dal costante sottofondo sonoro che sempre la caratterizza. Una realtà aleatoria e polifonica che, passando spesso inosservata perfino a chi la vive, è molto difficile da riprodurre fedelmente.
L'importanza di questo capitolo centrale deriva dal fatto che solo in questo terzo caso il suono è in grado di rendersi autonomo dall'immagine, di esprimersi nella sua natura e comunicare anch'esso qualcosa, senza però distaccarsi mai del tutto dalla componente visiva: le due dimensioni, secondo una felice definizione deleuziana, sono “eautonome”, indipendenti ma necessariamente sempre legate. Tale caratteristica non intacca, ma, anzi, rafforza la natura audiovisiva dell'immagine, permettendo al cinema moderno di sperimentare ulteriormente anche sulla dimensione sonora. È il caso della “poliarmonia anempatica” quotidiana (p. 52-53) presente nel capolavoro hitchcockiano Rear Window (1952), o ancora della confusione sonora in La femme du Gange (1973) di Marguerite Duras o, infine, del rapporto simboleggiato dalle coppie aria/suono e terra/immagine in Moses und Aron (1975) di Straub e Huillet, entrambi citati da Deleuze ne L’immagine-tempo.
Il quarto capitolo è invece incentrato su film e sequenze che dedicano particolare attenzione alla componente musicale dell'audiovisivo, sviluppata in forma narrativa oppure in grado di dare spazio ad un genere di protagonismo musicale non-narrativo che Ramaglia definisce “ludico”, in riferimento al concetto di gioco già presente in Gadamer (p. 68).
Quello del gioco è un tema direttamente collegato alle idee di movimento e danza, nonché al modo d'essere dell'auto-rappresentazione; ed è proprio in questi termini che va inteso il gioco musicale nel cinema, inseribile come ritardo ludico del racconto, come sospensione ludica nel corso del film o, infine, come conclusione ludica (si pensi rispettivamente all'ouverture di Apocalypse Now (1979) di Coppola, alle particolari sospensioni di 2001: A space Odyssey (1968) di Kubrick, e al finale di 8½ (1963) di Fellini, film adeguatamente analizzati nel corso del capitolo).
Nel quinto ed ultimo capitolo l’analisi verte sul silenzio, posto alla fine del testo non perché meno importante delle altre componenti del sonoro cinematografico, ma perché meno immediato da comprendere; di silenzio al cinema, infatti, si può iniziare a parlare solo con l'avvento del sonoro, come sua consapevole “negazione”.
Analogamente a ciò che accade con l'elemento sonoro, il silenzio può mimetizzarsi con la realtà cinematografica quando è giustificato dagli eventi e non sommerge totalmente la dimensione sonora (diegetico/relativo), oppure può invadere arbitrariamente l'intera gamma sonora della sequenza, che diventa così irrealistica (extradiegetico/assoluto). Nel primo caso sono i suoni in/off ad essere sospesi, pur lasciando spazio ad altri meno significativi, mentre nel secondo caso il silenzio è generato dall'improvvisa assenza del suono over del golfo mistico invisibile.
Caso estremo ed eccezionale su cui si chiude l'intero testo è, infine, quello del “silenzio diegetico assoluto” di 2001 odissea nello spazio di Kubrick, già citato in precedenza per le numerose sospensioni ludiche. Tale definizione apparentemente aporetica sta ad indicare un silenzio totale che però, allo stesso tempo, è anche giustificato dalla narrazione in cui ben si mimetizza: è il silenzio dello spazio, anempatico e raggelante, soprattutto nel momento in cui viene legato alla morte con la maestria di Kubrick, regista che «rimane uno dei più profondi indagatori delle possibilità del linguaggio audiovisivo» (p. 107).
Nell'analizzare lo sviluppo del sonoro in rapporto all'immagine, Deleuze sottolinea più volte come esso si renda sempre più indipendente dal monopolio del visivo, per cercare non solo di comunicare qualcosa in modo autonomo ma, anche e soprattutto, per riuscire a far vedere nell'immagine cui viene associato qualcosa che altrimenti non si sarebbe potuto vedere. L'atto udito, in altre parole, vede, «è visto, come se si tracciasse un percorso nell'immagine visiva»; scava lo spazio visivo e vi si inserisce, riempiendolo e arricchendolo. Non è un caso se anche Chion, e con lui Deleuze ne L'immagine-tempo, riporti tra gli esempi di “voci che vedono” quella del computer di 2001: A space Odyssey, confermando così l'importante rilevanza assegnata da Ramaglia alle componenti sonore del film.
Dalle analisi dell’autore e dalle riflessioni di Deleuze non si può che concludere, d'accordo con entrambi, che il suono è in grado di creare nell'immagine una dimensione nuova, diventandone così componente imprescindibile e permettendo al cinema di esplorare orizzonti di regia e montaggio innovativi. In questo modo il cinema può abbandonare progressivamente i retaggi di un ingenuo realismo, ancora imperniato sui “legami senso-motori”, per concentrarsi maggiormente sull'astratto dell'ottico-visivo, sui décadrages, sugli interstizi tra le inquadrature, sui falsi raccordi.
La musica rende l'immagine cinematografica interamente ed immediatamente leggibile, «un po' come una partitura», afferma Deleuze: l'immagine vede l'indicibile e il suono dice l'invisibile, in un'eautonomia che ha già raggiunto elevatissimi livelli di comunicazione e sperimentazione audiovisiva (si vedano, oltre ai già citati, anche Godard, Ozu, Rossellini, Resnais), nonostante questo resti un campo dalle risorse ampie, forse inesauribili.
Oltre che sperimentare ed analizzare, infine, del cinema bisogna fruire: «Perché il suono chiede di essere ascoltato. Mentre le immagini scorrono veloci davanti ai nostri occhi. Nel buio di una sala» (p. 108), conclude Ramaglia.
di Maria Adorno
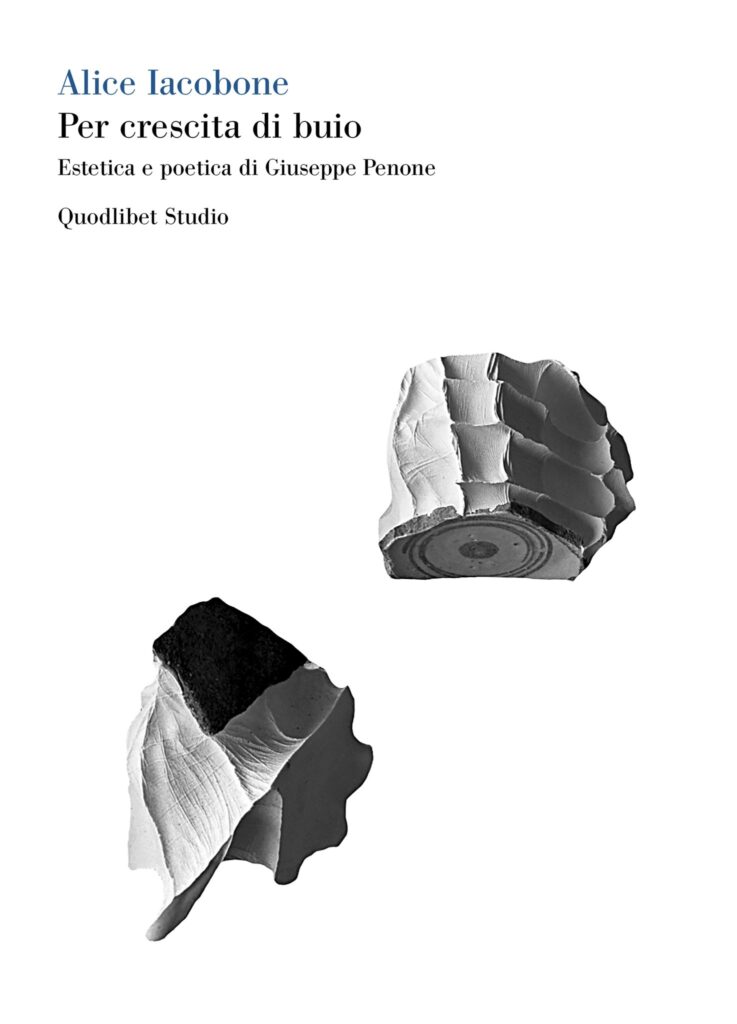
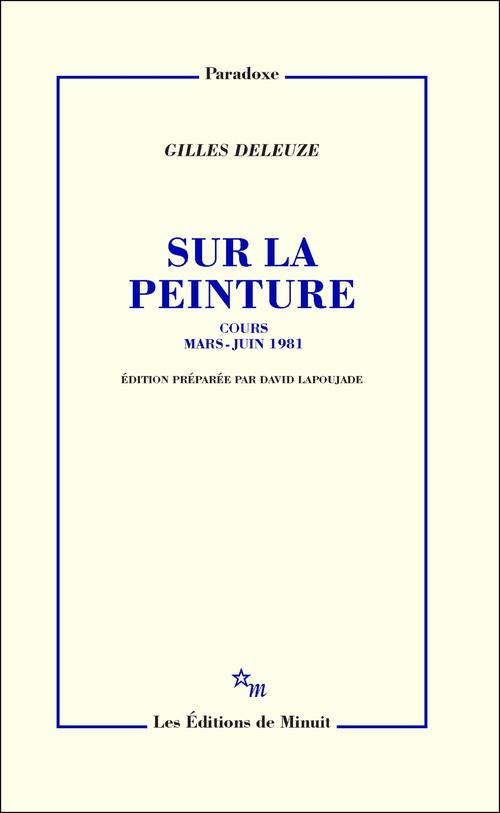
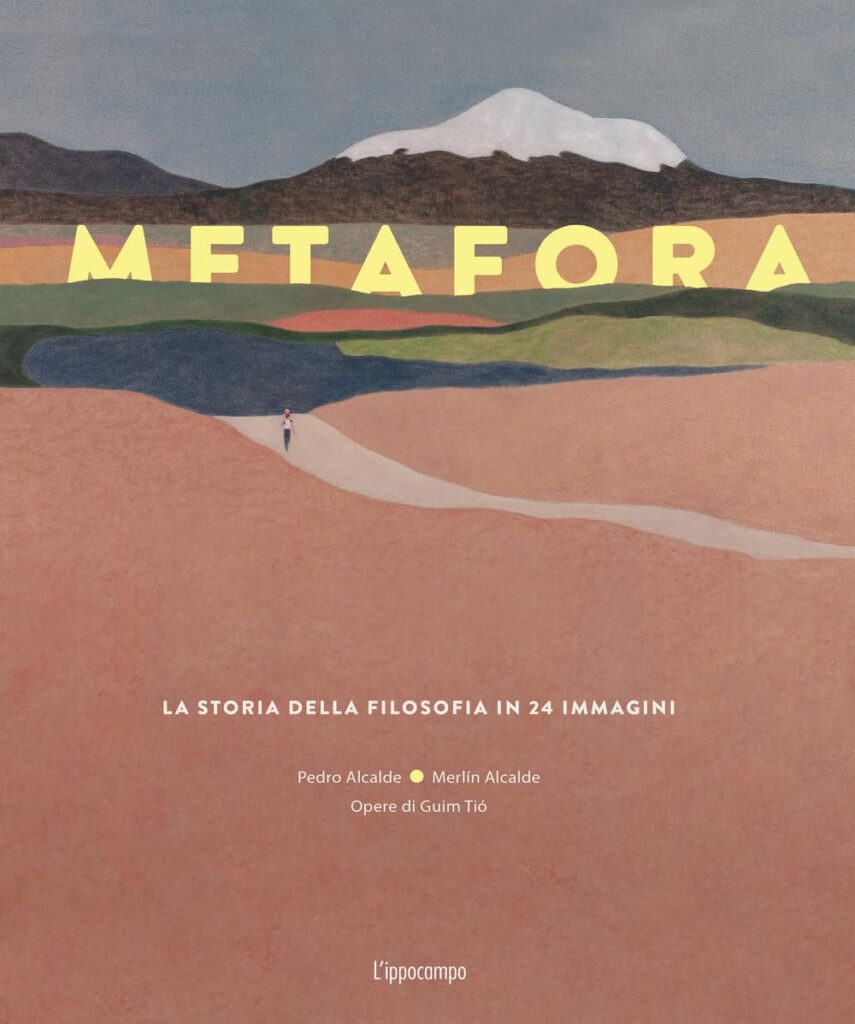




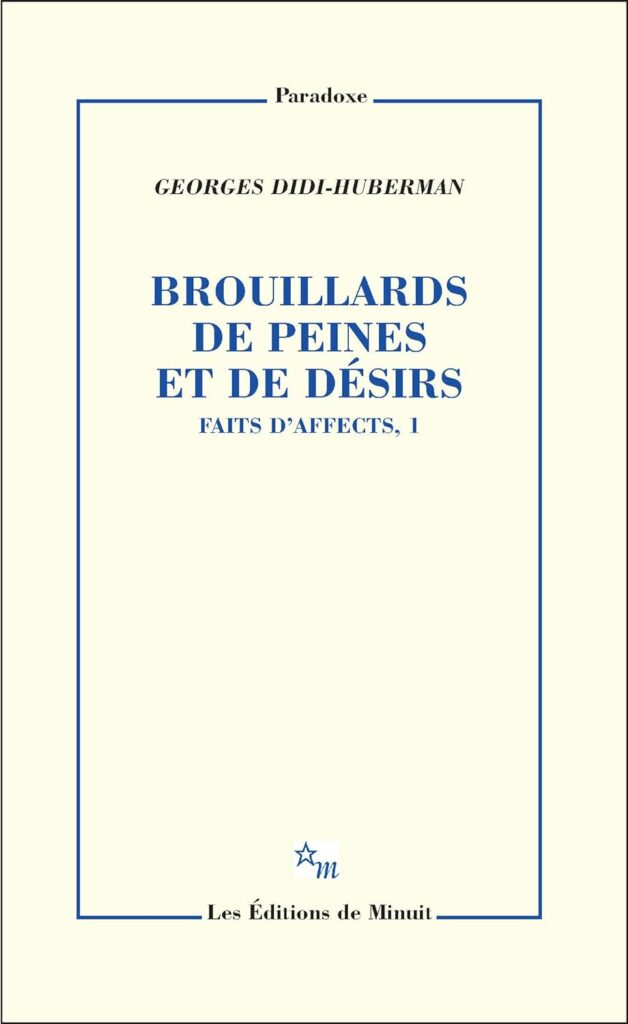
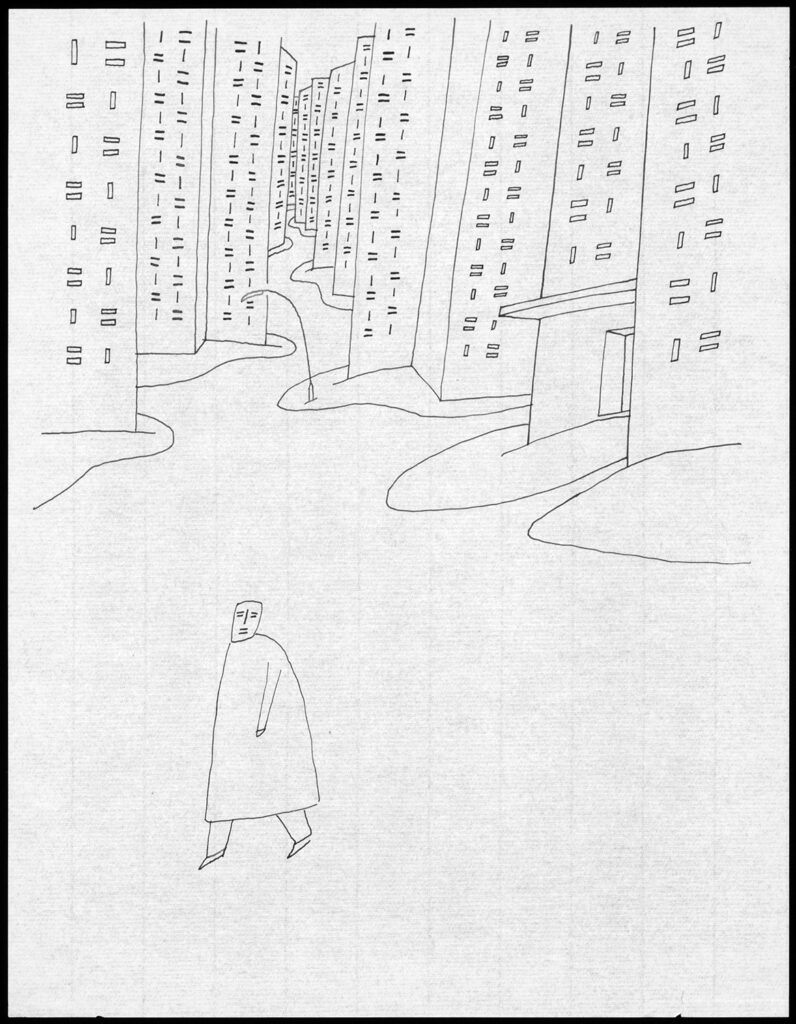



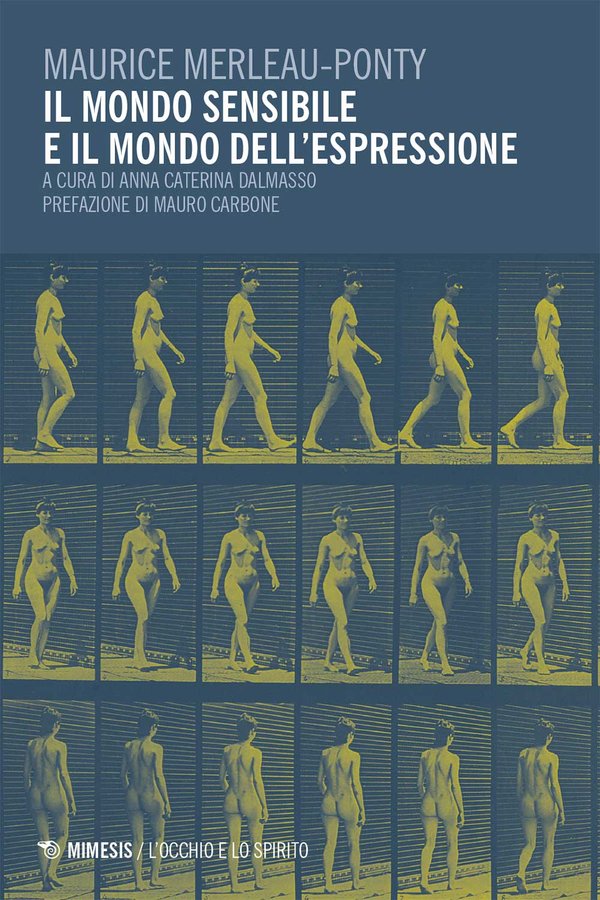


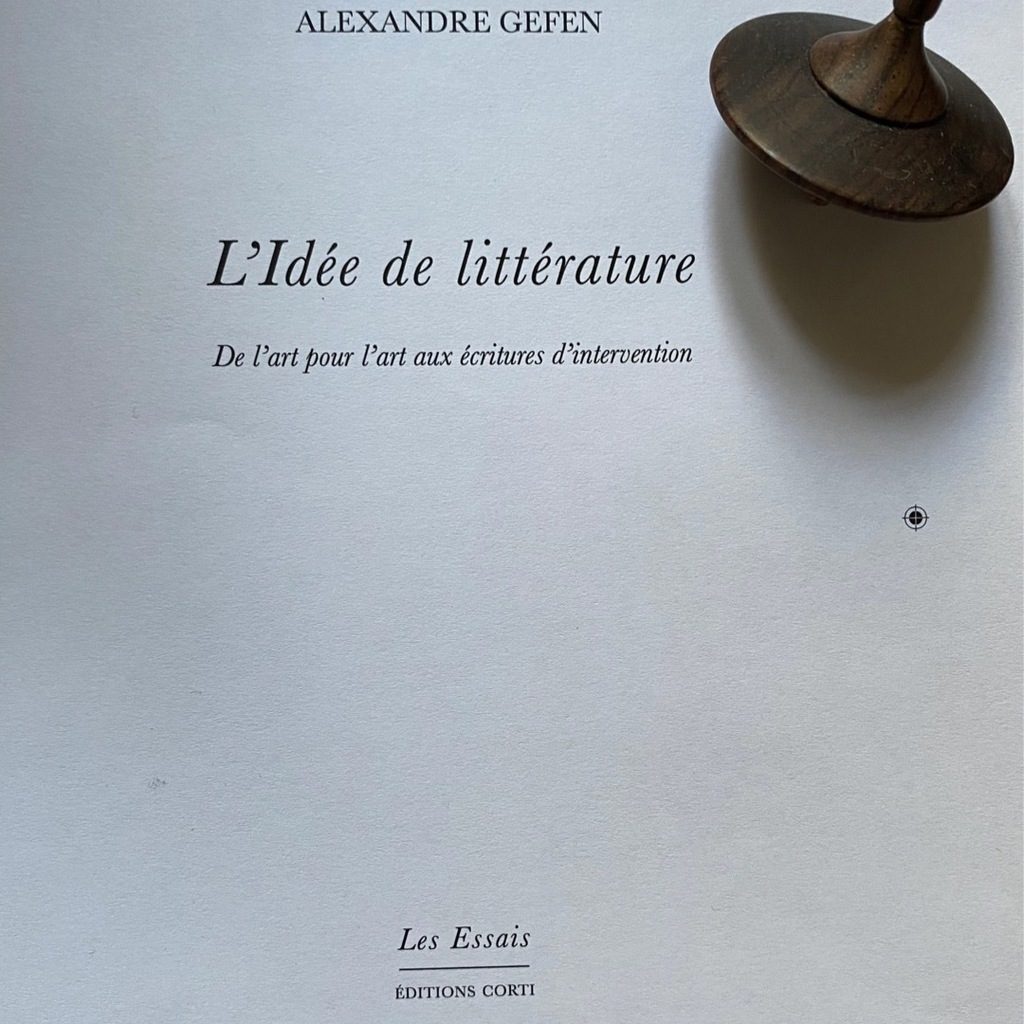












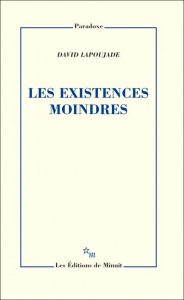
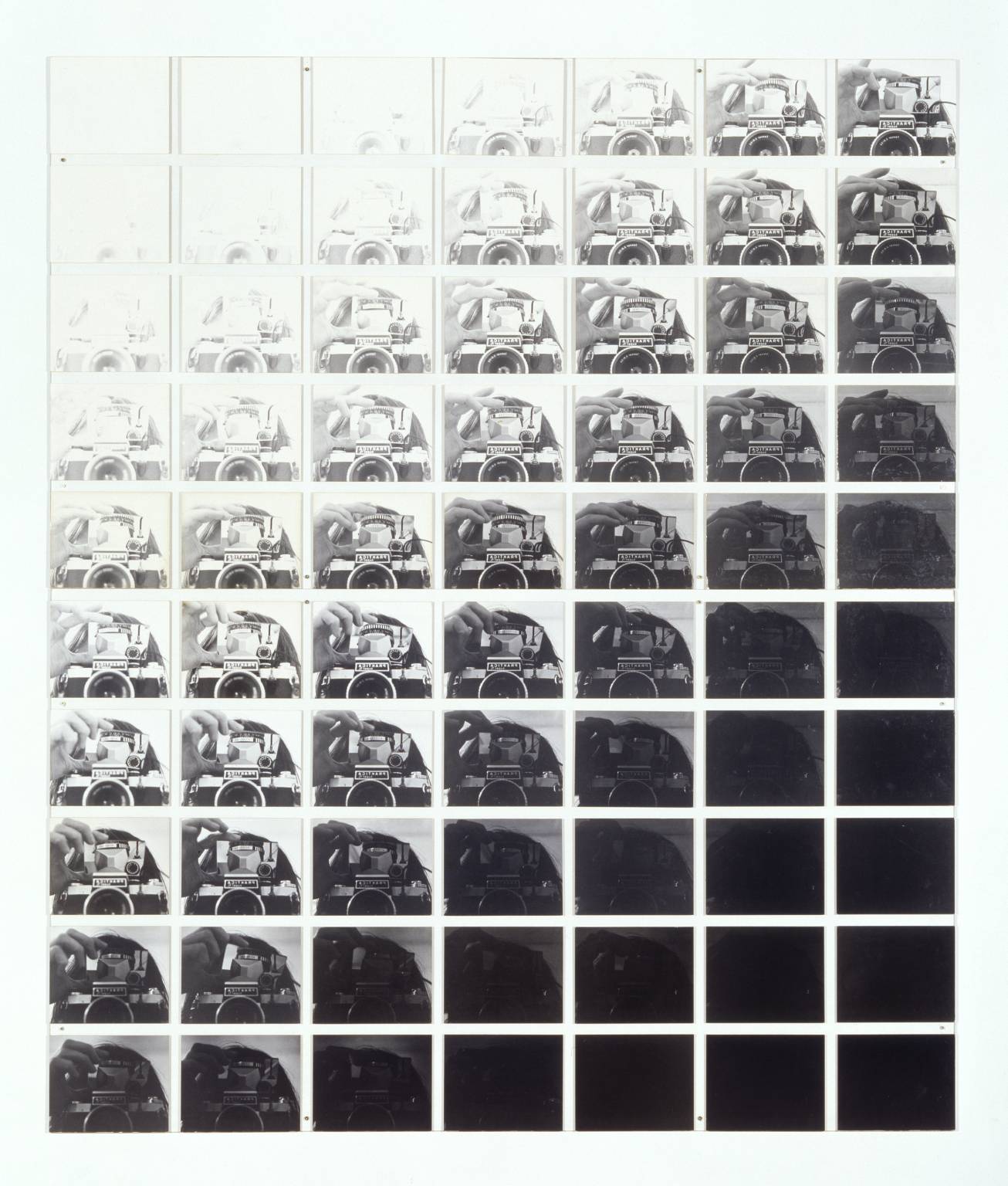


 Uno dei primi libri realizzati assieme da Philippe Lacoue-Labarthe e Jean-Luc Nancy è un saggio sui (e un’antologia dei) testi del primo romanticismo tedesco, dal titolo L’absolu littéraire. Théorie de la littérature du romantisme allemand (Lacoue-Labarthe – Nancy, 1978). Si tratta di un volume di grande importanza, purtroppo non disponibile in italiano. Nella raccolta, i due filosofi hanno scelto, introdotto, annotato e tradotto scritti dovuti principalmente ai fratelli Schlegel, a Novalis e a Schelling. La ragione del titolo viene spiegata in maniera sintetica nella quarta di copertina del volume: «Prima di far epoca nella letteratura e nell’arte, prima di rappresentare una sensibilità o uno stile […], il romanticismo è innanzitutto una teoria. E l’invenzione della letteratura. Costituisce anzi, precisamente, il momento inaugurale della letteratura come produzione della propria teoria – e della teoria che pensa se stessa come letteratura. In tal modo, apre l’epoca critica alla quale apparteniamo ancora. Poietica in cui il soggetto si confonde con la propria produzione, e Letteratura chiusa sulla legge del proprio generarsi, il romanticismo (noi, insomma) è il momento dell’assoluto letterario». Si tratta di dichiarazioni a prima vista azzardate, ma in realtà condivisibili. Di fatto, quelle nate in Germania alla fine del Settecento sono, se non proprio la letteratura e la critica tout court, perlomeno la forma autoriflessiva che esse hanno assunto, non di rado, in epoca moderna e contemporanea...
Uno dei primi libri realizzati assieme da Philippe Lacoue-Labarthe e Jean-Luc Nancy è un saggio sui (e un’antologia dei) testi del primo romanticismo tedesco, dal titolo L’absolu littéraire. Théorie de la littérature du romantisme allemand (Lacoue-Labarthe – Nancy, 1978). Si tratta di un volume di grande importanza, purtroppo non disponibile in italiano. Nella raccolta, i due filosofi hanno scelto, introdotto, annotato e tradotto scritti dovuti principalmente ai fratelli Schlegel, a Novalis e a Schelling. La ragione del titolo viene spiegata in maniera sintetica nella quarta di copertina del volume: «Prima di far epoca nella letteratura e nell’arte, prima di rappresentare una sensibilità o uno stile […], il romanticismo è innanzitutto una teoria. E l’invenzione della letteratura. Costituisce anzi, precisamente, il momento inaugurale della letteratura come produzione della propria teoria – e della teoria che pensa se stessa come letteratura. In tal modo, apre l’epoca critica alla quale apparteniamo ancora. Poietica in cui il soggetto si confonde con la propria produzione, e Letteratura chiusa sulla legge del proprio generarsi, il romanticismo (noi, insomma) è il momento dell’assoluto letterario». Si tratta di dichiarazioni a prima vista azzardate, ma in realtà condivisibili. Di fatto, quelle nate in Germania alla fine del Settecento sono, se non proprio la letteratura e la critica tout court, perlomeno la forma autoriflessiva che esse hanno assunto, non di rado, in epoca moderna e contemporanea...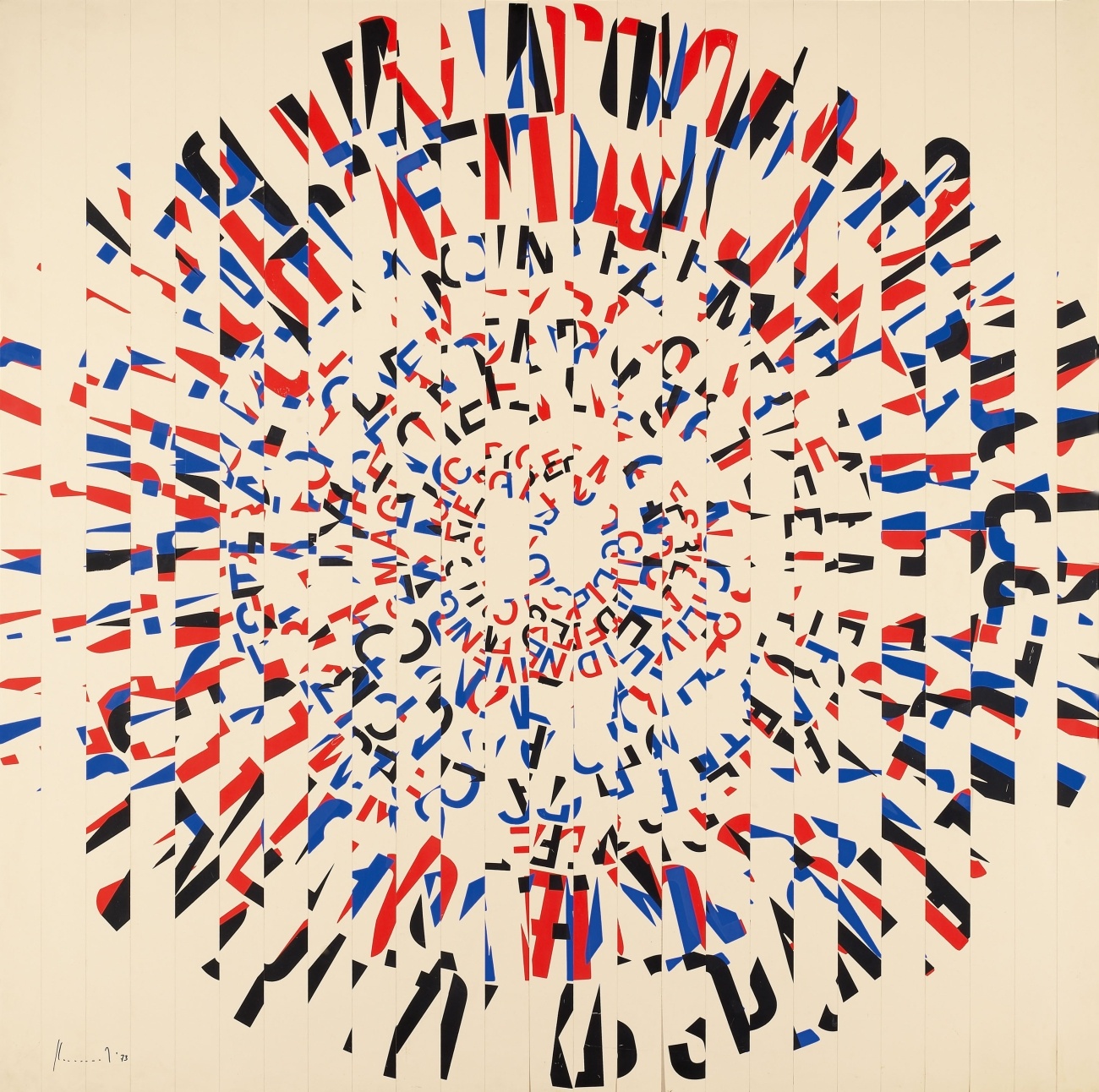

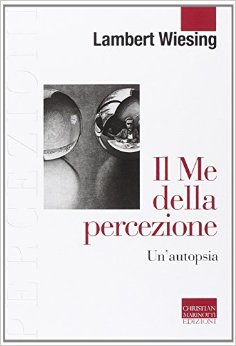

 zione ridisegnata da Wiesing, il trittico soggetto/oggetto/percezione si riconfigura, portando in primo piano la percezione come suo centro propulsore, in maniera non dissimile da quanto portato avanti, in un altro contesto, da Gilbert Simondon prima e da Bernard Stiegler oggi: nel passaggio all’individuazione non bisogna concentrarsi né sull’origine né sul termine, ma sul processo trasduttivo e relazionale in grado di articolare i due momenti. Al di qua della sclerotizzazione tra un soggettivismo autoreferenziale e un oggettivismo semplicistico, Simondon, Stiegler e Wiesing, in modi ovviamente differenti, propongono uno sguardo “terzo”, bergsonianamente orientato sui movimenti che riconfigurano le essenze statiche in poli di un processo.
zione ridisegnata da Wiesing, il trittico soggetto/oggetto/percezione si riconfigura, portando in primo piano la percezione come suo centro propulsore, in maniera non dissimile da quanto portato avanti, in un altro contesto, da Gilbert Simondon prima e da Bernard Stiegler oggi: nel passaggio all’individuazione non bisogna concentrarsi né sull’origine né sul termine, ma sul processo trasduttivo e relazionale in grado di articolare i due momenti. Al di qua della sclerotizzazione tra un soggettivismo autoreferenziale e un oggettivismo semplicistico, Simondon, Stiegler e Wiesing, in modi ovviamente differenti, propongono uno sguardo “terzo”, bergsonianamente orientato sui movimenti che riconfigurano le essenze statiche in poli di un processo.