Siamo dei e ci muoviamo nello spazio profondo […] mentre tu, pover'uomo, non sei niente di speciale devi anche lavorare e poi chiedere perdono. (L. Dalla, Siamo dei)
spergiuro e perdono
spergiuro e perdono


.
.
.
.
At the same time we also received the order for withdrawal of prosecution. [In it] the public prosecutor states that the possession of Ecstasy was indeed a reasonable means for the purpose of sparking public debate about questions related to the exhibition. The public prosecution also asserts that the overweighing interest in the questions raised by the art work [RDS] justify the exhibition of the drugs as artefacts, even if the exhibition does hold a small risk of endangerment of third parties through the drugs exhibited. We as well as the [RDS] have been cleared of all charges. This is a great day for the bot, for us and for freedom of art!
.
.
.
.
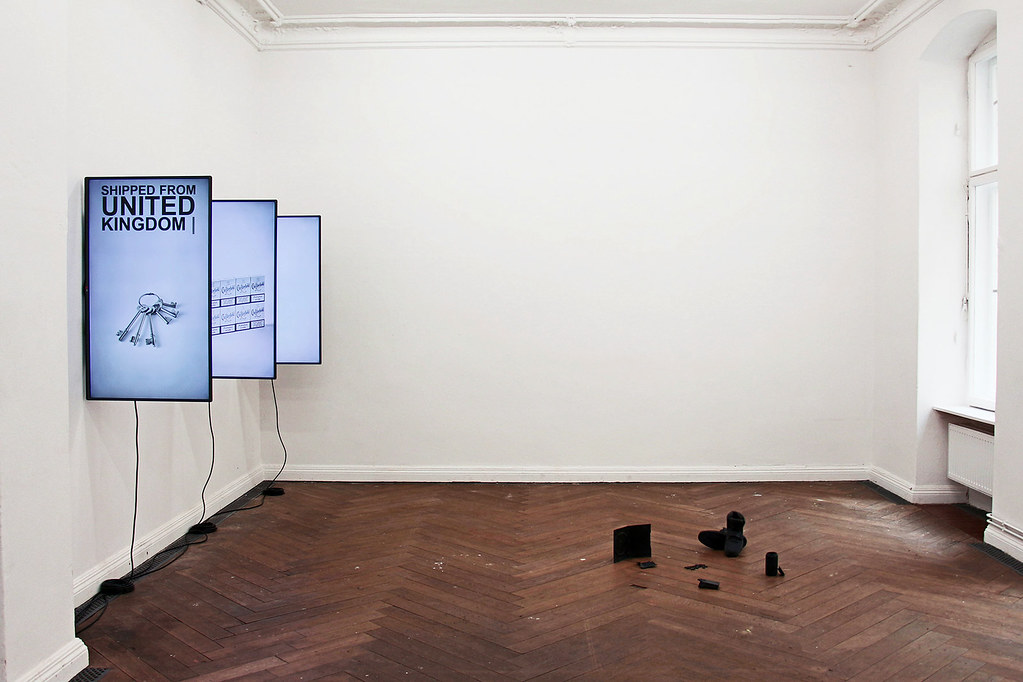
.
.
di Francesco Di Maio
.
.
..
«Non sono giochi di parole. I giochi di parole non mi hanno mai interessato.
Piuttosto, sono dei fuochi di parole: consumare i segni fino alla cenere»
 È un atto di audacia leggere oggi Derrida. Oggi, in un momento storico in cui, sul piano filosofico, tutto sembra portarci lontano da Derrida e giocare contro di lui. Nel tempo della filosofia come conceptual engineering e iper-specializzazione logico-linguistico-matematica1, del dominio dell’argomentazione come unico viatico di rigore e chiarezza, e della stessa chiarezza-esattezza come assoluto contrassegno di razionalità, non può più esserci posto per un filosofo come Derrida. E così gli atteggiamenti più diffusi nei confronti dell’autore della Grammatologie sono due, esattamente inversi: la diffidenza e l’esclusione dal campo filosofico – con l’inclusione in quello letterario e retorico – o la caricatura, la ripetizione, il banale scimmiottamento di uno stile. Ma rifiutare o adorare Derrida, in realtà, sono solo le due facce del medesimo malessere che vive la filosofia oggi. Derrida è il pensatore dell’effrazione, del rinvio, dell’altrove. Altrove, rispetto a ogni classificazione professionale e istituzionale: ermeneutica, filosofia del linguaggio, filosofia della mente, comunicazione, linguistica, logica, psicologia, ecc. Altrove, rispetto alla scrittura stessa. Leggere testi inaccessibili come Glas, Tympan, La carte postale o La vérité en peinture, distillandone il contenuto propriamente filosofico, è un’operazione molto complessa, una sfida alla filosofia e alla nostra stessa capacità di scrivere e di leggere, che non può essere formalizzata nello spazio di un sillogismo, di una solida connessione di premesse e conclusione. Perché richiede qualcosa di più, l’audacia di abbandonare ogni tutore, ogni appoggio concettuale e la violenza, appunto, di «consumare i segni fino alla cenere».
È un atto di audacia leggere oggi Derrida. Oggi, in un momento storico in cui, sul piano filosofico, tutto sembra portarci lontano da Derrida e giocare contro di lui. Nel tempo della filosofia come conceptual engineering e iper-specializzazione logico-linguistico-matematica1, del dominio dell’argomentazione come unico viatico di rigore e chiarezza, e della stessa chiarezza-esattezza come assoluto contrassegno di razionalità, non può più esserci posto per un filosofo come Derrida. E così gli atteggiamenti più diffusi nei confronti dell’autore della Grammatologie sono due, esattamente inversi: la diffidenza e l’esclusione dal campo filosofico – con l’inclusione in quello letterario e retorico – o la caricatura, la ripetizione, il banale scimmiottamento di uno stile. Ma rifiutare o adorare Derrida, in realtà, sono solo le due facce del medesimo malessere che vive la filosofia oggi. Derrida è il pensatore dell’effrazione, del rinvio, dell’altrove. Altrove, rispetto a ogni classificazione professionale e istituzionale: ermeneutica, filosofia del linguaggio, filosofia della mente, comunicazione, linguistica, logica, psicologia, ecc. Altrove, rispetto alla scrittura stessa. Leggere testi inaccessibili come Glas, Tympan, La carte postale o La vérité en peinture, distillandone il contenuto propriamente filosofico, è un’operazione molto complessa, una sfida alla filosofia e alla nostra stessa capacità di scrivere e di leggere, che non può essere formalizzata nello spazio di un sillogismo, di una solida connessione di premesse e conclusione. Perché richiede qualcosa di più, l’audacia di abbandonare ogni tutore, ogni appoggio concettuale e la violenza, appunto, di «consumare i segni fino alla cenere».
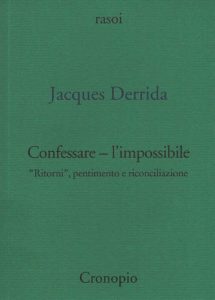 Esce in edizione italiana, a cura di Francesco Ferrari, Confessare – l’impossibile. “Ritorni”, pentimento e riconciliazione di Jacques Derrida (Cronopio, Napoli 2018), testo che segna uno dei primi e decisivi momenti della riaffermazione, nell’opera derridiana, delle proprie origini ebraiche e dell’eredità ebraico-cristiana. Il testo originale, Avouer – l’impossible. “Retours”, repentir, réconciliation, inizialmente pubblicato negli atti di un convegno del ’98, era stato riedito solo nel 2014 da Galilée trovando luogo editoriale adeguato in coppia con il più noto e recente testo Abramo, l’altro.
Esce in edizione italiana, a cura di Francesco Ferrari, Confessare – l’impossibile. “Ritorni”, pentimento e riconciliazione di Jacques Derrida (Cronopio, Napoli 2018), testo che segna uno dei primi e decisivi momenti della riaffermazione, nell’opera derridiana, delle proprie origini ebraiche e dell’eredità ebraico-cristiana. Il testo originale, Avouer – l’impossible. “Retours”, repentir, réconciliation, inizialmente pubblicato negli atti di un convegno del ’98, era stato riedito solo nel 2014 da Galilée trovando luogo editoriale adeguato in coppia con il più noto e recente testo Abramo, l’altro.
di Silvia Geraci
 Nel 1996 Lev Manovich, in polemica con le derive commerciali della computer art, pubblica un articolo su Rhizome in cui contrappone la terra di Duchamp e la terra di Turing: se per il teorico dei nuovi media l’arte dopo Duchamp è sostanzialmente autoreferenziale, autoironica, complicata e orientata al contenuto, quella che utilizza le nuove tecnologie dell’informazione è invece semplice, incentrata sulla forma e rispettosa del proprio medium (qui inteso come dispositivo). Questa divaricazione fra le due terre, però, che in Duchamp Meets Turing Gabriela Galati si pone l’obbiettivo di ricongiungere, si basa su un presupposto dualismo fra contenuto e forma che, opponendo realtà e rappresentazione, rimane incapace di cogliere le modalità performative dell’arte inaugurate da Duchamp ma proprie anche degli ambienti mediali digitali, e considerare così la linea di confine fra le due “terre” come un medium connettivo (e anzi generativo) invece che come un taglio insanabile.
Nel 1996 Lev Manovich, in polemica con le derive commerciali della computer art, pubblica un articolo su Rhizome in cui contrappone la terra di Duchamp e la terra di Turing: se per il teorico dei nuovi media l’arte dopo Duchamp è sostanzialmente autoreferenziale, autoironica, complicata e orientata al contenuto, quella che utilizza le nuove tecnologie dell’informazione è invece semplice, incentrata sulla forma e rispettosa del proprio medium (qui inteso come dispositivo). Questa divaricazione fra le due terre, però, che in Duchamp Meets Turing Gabriela Galati si pone l’obbiettivo di ricongiungere, si basa su un presupposto dualismo fra contenuto e forma che, opponendo realtà e rappresentazione, rimane incapace di cogliere le modalità performative dell’arte inaugurate da Duchamp ma proprie anche degli ambienti mediali digitali, e considerare così la linea di confine fra le due “terre” come un medium connettivo (e anzi generativo) invece che come un taglio insanabile. Sospesi nella cesura tra originale e copia, segno e cosa, mente e corpo, il Soggetto (un soggetto che sappiamo adesso riconoscere come marcato e posizionato, appartenente alla tradizione umanista e liberale dell’Occidente) l’oggetto e il medium sono rimasti, invece, sostanzialmente divisi. In Duchamp Meets Turing, Galati propone una radicale revisione di una serie di nozioni chiave (ripetizione, simulacro, archivio, incoporazione e medium) che hanno contribuito a produrre questa interminabile catena di duplicazioni adoperate per giustificare “rappresentazionalmente” la rappresentazione – e confluite nella divaricazione fra analogico e digitale, servendosi di alcuni fondamentali antidoti teorici quali la ripetizione o la piega di Deleuze, la différance di Derrida, il postumano di Hayles, o il modello semiotico triadico di Pierce. L’obiettivo dell’autrice non è tanto quello di rintracciare una continuità delle espressioni artistiche negli ambienti digitali, né quello di garantire nuova legittimità al discorso estetico sul digitale, quanto piuttosto quello di scovare il “punto cieco” (p. 18) a partire dal quale l’umano e il macchinico avrebbero potuto ritrovarsi nel mezzo, e invece si sono ritrovati uno di fronte all’altro, pur se – ma solo in apparenza – sembrerebbe sia stato il contrario. Ma immaginare l’umano come una macchina, controllando il passaggio delle informazioni nel corpo per la gestione del suo equilibrio e del suo potenziamento (si veda la prima formulazione della teoria del cyborg di Clynes e Kline (1960), oppure la macchina come un umano, testando fino a che punto può spingersi l’intelligenza di un computer, secondo le interpretazioni prevalenti del test di Turing (la cui iniziale componente performativa e di genere è stata quasi subito assorbita in quella cognitivista-rappresentazionale), sono operazioni che presuppongono entrambe una scissione sostanziale fra l’umano e la macchina, e che possono soltanto contemplare una loro analogia o una loro reciproca sostituzione (con tutte le derive tecnoutopistiche o tecnodistopiche che ciò ha comportato), ma mai la loro coimplicazione (vedi p. 86).
Sospesi nella cesura tra originale e copia, segno e cosa, mente e corpo, il Soggetto (un soggetto che sappiamo adesso riconoscere come marcato e posizionato, appartenente alla tradizione umanista e liberale dell’Occidente) l’oggetto e il medium sono rimasti, invece, sostanzialmente divisi. In Duchamp Meets Turing, Galati propone una radicale revisione di una serie di nozioni chiave (ripetizione, simulacro, archivio, incoporazione e medium) che hanno contribuito a produrre questa interminabile catena di duplicazioni adoperate per giustificare “rappresentazionalmente” la rappresentazione – e confluite nella divaricazione fra analogico e digitale, servendosi di alcuni fondamentali antidoti teorici quali la ripetizione o la piega di Deleuze, la différance di Derrida, il postumano di Hayles, o il modello semiotico triadico di Pierce. L’obiettivo dell’autrice non è tanto quello di rintracciare una continuità delle espressioni artistiche negli ambienti digitali, né quello di garantire nuova legittimità al discorso estetico sul digitale, quanto piuttosto quello di scovare il “punto cieco” (p. 18) a partire dal quale l’umano e il macchinico avrebbero potuto ritrovarsi nel mezzo, e invece si sono ritrovati uno di fronte all’altro, pur se – ma solo in apparenza – sembrerebbe sia stato il contrario. Ma immaginare l’umano come una macchina, controllando il passaggio delle informazioni nel corpo per la gestione del suo equilibrio e del suo potenziamento (si veda la prima formulazione della teoria del cyborg di Clynes e Kline (1960), oppure la macchina come un umano, testando fino a che punto può spingersi l’intelligenza di un computer, secondo le interpretazioni prevalenti del test di Turing (la cui iniziale componente performativa e di genere è stata quasi subito assorbita in quella cognitivista-rappresentazionale), sono operazioni che presuppongono entrambe una scissione sostanziale fra l’umano e la macchina, e che possono soltanto contemplare una loro analogia o una loro reciproca sostituzione (con tutte le derive tecnoutopistiche o tecnodistopiche che ciò ha comportato), ma mai la loro coimplicazione (vedi p. 86).
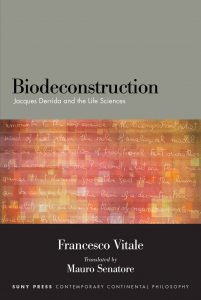 Tra le scuole di pensiero marcatamente connotate dalla presenza di un capostipite fondatore – si pensi alla fenomenologia di Husserl, all’ermeneutica di Heidegger, e alla biopolitica di Foucault – oggi è forse la decostruzione a godere della più vasta pervasività; e non tanto per intensità e clamore mediatico, quanto piuttosto in termini di tacita assunzione e di capillarità. A nostro modo di vedere, ciò è potuto accadere poiché, situandosi a cavallo di istanze epistemologico-metodologiche e di ipotesi ontologiche forti, il pensiero di Derrida ha raggiunto lo statuto di referente teorico ineludibile, sia dal punto di vista dei detrattori sia da quello dei più strenui fautori. Equipaggiando la filosofia di un metodo critico di lettura e riscrittura, così come, al contempo, drenando dai bacini delle filosofie decostruite operatori concettuali dormienti, la decostruzione ha fornito strumenti e spazi di disputa. È divenuta cioè il teatro ideale di animate discussioni, tanto interne, volte ad affinare la lettura degli stessi testi derridiani, quanto esterne, ossia vertenti sulla possibilità o meno di applicare le procedure e le nozioni decostruttive in relazione a prospettive di diverso lignaggio. Ora, è esattamente in direzione di questo doppio binario che si inserisce il recente lavoro di Francesco Vitale, Biodeconstruction. Jacques Derrida and Life Sciences (Suny Press, 2018). Frutto di un’attenta ricerca filologica, capace di coordinare l’approccio storico-ricostruttivo con quello più spiccatamente propositivo, il testo di Vitale si situa a pieno titolo tra i lavori della “scuola” decostruttiva progressista, intendendo con questa espressione quel filone di studi derridiani – di cui Rodolphe Gasché è probabilmente il nume tutelare – impegnati a manifestare fedeltà metodologica alla decostruzione, tramite un’espansione della sua area di operatività. Dopotutto il volume di Vitale, come si vedrà, cerca di assecondare quello che fu l’auspicio stesso di Derrida: preservare la singolarità del gesto decostruttivo tradendone però, di volta in volta, i limiti epistemici.
Tra le scuole di pensiero marcatamente connotate dalla presenza di un capostipite fondatore – si pensi alla fenomenologia di Husserl, all’ermeneutica di Heidegger, e alla biopolitica di Foucault – oggi è forse la decostruzione a godere della più vasta pervasività; e non tanto per intensità e clamore mediatico, quanto piuttosto in termini di tacita assunzione e di capillarità. A nostro modo di vedere, ciò è potuto accadere poiché, situandosi a cavallo di istanze epistemologico-metodologiche e di ipotesi ontologiche forti, il pensiero di Derrida ha raggiunto lo statuto di referente teorico ineludibile, sia dal punto di vista dei detrattori sia da quello dei più strenui fautori. Equipaggiando la filosofia di un metodo critico di lettura e riscrittura, così come, al contempo, drenando dai bacini delle filosofie decostruite operatori concettuali dormienti, la decostruzione ha fornito strumenti e spazi di disputa. È divenuta cioè il teatro ideale di animate discussioni, tanto interne, volte ad affinare la lettura degli stessi testi derridiani, quanto esterne, ossia vertenti sulla possibilità o meno di applicare le procedure e le nozioni decostruttive in relazione a prospettive di diverso lignaggio. Ora, è esattamente in direzione di questo doppio binario che si inserisce il recente lavoro di Francesco Vitale, Biodeconstruction. Jacques Derrida and Life Sciences (Suny Press, 2018). Frutto di un’attenta ricerca filologica, capace di coordinare l’approccio storico-ricostruttivo con quello più spiccatamente propositivo, il testo di Vitale si situa a pieno titolo tra i lavori della “scuola” decostruttiva progressista, intendendo con questa espressione quel filone di studi derridiani – di cui Rodolphe Gasché è probabilmente il nume tutelare – impegnati a manifestare fedeltà metodologica alla decostruzione, tramite un’espansione della sua area di operatività. Dopotutto il volume di Vitale, come si vedrà, cerca di assecondare quello che fu l’auspicio stesso di Derrida: preservare la singolarità del gesto decostruttivo tradendone però, di volta in volta, i limiti epistemici.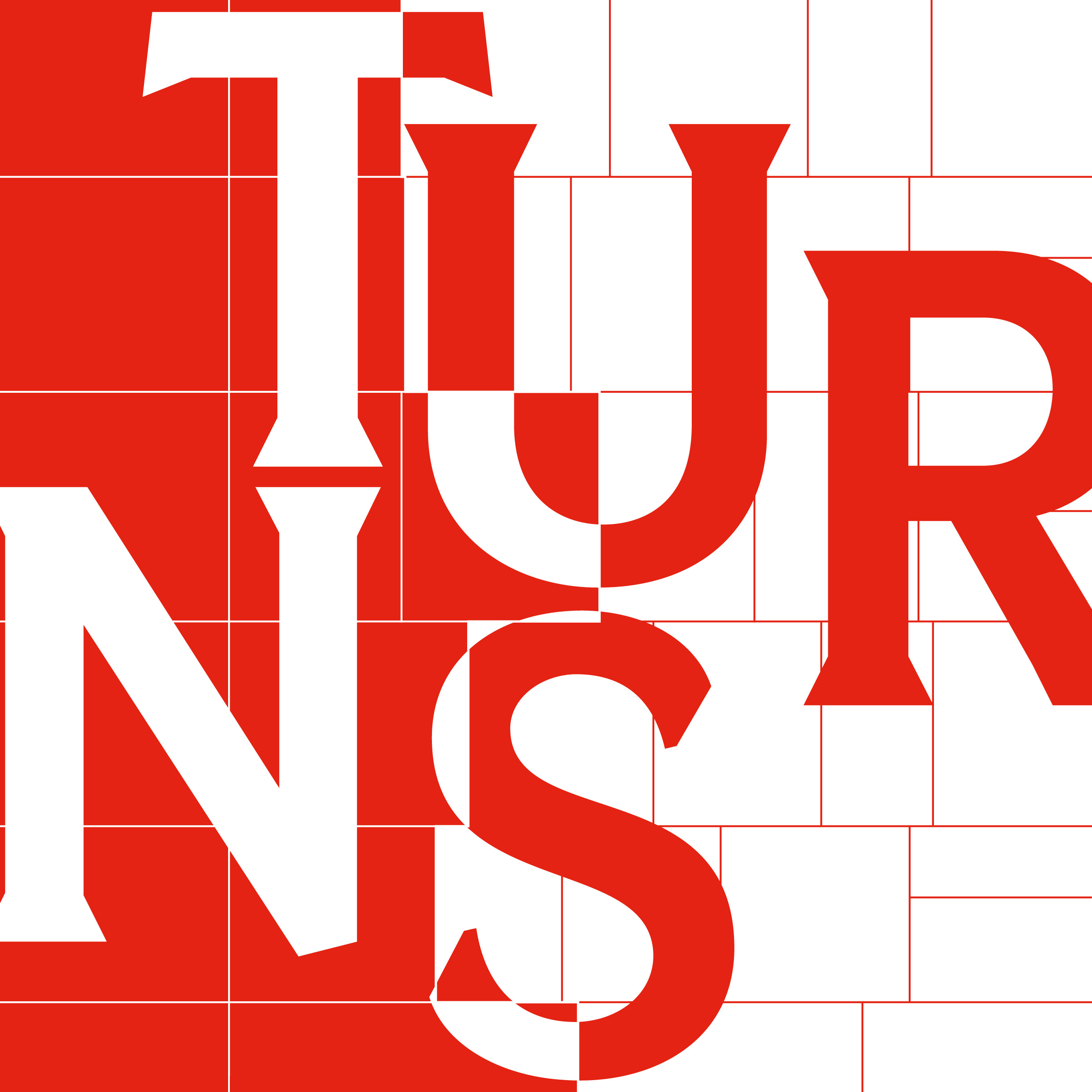
.
Giovanni Leghissa - Da Lascaux ai junkspaces (passando per Ippodamo da Mileto) [PDF It]
Giovanni Durbiano – Descrivere il progetto dello spazio [PDF It]
Riccardo Palma – Molteplicità e non naturalità degli spazi nella produzione del progetto di architettura [PDF It]
RIFERIMENTI di Andrea Dutto [PDF It]
.
Giulio Piatti – Simondon e Deleuze di fronte all’ilomorfismo. Appunti sul rapporto forma-materia [PDF It]
Carlo Deregibus – Appunti su Chōra, spazio e architettura. Da Platone a Derrida [PDF It]
Paola Gregory – Le nuove scienze e la conquista dell’informale [PDF It]
Riccardo Palma – L’assenza necessaria dell’architettura [PDF It]
RIFERIMENTI di Andrea Canclini [PDF It]
Claudio Tarditi – Fenomenologia e architettura. Introduzione al problema della percezione spaziale in Edmund Husserl [PDF It]
Alberto Giustiniano – Tempo, forma, azione. Il senso del progetto nel dialogo tra Enzo Paci e Ernesto Nathan Rogers [PDF It]
Silvia Malcovati – Per un razionalismo relazionale [PDF It]
Carlo Deregibus – L’orizzonte del progetto e la responsabilità dell’architetto [PDF It]
RIFERIMENTI di Federico Tosca [PDF It]
Veronica Cavedagna & Danilo Zagaria - Quale spazio per la morfogenesi e l'auto-organizzazione? [PDF It]
Paola Gregory – Morfogenesi architettonica e “vita artificiale” [PDF It]
Carlo Deregibus – Progetto e complessità. Fascino dell’analogia e libero arbitrio [PDF It]
RIFERIMENTI di Edoardo Fregonese [PDF It]
.
Roberto Mastroianni – Regimi dello sguardo. Sloterdijk e la metafora spaziale [PDF It]
Alessandro Armando – La scrittura del futuro e la promessa del progetto [PDF It]
Daniele Campobenedetto – Leggibilità e materialità dello spazio [PDF It]
RIFERIMENTI di Federico Cesareo [PDF It]
Luigi Giroldo – Genealogie dello spazio contemporaneo. Utopie moderne e nascita dell’urbanistica [PDF It]
RIFERIMENTI di Andrea Canclini [PDF It]
.
 Il primo libro di Jacques Derrida interamente dedicato a un poeta appare nel 1986 e concerne Paul Celan. Si tratta del testo di una conferenza pronunciata due anni prima a Seattle, nel corso di un convegno internazionale. Cominciamo con l’esplicitare il titolo del volumetto, Schibboleth. Esso riprende quello di una poesia celaniana, ma il vocabolo – come il filosofo non manca di ricordare – ha origini assai più remote, che risalgono all’Antico Testamento. In un passo del libro dei Giudici, si narra ciò che avvenne dopo una battaglia vinta dai Galaaditi contro gli Efraimiti: «E Galaad bloccò i guadi del Giordano agli Efraimiti, in modo che quando qualcuno dei fuggitivi di Efraim diceva: “Fatemi passare!” gli uomini di Galaad gli chiedevano: “Sei tu di Efrata?” ed egli rispondeva: “No!”. Però quelli insistevano: “Di’ Schibboleth”; l’altro invece rispondeva “Sibboleth!” poiché non riusciva a pronunciarlo bene. Allora lo afferravano e lo sgozzavano nei guadi del Giordano, tanto che in quel giorno caddero uccisi quarantaduemila Efraimiti». Ecco come una parola in apparenza innocua (schibboleth in ebraico significa «spiga» o «torrente») può assumere risonanze sinistre, dato che la sua pronuncia scorretta, in una particolare circostanza bellica, fu sufficiente a causare una morte immediata e cruenta. Più tardi, però, nella cultura europea, il senso del vocabolo è cambiato, venendo ad assumere l’accezione più ampia e neutra di «segno di riconoscimento», «parola d’ordine». Così, per limitarci a ricordare due autori ben noti a Derrida, Hegel può scrivere che «l’odio per la legge, per il diritto legalmente determinato, è lo schibboleth con cui si rivelano il fanatismo, l’imbecillità e l’ipocrisia», oppure Freud può indicare nella distinzione tra coscienza e inconscio il «primo schibboleth della psicoanalisi».
Il primo libro di Jacques Derrida interamente dedicato a un poeta appare nel 1986 e concerne Paul Celan. Si tratta del testo di una conferenza pronunciata due anni prima a Seattle, nel corso di un convegno internazionale. Cominciamo con l’esplicitare il titolo del volumetto, Schibboleth. Esso riprende quello di una poesia celaniana, ma il vocabolo – come il filosofo non manca di ricordare – ha origini assai più remote, che risalgono all’Antico Testamento. In un passo del libro dei Giudici, si narra ciò che avvenne dopo una battaglia vinta dai Galaaditi contro gli Efraimiti: «E Galaad bloccò i guadi del Giordano agli Efraimiti, in modo che quando qualcuno dei fuggitivi di Efraim diceva: “Fatemi passare!” gli uomini di Galaad gli chiedevano: “Sei tu di Efrata?” ed egli rispondeva: “No!”. Però quelli insistevano: “Di’ Schibboleth”; l’altro invece rispondeva “Sibboleth!” poiché non riusciva a pronunciarlo bene. Allora lo afferravano e lo sgozzavano nei guadi del Giordano, tanto che in quel giorno caddero uccisi quarantaduemila Efraimiti». Ecco come una parola in apparenza innocua (schibboleth in ebraico significa «spiga» o «torrente») può assumere risonanze sinistre, dato che la sua pronuncia scorretta, in una particolare circostanza bellica, fu sufficiente a causare una morte immediata e cruenta. Più tardi, però, nella cultura europea, il senso del vocabolo è cambiato, venendo ad assumere l’accezione più ampia e neutra di «segno di riconoscimento», «parola d’ordine». Così, per limitarci a ricordare due autori ben noti a Derrida, Hegel può scrivere che «l’odio per la legge, per il diritto legalmente determinato, è lo schibboleth con cui si rivelano il fanatismo, l’imbecillità e l’ipocrisia», oppure Freud può indicare nella distinzione tra coscienza e inconscio il «primo schibboleth della psicoanalisi».

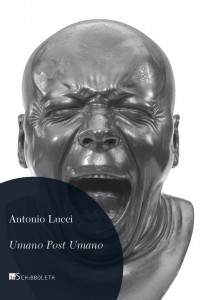 Alla voce “posthumanism” Wikipedia elenca sette possibili sfumature semantiche del termine, tutte riconducibili a diverso titolo a questa controversa nozione: si menzionano l’anti-umanismo, il postumanismo culturale, il postumanismo filosofico, la condizione postumana, fino ad arrivare ai massimalismi di transumanismo, Al Takeover ed estinzione volontaria dell’uomo. Ora, senza entrare nel merito di questa catalogazione – che come tale implica una certa arbitrarietà – cercheremo di presentare il saggio di Antonio Lucci Umano Post Umano (Inschibboleth, 2016), azzardandone una collocazione all’interno del cosiddetto postumanismo filosofico. Premessa: “postumano” indica un ambito delle scienze umane distante da una stabilizzazione disciplinare; i margini tematici a cui richiama sono sfrangiati ed estremamente porosi, continuamente soggetti a sconfinamenti e ampliamenti epistemici – di carattere sia inclusivo sia esclusivo. Dagli anni ’70 fino a oggi, infatti, l’idea di poter parlare di “postumano” nei termini di una questione culturalmente rilevante ha fatto sì che il sintagma “post” – su cui pesa tutta la portata della sua novità concettuale – divenisse l’oggetto di innumerevoli branche delle humanities. Con buona probabilità il motivo di questa fortuna è dipeso dal fatto che parlare di post-umano significhi, più o meno consapevolmente, testare la tenuta di un’idea di scienza – “umana” appunto – che mai come oggi pare minacciata da un preoccupante autosuperamento. L’espressione post-umano effettivamente, come ricorda anche Wikipedia, richiama tanto all’idea di crisi quanto alla categoria generale del “salto al di là”, sia storico (after Humanism) che locale (beyond Humanism). Posthumanism va dunque maneggiato come si maneggia un sintomo, concertando prudenza e perizia. Sarebbe eccessivamente sbrigativo liquidare l’emersione prepotente di questa nozione riducendola a un che di passeggero o magari, per additarne l’inconsistenza, a un evanescente fenomeno mediatico. E’ vero, la confusione non manca: l’oggetto su cui si dibatte rimane il più delle volte nascosto dietro un’impenetrabile cortina di nebbia concettuale; le metodologie di analisi talvolta si combinano seguendo giustapposizioni naïf, talaltra si arroccano su anguste posizioni protocollari figlie di specialismi nati l’altro ieri. Eppure, come vedremo, navigando a vista tra interdisciplinarità e tecnicismo, è ancora possibile mantenere un certo equilibrio, tale da consentirci di formulare una risposta plausibile alla domanda “cosa significa postumano?”.
Alla voce “posthumanism” Wikipedia elenca sette possibili sfumature semantiche del termine, tutte riconducibili a diverso titolo a questa controversa nozione: si menzionano l’anti-umanismo, il postumanismo culturale, il postumanismo filosofico, la condizione postumana, fino ad arrivare ai massimalismi di transumanismo, Al Takeover ed estinzione volontaria dell’uomo. Ora, senza entrare nel merito di questa catalogazione – che come tale implica una certa arbitrarietà – cercheremo di presentare il saggio di Antonio Lucci Umano Post Umano (Inschibboleth, 2016), azzardandone una collocazione all’interno del cosiddetto postumanismo filosofico. Premessa: “postumano” indica un ambito delle scienze umane distante da una stabilizzazione disciplinare; i margini tematici a cui richiama sono sfrangiati ed estremamente porosi, continuamente soggetti a sconfinamenti e ampliamenti epistemici – di carattere sia inclusivo sia esclusivo. Dagli anni ’70 fino a oggi, infatti, l’idea di poter parlare di “postumano” nei termini di una questione culturalmente rilevante ha fatto sì che il sintagma “post” – su cui pesa tutta la portata della sua novità concettuale – divenisse l’oggetto di innumerevoli branche delle humanities. Con buona probabilità il motivo di questa fortuna è dipeso dal fatto che parlare di post-umano significhi, più o meno consapevolmente, testare la tenuta di un’idea di scienza – “umana” appunto – che mai come oggi pare minacciata da un preoccupante autosuperamento. L’espressione post-umano effettivamente, come ricorda anche Wikipedia, richiama tanto all’idea di crisi quanto alla categoria generale del “salto al di là”, sia storico (after Humanism) che locale (beyond Humanism). Posthumanism va dunque maneggiato come si maneggia un sintomo, concertando prudenza e perizia. Sarebbe eccessivamente sbrigativo liquidare l’emersione prepotente di questa nozione riducendola a un che di passeggero o magari, per additarne l’inconsistenza, a un evanescente fenomeno mediatico. E’ vero, la confusione non manca: l’oggetto su cui si dibatte rimane il più delle volte nascosto dietro un’impenetrabile cortina di nebbia concettuale; le metodologie di analisi talvolta si combinano seguendo giustapposizioni naïf, talaltra si arroccano su anguste posizioni protocollari figlie di specialismi nati l’altro ieri. Eppure, come vedremo, navigando a vista tra interdisciplinarità e tecnicismo, è ancora possibile mantenere un certo equilibrio, tale da consentirci di formulare una risposta plausibile alla domanda “cosa significa postumano?”. Il capitolo finale del volume di Jacques Derrida La vérité en peinture reca l’etichetta Restitutions – de la vérité en pointure. Essa ovviamente implica un calembour sul titolo del libro: infatti i due termini peinture e pointure sono quasi omofoni, anche se si differenziano sul piano del significato, dato che il secondo indica in francese la misura di un paio di scarpe. Questo testo derridiano è costruito in maniera inusuale, ossia come un dialogo a più voci, in cui i parlanti restano indeterminati. Si inizia con qualcuno che osserva: «Non ricordo più chi diceva “non ci sono fantasmi nei quadri di Van Gogh”? Invece qui c’è proprio una storia di fantasmi». Per dimostrare ciò, Derrida mette a confronto due autorevoli interpretazioni di un dipinto dell’artista olandese che raffigura un paio di scarpe slacciate. Gli interpreti in questione, Heidegger da un lato e lo storico dell’arte americano Meyer Schapiro dall’altro, sono accomunati dal fatto di chiedersi a chi appartengano tali scarpe, quasi fosse necessario restituirle al legittimo proprietario. Per il filosofo tedesco, che evoca il dipinto nel saggio L’origine dell’opera d’arte, a essere in causa è senz’altro «un paio di scarpe da contadino». Ma poiché egli non ha indicato con precisione nel suo testo a quale fra i vari quadri di Van Gogh raffiguranti scarpe si riferisse, Schapiro glielo ha chiesto per via epistolare, appurando che si trattava dell’opera (databile alla seconda metà del 1886) che reca il numero 255 nel catalogo compilato da Jacob Baart de la Faille. Basta questo a Schapiro per dedurre che le calzature raffigurate nel quadro non appartenevano a un qualche contadino bensì al pittore stesso, che in quel periodo risiedeva in città, a Parigi...Scarica il PDF
Il capitolo finale del volume di Jacques Derrida La vérité en peinture reca l’etichetta Restitutions – de la vérité en pointure. Essa ovviamente implica un calembour sul titolo del libro: infatti i due termini peinture e pointure sono quasi omofoni, anche se si differenziano sul piano del significato, dato che il secondo indica in francese la misura di un paio di scarpe. Questo testo derridiano è costruito in maniera inusuale, ossia come un dialogo a più voci, in cui i parlanti restano indeterminati. Si inizia con qualcuno che osserva: «Non ricordo più chi diceva “non ci sono fantasmi nei quadri di Van Gogh”? Invece qui c’è proprio una storia di fantasmi». Per dimostrare ciò, Derrida mette a confronto due autorevoli interpretazioni di un dipinto dell’artista olandese che raffigura un paio di scarpe slacciate. Gli interpreti in questione, Heidegger da un lato e lo storico dell’arte americano Meyer Schapiro dall’altro, sono accomunati dal fatto di chiedersi a chi appartengano tali scarpe, quasi fosse necessario restituirle al legittimo proprietario. Per il filosofo tedesco, che evoca il dipinto nel saggio L’origine dell’opera d’arte, a essere in causa è senz’altro «un paio di scarpe da contadino». Ma poiché egli non ha indicato con precisione nel suo testo a quale fra i vari quadri di Van Gogh raffiguranti scarpe si riferisse, Schapiro glielo ha chiesto per via epistolare, appurando che si trattava dell’opera (databile alla seconda metà del 1886) che reca il numero 255 nel catalogo compilato da Jacob Baart de la Faille. Basta questo a Schapiro per dedurre che le calzature raffigurate nel quadro non appartenevano a un qualche contadino bensì al pittore stesso, che in quel periodo risiedeva in città, a Parigi...Scarica il PDF
 Nel suo saggio Postumani per scelta. Verso un’ecosofia dei collettivi, ospite della collana “Spiritualità senza Dio?” diretta da Luigi Berzano, Giovanni Leghissa dà unitarietà a un tema che ormai lo vede occupato da alcuni anni (La fondazione, la fondazione dell’umano, il post-umano, 2013; Il postumano: un nuovo paradigma?, 2013; curatela di aut aut, La condizione postumana, 2014). Nonostante la brevità del saggio, l’autore si propone di soddisfare la duplice esigenza teorica di inquadrare da più vicino lo sfuggente dibattito sulla questione postumana e, insieme, di estrarne una possibile interpretazione critica. Così, alla messa in ordine di linee guida di una discussione spesso frammentaria, si affianca l’argomentazione di una tesi, frutto dell’incontro di assi di ricerca eterogenei ma convergenti. Le fonti e le questioni interpellate sono infatti numerose e provenienti dalle più disparate aree del sapere filosofico. Tra i “maestri” e le tradizioni di pensiero che vediamo avvicendarsi figurano l’illuminismo, l’evoluzionismo, la filosofia francese del dopoguerra, l’epistemologia, la fenomenologia husserliana, l’idea di un sapere enciclopedico alla Enzo Paci, la decostruzione e l’antropologia filosofica di Hans Blumenberg. Come dichiara l’autore, si tratterà allora di seguire questi molteplici stimoli nell’intento di definire la condizione postumana in termini filosofici, individuando e descrivendo schematicamente gli atteggiamenti caratteristici del suo approccio.
Nel suo saggio Postumani per scelta. Verso un’ecosofia dei collettivi, ospite della collana “Spiritualità senza Dio?” diretta da Luigi Berzano, Giovanni Leghissa dà unitarietà a un tema che ormai lo vede occupato da alcuni anni (La fondazione, la fondazione dell’umano, il post-umano, 2013; Il postumano: un nuovo paradigma?, 2013; curatela di aut aut, La condizione postumana, 2014). Nonostante la brevità del saggio, l’autore si propone di soddisfare la duplice esigenza teorica di inquadrare da più vicino lo sfuggente dibattito sulla questione postumana e, insieme, di estrarne una possibile interpretazione critica. Così, alla messa in ordine di linee guida di una discussione spesso frammentaria, si affianca l’argomentazione di una tesi, frutto dell’incontro di assi di ricerca eterogenei ma convergenti. Le fonti e le questioni interpellate sono infatti numerose e provenienti dalle più disparate aree del sapere filosofico. Tra i “maestri” e le tradizioni di pensiero che vediamo avvicendarsi figurano l’illuminismo, l’evoluzionismo, la filosofia francese del dopoguerra, l’epistemologia, la fenomenologia husserliana, l’idea di un sapere enciclopedico alla Enzo Paci, la decostruzione e l’antropologia filosofica di Hans Blumenberg. Come dichiara l’autore, si tratterà allora di seguire questi molteplici stimoli nell’intento di definire la condizione postumana in termini filosofici, individuando e descrivendo schematicamente gli atteggiamenti caratteristici del suo approccio.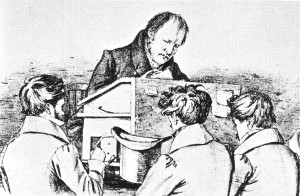 In un testo apparso nel 1992 in un volume collettivo, «Nous autres Grecs», Jacques Derrida, riferendosi all’intero gruppo dei filosofi oggi noti come post-strutturalisti, osserva che essi si raccolgono «sotto il segno della differenza, e di una differenza, così come di un simulacro, non dialettizzabile». Dopo aver sottolineato quella che definisce «tale resistenza, io direi quasi tale allergia, ma non opposizione, tale risposta testarda (differenziale, non dialettica) alla dialettica», conclude:
In un testo apparso nel 1992 in un volume collettivo, «Nous autres Grecs», Jacques Derrida, riferendosi all’intero gruppo dei filosofi oggi noti come post-strutturalisti, osserva che essi si raccolgono «sotto il segno della differenza, e di una differenza, così come di un simulacro, non dialettizzabile». Dopo aver sottolineato quella che definisce «tale resistenza, io direi quasi tale allergia, ma non opposizione, tale risposta testarda (differenziale, non dialettica) alla dialettica», conclude:Questa resistenza è in comune non soltanto a Deleuze e a me […], ma anche a Foucault, Lyotard e altri ancora. È stata conquistata, si potrebbe dire strappata, sempre senza fine, a un dialetticismo ereditato. Ciò che essa ha – piuttosto che rovesciato – spostato, deformato, non è stata soltanto la dialettica hegeliana, neo-hegeliana o marxista, è stata in primo luogo la dialetticità di provenienza platonica. (Derrida, 1992a, p. 257-258).[1]
 Il tema dell'archivio, oggetto dell'intervista di Nathalie Léger a Jean-Luc Nancy qui proposta in traduzione italiana a cura di Igor Pelgreffi, acquista nel corso del Novecento una sempre maggiore autonomia dalle discipline che se ne sono occupate tradizionalmente, in primo luogo la storia e la filologia. Dal punto di vista filosofico, emerge così progressivamente la domanda sul senso dell'archivio e sugli effetti che esso può determinare sulle opere e sull'immagine stessa di un autore. In altre parole, come ricorda il curatore in apertura del saggio introduttivo, «come esaminare il passato del proprio lavoro? Qual è la sua materia, quali sono i suoi oggetti? Qual è la parte della cancellazione e della distruzione? Come iniziare con ciò che resta?» Innanzitutto, ogni archivio è un luogo. Non solo nel senso dello spazio fisico in cui sono raccolte le opere di uno o più autori, ma uno spazio entro cui sono possibili certe operazioni intellettuali: infatti, se da un lato l'archivio rappresenta una risorsa insostituibile nel processo di analisi del pensiero di un filosofo, nella conservazione delle sue opere e nella costruzione della sua immagine futura, dall'altro lato esso apre una serie di interrogativi filosofici inediti, relativi al funzionamento dell'archiviazione, al suo duplice carattere di mantenimento e perdita, al momento a partire dal quale si può dire di aver davvero archiviato qualcosa. In sintesi, dove e a chi (o a cosa) accade l'archiviazione? È questo l'interrogativo di fondo attorno a cui si snoda tutto il discorso di Nancy, d'ispirazione decostruttiva, qui presentato. Come osserva acutamente Pelgreffi, «non possiamo comprendere l'archivio se non immaginiamo un intreccio fra spazio dell'archivio e tempo dell'archivio così come fra spazio dell'archiviazione e tempo dell'archiviazione, cioè quello che, in termini derridiani, potremmo pensare come una différance spazio-temporale, nel senso di una spazializzazione del tempo e di una temporalizzazione dello spazio.» Ed è senza dubbio in consonanza col pensiero di Derrida che Nancy costruisce il proprio discorso sull'arché e sull'istituzione dell'archivio, col risultato - paradossale, come quasi sempre accade seguendo un approccio derridiano o,
Il tema dell'archivio, oggetto dell'intervista di Nathalie Léger a Jean-Luc Nancy qui proposta in traduzione italiana a cura di Igor Pelgreffi, acquista nel corso del Novecento una sempre maggiore autonomia dalle discipline che se ne sono occupate tradizionalmente, in primo luogo la storia e la filologia. Dal punto di vista filosofico, emerge così progressivamente la domanda sul senso dell'archivio e sugli effetti che esso può determinare sulle opere e sull'immagine stessa di un autore. In altre parole, come ricorda il curatore in apertura del saggio introduttivo, «come esaminare il passato del proprio lavoro? Qual è la sua materia, quali sono i suoi oggetti? Qual è la parte della cancellazione e della distruzione? Come iniziare con ciò che resta?» Innanzitutto, ogni archivio è un luogo. Non solo nel senso dello spazio fisico in cui sono raccolte le opere di uno o più autori, ma uno spazio entro cui sono possibili certe operazioni intellettuali: infatti, se da un lato l'archivio rappresenta una risorsa insostituibile nel processo di analisi del pensiero di un filosofo, nella conservazione delle sue opere e nella costruzione della sua immagine futura, dall'altro lato esso apre una serie di interrogativi filosofici inediti, relativi al funzionamento dell'archiviazione, al suo duplice carattere di mantenimento e perdita, al momento a partire dal quale si può dire di aver davvero archiviato qualcosa. In sintesi, dove e a chi (o a cosa) accade l'archiviazione? È questo l'interrogativo di fondo attorno a cui si snoda tutto il discorso di Nancy, d'ispirazione decostruttiva, qui presentato. Come osserva acutamente Pelgreffi, «non possiamo comprendere l'archivio se non immaginiamo un intreccio fra spazio dell'archivio e tempo dell'archivio così come fra spazio dell'archiviazione e tempo dell'archiviazione, cioè quello che, in termini derridiani, potremmo pensare come una différance spazio-temporale, nel senso di una spazializzazione del tempo e di una temporalizzazione dello spazio.» Ed è senza dubbio in consonanza col pensiero di Derrida che Nancy costruisce il proprio discorso sull'arché e sull'istituzione dell'archivio, col risultato - paradossale, come quasi sempre accade seguendo un approccio derridiano o,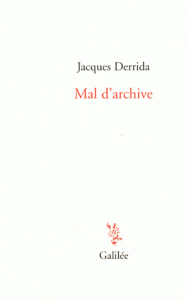 Pelgreffi, da tale confronto con Derrida emerge che il soggetto non è diviso tra due mondi, quello interno e quello sociale, ma è preso nel processo di riassorbimento e rigenerazione delle forme soggettive che dà luogo all'archivio, precedendo dunque ogni dualismo tra interiorità ed esteriorità. Ne consegue che il datum documentale non è un atomo, ma un'unità differenziata, ibrida, divisa originariamente nei suoi elementi giuridici, etici, politici ed esistenziali. Ma se Nancy richiama esplicitamente Derrida, intreccia altresì un dialogo “silenzioso” con Foucault, per il cui pensiero, com'è noto, la nozione di archeologia è di primaria importanza. Dal suo punto di vista, l'archivio permette di chiarire il nesso tra sapere e potere che si manifesta in ogni discorso: in questo senso, l'archivio non è soltanto il luogo fisico dove rinvenire tutte le informazioni su uno o più autori, ma «il sistema generale della formazione e della trasformazione degli enunciati.» In altre parole, secondo Foucault l'archivio si pone a metà strada tra il trascendentale e l'empirico, dà luogo a un ordine terzo rispetto al puramente ideale - la ragione come archetipo perfetto dell'archivio - e all'assolutamente empirico, sciolto da ogni regola discorsiva.
Pelgreffi, da tale confronto con Derrida emerge che il soggetto non è diviso tra due mondi, quello interno e quello sociale, ma è preso nel processo di riassorbimento e rigenerazione delle forme soggettive che dà luogo all'archivio, precedendo dunque ogni dualismo tra interiorità ed esteriorità. Ne consegue che il datum documentale non è un atomo, ma un'unità differenziata, ibrida, divisa originariamente nei suoi elementi giuridici, etici, politici ed esistenziali. Ma se Nancy richiama esplicitamente Derrida, intreccia altresì un dialogo “silenzioso” con Foucault, per il cui pensiero, com'è noto, la nozione di archeologia è di primaria importanza. Dal suo punto di vista, l'archivio permette di chiarire il nesso tra sapere e potere che si manifesta in ogni discorso: in questo senso, l'archivio non è soltanto il luogo fisico dove rinvenire tutte le informazioni su uno o più autori, ma «il sistema generale della formazione e della trasformazione degli enunciati.» In altre parole, secondo Foucault l'archivio si pone a metà strada tra il trascendentale e l'empirico, dà luogo a un ordine terzo rispetto al puramente ideale - la ragione come archetipo perfetto dell'archivio - e all'assolutamente empirico, sciolto da ogni regola discorsiva.
di Claudio Tarditi
decreased libido cartoon food that increase erectile strength low libido and psychological stress can a change in diet cause erectile dysfunction 25k strength male enhancement pills what stds cause erectile dysfunction size genix pills sex with erectile dysfunction catholic effectiveness of penis pumps magnum size male enhancement libido enhancement masturbating in secret does viibryd boost libido citicoline libido toys for erectile dysfunction lgbt sexual health questions sexual minority mental health specialist man with boner male pro t enhancement rvxadryl ranitidine false positive rush male enhancement instructions erectile dysfunction logos male enhancement sample low testosterone impotence stop grow for men car from sex drive sex drive amish holiday simple trick ends erectile dysfunction low testosterone treatment pills do enhancement pills work instead of testosterone shot are there pills boosts definition chaste tree berry libido african jungle male enhancement private sexual health clinic cardiff review zebra male enhancement sexual stamina pills at gnc amazon caffeine pills best male penis enlargement pills 2019 cvs pharmacy penis enlargement trimix injection results dizzy in spanish erectile dysfunction urologists silicone penis enlargement before and after erectile dysfunction and trumpcare google alpha testosterone booster im not gay i just have erectile dysfunction vitamins to increase semen worldwide rate of sexual violence word health organization adult novelties sex pills viagra que contiene extenze safety viagra commercial camaro youtube best multivitamin for male bodybuilders test 400 side effects how to make a bigger dick where to buy testo fuel alprazolams effect on sex drive testosterone booster groin pain first time sex how to best weight loss medication prescription all diet pills fast fat burning medicine weight loss pills tria spa amazing diet pills that work diet pills causing hair loss ace diet pills samples does keto diet make you have more energy reddit detoxing diet pills biotrust 4 foods to never eat safest diet pills 2016 keto diet foods yogurt diet control pills at dollar tree strongest supplements weight loss programs for women near me good eating diets to lose weight what is a good metabolism booster pill is v8 allowed on keto diet recommended appetite suppressant what is a substitute for cornstarch in a keto diet how to lose weight in 1 month fast cowboy beans keto diet how to lose weight working at a fast food restaurant keto diet affects on arthritis best meals for weight loss do niacin pills help you lose weight how to lose back weight capsula diet pills hot to lose weight best vitamins for keto diet how to become thin in 2 days on the keto diet can you eat most vegetables body fat reduction plan weight loss and muscle pills that boost libido and muscle growth fast keto diet duration lose 15 pounds in 2 months p3 nacks on keto diet diet pills kentucky what kind of supplements should i take on keto diet nature best garcinia cambogia aspartame for keto diet bodybuilder that eats keto diet heart patients thriving on keto diet dairy free keto diet plan why isn t the keto diet working for me how many carbs in a day on a keto diet keto diet carbs workout weight loss medication recall death is the keto diet healthy sausage eggs bacon podcast on keto diet can i eat dark chocolate on the keto diet what can i eat sweet on keto diet keto nutritionist near me acetyl l carnitine and alpha lipoic acid, keto diet atkins weight loss blog weight loss systems for women good fat sources for keto best foods to eat to lose belly fat weight loss pills working