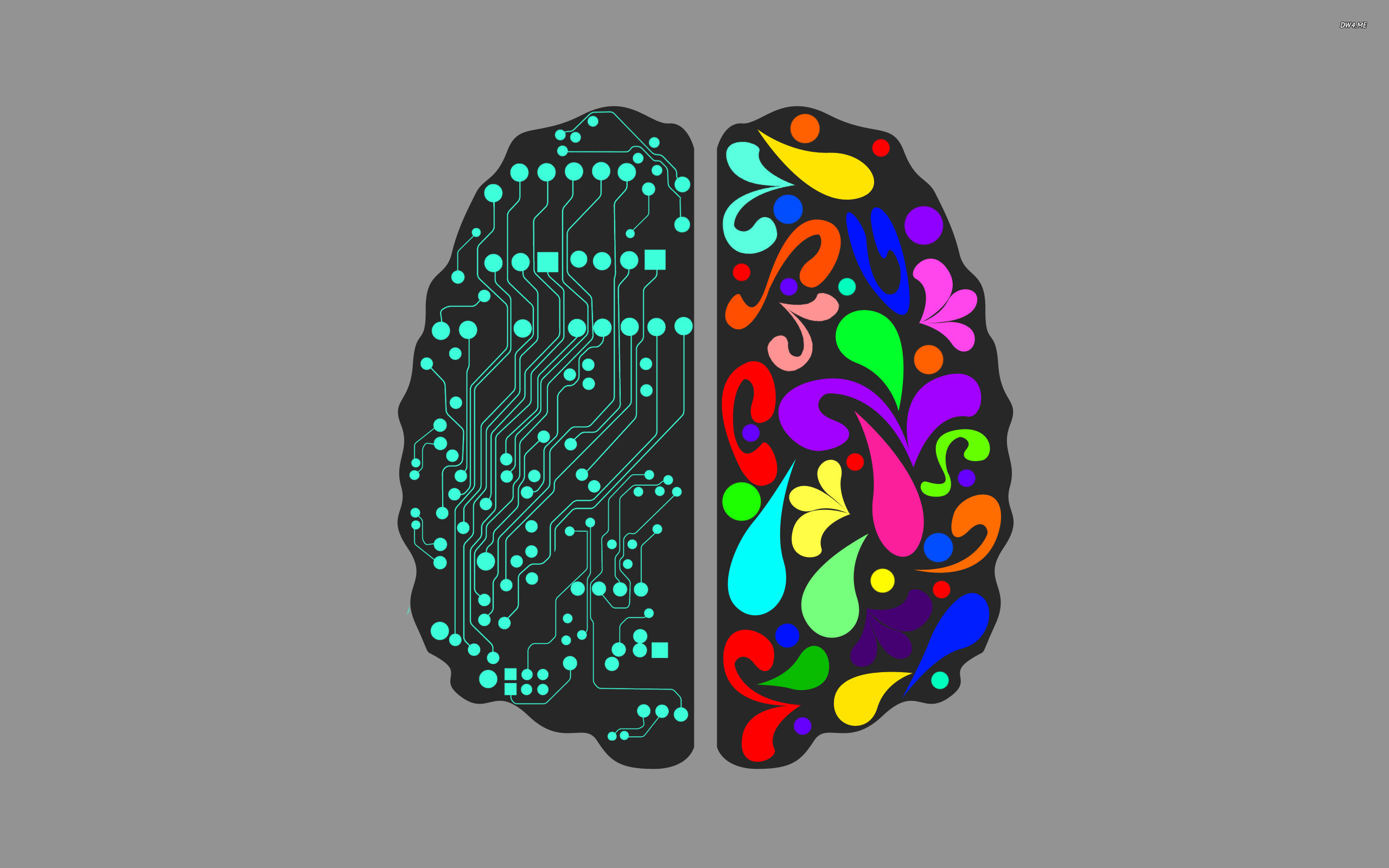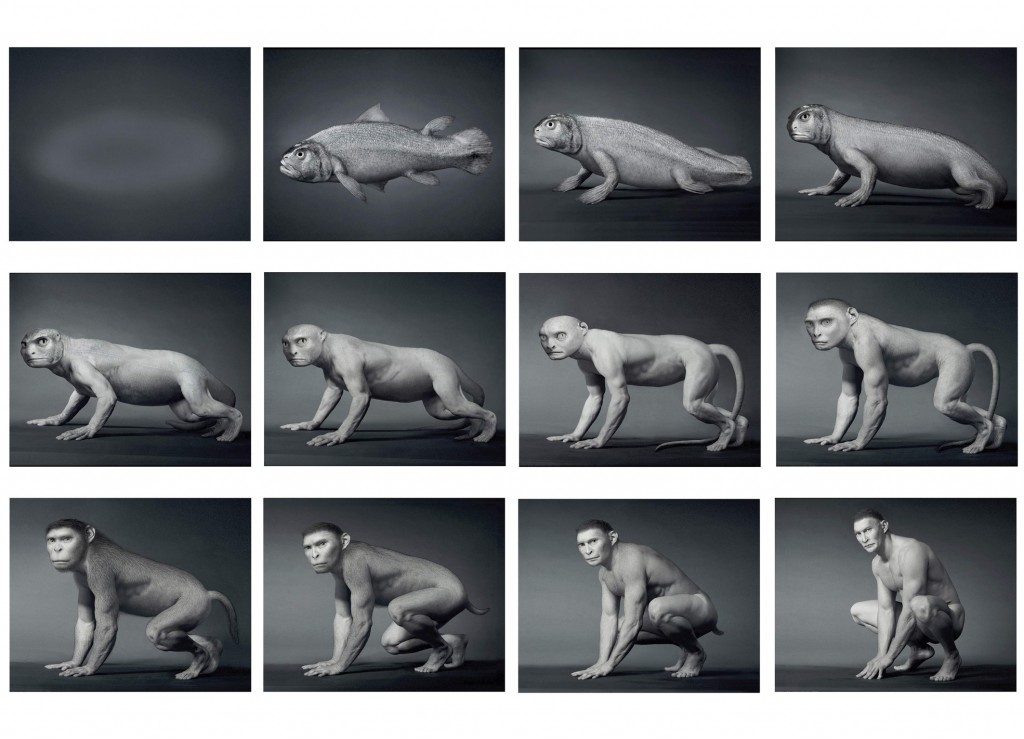-
-
Lo psichiatra e il sesso
Recensioni / Marzo 2022“E’ una bella buffoneria, il parlare: con esso l’uomo danza su tutte le cose.
Come è gradevole ogni discorso e ogni bugia di suoni!
Con i suoni il nostro amore danza su arcobaleni multicolori”
F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra
.
Nel 1973 un giovane psicologo allora poco più che ventenne convinse altre sette persone mentalmente sane a farsi internare assieme a lui in dodici ospedali psichiatrici americani, omogeneamente distribuiti tra la East e la West Coast, per condurre un esperimento scientifico.
Gli pseudomalati si presentarono presso questi centri specialistici esponendo una problematica specifica: sentivano delle voci proferire affermazioni confuse, oscure e dalle quali era possibile distinguere solo parole come “Empty” (Vuoto), “Thud” (rumore sordo) e “Hollow” (cavo), lamentando inoltre un senso di insoddisfazione generalizzato: come l’impressione di vivere per l’appunto una vita “vuota e priva di significato”.
Sette su otto pazienti vennero internati con una diagnosi di schizofrenia e furono poi dimessi, da una settimana fino a due mesi dopo, una volta accertata la “remissione” della loro fantomatica crisi psicotica.
Ironia della sorte, solo alcuni tra i pazienti psichiatrici ricoverati in questi ospedali si accorsero che in effetti c’era qualcosa che non quadrava, ovvero che questi sedicenti malati mentali non avevano nulla a che spartire con gli altri (quelli veri…), mentre i dottori si limitarono a giustificare i tempi record in cui erano state guarite queste psicosi immaginarie evocando il potere taumaturgico degli psicofarmaci somministrati.
Come se già questi risultati sperimentali, letteralmente raccolti sul campo, non bastassero da soli a insinuare qualche dubbio relativamente all’affidabilità dell’impianto nosografico e dottrinario di quella branca della medicina che passa sotto il nome di “psichiatria”, il noto esperimento – il Rosenham experiment, che prende il nome dallo psicologo David Rosenham, l’ideatore ed il primo sperimentatore di questa entusiasmante beffa epistemologica… – continuò anche dopo che tutti i sedicenti malati mentali furono dimessi dai reparti in cui erano stati maldestramente ricoverati. Lo staff di questi sanatori, infatti, venne informato che nei tre mesi successivi alla dimissione degli pseudomalati (i quali, per parte loro, avevano già palesato la loro identità ed i loro intenti al personale sanitario) negli stessi ospedali sarebbero stati inviati altri individui mentalmente sani per continuare a mettere alla prova la plausibilità e la veridicità delle categorie diagnostiche allora in uso. In un ospedale lo staff tacciò addirittura quarantuno pazienti su centonovantratrè nuovi ricoverati di essere dei finti malati, dei simulatori sperimentali di psicosi, ma nessun individuo era stato in realtà inviato da Rosenham in quell’istituto – come d’altronde negli altri, che caddero però tutti nello stesso tranello…
Ora: se l’esperimento in questione da una parte prova a rispondere alla domanda “Se la sanità e la malattia mentale esistono, come facciamo a conoscerle?” (Rosenham 1973, 250), dall’altra – e forse proprio perché offre una risposta a dir poco perturbante a questo quesito… – fa piombare gli studiosi di psicologia, scienze sociali, medicina e filosofia in un vero e proprio paradosso istituzional-epistemologico.
La psichiatria infatti esiste, esiste il TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio) quale sua extrema ratio ed esistono le pratiche di contenzione farmacologica che in alcuni casi compromettono irreversibilmente il funzionamento psichico e sociale dei pazienti che le ricevono, ma non esiste nulla che assomigli, anche solo lontanamente, ad una definizione scientifica, irrefutabile e chiara, di cosa sia la malattia mentale, di quali siano i parametri oggettivi che la definiscono e le cause che la innescano. Mancano, in breve (oggi come all’epoca del Rosenheim experiment), i criteri tali per cui la malattia psichica possa essere istituita come categoria scientifica ontologicamente opposta, in modo definitivo e non ambiguo, a quella altrettanto problematica di “sanità mentale”.
Ebbene: lo strumento atto a risolvere (anche se solo a livello legale, istituzionale e squisitamente formale, come vedremo) questo paradosso ontologico - politico di per sé insolubile è il DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 2014) ovvero il testo sacro della psichiatria occidentale, in costante aggiornamento ed ormai giunto alla sua quinta edizione, sul quale Sergio Benvenuto getta uno sguardo spietato ed ironico in una delle sue più recenti pubblicazioni: Lo psichiatra e il sesso. Una critica radicale del DSM – 5 (Mimesis, 2020).
L'indagine di Benvenuto (rinomato psicanalista e filosofo napoletano, allievo di Laplanche ed interprete sui generisdell’opera di Freud e Lacan) si distingue per originalità e audacia dalle innumerevoli, viete e monotone critiche al DSM di matrice antipsichiatrica. Il testo si propone per l’appunto di rilevare le criticità, le aporie e le contraddizioni che emergono da una lettura, certosina e attenta come solo l’ascolto psicoanalitico può permettere, della sezione dedicata ai disturbi sessuali. Certo, non manca un intero capitolo dedicato all’indagine della filosofia e dello spirito intellettuale che animano il monumentale progetto enciclopedico-nosografico del tanto celebre quanto bistrattato manuale diagnostico e ciò che lì traspare, in controluce, oltre all’assoluta infondatezza scientifica di quello che nel DSM-5 è affermato con inflessibile rigore, è anzitutto la torbida collusione ed il fatale intreccio tra le funzioni normative e descrittive, disciplinari ed analitiche che animano tale opera. L’autore sostiene infatti che «il DSM non è creatura della sperimentazione scientifica; è una costruzione essenzialmente etico-politica, addirittura un artefatto filosofico. Un costrutto “ideologico” direi, se io fossi marxista» (p. 53).
D’altronde anche solo per quanto riguarda la sfera dei disturbi sessuali – quella su cui si concentra la maggior parte del libro – l’autore evidenzia come lungi dal porre dei problemi relativi all’eziopatogenesi o al decorso clinico dei disturbi esaminati, e piuttosto di porsi questioni relative all’elaborazione teorica dei concetti che definiscono le patologie in questione, il DSM-5 aspiri anzitutto a perpetrare in ambito medico ed istituzionale una vera e propria finzione epistemico-ontologica. Il DSM-5, “l’artefatto filosofico” che Benvenuto nel suo libro smonta e demolisce pagina dopo pagina, non sarebbe nient’altro allora che lo strumento atto a sostenere e a diffondere il miraggio, l’illusione o la conciliante utopia secondo cui la sessualità potrebbe essere intesa come qualcosa di governabile, amministrabile e rendicontabile. E nel fare questo il manuale più utilizzato dagli psichiatri di tutto il mondo per produrre delle diagnosi psichiatriche sembrerebbe rispondere più a necessità di ordine igienico-sociale (come d’altronde già rilevato dallo stesso Foucault, e proprio a proposito della storia della psichiatria…) che ad esigenze di tipo scientifico o meramente medico-sanitario.
Il DSM viene infatti presentato dall’autore come un testo che, non misurandosi con i criteri di veridizione e validazione scientifici canonicamente intesi, si profila come il risultato di una calibrazione di varie correnti ideologiche e culturali presenti anzitutto nella psichiatria americana ed in secondo luogo nel cosiddetto “senso comune”. Basti pensare al caso esemplare dell’omosessualità: questa è stata depennata dalla ridda dei disturbi mentali elencati nel DSM solo nel 1974, durante la stesura della terza edizione e non a seguito di uno studio scientifico, statistico o quantitativo che ne stemperasse la supposta nocività ma letteralmente per alzata di mano…
In fondo è come se la metodologia che presiede alla definizione della malattia mentale e segnatamente dei disturbi sessuali, nel DSM, si limitasse a replicare passivamente l’andamento delle morali secolari, delle ideologie dominanti e del senso comune che si susseguono, di volta in volta e di epoca in epoca, come vere e proprie mode – così da offrirne una sorta di sanzione pseudoscientifica, una convalida istituzionale che ha lo scopo precipuo di assicurare stabilità (per quanto debole e basculante, in quanto teoricamente infondata…) all’assetto istituzionale e politico della psichiatria.
Quello che rimarca Benvenuto, allora, è che grazie ad una strategia che si basa su una sorta di formalizzazione grossolana ed approssimativa del senso comune dominante e collocandosi negli anfratti di quell’interdipendenza esiziale e per certi versi ineluttabile tra l’istituzione medica e quella giuridica, «la diagnostica psichiatrica – DSM-5 incluso – non è affatto oggettiva” ma “assorbe invece come una spugna visioni diffuse, mentalità, tropismi politico-filosofici alla moda, pregiudizi correnti, insomma, quelle che chiamerò Filosofie Popolari Dominanti, e dà a questo assorbimento una sorta di avvallo scientifico» (p. 31).
Esemplare, a tal proposito, è il caso del diverso trattamento riservato dai redattori del DSM-5 a quei due atteggiamenti che potremmo localizzare agli estremi della sessualità umana ovvero la castità e la promiscuità: quali sono i criteri che definiscono patologica l’assenza di eros e interessi sessuali (detta “anerosia”) tra i sedici ed i quarantaquattro anni (e perché non quattordici, quarantacinque o cinquanta?) e che permettono d’altra parte di soprassedere silenziosamente su di un’eventuale patologizzazione dell’ipersessualità, ovvero della dipendenza morbosa da rapporti sessuali con molti partner? La risposta dell’autore è netta ed ha un valore paradigmatico per quanto riguarda l’impianto pseudo-teorico e pseudo-scientifico del DSM:
«La ragione […] è etico-filosofica, non certo scientifica. Il punto è che oggi una certa promiscuità sessuale non solo è pienamente accettata, anche nelle donne, ma in molti casi è persino esaltata. Ammettere una categoria di sessuo-dipendenza potrebbe diventare una mina per un manuale diagnostico, in quanto potrebbe patologizzare chiunque sia un po' promiscuo. […] È la prevalenza di una filosofia popolare favorevole ad un’intensa attività sessuale, sia negli uomini che nelle donne, ad aver fatto scartare questo comportamento come disordinato» (p. 86).
Ora: è proprio nella misura in cui risulta logicamente e materialmente impossibile offrire un rendiconto sistematico, scientifico ed obiettivo di quei fenomeni cangianti e plastici che sono i costumi e le morali sessuali che i redattori dei vari DSM sono stati costretti ad adottare una metodologia non solo antiscientifica, ma anche assolutamente priva di qualsiasi riferimento critico all’epistemologia o alla filosofia della scienza. D’altronde ad essere recepita dagli autori del manuale diagnostico, secondo Benvenuto, non sarebbe nient’altro che la richiesta di senso avanzata dai più reconditi ed inconfessati anfratti della realtà sociale, e relativamente a questioni che potremmo benissimo derubricare – in un’ottica non ossessionata dalla medicalizzazione o dalla politicizzazione di ogni intimo recesso dell’esperienza umana… – come “esistenziali”, “ontologiche” o più semplicemente “metafisiche”. Tanto il concetto di sanità mentale quanto quello di una sessualità articolabile nei termini sanzionati e previsti dai linguaggi medico e giuridico solleverebbero per l’appunto interrogativi difficilmente liquidabili ricorrendo ad una terminologia e ad un metodo scientifici, con studi statistici o con generalizzazioni “da manuale” ad usum consumi di medici e giuristi. Là dove il DSM-5 e le edizioni che lo hanno preceduto falliscono, o quantomeno mostrano la corda, insomma, non è allora tanto nell’uso improprio di un impianto assolutamente privo di solide basi scientifiche ma è, al contrario, proprio nella pretesa (…delirante?) e nella perversa velleità di rendicontare e misurare, a fini tutto sommato disciplinari ed organizzativi, un fenomeno così proteiforme e variegato com’è quello della sessualità umana. Ma mai come in questo caso è proprio l’oggetto in sé (l’oggetto che in un linguaggio lacaniano ed heideggerianeggiante potremmo chiamare Das Ding…) che non si presta ad essere regolato, ordinato ed addomesticato da nessun discorso oggettivante e scientifico.
Come giustamente saprà Benvenuto, infatti, non v’è altra lezione che la psicoanalisi possa offrire per quanto concerne il rapporto del soggetto con il sesso e con il godimento ivi implicato se non questa: che “il sesso fa buco nel sapere” (per dirla con una celebre espressione di Lacan) e che il vuoto scavato da questa assenza deve essere assunto soggettivamente, secondo modalità sempre individuali e non generalizzabili. La sessualità umana costituisce infatti l’ostacolo, l’incaglio inaggirabile di ogni ontologia proprio perché quel che vi è in ballo, in questioni del genere, è davvero impermeabile ad ogni riduzionismo (manualistico, ideologico, politico) e refrattario ad ogni tipo di generalizzazione (enciclopedica, giuridica, ma anche identitaria…) in quanto radicalmente e fondamentalmente privo di senso[1]. Ed è qui che il libro di Benvenuto si presta ad una lettura inaspettatamente attuale e decisamente controcorrente.
Quando l’autore afferma che «i DSM non sono affatto liquidabili come aggeggi conservatori; al contrario, sono molto porosi a tutte le lobbies “identitarie” che oggi dilaniano l’America» (p. 86) sembra proprio che suggerisca un insolito parallelismo tra il programma diagnostico/disciplinare propalato dai redattori del DSM ed il programma emancipazionista che anima i vari movimenti identitari, come il movimento LGBTQIA+, che oggi imperversano ovunque nel mondo (o almeno in quello occidentale, democratico e liberale).
Per cogliere appieno il senso di questa sublime coincidentia oppositorum indicata quasi subliminalmente dall’autore basti pensare, ad esempio, che l’espansione costante a cui è sottoposta la sigla acrostica “LGBTQIA+” (e che varia a seconda di quanti genders o quante espressioni della sessualità umana vengano…come dire…scoperte? Ma poi: da chi?) sembra essere direttamente proporzionale all'aumento cui è sottoposto il tanto vituperato manuale psichiatrico (le pagine del DSM passano in sessant’anni, dalla prima alla quinta edizione, da 130 a 886 mentre le diagnosi psichiatriche quasi triplicano, aumentando da 106 a 297). In fondo è come se sia la sigla “LGBTQIA+” che il DSM fossero spronati da una sorta di forza motrice, invisibile e costante, che se da una parte concede a quelle minoranze che di volta in volta si scoprono tali il lusso di farsi rappresentare da una letterina maiuscola all’interno della sigla ufficiale della loro community dall’altra, al rovescio, produce una differenziazione ed una moltiplicazione incessante delle voci indicanti le patologie psichiatriche. Ad un prima occhiata è proprio come se vi fosse una sorta di paradossale comunione d’intenti (e che concerne la classificazione, la numerazione e la schedatura…) tra un programma politico liberatorio e la redazione di un manuale diagnostico…ma il punto, ovviamente, non è questo. Il punto è che entrambi i discorsi che stanno dietro a quegli “artefatti filosofici” che sono il movimento LGBTQIA+ da una parte e il DSM dall’altra (ovvero il discorso emancipatorio e quello disciplinare), proprio perché sono lungi dal porsi i problemi relativi all’elaborazione ontologica ed epistemologica delle loro premesse possono benissimo essere ascritti alla risma di quelle Filosofie Popolari Dominanti che per Benvenuto non fanno altro, come abbiamo già detto, che condensare il turbinio di “visioni diffuse, mentalità, tropismi politico-filosofici alla moda e pregiudizi correnti”. Ma non è tutto.
Il parallelismo tra DSM e movimento LGBTQIA+ può essere spinto ancora più in la, sino al cuore della questione che interessa le premesse ideologiche del DSM. Infatti è proprio il concetto che funge da pietra angolare ai gender studies, il concetto di “disforia di genere”, ad essere chiamato in causa da Benvenuto quale vera e propria “chiave di volta” dell’intera architettura pseudo-teorica del manuale diagnostico nella misura in cui, secondo l’autore, «per il DSM tutti i Disordini, tutto lo psicopatologico, sono disforie. Avrebbe potuto chiamarsi Diagnostic and Statistical Manual of Disphorias» (p. 98). Il termine in questione difatti non ha un preciso significato medico e non si riferisce a nulla che possa essere in un qualsiasi modo rilevato, verificato o testato ma, anzi, «connota qualcosa di squisitamente affettivo. Il termine greco δυσϕορία deriva da δυσ- (“cattivo”) e φέρω- (“porto”); letteralmente: “portare del cattivo”. Quindi, il termine ha una marcata connotazione emotiva, patetica. Si oppone a “euforia” e potremmo tradurlo con malessere» (p. 97).
È evidente, allora, come in un contesto in cui risulta impossibile separare e distinguere il normale dal patologico o il sano dal malato in modo netto, oggettivo e con l’obiettivo di produrre generalizzazioni profittevoli tanto sul piano nosografico quanto su quello politico-rappresentativo, il concetto di disforia possa funzionare come vero e proprio asso piglia tutto, come un jolly retorico. Tagliando corto su questioni di non poco conto come l’elaborazione di parametri atti ad individuarne la cogenza, o l’istituzione di soglie di tolleranza tali da rendere i disturbi psichici in questione più o meno gravi, il concetto di disforia funziona come passepartout retorico sia sul piano politico-identitario che su quello psichiatrico. D’altronde qual è il miglior discrimine per creare consenso attorno a ciò che non va, nella realtà sociale così come nella psiche individuale, che l’accorato appello ad una forma di inesprimibile, privato ed insondabile malessere?
Come abbiamo visto la critica radicale al DSM che Benvenuto propone nel suo acuto ed originalissimo libro è tesa a vagliare, ad indagare e a contestare la credibilità e la plausibilità della nosografia psichiatrica con gli strumenti offerti dalla psicanalisi e dalla filosofia. Per concludere si potrebbe però affermare, ed al netto di ogni ironia, che tanto i risultati del Rosenheim experiment condotto negli anni settanta quanto le riflessioni proposte più recentemente da Benvenuto confermano indirettamente quanto ebbe a dire Giacomo Contri, in una delle sue ultime interviste, a proposito della figura di Jacques Lacan: "Il manicomio di Lacan era il mondo!". Per quanto perturbante e scomodo possa sembrare, infatti, è necessario ammettere che il ricorso a quelle finzioni epistemico-ontologiche che sostengono l’infrastruttura istituzionale della psichiatria è reso necessario da un’urgenza antropologica specifica – magari inconscia, certo, ma comune ad ogni cultura... – che è quanto di più simile vi sia all’evitamento di un’incipiente psicosi. In ballo non c’è niente di meno che l’ineludibile esigenza di istituire un ordine simbolico, l’inaggirabile bisogno di demarcare dei significati, di perimetrare la comunicazione e di istituire quei confini soggettivi ed intersoggettivi senza i quali l’esperienza (ogni tipo di esperienza) è destinata ad inabissarsi nel fondo indistinto e magmatico del non-differenziato. In un simile contesto, quello che connota la condizione umana come sulla soglia del costante crollo psicotico, è chiaro come le categorie di sanità e di malattia mentale (così come quelle di uomo e di donna, verrebbe da dire…) rivestano un ruolo cruciale, fondamentale e cardinale nell’economia della verità, ovvero all’interno di quella pratica specificamente umana che consiste nel riempire di senso quelle pure entità differenziali che sono i significanti. Ma è altrettanto chiaro, soprattutto dal punto di vista psicanalitico, come sia impossibile produrre generalizzazioni, definizioni e categorizzazioni definitive, immutabili e dalla valenza universale – e questo è tanto più vero quanto più la discussione verte su tematiche quali la salute mentale, l’erotismo e la liceità dei costumi sessuali…
Il bisogno di quelle finzioni epistemico-ontologiche di cui parla Benvenuto, insomma, è un bisogno inaggirabile e propriamente umano al quale il Manuale Diagnostico e Statistico delle malattie mentali cerca di rispondere con tutti i limiti del caso ed in modo parziale, certo, ma obbedendo a criteri minimali di efficacia non solo burocratico-istituzionale. Il DSM assolve ad una funzione stabilizzante sul piano simbolico anche a livello, giocoforza, comunicativo ed esistenziale. Per quanto possa risultare difficile o quasi impossibile da riconoscere per gli studiosi di scienze sociali, per gli attivisti e per i filosofi – soprattutto per quelli che non riescono a muoversi al di fuori del recinto della critica, forse un po' dogmatica, al potere costituito… –, in fondo, forse è opportuno ammetterlo e accettarlo senza riserve: l’uomo si nutre di finzioni funzionali, di compromessi simbolici e di definizioni approssimative per evitare di rimettere costantemente in discussione le basi della comunicazione, le premesse del proprio agire e, in ultimo, per non impazzire…
Per tutto il resto ci sono la filosofia e la psicanalisi (e una menzione speciale, qui, spetta ai preziosi libri di Benvenuto). D’altro canto è stato proprio Freud – reclutato suo malgrado tra le file dei filosofi, o quantomeno assurto a punto di riferimento cardine per un certo modo di intendere la filosofia… – a tributare accanto all’ineluttabilità della finzione che ci tiene in ostaggio la necessità di rielaborare, di ripensare e di re-inventare nuovi confini, nuove regole del gioco simbolico individuale e collettivo – egli per primo, infatti, «ha considerato che non c’è nulla se non il sogno, e che tutto il mondo (se ci è concesso usare quest’espressione), tutto il mondo è folle, cioè delirante» (Lacan 1979, 278).
di Filippo Zambonini
.
.
Bibliografia
Benvenuto S. (2021). Il teatro di Oklahoma. Miti e illusioni della filosofia politica contemporanea, Castelvecchi, Roma 2021.
Benvenuto S. (2021). Lo psichiatra e il sesso. Una critica radicale del DSM – 5, Mimesis , Milano – Udine.
Clemente L. F. (2018). Jacques Lacan e il buco del sapere. Psicoanalisi, scienza, ermeneutica, Orthotes, Nepoli – Salerno.
_ (2014). Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, Quinta edizione, DSM-5. Raffaello Cortina Editore, Milano.
Lacan J.(1979). Ornicar? «Journal d’Ornicar?», n°17-18.
[1] Vale la pena di menzionare, a tal proposito, il libro di Alenka Zupancic (2018) oltre che l’inaggirabile volume di Luigi Francesco Clemente (2018).
-
Dall’incrinatura alla creazione
Longform / Novembre 2021Nel suo primo libro che non si presenta nella forma di studio monografico su un autore, ma come un’opera di carattere spiccatamente teorico, vale a dire Différence et répétition, Gilles Deleuze introduce un tema significativo: quello dell’incrinatura dell’Io. Egli fa risalire la presa di coscienza di tale fenomeno a Kant, richiamando in particolare una nota, nella Critica della ragione pura, in cui si legge: «L’io penso esprime l’atto del determinare la mia esistenza. Con ciò l’esistenza è quindi già data; tuttavia, con ciò non è ancora dato il modo in cui io debba determinare tale esistenza, cioè porre in me il molteplice che appartiene ad essa. Per questo si richiede l’auto-intuizione, che si fonda su una forma data a priori, cioè il tempo» (Kant 1997: 115) [1]. Da questa breve osservazione derivano, secondo Deleuze, conseguenze radicali. Infatti, se «la mia esistenza indeterminata può essere determinata solo nel tempo», allora «la spontaneità di cui ho coscienza nell’Io penso non può essere intesa come l’attributo di un essere sostanziale e spontaneo, ma soltanto come l’affezione di un io passivo il quale avverte che il proprio pensiero, la propria intelligenza, ciò attraverso cui egli dice io, si esercita in lui e su di lui […]. L’attività del pensiero si applica a un essere ricettivo, a un soggetto passivo, che si rappresenta dunque tale attività piuttosto che attuarla, ne sente l’effetto piuttosto di averne l’iniziativa, e che la vive come un Altro dentro di lui. […] Da parte a parte, l’io è come attraversato da un’incrinatura; è incrinato dalla forma pura e vuota del tempo» (Deleuze 1997: 116-117) [2].
Ma non basta: mentre ancora in Descartes «l’identità supposta dell’Io non ha altro garante che l’unità di Dio stesso», Kant annuncia «la simultanea scomparsa della teologia razionale e della psicologia razionale, il modo in cui la morte speculativa di Dio porta con sé un’incrinatura dell’Io» (Deleuze 1997: 116). Va precisato, però, che quest’audace avanzata teorica kantiana è seguita da un arretramento, per cui «il Dio e l’Io conoscono una resurrezione pratica. E anche nell’ambito speculativo, l’incrinatura è presto colmata da una nuova forma d’identità, l’identità sintetica attiva» (Deleuze 1997: 117). La prospettiva prima dischiusa e poi richiusa da Kant viene, a giudizio di Deleuze, riaperta da un poeta, Hölderlin, «che scopre il vuoto del tempo puro e, in tale vuoto, scopre nel contempo il continuo distogliersi del divino, l’incrinatura prolungata dell’Io e la passione costitutiva del Me. In questa forma del tempo, Hölderlin scorgeva l’essenza del tragico o l’avventura di Edipo, come un istinto di morte» Deleuze 1997: 117).
Il riferimento è ai commenti aggiunti dal poeta alle proprie traduzioni di due tragedie di Sofocle, e in particolare alle Note all’«Edipo» (Hölderlin 2019: 763-773). Qui Hölderlin sostiene che nella tragedia trova espressione il fatto che, «in un’epoca ristagnante, il dio e l’uomo, affinché non vi sia lacuna nel corso del mondo e non si spenga la memoria dei celesti, comunicano nella forma, dimentica di tutto, dell’infedeltà […]. In tale momento l’uomo dimentica sé e il dio, e gli si rivolta – seppur in modo sacro – come un traditore. Al limite estremo della sofferenza, infatti, non esiste più niente, tranne le condizioni del tempo e dello spazio» (Hölderlin 2019: 772-773). Deleuze allude anche a un’altra osservazione hölderliniana, quella secondo cui, essendo «il trasporto tragico […] in sé vuoto», ne consegue che, «nella sequenza ritmica delle figurazioni in cui il trasporto si manifesta, diventa necessaria la parola pura, l’interruzione antiritmica – ciò che nella metrica si chiama cesura» (Hölderlin 2019: 764). Quest’ultima nozione viene rapportata dal filosofo francese non soltanto al tempo, ma anche alla psiche, per cui «sono la cesura, e il prima e il dopo che essa ordina una volta per tutte, a costituire l’incrinatura dell’Io (la cesura è esattamente il punto d’insorgenza dell’incrinatura)» (Deleuze 1997: 119).
Già dai pochi passi citati (relativi a Kant e Hölderlin) emergono due tratti caratteristici: la propensione di Deleuze a proporre interpretazioni piuttosto libere dei testi, in funzione di una teoria che egli intende avanzare per interposta persona, e la tendenza ad utilizzare spesso esempi letterari, accanto a quelli filosofici. Questo secondo aspetto del suo modo di procedere trova conferma nel rinvio, nelle stesse pagine, a testi narrativi: «Sul tema di una “incrinatura” dell’Io, in rapporto essenziale con la forma del tempo intesa come istinto di morte, ci si riporterà a tre grandi opere letterarie, benché assai diverse fra loro: La bête humaine di Zola, Il crollo di F. S. Fitzgerald, Sotto il vulcano di M. Lowry» (Deleuze 1997: 117) [3].
Al primo di questi testi, Deleuze ha dedicato un saggio, incluso nel volume Logique du sens (Deleuze 1975: 281-291). Egli ricorda che è stato lo stesso Zola ad usare nel suo romanzo il termine «incrinatura», in riferimento a una specie di tara ereditaria di cui il protagonista, Jacques Lantier, subisce le conseguenze (Zola 2019: 63-64). In effetti è noto che lo scrittore prestava molto credito alle teorie, in voga a quell’epoca, relative all’ereditarietà. Ma Deleuze sostiene che, nel caso specifico di Lantier, le cose sono più complesse: «L’ereditarietà non è ciò che passa attraverso l’incrinatura, ma è l’incrinatura stessa: la frattura o il buco, impercettibili. […] Non trasmette nulla tranne se stessa» (Deleuze 1975: 282). Anche l’istinto (sessuale o omicida) a cui il protagonista cede, con esiti rovinosi per lui e per altri, «non si confonde mai con l’incrinatura, ma intrattiene con essa stretti rapporti variabili: ora la ricopre e rincolla alla meglio, e per un tempo più o meno lungo […]; ora l’allarga, le dà un diverso orientamento che fa esplodere i frammenti» (Deleuze 1975: 282-283). L’incrinatura non opera dunque alla maniera dell’ereditarietà, «non riproduce un “medesimo”, non riproduce nulla, si limita ad avanzare in silenzio, a seguire le linee di minor resistenza, sempre deviando, pronta a cambiare direzione» (Deleuze 1975: 284). Da ultimo, il filosofo ritiene di poter affermare che «l’essenziale di La bête humaine è l’istinto di morte nel personaggio principale, l’incrinatura cerebrale di Jacques Lantier, macchinista di locomotiva» (Deleuze 1975: 286).
Parlare di istinto di morte equivale senza dubbio a chiamare in causa la psicoanalisi. In Différence et répétition, Deleuze ricorda le tesi esposte (o, per meglio dire, prese in esame) da Freud in Al di là del principio del piacere (Freud 1989: 187-249), e tuttavia lo fa soprattutto al fine di contestarle. Così, se il fondatore della psicoanalisi giungeva a ipotizzare un contrasto di fondo tra pulsioni di vita, identificabili con l’eros, e pulsioni di morte, il filosofo nega l’indipendenza di queste ultime: «Non vediamo dunque alcuna ragione per supporre un istinto di morte che si distingua da Eros, sia per una differenza di natura tra due forze, sia per una differenza di ritmo o di ampiezza tra due movimenti. In entrambi i casi, la differenza sarebbe già data, e Thanatos indipendente. Secondo noi, al contrario, Thanatos si confonde interamente con la desessualizzazione di Eros» (Deleuze 1997: 148). Poiché la concezione di Deleuze è di tipo essenzialmente vitalistico, egli non può far altro che arretrare di fronte all’idea che esista un’autonomia delle pulsioni di morte.
Nel contempo, però, egli si rende conto che sarebbe poco corretto pensare all’incrinatura dell’io come se si trattasse unicamente di un fenomeno negativo, di una mera sottrazione di energia, sicché in altri punti del suo libro egli presenta la crepa che si produce nella psiche in maniera del tutto differente, ossia come generatrice di idee: «Per quanto il Cogito rinvii a un Io incrinato, spaccato da parte a parte dalla forma del tempo che lo attraversa, bisogna dire che le Idee formicolano in tale incrinatura, emergono costantemente sui bordi di essa, uscendo e rientrando senza posa, componendosi in mille modi diversi» (Deleuze 1997: 221). Può sembrare contraddittorio conferire all’incrinatura psichica caratteri nel contempo negativi e positivi, ma questa duplicità appartiene alla natura stessa del fenomeno in questione. Chi subisce gli effetti dell’incrinatura si trova suo malgrado a sperimentare qualcosa di eccessivo, che lo destabilizza fin nel profondo. A ciò può reagire in due maniere opposte, o lasciandosi scivolare sulla china della perdita, dell’istinto di morte, oppure trasformando l’incrinatura in uno stimolo, ad esempio per la creazione di concetti filosofici o di opere artistiche.
Infatti l’insorgenza del pensiero innovativo non dipende, secondo Deleuze, da una predisposizione innata o da uno sforzo volontaristico, bensì da uno choc iniziale che si è subito. Già nel suo libro su Proust egli avvertiva che «il torto della filosofia sta nel presupporre in noi una buona volontà di pensare, un desiderio, un amore naturale del vero. Perciò la filosofia arriva soltanto a verità astratte, che non compromettono nessuno e non sconvolgono nulla. […] Tali idee restano gratuite, perché sono nate dall’intelligenza, che conferisce loro una sola possibilità, e non da un incontro o da una violenza che potrebbero garantirne l’autenticità. […] La verità dipende da un incontro con qualcosa che ci costringe a pensare, e a cercare il vero» (Deleuze 1986: 16-17). Dato che Deleuze sta parlando di Proust, si può scorgere una corrispondenza tra la valorizzazione delle idee filosofiche subite rispetto a quelle elaborate razionalmente e il privilegio (conoscitivo, oltre che emotivo) concesso dall’autore della Recherche alla memoria involontaria in confronto a quella volontaria. Ma anche nel diverso contesto di Différence et répétition Deleuze ribadisce che le idee cui si perviene per semplice ragionamento logico hanno un valore limitato: «Manca ad esse una provocazione, che sarebbe quella della necessità assoluta, cioè di una violenza originaria fatta al pensiero, di un’estraneità, di un’inimicizia che sola lo farebbe uscire dal suo stupore naturale o dalla sua eterna possibilità: […] non c’è pensiero se non involontario, costrizione suscitata nel pensiero» (Deleuze 1997: 182).
Il fatto che la violenza subita dalla psiche non raggiunga necessariamente l’individuo quando si trova nel pieno possesso delle proprie forze fisiche e mentali, ma possa pure esercitarsi su persone in apparenza deboli verrà chiarito in opere successive, a cominciare da Dialogues. In quel libro leggiamo che, «attraverso ogni combinazione fragile, è una potenza di vita ad affermarsi, con una forza, un’ostinazione, una perseveranza nell’essere che sono impareggiabili. È curioso come i grandi pensatori abbiano una vita personale fragile, una salute molto incerta, e al tempo stesso innalzino la vita allo stato di potenza assoluta o di “grande Salute”» (Deleuze & Parnet 1998: 11-12) [4]. Così, parlando dei filosofi a cui si sente più legato, primi fra tutti Spinoza e Nietzsche, Deleuze osserva: «Tutti questi pensatori hanno una costituzione fragile, eppure sono attraversati da una vita insuperabile. Procedono solo per potenza positiva, e di affermazione. Hanno una sorta di culto della vita» (Deleuze & Parnet 1998: 21). È ammirevole la discrezione che induce il pensatore francese a non dire nulla riguardo al proprio stesso caso, che è quello di una persona afflitta, per gran parte dell’esistenza, da seri problemi di salute.
Il discorso non è valido solo per il filosofo, ma anche per l’artista. Quest’ultimo – si legge in un’altra opera – è qualcuno che «ha visto nella vita qualcosa di troppo grande, di troppo intollerabile anche», ed è proprio questa esperienza a renderlo «un veggente, un diveniente» (Deleuze & Guattari 1996: 176). Occorre dunque essersi trovati ad affrontare una dura prova: «Per aver raggiunto il percetto come “la fonte sacra”, per aver visto la Vita nel vivente o il Vivente nel vissuto, il romanziere o il pittore tornano con gli occhi rossi, col fiato corto» (Deleuze & Guattari 1996: 177) [5]. Sotto questo profilo, dunque, non c’è differenza tra il pensatore, che lavora con i concetti, e l’artista, che invece ha a che fare con i percetti. «In tal senso gli artisti sono come i filosofi, hanno spesso una salute troppo fragile; non a causa delle malattie o delle nevrosi, ma perché hanno visto nella vita qualcosa di troppo grande per chiunque, di troppo grande per loro, e che ha impresso su di essi il sigillo discreto della morte. Ma questo è anche la fonte o il respiro che consente loro di vivere, attraverso le malattie del vissuto (è ciò che Nietzsche chiamava salute)» (Deleuze & Guattari 1996: 178).
Anche nell’ultimo libro pubblicato in vita, Critique et clinique, il filosofo tornerà a ribadire la propria convinzione, parlando stavolta in maniera più specifica degli autori di opere letterarie: «Non si scrive con le proprie nevrosi. La nevrosi, la psicosi non sono passaggi di vita, ma stati in cui si cade quando il processo è interrotto, impedito, chiuso. […] Perciò lo scrittore in quanto tale non è malato, ma piuttosto medico, medico di se stesso e del mondo. Il mondo è l’insieme dei sintomi di una malattia che si confonde con l’uomo. La letteratura appare allora come un’impresa di salute: non che lo scrittore abbia necessariamente una salute vigorosa […], ma gode di un’irresistibile salute precaria che deriva dall’aver visto e sentito cose troppo grandi, troppo forti per lui, irrespirabili, il cui passaggio lo sfinisce, e tuttavia gli dischiude dei divenire che una buona salute dominante renderebbe impossibili» (Deleuze 1996: 16).
In queste stesse frasi non mancano gli echi letterari. Così la formula «cose troppo grandi, troppo forti per lui», presuppone forse, da parte di Deleuze, la reminiscenza di una lettura di Proust: infatti, nel romanzo giovanile incompiuto Jean Santeuil, il protagonista manifestava le proprie incertezze e paure pensando: «Il mondo è troppo complicato per me, la vita è troppo forte per me» (Proust 1976: 63). Quanto poi all’idea secondo cui lo scrittore non va considerato come malato bensì come terapeuta, era già stata formulata da un altro scrittore caro al filosofo, ossia Artaud, che parlando a nome degli alienati (categoria a cui sentiva di appartenere) dichiarava: «Noi che il dolore ha fatto viaggiare nella nostra anima alla ricerca di un luogo di calma a cui aggrapparci, alla ricerca della stabilità nel male come gli altri nel bene. Noi non siamo folli, siamo dei medici meravigliosi» (Artaud 2004: 128). Un terzo riferimento, stavolta reso esplicito da Deleuze, è al testo in cui Michaux, riferendosi alla propria raccolta di brani narrativi e poetici dal titolo Mes propriétés, dichiara di averla composta «per la mia salute. Senza dubbio non si scrive per un motivo diverso. Non si pensa in altro modo. […] Questo libro, quest’esperienza che pare dunque provenire tutta dall’egoismo, mi spingerei fino a dire che è sociale, a tal punto si tratta di un’operazione alla portata di tutti e che sembra dover essere così vantaggiosa per i deboli, i malati e malaticci, i bambini, gli oppressi e i disadattati di ogni genere. In tal modo, vorrei essere stato utile almeno a quei sofferenti immaginosi, involontari, perpetui» (Michaux 1998: 511-512) [6].
Si può dire pertanto che aver subito una certa incrinatura a livello psichico, o comunque l’aver fatto esperienza di qualcosa che destabilizza il soggetto percipiente, sottoponendolo a un eccesso di dolore (o magari di gioia), se può in certi casi indebolirne le difese, così da indurlo a cedere a pulsioni mortifere, in altri e più fortunati casi può conferirgli delle capacità di pensiero e di creazione che in precedenza erano per lui inaccessibili. Deleuze elogia ad esempio scrittori americani come Fitzgerald e Lowry perché, a suo dire, hanno colto appieno la potenza della vita e, per poterla sopportare, hanno fatto ricorso all’alcol. Questo ha consentito ad essi di trasmettere, nella scrittura letteraria, la loro particolare visione, ma evidentemente ha comportato anche dei rischi, poiché in effetti occorrerebbe sempre «fare in modo che la linea di fuga non si confonda con un puro e semplice movimento di autodistruzione» (Deleuze & Parnet 1998: 44). Infatti, quando la linea di fuga si volge in linea di morte, l’esistenza, e con essa la scrittura, divengono impraticabili. «Perché si scrive? Il fatto è che non si tratta di scrittura. Può darsi che lo scrittore abbia una salute fragile, una costituzione debole. Ciò non toglie che sia proprio l’opposto del nevrotico: una sorta di grande Vivente (alla maniera di Spinoza, di Nietzsche o di Lawrence), anche se è soltanto troppo debole per la vita che lo attraversa o gli affetti che passano in lui» (Deleuze & Parnet 1998: 55). Occorre dunque saper trasformare l’incrinatura iniziale in una creativa linea di fuga, ma occorre anche, mentre si è impegnati a tracciare tale linea, imparare a conoscere «i pericoli che vi si corrono, la pazienza e le precauzioni che bisogna impiegare, le correzioni che bisogna apportare di continuo» (Deleuze & Parnet 1998: 44). Solo così, secondo Deleuze, l’atto di creazione giungerà a buon fine, e il pensatore o lo scrittore potranno dire di essere riusciti a esprimere la potenza, nel contempo terribile ed esaltante, della vita.
di Giuseppe Zuccarino
.
.
Bibliografia
Artaud, A. (2004). Sûreté générale - La liquidation de l’opium. In Œuvres. Paris: Gallimard, 2004, 126-128.
Deleuze, G. (1986). Marcel Proust e i segni. Torino: Einaudi.
Id. (1975). Zola e l’incrinatura. In G. Deleuze, Logica del senso. Milano: Feltrinelli, 281-291.
Id. (1997). Differenza e ripetizione. Milano: Cortina.
Id. (1996). Che cos’è la filosofia? Torino, Einaudi, 1996.
Deleuze, G. & Parnet, C. (1998). Conversazioni. Verona: Ombre corte.
Deleuze, G. & Guattari, F. (2017). Mille piani. Capitalismo e schizofrenia, Napoli-Salerno : Orthotes.
Id. La littérature et la vie, in Critique et clinique, Paris, Éditions de Minuit, 1993, pp. 11-17 (tr. it. La letteratura e la vita, in Critica e clinica, Milano, Cortina, 1996, pp. 13-19).
Deleuze G. (2004). L’abbecedario di Gilles Deleuze, Roma: DeriveApprodi.
Fitzgerald, F. S. (2010), Il crollo. Adelphi: 2010.
Freud, S. (1989). Al di là del principio del piacere. in Opere, vol. 9. Torino: Bollati Boringhieri, 187-249.
Hölderlin, F. (2019). Note all’«Edipo». In Prose, teatro e lettere, Milano: Mondadori, 763-773.
James, H. (1984). La fonte sacra. Torino: Einaudi.
Kant, I. (1995),.Critica della ragione pura. Milano: Adelphi.
Lowry, M. (1961). Sotto il vulcano. Milano: Feltrinelli.
Michaux, H. (1998), Postface a Mes propriétés. In La nuit remue, in Œuvres complètes, vol. I. Paris: Gallimard, 511-512.
Nietzsche, F. (1991), La gaia scienza. in Opere, vol. V, tomo II. Milano : Adelphi, 13-323.
Proust, M. (1976), Jean Santeuil, Torino : Einaudi.
Zola, É (2019). La bestia umana, Milano: Rizzoli.
.
.
[1] Al passo si rimanda in Deleuze 1997: 115.
[2] Si avverte che i passi delle traduzioni italiane cui si rimanda vengono spesso citati con modifiche.
[3] Cfr. Zola 2019; Scott Fitzgerald 1961. Sul racconto di Fitzgerald, si veda anche Deleuze & Guattari 2017: 287-289.
[4] L’espressione citata da ultimo fra virgolette rimanda a un concetto nietzschiano: cfr. l’aforisma La grande salute, in Nietzsche 1991: 307-309.
[5] La fonte sacra è il titolo di un romanzo di Henry James del 1901 (1984).
[6] Deleuze rimanda a queste pagine in Deleuze & Guattari 1997: 163 e in Deleuze 1996: 16.
-
Filosofia del gesto
Recensioni / Giugno 2021Diceva Peirce che il pensiero di uno scrittore vivente risiede maggiormente nelle copie stampate dei suoi libri piuttosto che nel suo cervello (CP 7.364). Ovviamente, con questa formulazione, Peirce non voleva affatto mettere in luce la mera dimensione quantitativa della produzione di un autore, quanto piuttosto sostenere che è nella pratica di scrittura – condivisa, corporea, intersoggettiva e proprio per questo valutabile e aperta al dibattito – che si discutono le idee, che i pensieri acquisiscono corpo e che diventa possibile saggiarne la consistenza e l’effettività pratica. La filosofia del gesto di Giovanni Maddalena, nella versione italiana appena pubblicata, conferma in qualche modo questa idea del pragmatista americano. Mentre The Philosophy of Gesture, uscito nel 2015 per la prestigiosa casa editrice McGill, si presentava come un testo più corposo e tecnico, la versione italiana è invece più agile e diretta e nasce dall’esigenza di far arrivare la proposta teoretica di questo testo ad un pubblico più ampio di quello degli studiosi e degli specialisti del pragmatismo. Giovanni Maddalena è professore ordinario di filosofia teoretica all’università del Molise e si occupa principalmente di pragmatismo americano, della semiotica di Charles Peirce, della logica della continuità e dello studio dei grafi esistenziali.
Per inquadrare agilmente la struttura di questo testo, si potrebbe dire che è suddiviso in due parti. Con un piccolo nota bene però: che con questa operazione – e dunque con questo gesto – si è già tradita in qualche modo la complessità e la sinteticità di questo nuovo modo di intendere la pratica gestuale, dove teoria e prassi, mente e corpo, comunicazione e pensiero sono già da sempre coinvolti in un’unità dinamica e creativa.
Nella prima parte Maddalena discute, sul versante teoretico, in quale senso quello del gesto sia un nuovo paradigma di ragionamento sintetico. Nella seconda parte, invece, l’autore fornisce un ventaglio di applicazioni pratiche entro cui questo nuovo paradigma di ragionamento può muoversi e contribuire, dalle riflessioni sulla tecnologia alla religione, dal diritto alla pedagogia.
Sin dalle prime pagine, questo testo presenta le ragioni per cui è necessario pensare ad una filosofia del gesto: l’obiettivo polemico di questo nuovo paradigma di ragionamento è infatti il come della distinzione kantiana tra analitico e sintetico. Nella Critica della ragion pura, Kant definisce analitico quel giudizio che, basandosi sul principio di contraddizione, presenta le caratteristiche di necessità e universalità; definisce invece sintetico quel giudizio che, basandosi sull’esperienza, permette di acquisire nuove conoscenze. Di più: partendo da questa distinzione, Kant si chiedeva se fosse possibile trovare dei giudizi che fossero allo stesso tempo universali, necessari e sintetici. Secondo Kant, i giudizi della matematica e della geometria (si ricordi il famoso esempio 7+5=12) incarnano la struttura dei giudizi sintetici a priori, poiché permettono di conoscere un contenuto nuovo senza però dover rinunciare alla necessità e all’universalità. La critica che Maddalena rivolge a Kant è che i giudizi sintetici a priori, per come vengono intesi e esposti da Kant, hanno caratteristiche di universalità e necessità ristrette. Si applicano cioè solamente ad un certo tipo di spazio e di tempo. In breve, “la sintesi a priori kantiana si appoggia su uno schema tutto-parte che è identico a quello dell’analitica…La sintesi dunque funziona, cioè mantiene universalità e necessità, perché è analitica” (p. 26).
Oltre a Kant, vi è poi un altro obiettivo polemico di cui occorre fare menzione per comprendere il quadro teorico entro cui si colloca la filosofia del gesto. Dopo un breve storia della gestualità volta a scardinare l’idea antica e moderna che i gesti costituiscano un linguaggio primordiale e incoativo, Maddalena si confronta con i gesture studies e quindi con la classificazione dei gesti di Adam Kendon. Secondo Kendon, i gesti si suddividono in 1) gesticolazione, 2) gesti language-like, 3) pantomine, 4) emblemi, 5) lingue segnate.
Maddalena riconosce il contributo di autori come Kendon e Austin nell’averci insegnato che si possono fare cose con le parole, ma intende, attraverso gli strumenti concettuali della teoria segnica di Peirce, mostrare la necessità di allargare questo paradigma di ragionamento, assumendo un diverso approccio per trattare la complessità delle pratiche gestuali: “i problemi classici dello studio dei gesti, i tipi vecchi e nuovi di parallelismo e continuismo, possono in questo modo essere compresi senza creare alternative: la gesticolazione è un modo di conoscere ma l’aspetto simbolico-linguistico riveste una parte fondamentale affinché tali gesti giungano a una completezza” (p. 94).
È vero che in questo testo le sottili analisi della semiotica di Peirce sono maggiormente lasciate sullo sfondo rispetto al precedente Philosophy of Gesture; è altrettanto vero che sarebbe impossibile prescindere dal progetto peirciano per comprendere la struttura di questo testo. Uno dei meriti di questo testo sta proprio nel vedere la teoria del segno di Peirce come un punto di rottura con la filosofia kantiana e in particolare, con la distinzione tra fenomeno e noumeno, così come tra sintetico e analitico.
Per descrivere al meglio in cosa consista questo nuovo paradigma di ragionamento, Maddalena, in contrasto con Kant, ci invita a guardare la sintesi non come “il rovesciamento dell’analisi ma come un processo originale per cui conosciamo mentre facciamo e mentre comunichiamo” (p. 9).
Il ragionamento, sostiene Maddalena, non è bipartito ma tripartito e pendolare e comprende l’ambito analitico, quello sintetico e, infine, quello vago. Sintetico è il ragionamento che riconosce l’identità nel cambiamento mentre invece quello analitico è il ragionamento che la perde. Il giudizio vago rappresenta la transizione tra l’analitico e il sintetico, il confine liminare tra il riconoscimento e la perdita dell’identità nel cambiamento. Delinea dunque una zona del ragionamento ancora inarticolata. La nozione di identità in mutamento è fondamentale per comprendere la critica che Maddalena rivolge alle filosofie della coscienza così come per strutturare questo nuovo paradigma gestuale. In ambito matematico, il termine mutamento si traduce con “continuo” ed è per questo motivo che i punti da tenere fermi per capire l’urgenza di ragionamento sintetico gestuale sono l’identità e il continuo.
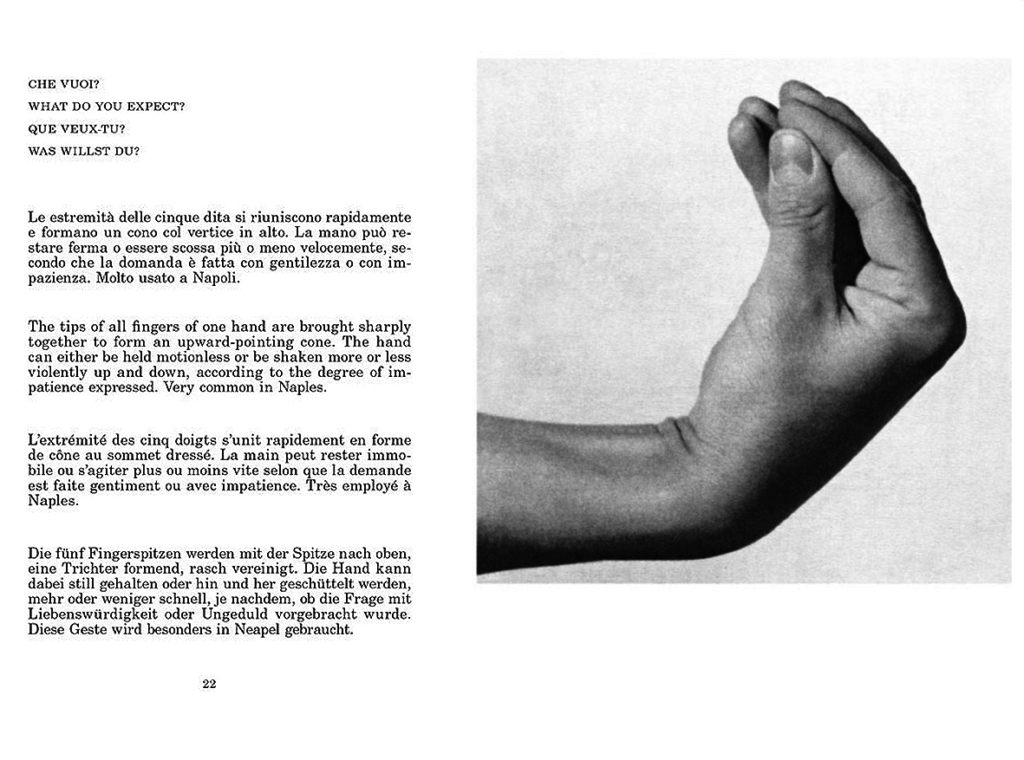
Entrando nel vivo della strutturazione del gesto, Maddalena ne distingue due aspetti, uno semiotico e uno fenomenologico: più nello specifico, per quanto riguarda il versante semiotico, il gesto, secondo la celebre tripartizione peirciana, si compone di icona, indice e simbolo. Iconico è quel segno che rappresenta il proprio oggetto per similarità, indicale quello che lo rappresenta per connessione diretta mentre simbolico è quel segno che richiede una mediazione interpretativa per poter rappresentare il suo oggetto. Sul versante fenomenologico (o, come direbbe Peirce, faneroscopico), il gesto si articola in firtsness, secondness e thirdness. Queste tre categorie traducono sul piano fenomenologico i tre modi del segno prima accennati “ma ne sottolineano la trasmissione del significato” (p. 39). La dimensione fenomenologica permette di intendere simultaneamente le modalità del segno e la pratica comunicativa che le istanzia.
Un gesto è completo quando produce una sintesi, cioè quando operano in completa sintonia sia gli aspetti semiotici che quelli fenomenologici, permettendo di acquisire un nuovo significato. Un gesto è invece incompleto quando non vi è una piena collaborazione di questi aspetti e dunque non è possibile produrre una sintesi completa. Ovviamente, precisa Maddalena, seppure incompleti, tali gesti non sono però inutili; anzi, “coincidono con gran parte delle nostre azioni ed hanno una funzione” (p. 37).
A questa gran parte delle nostre azioni occorre accennare, facendo così emergere la trattazione applicativa di questo nuovo paradigma di ragionamento, fondato sulla struttura semiotico-fenomenologica dei gesti completi e incompleti. Anche se il focus del testo è rivolto alla distinzione tra analitico e sintetico e alla sua riformulazione, non bisogna dimenticare la terza partizione del ragionamento, ossia la vaghezza. Il ragionamento vago è infatti un costituente irriducibile del gesto poiché rappresenta il punto di partenza di ogni azione e dunque di ogni pratica gestuale. La dimensione vaga mette in luce l’orienza del significato, la potenziale qualità differenziantesi che, in the long run, condurrà alla costituzione di una generalità significante. Certo la conoscenza umana è fallibile, sempre in difetto e correggibile: in breve, in cammino. Quello che però non bisogna omettere da questo racconto è che il nostro rapporto quotidiano con il mondo è costantemente regolato da un groviglio di certezze, di abiti cristallizzati e di pratiche per lo più non tematizzate che ci permettono un incontro gestuale e corporeo con esso. Uno dei contribuiti a mio parere più interessanti di questo testo sta nel riconoscere che “il nostro modo di affrontare, conoscere e comunicare la realtà è innanzi tutto vago” (p. 47). L’origine del significato è vaga poiché è praticamente certa, o meglio, stabilizzata da una parte della conoscenza che “ha a che fare il corpo, con l’esistenza, con l’azione” (p. 7).
In questo senso occorre considerare le riflessioni di Maddalena sul lavoro, inteso come “modo quotidiano di ragionare sinteticamente” (p. 81), capace di offrire una comprensione della propria identità e di quella altrui grazie alla prospettiva simbolica che accompagna lo sforzo del lavoro. Oppure l’analisi che l’autore rivolge al mondo della tecnologia e del digitale, vedendo la tecnologia come il motore del pensiero e gli strumenti tecnologici come prolungamenti macchinici dei nostri gesti.
In conclusione, concluderei questa recensione con una citazione di Nietzsche, tratta dallo Zarathustra e dedicata ironicamente ai dispregiatori del corpo, che ben sintetizza l’impianto e la tonalità pragmatista di questo libro: “V’ha maggior ragione nel tuo corpo, che non ne contenga la tua miglior sapienza. E chi sa mai perché il tuo corpo ha proprio bisogno della tua miglior sapienza?”.
di Rocco Monti
-
I diari segreti di Wittgenstein
Recensioni / Marzo 2021A distanza di oltre trent’anni dalla prima traduzione italiana per Laterza, Meltemi ripubblica i Diari segreti di Ludwig Wittgenstein, formidabile documento di un’epoca, di una temperie culturale, di una vita. Scritte durante la Prima guerra mondiale, mentre il filosofo era impegnato come volontario al fronte, le annotazioni qui pubblicate costituiscono una parte degli appunti presi da Wittgenstein nel periodo 1914-1916. Ma, come suggerisce il titolo, questi diari hanno la particolarità di essere scritti in codice: «dividendo la sequenza alfabetica a metà, Wittgenstein sostituiva simmetricamente le lettere, vale a dire al posto della “a” (prima lettera) scriveva la “z” (ultima), al posto della “b” la “w” ecc., e viceversa» (p. 160). Appunti criptati, dunque, il cui contenuto si rivela da subito molto personale: sfoghi sulle condizioni di vita in guerra, considerazioni sui commilitoni («le persone con cui sto, più che volgari, sono incredibilmente limitate!», 8.5.’16), resoconti sull’avanzamento della riflessione filosofica (indicata da Wittgenstein semplicemente come «il lavoro»), ma anche preghiere («Oggi dormo sotto il fuoco della fanteria, e probabilmente perirò. Dio sia con me! Per sempre. Amen», 16.5.’16), meditazioni sul senso della vita, unitamente a più prosaiche descrizioni delle pratiche igieniche e delle abitudini sessuali del filosofo. La condizione materiale del linguaggio cifrato e la qualità dei contenuti convinsero Elisabeth Anscombe e George H. von Wright, esecutori letterari di Wittgenstein, a non includere queste annotazioni nell’edizione dei Quaderni 1914-1916, i cui appunti provengono dagli stessi taccuini ma sono scritti in chiaro. Come scrive nella prefazione Luigi Perissinotto, la mancata inclusione di questi materiali nell’edizione dei Quaderni costituisce un importante capitolo della ricezione del pensiero di Wittgenstein e risponde a precise scelte di ordine interpretativo: secondo Anscombe evidentemente la biografia doveva essere tenuta ben distinta dal pensiero filosofico, evitando commistioni mosse da indebiti pruriti voyeuristici.
Quello che Anscombe sembra qui suggerire è che solo una malsana e ben poco filosofia curiosità poteva giustificare la pubblicazione di annotazioni che lo stesso Wittgenstein aveva inteso proteggere con un codice, lasciandoci così intendere che esse non dovessero essere divulgate. Non è facile, tuttavia, condividere questo atteggiamento. Innanzitutto, perché esso si basa sull’assunto, tutt’altro che scontato, che nel lascito di un filosofo il materiale privato (il personale) sia sempre facilmente distinguibile dal pubblico (dal filosofico). Forse questo vale per alcuni filosofi o tipi di filosofi, ma non è affatto certo che valga anche per Wittgenstein o per quel tipo di filosofo che egli era o aspirava a essere (p. 14).
Perissinotto argomenta in maniera convincente a favore della ‘filosoficità’ degli appunti personali di Wittgenstein, nell’ottica di una confluenza tra vita e pensiero che tende all’indiscernibilità dei due poli. Sono due in particolare le circostanze riportate nei Diari segreti che vengono indicate come particolarmente significative sul piano teoretico: la lettura di Nietzsche, e più precisamente dell’ottavo volume dell’opere (quello contenente l’Anticristo), e la ‘svolta’ del luglio 1916, in cui Wittgenstein prospetta una connessione tra le sue ricerche sulla logica e la tematica etica, che diventerà preponderante nelle proposizioni conclusive del Tractatus logico-philosophicus.
Partiamo da quest’ultimo punto. Il 6 luglio 1916 Wittgenstein annota in una pagina di quelli che diventeranno i Diari segreti: «Nell’ultimo mese ho avuto colossali strapazzi. Ho riflettuto a lungo su ogni cosa possibile, però stranamente non riesco a stabilire una connessione con i miei ragionamenti matematici». Il giorno dopo però aggiunge: «Ma la connessione verrà stabilita! Ciò che non può dirsi, non può dirsi”». Senza trascurare l’evidente assonanza tra questa ultima esclamazione e la prop. 7 del Tractatus, è interessante qui accostare la pagina criptata alla pagina in chiaro, quella pubblicata nei Quaderni 1914-1916. Già l’annotazione dell’11 giugno introduceva riflessioni su Dio e sul fine della vita apparentemente estranee all’indagine filosofica fino ad allora condotta da Wittgenstein. Gli appunti del 5 luglio e dei giorni immediatamente successivi testimoniano un approfondimento di questo genere di riflessioni, che potrebbero sembrare osservazioni vibranti ma estemporanee o in ogni caso non connesse in maniera organica al resto delle riflessioni, di ordine logico-matematico. La pagina dei Diari segreti in questo caso chiarisce come lo stesso autore considerasse i due versanti del suo pensiero destinati a connettersi. Difficile negare dunque il valore filosofico di un appunto che, sebbene criptato (e dunque, secondo i curatori dei Quaderni, strettamente personale), risulta della massima importanza sul piano interpretativo.
L’altra circostanza cui si faceva riferimento, la lettura di Nietzsche condotta da Wittgenstein al fronte, risulta ancora più evidente e dimostra non soltanto l’interesse filosofico dei Diari, ma anche la già menzionata indiscernibilità tra vita e pensiero. Durante la sua esperienza come volontario, Wittgenstein legge alcuni autori che si riveleranno particolarmente significativi per il suo lavoro. Nei Diari vengono citati Tolstoj, Emerson e, appunto, Nietzsche:
Nella mattina ho marcato visita a causa del piede: distorsione muscolare. Non ho lavorato molto. Ho comprato l’ottavo tomo di Nietzsche e ne ho letto una parte. Sono rimasto fortemente colpito dalla sua avversità al cristianesimo. Perché anche nei suoi scritti è contenuto qualcosa di vero. Certamente il cristianesimo è l’unica via sicura per la felicità. Ma che succede se si rifiuta quel tipo di felicità?! Non sarebbe meglio andare tristemente alla deriva nella lotta senza speranza contro il mondo esterno? Ma una vita del genere è priva di senso. E perché non condurre una vita senza senso? È indegno? Come si accorda questo con il punto di vista rigorosamente solipsistico? Ma cosa devo fare affinché la mia vita non vada sprecata? Devo sempre essere cosciente dello spirito – esserne sempre cosciente – (8.12.’14).
Un filosofo che legge un altro filosofo è una circostanza evidentemente non solo biografica, così come sostiene Perissinotto. Ma un antifilosofo che legge un altro antifilosofo è un evento in cui teoria e vita tendono a coincidere. È questo il punto di partenza dell’interpretazione di Wittgenstein proposta da Alain Badiou, che inserisce l’autore del Tractatus nell’album di famiglia degli antifilosofi, accostandolo in questo modo proprio a Nietzsche e citando esplicitamente la lettura dell’Anticristo condotta da Wittgenstein al fronte. Scrive Badiou, dopo aver ricordato l’appunto wittgensteiniano citato poc’anzi:
La nostra prima domanda sarà: qual è questa “parte di verità” che Wittgenstein riconosce nelle imprecazioni di Dioniso contro il Crocifisso? E la seconda: che cosa può mai essere il cristianesimo di Wittgenstein se, a dispetto di questa “parte”, egli viene profondamente ferito dalla legislazione anticlericale del pazzo di Torino? Domande decisive, se si considera che Nietzsche e Wittgenstein in questo secolo, l’uno dopo l’altro, hanno dato il la a una certa forma di disprezzo filosofico per la filosofia (Badiou 2018, p. 17).
Il nome di questo disprezzo filosofico per la filosofia è, secondo Badiou, antifilosofia; le tre caratteristiche principali di quest’ultima sono rintracciabili, secondo il filosofo francese, tanto in Nietzsche quanto in Wittgenstein: «Una critica linguistica, logica, genealogica, degli enunciati della filosofia […]. Riconoscimento della non riducibilità della filosofia, in ultima istanza, alla sua apparenza discorsiva, alle sue proposizioni, alla sua fallace esteriorità teorica. […] L’appello fatto, contro l’atto filosofico, a un altro atto radicalmente nuovo che verrà detto sia, in modo equivoco, filosofico […] sia, più onestamente, sopra-filosofico e perfino a-filosofico» (Badiou 2018, pp. 18-19). Nel compimento di questo atto che, secondo Badiou, nel caso di Wittgenstein consiste nell’accesso a una «vita santa», si consuma quella perfetta saldatura tra biografia e teoresi che rende la distinzione tra le due inservibile. Di nuovo, sottolinea Badiou, questa saldatura paradossalmente viene suggerita a Wittgenstein da Nietzsche: «il cristianesimo designa la vita ordinata al suo senso indicibile, la vita “bella”, che è la stessa cosa della vita santa. Esso è sinonimo di felicità. Wittgenstein lo scriveva già nel suo diario, a proposito di Nietzsche. Poiché continuava: “Il cristianesimo è l’unica via sicura per la felicità”» (Badiou 2018, p. 24).
Sulla scorta dell’interpretazione di Badiou, e riprendendo le parole di Perissinotto, appare chiaro come la comprensione di quel tipo di filosofo (un antifilosofo?) che Wittgenstein era, o avrebbe voluto essere, non solo non può prescindere dal materiale biografico a nostra disposizione ma, più radicalmente, deve tenere in conto il proposito del pensatore in questione: quello di superare la dimensione esclusivamente teorica della filosofia, in vista della produzione di un atto che coinvolga l’esistenza e la trasformi in una vita santa, vale a dire felice e compiuta. In quest’ottica, la ripubblicazione dei Diari segreti risponde a un bisogno degli studiosi del pensiero (e della vita) di Wittgenstein, un bisogno che non può essere di certo derubricato a mera curiosità. E forse su questo, possiamo aggiungere, lo stesso filosofo che scriveva «sì, il mio lavoro s’è esteso dal fondamento della logica all’essenza del mondo» (Wittgenstein 1964, p. 181) sarebbe stato d’accordo.
di Stefano Oliva
.
.
Bibliografia
A. Badiou, L’antifilosofia di Wittgenstein, traduzione postfazione di S. Oliva, Mimesis, Milano-Udine 2018.
L. Wittgenstein, Quaderni 1914-1916, in Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-1916, Einaudi, Torino 1964.
-
Che la teoria sia sede di conflitti, anche aspri, esiziali e ultimativi, tanto da trascinare con sé e pregiudicare in profondità l’obiettività (presunta) dei contendenti, è cosa nota da almeno duecento anni a questa parte (da Hegel in poi). Che il sapere, allo stesso modo, configuri un’occasione per la riproduzione di sistemi di dominio di varia natura, facendosi spesso occasione di esclusione, marginalizzazione e oppressione, anche questo è diventato ormai un truismo della teoria critica contemporanea, informata come è, persino quando non lo dichiara apertamente, da marxismo, freudismo e nietzschianesimo (i quali hanno fatto nello scorso secolo il loro lavoro di decisiva persuasione). Che questa consapevolezza diffusa e diversamente articolata vada poi trasformata in una pratica pedagogica alternativa, incentrata sulla funzione guaritrice della teoria, è invece cosa ben meno scontata e largamente disattesa, nei fatti, da coloro che coltivano e insegnano discipline teoriche in ambito umanistico. Ora, è di questa esigenza, elevata a principio euristico cardinale, che si fa portatore Insegnare a trasgredire. L’educazione come pratica della libertà di bell hooks, recentemente pubblicato in italiano da Meltemi (2020, 18 euro). Il volume, tradotto da feminoska, nota attivista transfemminista nostrana, prefato da Rahel Sereke e Mackda Ghebremariam Tesfaù, anche loro attiviste della blackness italiana, e seguito da un breve intervento del Gruppo Ippolita, che dirige la collana di Culture radicali in cui è apparso, si segnala innanzitutto per il tono, caratteristico della scrittura saggistica dell’autrice, lontano anni luce dagli stilemi e dai tic della ricerca accademica standard. Al secolo Gloria Jean Watkins, l’autrice, femminista africano-americana, è infatti la rappresentante forse più esemplare di un orientamento della ricerca contemporanea che incentra la propria operatività sull’«enfasi sulla voce» (p. 183) personale e che concepisce, di conseguenza, la «teoria come pratica sociale dal valore libertario» (p. 99). Partendo dalla constatazione di una discrasia fondamentale tra pratica e teoria che affligge il pensiero occidentale, riflessa oggigiorno nell’introduzione nei programmi educativi di argomenti progressisti a cui non fa seguito tuttavia un adeguato mutamento del processo pedagogico, bell hooks discute infatti in maniera dettagliata il modo in cui ogni soggetto, e anzi, meglio: ogni corpo, è sempre implicato in un vissuto che lo colloca necessariamente da una certa parte della barricata, con buona pace di quell’universalità del sapere che è spesso null’altro che il nome attribuito al posizionamento dell’uomo bianco occidentale eterosessuale.
Il libro è articolato in saggi, i quali procedono in maniera concentrica intorno a uno stesso perno: dare spazio, letteralmente e metaforicamente, a coloro che un certo regime di verità – quello, appunto, dei saperi accademici – ha espulso con certosina meticolosità dal novero dei soggetti autorizzati a far risuonare la propria esperienza, i soggetti supposti non sapere. Il piano autobiografico diventa così terreno di verifica sperimentale della proposta di bell hooks, fondata come è sulla rivendicazione di un «accesso significativo alla verità» (p. 61) per tutti/e coloro ai quali e alle quali esso è stato in qualche modo negato. Il racconto della propria formazione prima nelle scuole nere degli anni Sessanta, dove «l’apprendimento e la vita della mente» erano «un atto contro-egemonico, un gesto fondamentale di resistenza alle strategie di colonizzazione razzista bianca» (p. 32), poi nelle scuole desegregate, dove al contrario «improvvisamente, la conoscenza riguardava solo l’informazione» (p. 33), così come la sua esperienza diretta di insegnante, dapprima nelle università private e poi in quelle statali, diventa perciò il filo conduttore di un’inchiesta sulla necessità di abbandonare la concezione «depositaria dell’educazione» in favore di una pratica dell’istruzione in cui «la volontà di sapere» va sempre a braccetto con «la volontà di diventare» (p. 51). Di diventare che cosa? La risposta è netta: capaci di vivere più intensamente la propria esistenza perché, infine, più liberi/e. Il nome di questa pratica, «pedagogia impegnata», va allora inteso nel suo duplice senso: impegnata nei temi e nelle forme, sul piano dell’enunciato ma anche, ancora più significativamente, sul piano dell’enunciazione, dell’insieme dei presupposti pragmatici grazie ai quali parlare non è mai un atto neutro, un semplice comunicare contenuti cognitivi resecati dal resto della vita delle persone, ma sempre anche un atteggiarsi concretamente rispetto alle costellazioni di poteri che informano ogni società. La «narrativa confessionale» e la «discussione digressiva» diventano allora, nel concreto della scrittura come dell’insegnamento, lo strumento principale di tematizzazione della propria condizione, ciò mediante cui «rivendicare una forma di conoscenza» (p. 183) di cui tutti e tutte, studenti e studentesse compresi, possono parlare, sentendosi autorizzati a farlo. D’altronde, ne va di una messa in mora della stessa logica dicotomica che organizza le nostre società, in cui sembra si debba sempre sacrificare qualcosa per accedere al potere che le diverse istituzioni (educative, economiche, politiche ecc.) consentono di beneficiare a chi ne fa parte: «questo processo [l’essere partecipanti attivi nel percorso pedagogico] non è semplice: ci vuole coraggio per abbracciare una visione di completezza dell’essere che non rafforza la narrazione capitalista che suggerisce, invece, che sia sempre necessario rinunciare a qualcosa per ottenerne un’altra» (p. 217).

bell hooks Ecco allora che uno dei meriti di bell hooks consiste nella capacità di mettere sistematicamente in tensione due aspetti, la razza e il genere, i quali si intersecano spesso, anche all’interno degli ambienti femministi, secondo geometrie tutt’altro che invariabili. Come racconta ampiamente la studiosa, questa linea di frattura interna al campo femminista ha determinato in passato una esclusione programmatica dell’esperienza femminile nera, che, con le sue peculiarità, di razza e di classe, non risponde al tipo della femminista bianca, spesso proveniente da contesti economici e culturali privilegiati. «Eravamo prima donne o nere?» (p. 158), si chiede allora sintomaticamente bell hooks, dando un contributo imprescindibile anche alla «decostruzione della donna come categoria analitica», alla critica dell’«esperienza della donna universalizzata» (p. 124). Il suo invito è dunque a parlare di genere in modo più complesso, tenendo conto della doppia emarginazione, da parte delle femministe bianche e del patriarcato nero, di cui sono state vittime le donne nere (e di colore in generale) nel momento in cui hanno, anche a livello accademico, rivendicato il proprio punto di vista. Scritto in una forma quasi diaristica, Insegnare a trasgredire conduce perciò il lettore in una sorta di progressiva coscientizzazione – termine che la scrittrice riprende dalla pedagogia libertaria di Paulo Freire, vero e proprio punto di riferimento della sua riflessione – concernente il proprio posizionamento nei riguardi del sapere, costringendo chi scrive a chiedersi in che misura possa essere titolato a esprimersi su un libro simile, senza arrogarsi al contempo un diritto di parola che non muove, almeno di primo acchito, da un’esperienza in prima persona analoga a quella evocata dall’Autrice.
Il percorso, pacato e graduale, verso l’acquisizione di un’evidenza che, nel suo carattere meta-teorico, sembra sospendere la vigenza delle prerogative e dei privilegi del discorso universitario, richiede dunque di essere attentamente valutato e meditato, a scanso degli equivoci che potrebbe in prima istanza ingenerare. Nella misura in cui enuncia che ogni teoria risponde sempre anche a un’esigenza singolare, calata nel vivo di un’esistenza materiata, e che non c’è punto di vista universale che non sia comunque anche particolare – che il soggetto del sapere, in altre parole, è sempre un soggetto orientato, incapace di ergersi una volta per tutte al di là di se stesso, per valutare in modo neutrale il punto di vista dell’altro – sembrerebbe, banalmente, autorizzare una forma di relativismo generale sub specie subalternitatis. Al rischio di auto-confutazione che una simile enunciazione comporta, in quanto essa stessa teorica, l’Autrice oppone però un punto fermo invalicabile, che sembra riecheggiare, senza citarlo (almeno in queste pagine), il celebre motto foucaltiano sul sapere – il quale non sarebbe fatto per comprendere, ma per prendere posizione. Con un fondamentale distinguo, però, che anche il “comprendere” – pratica pedagogica se mai ce n’è stata una – è una delle forme del prendere posizione e, per certi versi, la forma per eccellenza con cui ci si atteggia praticamente nel reale, per modificarlo, modificando la propria stessa esistenza (aspetto sul quale, ipotizziamo, il Foucault più tardo, quello dell’estetica dell’esistenza, avrebbe convenuto). Contro quindi chi ritiene che l’alternativa tra pratica e teoria sia inaggirabile, come quella tra verità ed esperienza, e che si tratti, riprendendo la tesi marxiana, di interpretare o di trasformare il mondo, disgiuntivamente, la teoria è presentata da bell hooks come un «luogo di guarigione» (p. 95) a tutti gli effetti: come, in breve, «forma di azione» (p. 99), innanzitutto su se stessi e poi, inevitabilmente, anche sul circostante. Solo un teorico privilegiato, rappresentante del patriarcato capitalista e colonialista bianco, può credere infatti che la teoria sia senza effetti immediati e che vada dunque coltivata a riparo da perturbazioni pragmatiche ed esperienziali d’ogni sorta, con l’esclusione, naturalmente, di quelle che contribuiscono inavvertite alla riproduzione del sistema di dominio vigente. «Penso che uno dei disagi inespressi relativi al modo in cui il discorso su razza e genere, classe e pratica sessuale ha portato scompiglio nell’accademia è proprio la sfida a quella divisione tra mente e corpo. Chi è potente ha il privilegio di negare il proprio corpo» (p. 172). Senza nulla togliere, perciò, al valore più-che-personale del sapere (al suo portato, appunto, in senso proprio scientifico: vale a dire, intersoggettivo e transculturale), dato anzi esattamente dal suo sprofondare nelle proprie condizioni ‘carnali’ di possibilità, bell hooks ci invita a tenere sempre conto della situazionalità in cui ogni atto teorico è fattivamente inserito, senza far finta che se ne possa fare tranquillamente a meno, come si trattasse di scorie da eliminare il prima possibile, perché per il resto non fanno che inquinare (inquietare) la trasparenza cristallina della ragione. La ragione militante – e ogni ragione in un certo senso lo è, anche senza saperlo – è tanto più lucida quanto più si fonda consapevolmente sulle proprie radici auto-biografiche, quanto più espone, nel corpo della sua articolazione logico-concettuale, i segni dell’oppressione che tenta proprio per ciò di scardinare, facendoli diventare il punto di partenza di una vera e propria «comunità di apprendimento». È qui che, credo, anche l’esperienza di un o una non marginalizzato/a, almeno a prima vista, può trovare non solo di che imparare, il che è ovvio e auspicabile, ma anche di che entrare in risonanza, per reperirsi sul limite della propria esperienza di soggetto di sapere che è spesso, nondimeno, soggetto alsapere altrui. Se ci si incunea negli interstizi della propria esistenza in cui si è sperimentato (e chi, in qualche modo, non l’ha fatto?) una qualche forma di esclusione dettata dalla propria appartenenza, anche temporanea, a una categoria non egemonica, la necessità di partire dal sé, per raggiungere il prossimo, diventa inaggirabile. Come discenti, d’altro canto, abbiamo tutti attraversato quella situazione specifica in cui il sapere sembra provenire immancabilmente dall’Alt(r)o, da una fonte esterna sulla quale non si ha il minimo controllo e dalla quale, in ultima istanza, ci si sente sempre giudicati/e. È come operatori di conoscenza che, in primis, si è costretti a riconoscere che il sapere non è un’operazione priva di attriti concreti, a cui ciascuno/a accede sempre da una posizione di relativa marginalizzazione e la cui costruzione avviene però davvero soltanto nello spazio tra le persone, tra i corpi, tra le esperienze, anche le più negative.

Kara Walker L’evidenza al cospetto della quale ci conduce hooks è dunque la seguente: non c’è teoria in ambito umanistico che non si radichi in un vissuto singolare, senza con ciò erodere tutta la sua eventuale portata veritativa; non c’è concetto che non abbia la sua scaturigine in un affetto situato, che non sia enunciato dalla bocca o esca dalla penna di una persona in carne e ossa, promanando così da un io concreto, incistandosi sempre in una materia viva, senziente, desiderante e, quando è il caso, persino dolente, senza per questo diventare l’incarnazione di una prospettiva solamente idiosincratica, privata, collettivamente inaccessibile. Anzi, è il dolore – quel dolore che un ‘malato’ come Ottiero Ottieri definiva «il problema filosofico più serio» – a essere l’elemento che articola il pensiero all’esistenza, che congiunge il logos al pathos e viceversa: che lega insomma la Ragione, con la maiuscola a capolettera, al corpo (alle ragioni, al plurale, dei corpi), rendendola appunto frequentabile anche dal prossimo e al suo bagaglio di esperienze singolarizzate. Rendendola vera, in un senso al contempo epistemico ed etico. Ecco la consapevolezza di cui una pratica del sapere informata a criteri di unilaterale ‘scientificità’ vorrebbe fare piazza pulita, in quanto ritenuta incompatibile con il ‘rigore’ altrimenti esigito dalla teoria, e della quale sono innanzitutto i cosiddetti “subalterni” a essere i depositari. È nei comportamenti degli ‘anormali’, per usare una categoria di vaga eco foucaultiana, che fa capolino, in modo senz’altro urticante ma indiscutibile, l’implicatura necessaria che ogni atteggiamento epistemico intrattiene con quanto, faute de mieux, si può chiamare la prospettiva in prima persona. Sono loro i tenutari del sapere di secondo livello, e invero di ultimo livello, concernente il radicamento storico e carnale del sapere, l’unico in grado di estrapolarsi dalle proprie condizioni di emersione e di additare se stesso, restando vero. Come scrive bell hooks: «Sono giunta alla teoria attraverso la sofferenza: il dolore dentro di me era così intenso che non potevo più sopportarlo. Sono arrivata alla teoria disperata, bisognosa di comprendere – comprendere cosa stesse accadendo intorno a me e nel mio intimo. Più di ogni altra cosa, desideravo che il dolore sparisse. La teoria ha rappresentato per me un luogo di guarigione» (p. 93). Esiste insomma un sapere, minoritario per definizione, che concerne la centralità inaggirabile del dolore, un sapere che riguarda la necessaria implicatura (uso un termine della pragmatica non a caso) soggettiva della conoscenza, quale che sia la sua forma, per quanto possa essa presentarsi in una veste intenzionalmente avalutativa, neutrale: in una parola, “scientifica”. E questo per un motivo molto semplice: donne, soggetti razzializzati, persone neuro-atipiche, trasgressori della norma eterosessuale, sfruttati d’ogni tipo, malati in generale, coloro che, in un modo o nell’altro, sono considerati innanzitutto come oggetti, prima ancora che come soggetti, e il cui corpo o comportamento non sono mai del tutto invisibili, non possono mai, in forza di quello che subiscono, prescindere dalla loro situazione concreta, segnata invariabilmente da un certo coefficiente di sofferenza. L’invisibilità – come il silenzio degli organi per la salute – è infatti un privilegio dei ‘normali’: l’incorporeo è il prodotto di un modo di esistenza che non conosce (troppi) limiti. «La cancellazione del corpo incoraggia a pensare che stiamo ascoltando fatti neutrali e oggettivi, fatti che non sono legati a chi condivide le informazioni. Siamo invitati a insegnare come se le nozioni non emergessero dai nostri corpi. È significativo che quelli di noi che cercano di criticare i pregiudizi in classe sono stati costretti a tornare al corpo per parlare di noi stessi come soggetti nella storia. Siamo tutti soggetti nella storia. Dobbiamo tornare allo stato di esseri incarnati per decostruire il modo in cui il potere viene tradizionalmente utilizzato in classe, negando la soggettività ad alcuni gruppi ed accordandola ad altri. Riconoscendo la soggettività e i limiti dell’identità, interrompiamo quell’oggettivazione che è così necessaria in una cultura del dominio» (p. 174).
All’alternativa secca di verità ed esperienza, e alla «svalutazione paternalistica» (p. 122) della seconda, bisogna opporre dunque, seguendo bell hooks, la consapevolezza che la verità ultima dell’esperienza (personale) consiste in un'esperienza (interminata e collettiva) di verità: in un apprendimento «senza limiti» (p. 235) in cui pratica e teoria convergono senza mai arrivare a suturarsi definitivamente l’una all’altra, restando aperte a nuovi contributi, sempre. In cui il limite – incontrato ed esperito proprio malgrado – gioca insomma la funzione di ostacolo e di rilancio, al contempo: «anche desiderare è un modo di conoscere» (p. 126). Non si tratta quindi di cedere a forme autoconsolatorie di whisful thinking, ma, si potrebbe dire, di rintracciare nel desiderio stesso una forma di sapere imperniata sulla sua capacità di eccedersi di continuo, nel confronto con la diversità e la difficoltà. Di superare insomma ogni status quo, anche epistemologico, in vista della sua riformulazione condivisa, grazie al pungolo del dolore, di cui una teoria estranea alla vita vorrebbe rimuovere toto cælo la presenza, rinchiudendo ciascuno e ciascuna in se stesso/a, e del quale invece una pratica libertaria dell’educazione non può non tenere conto, per farne il proprio atout fondamentale, risolvendolo nell’esperienza comune dell’imparare. Qui habet aures audiendi, audiat…
di Daniele Poccia
-
Alenka Zupančič – Che cosa è il sesso?
Recensioni / Maggio 2019 Che cosa è il Sesso? (trad. di P. Bianchi, Ponte alle Grazie, Genova 2018), ultima opera della filosofa slovena Alenka Zupančič, già autrice di lavori su Kant, Nietzche e Lacan, è un testo che raccoglie anni di riflessione sulla psicoanalisi freudo-lacaniana e che si pone la sfida di affrontare la sessualità come una questione intimamente ontologica. Lo scopo di Zupančič non è però quello di “recuperare” la psicoanalisi di Freud e Lacan e dare a essa uno statuto ontologico che nobiliti la disciplina psicoanalitica (che sicuramente ha sempre subito accuse di pseudoscientificità e determinismo sessuale). Quello di Zupančič non è neanche (o non solo) un tentativo di rispondere alle domande della filosofia con la psicoanalisi né una sua difesa acritica; anzi, la posizione della filosofa slovena è conflittuale anche internamente al discorso psicoanalitico, portando al centro una delle questioni che sono state problematiche sin dagli esordi freudiani – appunto, la sessualità. Il sesso di cui ci parla Zupančič non è semplicemente l’insieme di pratiche sessuali, a cui fornire uno statuto ontologico maneggevole che ci risollevi immaginariamente dagli imbarazzi e angosce che questa dimensione ha scatenato nel tempo; piuttosto la filosofa vuole andare a svelare quanto il sesso sia proprio quella faglia o mancanza strutturale che permette al soggetto di diventare tale. Il sesso protagonista di questo libro non è una presunta naturalità che dovremmo accettare, ma è esattamente quella dimensione “disontologica” e “disorientante” che fa che sì che emerga un soggetto e, quindi, un inconscio.
Che cosa è il Sesso? (trad. di P. Bianchi, Ponte alle Grazie, Genova 2018), ultima opera della filosofa slovena Alenka Zupančič, già autrice di lavori su Kant, Nietzche e Lacan, è un testo che raccoglie anni di riflessione sulla psicoanalisi freudo-lacaniana e che si pone la sfida di affrontare la sessualità come una questione intimamente ontologica. Lo scopo di Zupančič non è però quello di “recuperare” la psicoanalisi di Freud e Lacan e dare a essa uno statuto ontologico che nobiliti la disciplina psicoanalitica (che sicuramente ha sempre subito accuse di pseudoscientificità e determinismo sessuale). Quello di Zupančič non è neanche (o non solo) un tentativo di rispondere alle domande della filosofia con la psicoanalisi né una sua difesa acritica; anzi, la posizione della filosofa slovena è conflittuale anche internamente al discorso psicoanalitico, portando al centro una delle questioni che sono state problematiche sin dagli esordi freudiani – appunto, la sessualità. Il sesso di cui ci parla Zupančič non è semplicemente l’insieme di pratiche sessuali, a cui fornire uno statuto ontologico maneggevole che ci risollevi immaginariamente dagli imbarazzi e angosce che questa dimensione ha scatenato nel tempo; piuttosto la filosofa vuole andare a svelare quanto il sesso sia proprio quella faglia o mancanza strutturale che permette al soggetto di diventare tale. Il sesso protagonista di questo libro non è una presunta naturalità che dovremmo accettare, ma è esattamente quella dimensione “disontologica” e “disorientante” che fa che sì che emerga un soggetto e, quindi, un inconscio.
Santa Lucia di Domenico Beccafumi, utilizzato dall’autrice nel testo per mostrare la perversione della pulsione nel cristianesimo
Non è un caso, infatti – e Zupančič lo sottolinea continuamente nel testo – che Freud abbia sempre così insistito sulla centralità del Sesso nella psicoanalisi e che i suoi primi allievi, come Jung e Adler, abbiano sempre e sistematicamente reagito su questo punto. Ancora oggi la questione della sessualità rimane problematica e fa spesso da confine fra le varie correnti psicoanalitiche. André Green, nel 1995, pone una domanda apparentemente banale per la disciplina: “la sessualità ha ancora a che fare con la psicoanalisi?”. La questione, difatti, non è scontata: se in Europa (soprattutto in Francia) le nozioni di sessualità e pulsione avevano continuato a godere di un certo successo, oltreoceano invece la psicoanalisi aveva fatto vertere la propria pratica e la teoria verso concetti come quello di Sé e di Relazione. A dare ulteriore conferma del rapporto problematico della psicoanalisi con la sessualità, è una ricerca di Shalev e Yerushalmi (2009), ripresa anche da Zupančič, dove gli autori intervistano 10 psicoanalisti riguardo la tematica della sessualità in psicoterapia: ne emerge una generale e diffusa rimozione, e addirittura imbarazzo da buona parte dei clinici. La primigenia scoperta di Freud, la sessualità, piuttosto che essere l’elemento unificante delle varie divisioni e diaspore psicoanalitiche, è proprio il seme della discordia.
La domanda “Che cosa è il sesso?” – che, come abbiamo visto, è problematica anche per la stessa psicoanalisi – diventa il fil rouge per affrontare in maniera inedita e “rumorosa” domande classiche dell’ontologia. Non è senza peso che Freud, che aveva sempre cercato di tenersi distante dai riferimenti filosofici, in Endliche und Unendliche Analyse (1937) abbia riconosciuto proprio alla sessualità (come alla questione della pulsione di morte) un’origine filosofica nel dualismo empedocleo fra Eros e Neikos, che, sempre secondo Freud, avrebbe lavorato come criptomnesia inconscia. Ma in che misura il sesso (o meglio, l’interrogazione continua su quel punto di frattura e di inciampo che è il sesso) può funzionare come vettore nella lettura dei problemi dell’ontologia, del soggetto e della politica contemporanei? Non si tratta di ribadire, per Zupančič, semplicemente che il sesso c’è e che nasconderebbe in Sé quel senso e quella verità che tanto gli esseri umani si affannerebbero a cercare. Su questo la filosofa è chiara: il sesso non è “l’ultimo orizzonte del senso e della realtà”, qualcosa che semplicemente si può ritrovare dopo aver grattato la patina delle apparenze, eppure il Sesso è qualcosa di Reale. Ma questo Reale, ricavato dalle elaborazioni di Lacan, su cui tanto insiste Zupančič, non è la realtà dei filosofi, un orizzonte ontologico-epistemologico neutro e quasi rassicurante, piuttosto il Reale è, della realtà, quel nocciolo che resiste a ogni forma di simbolizzazione e ontologizzazione. Il Reale è esattamente ciò che viene tagliato fuori dall’Essere-in-quanto-essere perché sia possibile descriverlo e parlarne, e allo stesso tempo è quella dimensione che curva lo spazio ontologico dell’Essere. Non è un caso che sia Lacan sia Zupančič insistano tanto sulla sessualità di questo Reale, ed è l’inconscio il concetto che permette loro di giustificare questa insistenza. L’inconscio sessuale non è luogo di rimozione di un’istintività animale che “farebbe ritorno” in maniera disturbante, ma piuttosto un gap, un buco strutturale nel soggetto, che lo frattura dall’interno. Questo buco o negatività non è semplicemente un’assenza o uno zero, ma una quantità negativa (di eredità kantiana), inassimilabile e disgregante che funziona come luogo di emergenza del soggetto. Una crepa non è un niente, anzi conta spesso più dei muri, e il sesso è esattamente la crepa che divide i soggetti internamente. È in questo senso che la ripresa delle tavole della sessuazione lacaniana non serve a reiterare la formula della differenza sessuale, bensì a mostrare come essa lavori come operatore simbolico, tagliando il soggetto da dentro, piuttosto che dividendo i soggetti in due sessi o generi determinati fra di loro da un fantasmagorico rapporto sessuale (che non c’è). La sessualità, l’inconscio, il godimento e il Reale sono tutti nomi di ciò in cui il soggetto cartesiano inciampa svelando la frattura che lo domina dall’interno. Zupančič , riprendendo la questione lasciata aperta da Lacan (1973) nel Seminario XI su una sua possibile (para)-ontologia, in cui vi sarebbe una schisi fra l’Essere e il suo Reale, contribuisce a radicalizzare, anche in risposta ai progetti delle Object-Oriented Ontologies, nelle quali il soggetto tende a confondersi neutralmente con gli oggetti in una sorta di democrazia ontologica, l’immagine di un’ontologia dis-orientata agli oggetti, dove, invece, il soggetto continua a essere la frattura e l’alienazione scritta nel tessuto della realtà. Ed è proprio uno dei concetti fondamentali della psicoanalisi, la pulsione, a permettere la costruzione di una topologia del soggetto estimo, in cui i confini fra interiorità e esteriorità si deformano e l’oggetto (il famoso oggetto piccolo a lacaniano) si incista dentro il soggetto. Certo, parlare di pulsioni significa anche riportare all’attenzione antagonismi e conflitti rimossi o appiattiti in seno ai discorsi contemporanei.

Francis Bacon, Lying Figure
Si può dire che ciò che pone le basi del progetto (dis)ontologico di Zupančič sia proprio questa nozione di pulsione. Infatti, Zupančič riprende e rianalizza il Trieb freudiano, le cui vicissitudini di significante lo hanno portato ad essere tradotto e rinaturalizzato come istinto. Invece, ciò su cui insiste, a ragione, la filosofa slovena, è proprio l’innaturalità della pulsione, che poco ha a che fare con eventuali istinti biologico-riproduttivi: essa si produce piuttosto come scarto di godimento nel lavoro del corpo, eccedenza che ritorna sul soggetto, lavorando sui suoi bordi. E non è un caso che Zupančič riprenda quella sezione del Seminario XI dove Lacan parla della pulsione come “farsi vedere”, “farsi cacare”, “farsi masturbare”: pulsione è ritorno del godimento del soggetto, nelle parole di Freud “una bocca che si bacia da sola”. Nel bambino attaccarsi al seno non è semplicemente la soddisfazione di un istinto dell’ordine del nutrimento, ma si produce un resto di godimento, un’eccedenza “libera” nel neo-soggetto. Certo, come dice la filosofa, “con la soddisfazione in eccesso non si può ancora parlare di pulsione” (p. 156) ma è necessario che la soddisfazione inizi “a funzionare, allo stesso tempo, come incarnazione oggettiva […] del negativo e come gap implicito nell’edificio significante dell’essere” (p. 157). Allora la pulsione è proprio il rappresentante di questo negativo interno al soggetto, ne diviene la figura (dis)ontologica centrale. La pulsione è per definizione parziale e frammentaria: non ha un Eden perduto verso il quale tornare né una “teleologia” pulsionale. Non esiste, dunque, un carattere genitale maturo a cui il soggetto dovrebbe tendere. L’impasto pulsionale è sempre un azzardo, un incastro sregolato e polimorfo: “se c’è qualcosa cui la pulsione assomiglia, è a un montaggio” (Lacan, 1973 p. 172). Non c’è sessualità né desiderio normale (ma al massimo normalizzabile) proprio perché queste dimensioni non hanno una forma precisa alle quali le pulsioni si dovrebbero adattare. L’incastro è sempre necessariamente contingente, idiosincratico. E proprio a partire da questa ripresa della pulsione, Zupančič apre una possibilità (psicoanalitica) di ricucire la ferita aperta fra i queer studies e la psicoanalisi, mostrando il volto “anarchico” e “polimorfo” delle pulsioni e cercando di sollevare la psicoanalisi da quella posizione “normalizzatrice” di cui spesso è stata accusata (e di cui di fatto è stata responsabile in molti casi).
Altro merito della filosofa è quello che, seguendo il percorso della pulsione sessuale, fra Freud, Lacan e Deleuze, viene ritrovata la tanto temuta pulsione di morte. Come sostiene Lacan stesso: “Come stupirsi che il suo termine ultimo sia la morte? Poiché la presenza del sesso nel vivente è legata alla morte” (Lacan, 1973 p. 180). L’essere umano non è la lamella lacaniana, il mitico essere scissiparo e immortale: per noi la condizione della divisione sessuata implica la morte del soggetto individuale. L’equazione è questa: dove il soggetto è sessuato, significa che il soggetto deve morire. Allora, di nuovo con un gioco topologico, una condensazione si verifica: cercando il sesso sul nastro di Möbius, questo viene incontrato nel luogo della morte. Non solo, la pulsione di morte, primaria rispetto al brulichio delle pulsioni sessuali ci appare proprio come quell’incrinatura, quella contraddizione, “singolarità unificante” dalla quale le pulsioni emergono e alla quale ritornano: “Presa a questo livello, la sessualità è davvero sinonimo di pulsione di morte e non è un suo opposto come Eros con Thanatos.” (p. 176)
Se il lavoro di Zupančič è proprio quello di svelare filosoficamente le contraddizioni inerenti il soggetto (il sesso, la morte, l’inconscio, il Reale), allora proprio questo soggetto è “l’incarnazione oggettiva di questa contraddizione nella realtà” (p. 185). Per la filosofa incontrare la paradossalità della contraddizione non significa, però, doversi abbandonare a un atteggiamento scettico o cinico; si tratta, piuttosto, di accettare la contraddizione proprio come quel Reale accessibile al pensiero, di pensare la contraddizione, come gli stessi matemi lacaniani hanno fatto, portando la logica ai suoi punti di frattura e rendendo disponibile al pensiero, paradossalmente formalizzata, la contraddizione.

Francis Bacon, Three Studies for Figures at the Base of Crucifixion 2
What is Sex? è un libro originale, radicale e coraggioso per la forza con cui l’autrice invita a affrontare, pensare e concepire la contraddizione e il conflitto (e l’invito non è rivolto solo a filosofi e psicoanalisti, poiché la filosofa ha la capacità di sciogliere nodi intricati con battute immediatamente comprensibili). Chi volesse cercare qui una risposta alla domanda “cosa è il sesso” nel senso più rassicurante e definitivo di certo si troverebbe deluso, perché questo interrogativo diventa piuttosto l’intelaiatura di una riflessione filosofica che vuole prendere di petto tutte quelle contraddizioni, quei conflitti e quelle fratture che la psicoanalisi ha saputo riconoscere (e che, in molti casi, ha saputo anche dimenticare e rimuovere) nel soggetto, nella sessualità, nella morte, nell’inconscio e nell’ambiguità del legame sociale. In questo senso Che cosa è il Sesso? è anche un testo esplicitamente politico, che ci porta nuovamente di fronte quell’antagonismo strutturale che anima e agita la società dal suo interno, facendoci guardare con sospetto dove e quando il Rapporto (sessuale) e la Relazione sono state scritte con la R maiuscola, ponendo proporzioni “sacre” e determinate fra classi, sessi, popoli. Alenka Zupančič ci insegna a guardare con diffidenza chi istituisce questo rapporto in maniera ferrea (come i sistemi dittatoriali), ma anche chi tende a nascondere il conflitto insito nella relazione, neutralizzandolo nell’Etica. La filosofa, infatti, leggendo in chiave politica il famoso ed enigmatico detto di Lacan “non c’è rapporto sessuale”, ci restituisce l’immagine di un rapporto senza prototipo o modello ideale, ma che può sorgere, ogni volta nuovo e da ricostruire, sotto la “necessità” della contingenza, dell’idiosincrasia degli incontri fra i soggetti e nei conflitti che si generano dentro e fra i soggetti. Insomma, una prospettiva che ci fa assumere la responsabilità della contraddizione, piuttosto che negarla o rimuoverla, della frattura che ci domina da dentro e che noi incarniamo nel mondo anche in una dimensione autenticamente politica e trasformativa.
di Lorenzo Curti
Bibliografia:
Freud, S. (1937) Analisi terminabile e interminabile.Trad. it. R. Colorni. OSF Vol. XI. Torino: Bollati Boringhieri
Green, A. (1995) Has sexuality anything to do with psychoanalysis? International Journal of Psychoanalysis78: 871-883
Lacan, J (1973). Seminario: Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi. Trad. it. S. Loaldi e I. Molina. Torino: Einaudi, 1979
Shalev, O. & Yerushalmi, H. (2009) Status of sexuality in contemporary psychoanalytic psychotherapy as reported by therapists. Psychoanalytic Psychology, Vol. 26, No. 4, 343–361
Zupančič, A. (2018) Che cosa è il sesso?. Tr. it. P. Bianchi. Milano: Ponte alle Grazie.
-
Bataille e la notte del non-sapere
Recensioni, Sconfinamenti / Luglio 2018 Sono molte e significative le vicende, personali e culturali, attraversate da Georges Bataille nel corso degli anni Trenta. La più singolare è forse quella legata a una rivista da lui fondata, «Acéphale», e alla società segreta che recava lo stesso nome. L’intento del duplice progetto era, in un certo senso, di tipo religioso, ma di una religiosità che prendeva atto fin da subito della morte di Dio annunciata da Nietzsche. La setta, che riuniva attorno a Bataille un ristretto numero di adepti, svolgeva un’attività di riflessione sulle opere del filosofo tedesco, ma praticava anche dei rituali di tipo cerimoniale. L’esperienza è stata importante per lo scrittore, anche se è durata solo pochi anni e se alla fine egli è sembrato giudicarla, per molti aspetti, mancata. Ha ricordato infatti, in una nota autobiografica, quanto segue: «Avevo passato gli anni precedenti [al 1940] con una preoccupazione insostenibile: ero deciso, se non a fondare una religione, almeno a dirigermi in tal senso. […] Per quanto una simile ubbia possa sembrare stupefacente, io la presi sul serio. È l’epoca in cui feci apparire con degli amici la rivista “Acéphale”. […] Voglio solo precisare che l’inizio della guerra rese decisamente avvertibile l’insignificanza di questo tentativo»
Sono molte e significative le vicende, personali e culturali, attraversate da Georges Bataille nel corso degli anni Trenta. La più singolare è forse quella legata a una rivista da lui fondata, «Acéphale», e alla società segreta che recava lo stesso nome. L’intento del duplice progetto era, in un certo senso, di tipo religioso, ma di una religiosità che prendeva atto fin da subito della morte di Dio annunciata da Nietzsche. La setta, che riuniva attorno a Bataille un ristretto numero di adepti, svolgeva un’attività di riflessione sulle opere del filosofo tedesco, ma praticava anche dei rituali di tipo cerimoniale. L’esperienza è stata importante per lo scrittore, anche se è durata solo pochi anni e se alla fine egli è sembrato giudicarla, per molti aspetti, mancata. Ha ricordato infatti, in una nota autobiografica, quanto segue: «Avevo passato gli anni precedenti [al 1940] con una preoccupazione insostenibile: ero deciso, se non a fondare una religione, almeno a dirigermi in tal senso. […] Per quanto una simile ubbia possa sembrare stupefacente, io la presi sul serio. È l’epoca in cui feci apparire con degli amici la rivista “Acéphale”. […] Voglio solo precisare che l’inizio della guerra rese decisamente avvertibile l’insignificanza di questo tentativo»Scarica il PDF
A cura di
Giuseppe Zuccarino è critico e traduttore. Ha pubblicato vari saggi: La scrittura impossibile, Genova, Graphos, 1995; L’immagine e l’enigma, ivi, 1998; Critica e commento. Benjamin, Foucault, Derrida, ivi, 2000; Percorsi anomali, Udine, Campanotto, 2002; Il desiderio, la follia, la morte, ivi, 2005; Il dialogo e il silenzio, ivi, 2008; Da un’arte all’altra, Novi Ligure, Joker, 2009; Note al palinsesto, ivi, 2012; Il farsi della scrittura, Milano-Udine, Mimesis, 2012; Prospezioni. Foucault e Derrida, ivi, 2016. Tra i libri da lui tradotti figurano opere di Mallarmé, Bataille, Klossowski, Blanchot, Caillois e Barthes. Ha inoltre curato un fascicolo monografico della rivista «Riga» (n. 37, 2017) dedicato a Maurice Blanchot.
-
 La constatazione della pervasività degli automatismi che intessono la nostra esistenza individuale e collettiva porta Pelgreffi a sviluppare un’interrogazione radicale intorno all’essenza di tale fenomeno. L’automatismo viene considerato a partire dall’ampiezza del suo senso, che trova applicazione in ambiti apparentemente eterogenei, come il biologico e il sociale, rivelando, fin dall’inizio, la sua costitutiva ambiguità, che porta, tra l’altro, a un’essenziale riconfigurazione della tradizionale opposizione tra naturale e culturale. Il comportamento automatico si rivela essere, da una parte, il modo di manifestarsi di ciò che è spontaneo, non programmato, emergente. In quest’ottica, afferisce all’ambito del biologico, delle procedure innate radicate nel profondo del bios, dell’inconscio corporeo e psichico. Dall’altra, richiama ciò che è stato appreso ed è diventato abitudine, nel senso di ciò che si impone come prassi automatica a seguito di ripetizioni esercitanti. Si tratta, in questo caso, dello spettro di significati che rimandano al contesto della “seconda natura”, ossia delle abitudini acquisite nel corso della vita, le quali si installano sugli automatismi innati, rimpiazzandoli e riconfigurandoli.
La constatazione della pervasività degli automatismi che intessono la nostra esistenza individuale e collettiva porta Pelgreffi a sviluppare un’interrogazione radicale intorno all’essenza di tale fenomeno. L’automatismo viene considerato a partire dall’ampiezza del suo senso, che trova applicazione in ambiti apparentemente eterogenei, come il biologico e il sociale, rivelando, fin dall’inizio, la sua costitutiva ambiguità, che porta, tra l’altro, a un’essenziale riconfigurazione della tradizionale opposizione tra naturale e culturale. Il comportamento automatico si rivela essere, da una parte, il modo di manifestarsi di ciò che è spontaneo, non programmato, emergente. In quest’ottica, afferisce all’ambito del biologico, delle procedure innate radicate nel profondo del bios, dell’inconscio corporeo e psichico. Dall’altra, richiama ciò che è stato appreso ed è diventato abitudine, nel senso di ciò che si impone come prassi automatica a seguito di ripetizioni esercitanti. Si tratta, in questo caso, dello spettro di significati che rimandano al contesto della “seconda natura”, ossia delle abitudini acquisite nel corso della vita, le quali si installano sugli automatismi innati, rimpiazzandoli e riconfigurandoli.L’intento di Pelgreffi è rendere tale ambiguità, consustanziale al concetto di automatismo, non già paradosso paralizzante, ma apertura di senso produttiva e meritevole di essere indagata nella sua doppiezza. Tale approccio permette di chiamare in causa un’altra ambiguità del concetto di automatismo, che concerne il suo riferirsi, al tempo stesso, alla vita individuale e collettiva. Gli automatismi sviluppati dai singoli individui si riflettono e dialogano costantemente con le dinamiche che regolano la convivenza, culturalmente codificata, all’interno di un collettivo. Tale prisma semantico viene messo in luce tramite un’attenta e avveduta rassegna delle teorie di coloro che si sono occupati, ciascuno a modo proprio ma anche in dialogo reciproco, del concetto di automatismo. Dalle analisi classiche intorno al concetto aristotelico di hexis si giunge alla filosofia francese novecentesca, passando per Hume, Nietzsche e Butler. Non viene tralasciato il dialogo, da una parte, con le scienze psicologiche (in particolare Pavlov e Janet) e, dall’altra, con la pratica artistica dell’attore, compresa attraverso le riflessioni di Diderot e di Stanislavskij. Tali incursioni ermeneutiche permettono a Pelgreffi di approdare a un dialogo serrato con i risultati teorici ottenuti da Merleau-Ponty, in particolare nella sua Fenomenologia della percezione, e mettere in evidenza il ruolo cruciale che la corporeità svolge all’interno di una teoria generale degli automatismi.

Il corpo, compreso come limite e soglia, si configura come il punto fondamentale di incrocio e trasformazione tra le diverse forme di automatismo evidenziate in precedenza. Tale approccio permette di delineare la funzione formante degli automatismi, ossia la circostanza, secondo la quale l’acquisizione di abitudini ripetute ha valore soggettivante, nella misura in cui plasma la modalità di esistenza di chi incarna tali abitudini. È una simile prospettiva che permette a Pelgreffi di introdurre la dinamica eminentemente etica aperta da una filosofia dell’automatismo, nella misura in cui la funzione formante di quest’ultimo rivela, come suo doppio costitutivo, la presenza di una resistenza basale, della possibilità di uno stacco produttore di divergenza, nel processo di acquisizione degli automatismi e nella loro riconfigurazione. In tale potenzialità trasformante si cela la possibilità etica e il focus gnoseologico che permettono di comprendere come si possa produrre differenza attraverso la ripetizione, ossia come sia possibile la de-automatizzazione dei propri automatismi, pur dimorando all’interno dell’orizzonte ampiamente automatizzato in cui la vita si esplica in quanto tale.
La peculiarità dell’approccio adottato da Pelgreffi consiste nel situare nel corpo e, pertanto, nell’insieme di pratiche che possono proporsi di istituire i criteri di un’etica della corporeità, la soglia di tale possibilità di de-automatizzazione, ossia di riconfigurazione critica dei propri automatismi attraverso gli automatismi stessi: «la corporeità è la zona intermediale in cui l’automatismo come senza precedenti e l’automatismo come risultato della ripetizione trovano una sintesi non neutralizzante, aperta anche alla diversione dalla forma sintetica operante» (p. 88). Una tale prospettiva viene conquistata considerando gli automatismi nella loro dimensione genetica e processuale, al fine di comprendere l’acquisizione di un’abitudine nel suo svolgersi e affermarsi e metterne in luce la struttura composta da esercizi ripetuti con effetti di ritorno plastici e in continuo dialogo con una resistenza produttiva installata nella corporeità. Particolare rilievo assume, in una tale ottica, l’attenzione al processo di apprendimento delle abitudini, nel quale si celano le codificazioni sociali (Bourdieu) e i presupposti manuali della tecnica (Sennett). L’intento è quello di ricondurre criticamente il potere della ripetizione automatizzantesi contro la ripetizione stessa, in quanto «all’interno dell’automatismo, esistono contro-movimenti di de-automatizzazione che si tratta di veicolare, di guidare e gestire dall’interno» (p. 220). A partire da questa prospettiva, è importante rilevare come un tale approccio permetta di aprire la strada a una radicale riconfigurazione del ruolo della soggettività, la quale non viene abbandonata, ma ridimensionata e ricondotta alle pratiche di vita, innervate nella corporeità e nel suo fondo inconscio, solo a partire dalle quali la figura del soggetto si può manifestare, dato che «non c’è soggetto senza automatismo, senza estroflessione originaria al dispositivo» (p. 179). È al livello di tali pratiche, delle quali il soggetto rappresenta il risultato epifenomenico parziale e posteriore, che un’etica della resistenza produttiva e della ripetizione differenziante può essere codificata.
di Marco Pavanini
-
VITTORIO HÖSLE – A SHORT HISTORY OF GERMAN PHILOSOPHY
Recensioni / Febbraio 2017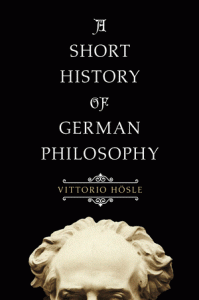 É uscita a novembre 2016, tre anni dopo la prima edizione tedesca, la traduzione inglese dell'ultima fatica di Vittorio Hösle, A Short History of German Philosophy, curata da Steven Rendall per Princeton University Press e arricchita di una nuova prefazione. L'autore, italo-tedesco e attualmente docente alla University of Notre Dame, la più prestigiosa università cattolica degli Stati Uniti, si è distinto sin da giovane grazie a una serie di pubblicazioni ambiziose, culminate nel 1987 in un poderoso studio sul sistema filosofico hegeliano (Il sistema di Hegel, tradotto in italiano nel 2012 per La scuola di Pitagora), e nel 1997 in un altrettanto voluminoso lavoro sul rapporto tra moralità e politica (Moral und Politik, non ancora tradotto in italiano). In altri libri e saggi Hösle ha coltivato interessi interdisciplinari, mostrando una padronanza di diversi campi culturali a dir poco rara al giorno d'oggi (si è occupato tra le altre cose di Darwin, di filosofia della religione e di estetica del cinema). Il tratto distintivo del suo pensiero consiste nel riconoscere la verità filosofica dell'idealismo oggettivo, seguendo la via tracciata tra gli altri da Platone, Vico ed Hegel, e tenendo conto del fondamentale contributo kantiano. Questa impostazione secondo Hösle si rivela valida ancora oggi, ma va aggiornata e confrontata con le acquisizioni del dibattito scientifico e filosofico attuale. Torna così in questo autore a essere cruciale l'istanza sistematica dell'opera hegeliana, oggi a dir poco negletta: coloro che recentemente si sono avvicinati a Hegel (si pensi solo agli americani Robert Brandom e John McDowell, o al tedesco Axel Honneth) si rapportano a essa con indifferenza, se non con sospetto.
É uscita a novembre 2016, tre anni dopo la prima edizione tedesca, la traduzione inglese dell'ultima fatica di Vittorio Hösle, A Short History of German Philosophy, curata da Steven Rendall per Princeton University Press e arricchita di una nuova prefazione. L'autore, italo-tedesco e attualmente docente alla University of Notre Dame, la più prestigiosa università cattolica degli Stati Uniti, si è distinto sin da giovane grazie a una serie di pubblicazioni ambiziose, culminate nel 1987 in un poderoso studio sul sistema filosofico hegeliano (Il sistema di Hegel, tradotto in italiano nel 2012 per La scuola di Pitagora), e nel 1997 in un altrettanto voluminoso lavoro sul rapporto tra moralità e politica (Moral und Politik, non ancora tradotto in italiano). In altri libri e saggi Hösle ha coltivato interessi interdisciplinari, mostrando una padronanza di diversi campi culturali a dir poco rara al giorno d'oggi (si è occupato tra le altre cose di Darwin, di filosofia della religione e di estetica del cinema). Il tratto distintivo del suo pensiero consiste nel riconoscere la verità filosofica dell'idealismo oggettivo, seguendo la via tracciata tra gli altri da Platone, Vico ed Hegel, e tenendo conto del fondamentale contributo kantiano. Questa impostazione secondo Hösle si rivela valida ancora oggi, ma va aggiornata e confrontata con le acquisizioni del dibattito scientifico e filosofico attuale. Torna così in questo autore a essere cruciale l'istanza sistematica dell'opera hegeliana, oggi a dir poco negletta: coloro che recentemente si sono avvicinati a Hegel (si pensi solo agli americani Robert Brandom e John McDowell, o al tedesco Axel Honneth) si rapportano a essa con indifferenza, se non con sospetto.A Short History of German Philosophy, come recita il titolo “una breve storia della filosofia tedesca”, è un lavoro certamente più leggero e accessibile rispetto ad altri dell'autore, ma non per questo meno ricco di stimoli intellettuali. Il libro è espressamente rivolto a un pubblico non solo specialistico e vuole invogliare a una lettura di prima mano delle grandi opere filosofiche di cui si occupa. In circa 300 pagine Hösle riesce a condensare, adottando una prosa chiara e brillante, l'epopea filosofica dello “spirito tedesco”, dai suoi albori con Meister Eckhart ai suoi sviluppi fino ad Hans Jonas. Gli autori selezionati sono tutti classici, per la qualità delle loro opere e l'influsso generato sul dibattito filosofico, e tutti di lingua tedesca. Il criterio linguistico, piuttosto che etnico o geografico, è quello selezionato dall'autore per poter essere considerati parte della “filosofia tedesca”: i filosofi esaminati che pure hanno pubblicato importanti opere in lingue diverse (per esempio Leibniz o Jonas) sono comunque legati al tedesco almeno in una delle loro opere più importanti.
Secondo Hösle – come ha modo di chiarire nella prefazione all'edizione inglese del libro – esistono dei tratti filosofici comuni, almeno alcuni dei quali si riscontrano in tutti i grandi filosofi di lingua tedesca. É perciò legittimo considerarli non come un affastellarsi di autori slegati tra loro, ma alla luce del contributo comune dato dallo “spirito tedesco” alla filosofia. I tratti caratteristici individuati dall'autore sono la concezione razionalistica della teologia; la tensione sistematica; la ricerca di una conoscenza sintetica a priori; la fondazione dell'etica sulla ragione piuttosto che sul sentimento; la combinazione di filosofia e filologia. Anche una figura apparentemente eterodossa come quella di Nietzsche rientra in questa tradizione, non soltanto per i suoi brillanti esordi come filologo greco, ma per la polemica che intraprende contro l'idea di Dio, che è allo stesso tempo lotta contro il razionalismo e la sistematicità del pensiero: l'unitarietà con cui Nietzsche considera razionalismo e teologia, pur nella radicale presa di distanza, è profondamente insita nello spirito tedesco.
Hösle non si limita a ricostruire -in modo sintetico ma mai superficiale - le elaborazioni concettuali più significative elaborate dai diversi autori, ma ne offre una valutazione teoretica, alle volte a dire il vero piuttosto succinta. Non sorprende, considerato l'orientamento filosofico dell'autore, che nel libro la stagione dell'idealismo tedesco occupi il posto d'onore. Nonostante lo sforzo di rendere giustizia alla grandezza di ogni filosofo preso in esame (anche quando, come nel caso di Nietzsche o Marx, risulta evidente la distanza critica), la sensazione che si ha leggendo il testo è di assistere, in una prima fase, a una climax ascendente: dopo i contributi ancora non pienamente maturi di Eckhart, Cusano, Paracelso e Böhme si prende rapidamente quota grazie al razionalismo di Leibniz e alla filosofia trascendentale di Kant (in particolare la sua etica), ci si eleva ulteriormente con l'idealismo soggettivo di Fichte e la sua ricerca di un fondamento ultimo, e infine si culmina nell'idealismo oggettivo di Schelling e nel sistema di Hegel.
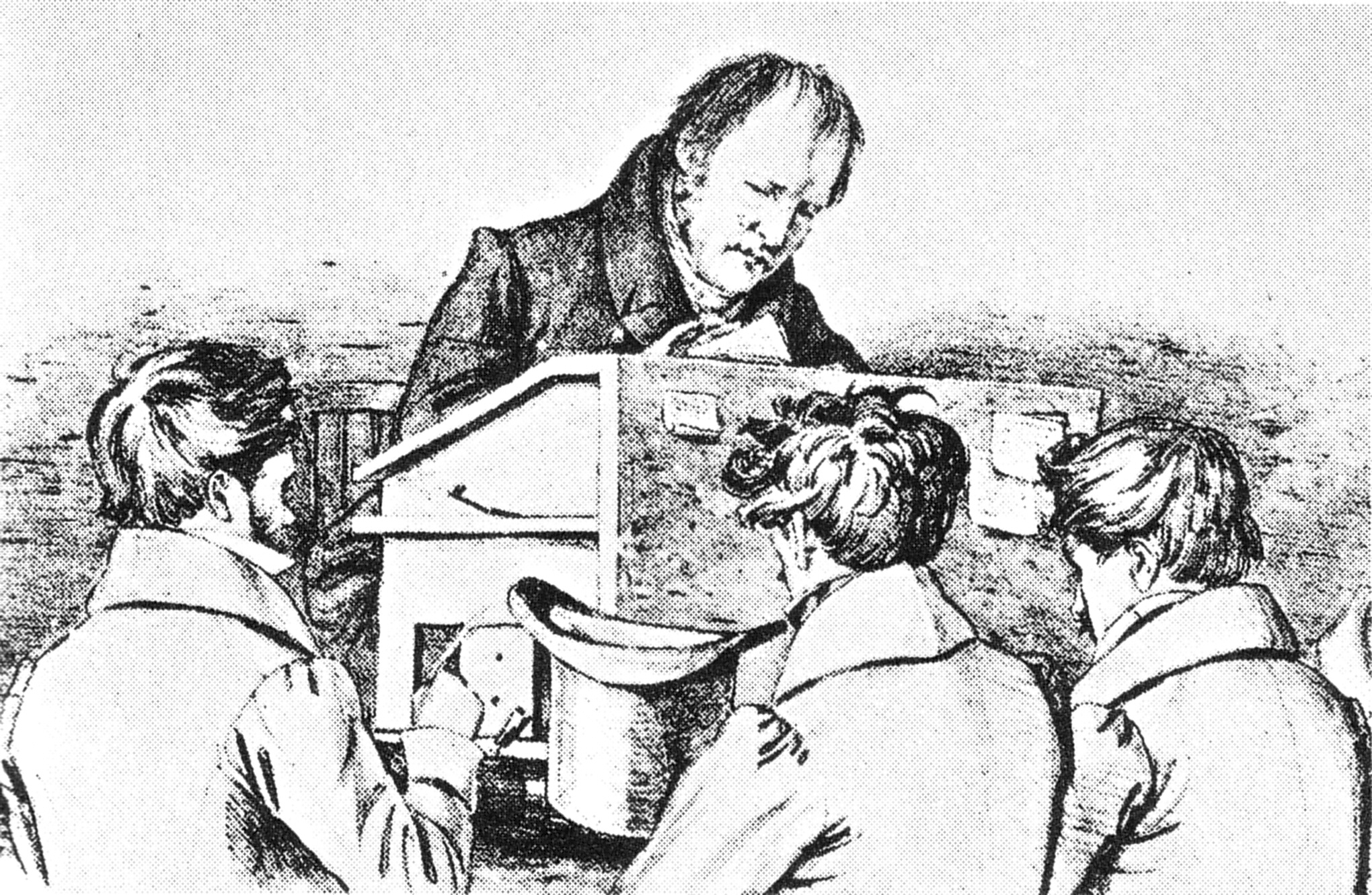
Dopo l'idealismo, l'impressione che si ricava dal libro è una sorta di fuga della filosofia tedesca da se stessa, che si concretizza nella rivolta contro il Cristianesimo (Schopenhauer), contro il mondo borghese (Marx) e contro la morale universale (Nietzsche); per poi disperdersi in sentieri non più ricomponibili. Si passano in rassegna quindi gli autori da cui trarrà origine la tradizione analitica (Frege, gli empiristi logici e Wittgeinstein); il tentativo di fondare le scienze umane e sociali da parte dei neokantiani e di Dilthey, che scade però nel relativismo; l'originale ricerca heideggeriana di una riproposizione della “questione dell'essere”. Un capitolo è dedicato a Carl Schmitt e Arnold Gehlen, i filosofi più compromessi con il nazionalsocialismo, dei quali viene in ogni caso riconosciuta la grandezza. A questo proposito Hösle non dà credito a una visione che consideri il percorso della filosofia tedesca come necessariamente predeterminato verso il nazismo, tuttavia l'opera non manca di rilevare le lacune e le elaborazioni che possono aver favorito o assecondato, al di là di fattori contingenti ben più decisivi, l'ascesa di Hitler (per esempio l'assenza nel pensiero tedesco di una teoria della resistenza, in parte dovuta al potente influsso luterano; la morale anti-cristiana di Nietzsche; la mancanza di un'etica e l'enfasi sulla decisione infondata in Heidegger e Schmitt). Vengono quindi presi in esame Gadamer, di cui viene apprezzata più che altro la teoria estetica; i filosofi della Scuola di Francoforte, tra i quali Hösle mette in maggior rilievo il meno noto Karl-Otto Apel, valorizzando il suo tentativo di fondazione dell'intersoggettività trascendentale; e infine Hans Jonas, il cui Principio responsabilità ha avuto il grande merito di mettere a fuoco uno dei maggiori problemi etici e politici del Ventunesimo secolo, la salvaguardia del pianeta.
A modo di vedere dell'autore non è più possibile oggi parlare di una “filosofia tedesca”: non solo il livello della ricerca in Germania si è sensibilmente abbassato, in parte a causa della fuga di intellettuali all'estero per via del nazismo; la Germania attuale è inoltre parte di una cultura europea, a sua volta sempre più intrecciata con una cultura globale, e non ha più senso distinguere uno “spirito tedesco” con caratteristiche peculiari che si distingua con nettezza rispetto agli altri. Il mondo globalizzato rende poi sempre più difficile elaborare una filosofia con le caratteristiche e le ambizioni proprie della migliore tradizione dello “spirito tedesco”. L'ascesa dell'inglese come lingua accademica internazionale tende a uniformare lo stile e le problematiche del dibattito filosofico alla tradizione anglo-sassone, per lo più analitica; la specializzazione sempre più marcata rende arduo conservare lo sguardo d'insieme e l'ampiezza di prospettive richieste da un pensiero sistematico; l'industria culturale livella la produzione intellettuale verso il basso e rende più difficile che un pensiero valido sia riconosciuto quando emerge. Auspicio e speranza dell'autore è che il pensiero filosofico del futuro, superata la gigantesca crisi ecologica, istituzionale e mentale che viviamo oggi, saprà trarre nuovo nutrimento dagli antichi maestri, tra i quali un posto di rilievo spetta senza dubbio agli autori citati nel libro.
Una considerazione a parte merita infine la fenomenologia di Husserl. Hösle non esita a riconoscere in quest'ultimo “il più grande filosofo del ventesimo secolo”, per la sua grande finezza teorica e la sua dedizione al pensiero; tuttavia non sembra giudicare la sua fenomenologia foriera di sviluppi così decisivi. Eppure il tentativo husserliano costituisce senza dubbio il maggior sforzo, successivo all'idealismo tedesco, di rifondare il pensiero filosofico su un piano trascendentale. La vastità dell'impresa fenomenologica e la fecondità degli influssi che essa continua a esercitare in ambiti diversi come le scienze cognitive, la biologia e la psicologia, inducono a pensare che proprio la fenomenologia sia la migliore erede dello “spirito tedesco” di cui parla il libro, e che sia in grado di “urbanizzare” (o meglio globalizzare) tale spirito depurandolo degli aspetti più stantii. Ci auguriamo che l'autore abbia occasione in futuro di tornare più estesamente sulla possibilità e fertilità di accogliere la fenomenologia nel solco dell'idealismo oggettivo.
di Luca Pagano
-
 Dopo avere dedicato un saggio alle origini della filosofia (Sassi 2009), Maria Michela Sassi affronta in questo libro (Indagine su Socrate. Persona filosofo cittadino, Einaudi, Torino 2015) la sfuggente e complessa figura di Socrate, nella quale tradizionalmente è stata individuata una discontinuità cruciale rispetto agli inizi di cui furono protagonisti i cosiddetti Presocratici e che costituisce dunque, per così dire, un secondo inizio rispetto a quel “prima”. Se ogni inizio pone caratteristiche difficoltà all’interprete, proporre oggi un’indagine su Socrate è impresa più ardua di altre da concepire e da impostare, considerando la vastità dei contributi esistenti sulla questione formulata fin dal 1815 da Friedrich Schleiermacher nel saggio Sul valore di Socrate come filosofo, quando si chiedeva «cosa può essere stato Socrate, al di là di ciò che racconta Senofonte», senza contraddire i tratti che lo stesso Senofonte presenta come propriamente socratici, e «cosa deve essere stato» perché Platone potesse rappresentarlo come ha fatto. La secolare sequela delle interpretazioni è altresì alimentata da un paradosso di cui Sassi dà conto in modo chiaro e articolato: resta controverso chi sia stato il Socrate storico nonostante proprio la sua persona e le sue azioni abbiano segnato un punto di riferimento cruciale – se non l’origine – del genere biografico in Grecia. A questo proposito, richiamando le tesi di Albrecht Dihle e il ridimensionamento fattone da Arnaldo Momigliano, Sassi sottolinea la centralità dei Socratici nella storia degli esperimenti biografici del IV secolo e la peculiarità dei loro scritti, che tendevano più a cogliere le potenzialità della vita del maestro che a raccontarla, facendone così una «guida per territori ancora inesplorati», come Momigliano scriveva nel saggio su Lo sviluppo della biografia greca (1974).
Dopo avere dedicato un saggio alle origini della filosofia (Sassi 2009), Maria Michela Sassi affronta in questo libro (Indagine su Socrate. Persona filosofo cittadino, Einaudi, Torino 2015) la sfuggente e complessa figura di Socrate, nella quale tradizionalmente è stata individuata una discontinuità cruciale rispetto agli inizi di cui furono protagonisti i cosiddetti Presocratici e che costituisce dunque, per così dire, un secondo inizio rispetto a quel “prima”. Se ogni inizio pone caratteristiche difficoltà all’interprete, proporre oggi un’indagine su Socrate è impresa più ardua di altre da concepire e da impostare, considerando la vastità dei contributi esistenti sulla questione formulata fin dal 1815 da Friedrich Schleiermacher nel saggio Sul valore di Socrate come filosofo, quando si chiedeva «cosa può essere stato Socrate, al di là di ciò che racconta Senofonte», senza contraddire i tratti che lo stesso Senofonte presenta come propriamente socratici, e «cosa deve essere stato» perché Platone potesse rappresentarlo come ha fatto. La secolare sequela delle interpretazioni è altresì alimentata da un paradosso di cui Sassi dà conto in modo chiaro e articolato: resta controverso chi sia stato il Socrate storico nonostante proprio la sua persona e le sue azioni abbiano segnato un punto di riferimento cruciale – se non l’origine – del genere biografico in Grecia. A questo proposito, richiamando le tesi di Albrecht Dihle e il ridimensionamento fattone da Arnaldo Momigliano, Sassi sottolinea la centralità dei Socratici nella storia degli esperimenti biografici del IV secolo e la peculiarità dei loro scritti, che tendevano più a cogliere le potenzialità della vita del maestro che a raccontarla, facendone così una «guida per territori ancora inesplorati», come Momigliano scriveva nel saggio su Lo sviluppo della biografia greca (1974).Proprio in ragione di questa circostanza c’è chi – come Olof Gigon nel saggio Sokrates. Sein Bild in Dichtung und Geschichte (1947) – ha sostenuto che quanto più si approfondisce lo studio delle fonti, tanto più ci si accorge di non poter dire nulla del Socrate storico: non avendo ereditato una biografia propriamente detta (Sokratesbiographie), ma soltanto poesia (Sokratesdichtung) su di lui, ai contemporanei non resterebbe altra possibilità che liquidare il problema della sua personalità filosofica accettando di non poterne dire nulla (cfr. Gigon 2015). L’Indagine su Socrate qui proposta si muove su un piano differente, animata da una «fiducia ricostruttiva» che l’autrice basa sulla convinzione «che la varietà e anche divergenza delle fonti si spieghi meglio presupponendo la ricchezza e le potenzialità del modello di base che liquidandole come creazioni ex nihilo» (p. X).
In tale prospettiva, la «plasmabilità del modello che ha offerto ai contemporanei e ai posteri» diventa uno degli elementi di cui dare conto, anziché un motivo a favore dello scetticismo: si può così tentare di inquadrare proprio la «natura plastica» del pensatore e del cittadino Socrate – secondo l’efficace definizione di Hegel nelle Lezioni sulla storia della filosofia – come tratto caratterizzante della sua biografia, intendendola non tanto come l’effetto indotto ex post su di noi dalle testimonianze antiche, con il loro spaziare dalla caricatura alla celebrazione, quanto come il motivo ispiratore ex ante della varietà dei ritratti giunti fino a noi. È questa l’impostazione che guida la presentazione complessiva del pensiero di Socrate proposta nel libro, che a tal fine tiene conto sia del panorama degli studi più recenti su Senofonte e sul valore della sua testimonianza, sia dei cosiddetti logoi sokratikói.
Spicca poi, naturalmente, Platone, al quale dobbiamo alcuni indizi importanti sulla percezione dei contemporanei, con le allusioni alla «stranezza» (atopia) di Socrate (Simposio, 215a-b) e alla consapevole presenza di «qualcosa di stravagante» (perittoteron) nel suo carattere (Apologia, 20c). Si può sostenere che «Socrate stesso si è costruito in vita come un modello di sapere e virtù, destinato a essere via via ri-costruito nei secoli e spesso rivissuto, ma non (nella nostra prospettiva) falsificato» (p. 12). Lo stesso Platone dà molteplici esempi di tale “ricostruzione”: oltre al Socrate de Le Nuvole di Aristofane (423 a.C.) e a quello di Senofonte o dei frammenti di Antistene, Eschine di Sfetto, Fedone di Elide, ci sono infatti il Socrate dei primissimi dialoghi (Apologia di Socrate e Critone), quello dei dialoghi del primo periodo – dalla condanna a morte del maestro alla fondazione dell’Accademia (388/387 a.C.) – e quello dei dialoghi successivi, fino al terzo viaggio di Siracusa (361/360 a.C.), caratterizzati dalla presentazione di dottrine più costruttive, la cui paternità può essere attribuita allo stesso Platone. Anche in questo caso, non mancano interpretazioni che finiscono con l’impedire di pronunciarsi sulla figura di Socrate, escludendo la possibilità di riconoscerne dei tratti specifici nella rielaborazione e, per così dire, nella “messa in scena” escogitata dal suo geniale allievo: ciò accade soprattutto quando prevale un approccio unitarista e non evolutivo all’opera platonica, come nel caso esemplare di Charles H. Kahn.
Sassi si inserisce invece tra quegli studiosi che ritengono possibile indagare negli scritti di Platone il complesso gioco di adesione, approfondimento e distacco dal maestro (p. 234) che rende possibile considerare lo stesso Socrate come «la levatrice del Platonismo» (The Midwife of Platonism), riprendendo il suggestivo titolo di un libro di David Sedley sul Teeteto. Tenendo conto di tutto ciò, questa Indagine su Socrate permette al lettore di seguire parallelamente e di mettere in relazione gli aspetti emergenti dalle testimonianze relative ora alla persona, ora al filosofo e ora al cittadino, in capitoli dedicati all’eccezione filosofica e fisiognomica di Socrate, al suo conversare vivace e scherzoso, alle sue qualità di maestro, al suo dirsi in missione per conto del dio, all’ironia, al metodo di confutazione (elenchos) e all’esigenza di chiarificazione della sfera morale attraverso la ricerca di definizioni.
Emerge peraltro proprio qui, nel nucleo della preoccupazione morale socratica, un altro motivo della stranezza del filosofo, così distante dai Sofisti eppure a essi vicino, per l’utilizzo di confutazioni in cui – come è stato rilevato da molti interpreti – non mancano aporie, fallacie logiche e mosse ingannevoli. Al riguardo è interessante soffermarsi sul fatto che «nel linguaggio non filosofico fin da Omero (e del resto anche dopo l’età classica), sia il sostantivo elenchos che il verbo elenchein indicano l’atto di “mettere alla prova” un individuo e “verificare” la correttezza della sua condotta morale, misurando l’aderenza delle sue parole all’azione compiuta, sì che quello, se venga “smentito” ovvero colto in fallo, ne provi vergogna» (p. 69).
Un singolare pregio del libro sta nel dare conto della generatività del modello proposto da Socrate sui tre piani dell’essere persona, filosofo e cittadino, facendo interagire l’analisi delle fonti più antiche con le riprese successive: incontriamo così il Socrate di Ficino, capace di ispirare a quasi due millenni dalla morte uno stile educativo problematizzante e non gerarchico, e i tanti Socrate di Hegel, Kierkegaard, Nietzsche, Strauss o del circolo di intellettuali che nella Vienna fin de siècle si dissero Neosocratici. Per ognuno di essi, il lettore potrà chiedersi se assomigli maggiormente al Socrate di Aristofane, di Platone o di Senofonte, senza che l’impressione di trovarsi in una sorta di stanza degli specchi filosofica faccia disperare della possibilità di cogliere qualche aspetto originale attribuibile al referente in absentia delle tante immagini riflesse.

Critone chiude gli occhi a Socrate (1787-1792)
Particolarmente significative risultano in tale prospettiva le pagine dedicate al modo in cui Socrate, per primo, applicò sistematicamente il paradigma delle technai all’anima (psyche), ispirando la riflessione platonica sulla paideia e sulla cura di sé (epimeleia heautou, in latino cura sui) e proiettando, attraverso essa, la propria ombra su tutto il pensiero greco, ellenistico e romano, arrivando fino alla spiritualità cristiana e a ciò che a essa è correlato in modo più o meno diretto. Si tratta di un punto cruciale per definire l’attualità di Socrate, già esemplarmente sollevato tanto dalla ricerca di Pierre Hadot sugli esercizi spirituali nell’antichità quanto dalle ultime riflessioni di Michel Foucault sull’ermeneutica del soggetto (al centro del corso al Collège de France del 1981/1982) e sulle tecnologie del sé. Socrate risulta essere una delle origini anche di questa storia e Sassi lo ribadisce, sottolineando l’importanza di alcune intuizioni di Foucault e, in particolare, della sua valorizzazione dell’Alcibiade primo o maior, come primo testo filosofico in cui viene sollevata la domanda su cosa sia l’uomo, ovvero su cosa sia il “se stesso” di cui si parla quando si pensa alla “cura di sé”, con un richiamo, seguendo Hegel, all’Edipo re di Sofocle (cfr. pp. 121 sgg.).
Il Socrate dell’Alcibiade primo di Platone, dunque, viene analizzato come testo che inaugura la questione del soggetto, ovvero delle pratiche di soggettivazione attraverso le quali un soggetto può diventare campo di conoscenza, d’azione e d’esercizio per se stesso. Tenendo conto di questo dialogo e dell’imperativo etico ch’esso ha consegnato ai posteri («Cerca di essere bello il più possibile!», Alcibiade primo, 131c-d), Sassi precisa di non ritenere in toto sottoscrivibile la critica di Hadot a Foucault sulla surrettizia trasposizione nel pensiero antico di una sorta di estetica dell’esistenza, la cui esigenza sarebbe precipuamente contemporanea: si tratta peraltro di intendersi sul senso della bellezza qui richiamata, applicabile tanto all’ars moriendi, quanto all’arte di vivere di cui Socrate fu considerato modello esemplare (oltre al saggio di Cambiano su Platone e le tecniche del 1971, si richiamano qui studi più recenti, come quello di Nehamas 1998).
L’Indagine su Socrate proposta da Sassi aiuta però a ricordare che proprio qui la persona, il filosofo e il cittadino Socrate si incontrano per il privilegio accordato al dialogare come tecnica dell’anima per eccellenza, che non permette di declinare in termini puramente individualistici l’imperativo a cambiare la propria vita, come invece sembra suggerire Sloterdijk. Il domandare socratico non riguarda infatti l’individuo che da sé assume un impegno a cambiare la propria vita, ma è al tempo stesso un fatto etico e politico, nel senso dischiuso dall’interrogativo generale sul «come si dovrebbe vivere?», che secondo Julia Annas inaugura il più ricco e caratteristico filone dell’etica greca: interrogativo attribuito a Socrate e inserito non a caso in un’opera intitolata Politeia, incentrata su sottili giochi di corrispondenze tra il destino della psyche e quello della polis (cfr. l’hontina tropon chrē zēn di Repubblica 352d e Annas 1997). In tale prospettiva, questo ritratto di Socrate aiuta a mettere a fuoco le caratteristiche peculiari del maestro di Platone anche sul piano della storia delle tecnologie del sé e delle antropotecniche, mostrando al lettore contemporaneo interessato all’argomento quanto sia proficua la rilettura delle fonti antiche a cui spesso si fa appello come esemplari, per cogliere continuità e discontinuità tra le varianti esistenti e tra quelle possibili.
di Luca Mori
Bibliografia
Annas, J. (1997). La morale della felicità in Aristotele e nei filosofi dell’età ellenistica. Milano: Vita&Pensiero.
Cambiano, G. (1971). Platone e le tecniche. Torino: Einaudi.
Foucault, M. (1992). Tecnologie del sé. Torino: Bollati Boringhieri.
Foucault, M. (2016). L’ermeneutica del soggetto. Corso al Collège de France (1981-1982). Milano: Feltrinelli.
Gigon, O. (2015). Socrate. La sua immagine nella letteratura e nella storia. Milano: Vita&Pensiero.
Hadot, P. (2005). Esercizi spirituali e filosofia antica. Torino: Einaudi.
Kahn, C.H. (2008). Platone e il dialogo socratico. L’uso filosofico di una forma letteraria. Milano: Vita&Pensiero.
Momigliano, A. (1974). Lo sviluppo della biografia greca. Torino: Einaudi.
Nehamas, A. (1998). The art of living. Socratic Reflections from Plato to Foucault. Berkeley-Los Angeles-London: University of California Press.
Sassi, M. M. (2009). Gli inizi della filosofia: in Grecia. Torino: Bollati Boringhieri.
Sedley, D. (2004). The Midwife of Platonism. Text and Subtext in Plato’s Theaetetus. Oxford: Clarendon Press.
Sloterdijk, P. (2010). Devi cambiare la tua vita. Milano: Raffaello Cortina Editore.
-
 Presentarsi come discepolo di un autore significa rispettare ricorrenze e alle volte pronunciare elogi funebri. Un elogio funebre, soprattutto se pronunciato a distanza di cento anni dalla morte dell’elogiato, non è semplicemente l’occasione per ricordare al pubblico interessato i passaggi salienti di una vita ormai trascorsa, ma la possibilità di un’apertura verso la reinterpretazione totale di un evento mai tramontato. Sembra essere questa l’intenzione di Peter Sloterdijk, filosofo tedesco autore di saggi come Critica della ragion cinica (1983), Sfere (1998-2004) e Devi cambiare la tua vita (2009), nel pronunciare il suo discorso a Weimar nel 2000 per il centenario della morte di Friedrich Nietzsche, oggi raccolto in volume da Mimesis con il titolo Il quinto «Vangelo» di Nietzsche. Sulla correzione delle buone notizie (2015). Con spirito simile a quello di Francesco d’Assisi nel suo Testamentum, Sloterdijk ci dice sin dall’inizio della sua prolusione: «Cercate di comprendere con semplicità e senza glosse i testi nietzscheani. Nietzsche è presentato come una «catastrofe nella storia del linguaggio» (p. 19), come colui che richiamandosi alla reale origine del linguaggio, emendandolo dalle falsificazioni metafisiche proprie del ressentiment, lo restituisce alla dimensione genuinamente eulogistica, libera dalla proprie inibizioni. Essere “quinto” evangelista significa tutto questo: liberare le forze linguistiche propriamente creative per percorrere una via d’ascesa radicalmente diversa sia rispetto al cristianesimo primitivo sia rispetto ai “nuovi evangelisti” come Lutero. A risuonare nelle parole di Sloterdijk sembra essere una delle più potenti affermazioni di Nietzsche: «In fondo è esistito un solo cristiano e questi morì sulla croce. Il “Vangelo” morì sulla croce» (1977, p. 50). Per questo sembra giunto il tempo per un nuovo “vangelo”, in grado di trasfigurare tutti i valori consegnatici dalla tradizione e capace di fuoriuscire da quel circolo vizioso della negazione come liberazione dalla realtà, generando al suo posto un’affermazione propriamente produttiva, «una nuova regola di vita, non una nuova fede» (ivi, p. 44).
Presentarsi come discepolo di un autore significa rispettare ricorrenze e alle volte pronunciare elogi funebri. Un elogio funebre, soprattutto se pronunciato a distanza di cento anni dalla morte dell’elogiato, non è semplicemente l’occasione per ricordare al pubblico interessato i passaggi salienti di una vita ormai trascorsa, ma la possibilità di un’apertura verso la reinterpretazione totale di un evento mai tramontato. Sembra essere questa l’intenzione di Peter Sloterdijk, filosofo tedesco autore di saggi come Critica della ragion cinica (1983), Sfere (1998-2004) e Devi cambiare la tua vita (2009), nel pronunciare il suo discorso a Weimar nel 2000 per il centenario della morte di Friedrich Nietzsche, oggi raccolto in volume da Mimesis con il titolo Il quinto «Vangelo» di Nietzsche. Sulla correzione delle buone notizie (2015). Con spirito simile a quello di Francesco d’Assisi nel suo Testamentum, Sloterdijk ci dice sin dall’inizio della sua prolusione: «Cercate di comprendere con semplicità e senza glosse i testi nietzscheani. Nietzsche è presentato come una «catastrofe nella storia del linguaggio» (p. 19), come colui che richiamandosi alla reale origine del linguaggio, emendandolo dalle falsificazioni metafisiche proprie del ressentiment, lo restituisce alla dimensione genuinamente eulogistica, libera dalla proprie inibizioni. Essere “quinto” evangelista significa tutto questo: liberare le forze linguistiche propriamente creative per percorrere una via d’ascesa radicalmente diversa sia rispetto al cristianesimo primitivo sia rispetto ai “nuovi evangelisti” come Lutero. A risuonare nelle parole di Sloterdijk sembra essere una delle più potenti affermazioni di Nietzsche: «In fondo è esistito un solo cristiano e questi morì sulla croce. Il “Vangelo” morì sulla croce» (1977, p. 50). Per questo sembra giunto il tempo per un nuovo “vangelo”, in grado di trasfigurare tutti i valori consegnatici dalla tradizione e capace di fuoriuscire da quel circolo vizioso della negazione come liberazione dalla realtà, generando al suo posto un’affermazione propriamente produttiva, «una nuova regola di vita, non una nuova fede» (ivi, p. 44).La difficoltà maggiore nella ricezione del nuovo messaggio sembra essere la spesa enorme che esso richiede in termini di energie, la sua forma propriamente anacoretica, la quale impone una rinuncia radicale a ogni struttura tradizionale, più che concentrarsi sulle classiche discipline della astinenza sia sessuale sia dal cibo. Un tale discorso viene letto da Sloterdijk come un’esplosione aperta e forsennata delle strutture immunitarie del sistema della morale. Il soggetto trasfigurato disporrà così della potenza del Übermensch come fosse un vaccino creatore in grado di scongiurare la disillusione derivante da uno sguardo diretto sulla realtà. La spaccatura interna all’ordine della morale è data dalle forze auto-celebrative che si dispiegano in quanto riconoscono nel Sé qualcosa che merita di essere celebrato e non si accontentano di una mera affermazione d’esistenza. Viene così a concretizzarsi quell’“egocentrismo” – tanto caro a Sloterdijk in altri suoi saggi, spesso denigrato perché mal compreso – in cui si concentrano le migliori possibilità vitali per l’umanità. L’egocentrismo viene a costituire il nucleo di un esercizio di reiterazione in cui si realizzano le possibilità del proprio divenire quel che si è. Esso è anche il contenuto donato a partire dalla novella di Zarathustra.

L’arte dell’eulogia praticata da Nietzsche è presentata come compromissione a un alto livello nella forma del dono impossibile. Un dono che non prevede scambio è la dimensione propria del tempo della generosità come figura divergente rispetto all’economia del debito. In particolare, a essere donata sarà una forma di nobiltà dello spirito senza precursori né nella figura di Gesù né in quella di Buddha, entrambe troppo legate a un ideale di soppressione dell’azione, nonostante fossero inserite in una dimensione di realismo radicale. La struttura linguistica del dono eccessivo è la spudoratezza come alternativa al risparmio e alla moderazione. In questa maniera, se il buono è moderato, il generoso è spudorato e la spudoratezza viene a configurarsi come reazione immunitaria di un’umanità che supera se stessa in un’eulogia acrobatica. Il negativo, il bisogno di sminuire l’altro come tema centrale del ressentiment, è superato da uno straripamento del Sé nell’auto-elogio. Straripare significa propriamente fuoriuscire dall’Ego per lodare l’estraneo come ciò che rende possibile il funzionamento del meccanismo di soggettivazione. In questo senso ci si riferisce a Nietzsche come a un “etero-narcisista” o a un “corpo di risonanza”, e così al suo vangelo.
Se esiste un punto di originalità nell’interpretazione che Sloterdijk dà della novella di Nietzsche possiamo ritrovarlo nell’abbandono della centralità affidata alla nozione di volontà di potenza a favore di una pluralità di nozioni o, per meglio dire, a una composizione di forze strutturate, intrecciate e sovrabbondanti. L’elogio funebre è così occasione per strappare l’effettività di un gesto a una vulgata deformante e aprire la strada a una nuova forma d’interpretazione lontana da quella tradizionale, per inaugurare una nuova catena in grado di donare la novella e per sostituire alla fede in Zarathustra una nuova regola di vita.
BIBLIOGRAFIA
Nietzsche F. (1977). L’anticristo. Maledizione del cristianesimo. Milano: Adelphi
di Alessandro Calefati
-
Rocco Ronchi – Deleuze. Credere nel reale
Recensioni / Settembre 2015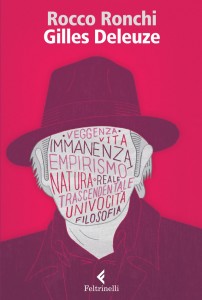 Perché un’altra monografia su Deleuze? E perché dedicare un lavoro a Deleuze in una collana che si chiama «Eredi» (diretta da Massimo Recalcati), quando si è cominciato il proprio cammino filosofico studiando Bergson? Ma, soprattutto, perché scegliere un sottotitolo, Credere nel Reale, per un saggio consacrato al re dei simulacri, a colui che ha rovesciato ogni credenza e ogni realtà, similmente a ogni credenza nella realtà?Il Deleuze di Rocco Ronchi (Feltrinelli, Milano 2015) non è l’ennesimo saggio dedicato al filosofo francese a cui Michel Foucault, con una lungimiranza prossima alla veggenza, legò le sorti della filosofia a venire. Non è l’ennesimo saggio però proprio perché lo è: è ennesimo e lo vuole essere.Questo è solo il primo dei tre paradossi con cui è possibile afferrare l’operazione che Ronchi fa col suo ultimo lavoro. Gli altri due sono veicolati rispettivamente dal rapporto che quest’ultimo intrattiene col titolo della collana («Eredi») e col suo stesso sottotitolo (Credere nel reale). A partire da questi tre interrogativi, solo apparentemente aporetici, è cioè possibile trattenere per qualche istante l’attenzione sulla nuova immagine che, di Deleuze, emerge dall’ultimo libro di Ronchi., non stupendosi però che sia proprio una via paradossale e lastricata da cattive intenzioni a permetterci di toccare il senso di questo breve ma calibratissimo saggio.
Perché un’altra monografia su Deleuze? E perché dedicare un lavoro a Deleuze in una collana che si chiama «Eredi» (diretta da Massimo Recalcati), quando si è cominciato il proprio cammino filosofico studiando Bergson? Ma, soprattutto, perché scegliere un sottotitolo, Credere nel Reale, per un saggio consacrato al re dei simulacri, a colui che ha rovesciato ogni credenza e ogni realtà, similmente a ogni credenza nella realtà?Il Deleuze di Rocco Ronchi (Feltrinelli, Milano 2015) non è l’ennesimo saggio dedicato al filosofo francese a cui Michel Foucault, con una lungimiranza prossima alla veggenza, legò le sorti della filosofia a venire. Non è l’ennesimo saggio però proprio perché lo è: è ennesimo e lo vuole essere.Questo è solo il primo dei tre paradossi con cui è possibile afferrare l’operazione che Ronchi fa col suo ultimo lavoro. Gli altri due sono veicolati rispettivamente dal rapporto che quest’ultimo intrattiene col titolo della collana («Eredi») e col suo stesso sottotitolo (Credere nel reale). A partire da questi tre interrogativi, solo apparentemente aporetici, è cioè possibile trattenere per qualche istante l’attenzione sulla nuova immagine che, di Deleuze, emerge dall’ultimo libro di Ronchi., non stupendosi però che sia proprio una via paradossale e lastricata da cattive intenzioni a permetterci di toccare il senso di questo breve ma calibratissimo saggio.Deleuze è stato infatti il filosofo che più di tutti, almeno nel 900, ha fatto del paradosso l’agente provocatore della filosofia, il lampo scatenante il tuono del pensiero. A esso, ci insegna, siamo costretti da un trauma, da un incontro imprevisto e letale al quale non possiamo sottrarci. Un unico e intempestivo incontro che poi risuona e si distribuisce frattalmente in piccoli traumi che si ripetono come “piccoli limiti” (L’Anti Edipo, 1972), traumi e limiti che coincidono con i singolari arresti della doxa, con i suoi controsensi e i suoi inciampi.
È qui che si comincia a pensare, perché è in un controtempo che Deleuze rintraccia la possibilità di “generare l’atto di pensare nel pensiero” (Differenza e ripetizione, 1968). E prima di lui fu Platone a intercettare la stessa possibilità nel contraccolpo provocato dai ta parakalunta, oggetti capaci di scuotere il pensiero provocando “sensazioni nello stesso tempo contrarie” (Filebo 46 c e Repubblica VII, 523 b). Pensare non è nulla di ovvio, afferma Ronchi (p. 77) e i ta parakalunta sono proprio le pieghe in cui si sospende il dativo dell’“a me pare”, sono gli scogli su cui si frantuma bruscamente l’opinione, i luoghi in cui si contorce e storce il duplice filo del senso comune e del buon senso.
Al bucolico e troppo irenico thaumazein di aristotelica memoria, Deleuze ha del resto sempre preferito il traumatizestai, l’essere ferito, la violenza dell’urto, l’impatto col Reale e col Fuori che, solo, forza il pensiero costringendolo al movimento. Il traumatizestai è dunque questa spinta paradossale e quella situazione ottica pura in cui, soltanto, gli eventi fanno segno (p. 63).
Che sia una via paradossale a permetterci di cogliere il senso di questo libro è dunque forse il primo e più significativo segno che non si tratta di lettera morta. Per dire, per esplicitare il sottinteso di una filosofia, lo storico, così come il saggista e lo scrittore, deve d’altronde condividere con quel pensiero una “causa comune”, la medesima urgenza nascosta magari tra le pieghe del discorso. In altre parole, l’atto ermeneutico è sempre creativo, ma creativo perché critico e critico perché violento.
«Con questo saggio non pretendo di aggiungere una mia introduzione all’opera di Gilles Deleuze alle tante, validissime, che circolano. La mia intenzione è un’altra. Ciò che mi sono proposto è scrivere un capitolo di storia della filosofia contemporanea» (p. 9). Tutto sta, quindi, nell’intendersi su cosa sia la storia della filosofia contemporanea e su cosa significhi scriverne un capitolo. Deleuze al riguardo è piuttosto chiaro: «Il mio modo di cavarmela –scrive ‒ consisteva soprattutto nel fatto di concepire la storia della filosofia come una specie di inculata o, che è lo stesso, di immacolata concezione. Mi immaginavo di arrivare alle spalle di un autore e fargli fare un figlio, che fosse suo e tuttavia fosse mostruoso» (Pourparler, 1990).
L’immacolata concezione evocata da Deleuze è critica radicale all’immagine dogmatica e stereotipata della filosofia e della storia che se ne scrive. «Critica» nel senso in cui, provocando un “crollo centrale” del pensiero, obbligandolo a pensare questo crollo e questa impotenza che è sua propria, essa apre una crisi che mette in causa il modello trascendentale implicato dall’immagine dogmatica, ossia il modello della ricognizione mediata dall’esercizio concorde di tutte le facoltà e garantita dall’identità dell’Io per un soggetto supposto identico. Nella sua differenza la filosofia deve, per Deleuze, opporre all’immagine l’avventura dell’incontro senza affinità né predestinazione. Detto altrimenti, in gioco è una certa tensione, da sopportare e da cui lasciarsi attraversare. Per Deleuze infatti non è questione di giudicare ma di “far esistere” (Critica e clinica, 1993), di creare, spingendo il pensiero critico fino in fondo, ossia al di là del principio della quadruplice e organica ragione.
“Sua e mostruosa”, in una parola, perturbante, la nuova immagine del pensiero (a cui Deleuze dà il nome di empirismo trascendentale) non è perciò una semplice rappresentazione ma un’intuizione e questa non tanto come sguardo panottico e distaccato che tenta il sorvolo quanto, piuttosto, come esperienza diretta, intensiva e affettiva di forze che si dispiegano e che disfano ogni elemento di trascendenza, il soggetto come l’oggetto. Questa è l’avanguardia deleuziana: stazionare, fuggire fermi sul posto, perché divenienti infinite variazioni. E quale filosofo non si augurerebbe di produrre una immagine del pensiero che non dipenda più dalla buona volontà del pensatore e dalla sua decisione premeditata? Chi cioè non vorrebbe affrancarsi dal dogmatico atteggiamento trascendentale che questiona le condizioni dell’esperienza possibile per guadagnare quella genitalità che è genesi statica e intrinseca dell’esperienza reale?
La differenza dunque risiede nella concezione di storia della filosofia che si presuppone e che, nel caso di Ronchi lettore di Deleuze, è indubbiamente mutuata dal suo oggetto di studio. Nessun racconto lineare in cui la vicenda si è già tutta consumata e che, da qualche parte nella “mente” dell’autore che si accinge a esporla, attende solo di essere “rivelata”. Nessun monumentale e mortifero allestimento di fatti avvenuti, e perciò morti, in cui il tempo del racconto non fa nulla (p. 9). Da Deleuze viene tutta un’altra idea di storia della filosofia che, accettando il suggerimento di Ronchi, si può definire “problematica”, campo e insieme teatro di una battaglia di cui non si conosce anticipatamente né l’esito né lo scioglimento. Del resto, solo l’assenza di presupposti punta dritta alla creazione. E lo fa procedendo senza concetto: come l’intuizione di Kant e al modo della differenza di Deleuze.
Affermare che il testo di Ronchi non è l’ennesimo saggio su Deleuze proprio perché lo è significa, allora, affermare quest’assenza di presupposti, ribadire quel “senza concetto”. Così vicino al “senza tempo” dell’inconscio di Freud, al “senza senso” del Reale che ossessiona Lacan, ma anche e soprattutto, al “senza immagini” che Deleuze attribuisce al pensiero.
E tuttavia, se il saggio di Ronchi non è l’ennesimo lavoro consacrato a Deleuze è perché, anzitutto, esso consiste in quell’atto, del vivente prima che della matematica (o della matematica perché del vivente) che è l’elevazione alla n, la “messa in potenza”. La n come lettera, viva, della ripetizione cara a Deleuze, della buona ripetizione in cui a tornare è la differenza. N è la lettera del ritornello a cui la musica fa subire il “trattamento molto speciale della diagonale o della trasversale” (Millepiani, 1980) strappandolo così alla sua territorialità. Ennesima è cioè la ripetizione che sfugge al concetto perché preferisce crearlo, è la differenza come forza selettiva. N è il tema assunto come radiale e non come terminale per dirla con Glenn Gould; è il marchio di quella “superfetazione di un atomo intuitivo e indicibile” che è il filosofo secondo Henri Bergson. N è, infine, il segno di una nuova immagine del pensiero.
A partire da un singolare anacronismo si sostanzia la scelta di dedicare a Deleuze e non a Bergson un saggio in una collana che si chiama «Eredi». Se infatti il filosofo, come Deleuze ama ricordare, è l’artista del concetto, egli è tale, ossia lo diviene, solo dopo essere stato un umile ritrattista. Perché è nel servizio, nell’apprendistato e nell’esercizio con la E maiuscola che si prepara il terreno propizio alla creazione. Ronchi ha cominciato ritraendo Bergson e lo ha fatto mostrando che ogni volta che si rileggono davvero, ossia integralmente e senza pregiudizi, i testi di autori famosi, di filosofi e maestri da tempo assegnati e «sistemati» entro la tradizione storico-critica, si scopre, con immenso stupore, quanto quest’ultima sia spesso in difetto rispetto alla verità. E siccome ogni apprentissage è, nel tempo, un’avventura dell’involontario (Proust e i segni, 1964), accade che, après-coup, dopo i colpi della tecnica e dell’esercizio, improvvisamente s’incontri qualcuno per la prima volta pur avendo certezza che sia l’ennesima. Primultima direbbe Jankélevitch.
 In una collana dedicata ai maestri di cui ci sente eredi, Ronchi sceglie Deleuze proprio perché ha cominciato con Bergson. Ritraendo il filosofo dell’élan vital (cose antiche), egli si è infatti imbattuto nell’empirismo trascendentale (cose meno antiche). Meglio: è riuscito a ritrarre Bergson come un filosofo dell’interpretazione solo perché, senza saperlo, era già interpretante dei segni deleuziani (cose antiche che vengono dopo cose meno antiche). Come ricorda Deleuze: «apprendere è qualcosa che concerne essenzialmente i segni. Questi sono appunto oggetto di un apprendimento temporale e non di un sapere astratto […] Occorre essere predisposto ai segni, aprirsi al loro incontro, aprirsi alla loro violenza» (Proust e i segni, 1964).
In una collana dedicata ai maestri di cui ci sente eredi, Ronchi sceglie Deleuze proprio perché ha cominciato con Bergson. Ritraendo il filosofo dell’élan vital (cose antiche), egli si è infatti imbattuto nell’empirismo trascendentale (cose meno antiche). Meglio: è riuscito a ritrarre Bergson come un filosofo dell’interpretazione solo perché, senza saperlo, era già interpretante dei segni deleuziani (cose antiche che vengono dopo cose meno antiche). Come ricorda Deleuze: «apprendere è qualcosa che concerne essenzialmente i segni. Questi sono appunto oggetto di un apprendimento temporale e non di un sapere astratto […] Occorre essere predisposto ai segni, aprirsi al loro incontro, aprirsi alla loro violenza» (Proust e i segni, 1964).Dalle cinque sezioni-sfondo in cui si articola il volume, si staglia l’immagine di un Deleuze radicalmente monista, inaspettatamente platonico e sorprendentemente reale. Contro ogni lettura della filosofia deleuziana in termini di metamorfismo energetico, caleidoscopico e, però, eminentemente entropico, Ronchi insiste su quell’unico ritornello, su quell’unico evento colto da diverse date e rifrangentesi in quella “multiversità dello spettro filosofico” (P.A. Rovatti) che è la filosofia di Deleuze, il quale, come l’autore sottolinea più volte, dice, in fondo, sempre la stessa cosa. In secondo luogo, ribaltando la vulgata tradizionale – quella che allestisce l’immagine, forse la più stereotipata, di un Deleuze eroe del rovesciamento del platonismo, colui che cioè ha realizzato, nel senso di portare a compimento, il programma nietzscheano ‒ Ronchi piazza al centro del pensiero contemporaneo l’immagine di un Deleuze profondamente platonico, di un Deleuze classico e perciò davvero eversivo. Infine, alla lettura militante ma sclerotizzata che ha fornito le chiavi per aprire e utilizzare quello scrigno di parole-azione che è L’Anti Edipo, immagine sacrificata all’aut-aut tra simbolico e immaginario, Ronchi sostituisce quella di un Deleuze speculativo, filosofo rigoroso e singolarmente realista, nel duplice senso di colui che, con un unico atto di fede nel Reale, dichiara simultaneamente scacco matto al re e alla regina. Né simbolico né immaginario, al di là del padre e della madre, il Deleuze di Ronchi è infatti assolutamente reale, vera e propria intrusione del primum et tertium, puro e anedipico, che spezza il doppio vincolo tra legge repressiva e godimento illimitato. Facendo dell’intuizione un metodo e della diairesis agonistica il suo banco di prova, la lettura che Ronchi propone di Deleuze è militante perché atletica, in lotta per l’affermazione dell’infinita uguaglianza dell’essere in ogni ente contro ogni oscena e fascista visione di questa univocità.
Si tratta, per riprendere una battuta delle pagine iniziali del testo, di essere “veggenti più che attanti”, di provare a vedere nella luce più che con gli occhi e di indicare, poi, ciò che si è visto, piuttosto che sforzarsi a organizzarne fin da subito la traduzione simbolica. Il mistico infatti “fissa, intensifica e completa in azione” ma, soprattutto, crede. Crede intransitivamente perché veggente. L’atto di fede è questa forza neghentropica che approda a un’immagine diretta del tempo e/o dell’evento e che spinge in direzione contraria all’entropia del senso comune (p. 18). E l’evento in questione è il ’68. A quella data Deleuze associa l’intrusione del Reale puro, del Reale univoco che è processo morfogenetico, produzione incessante della forma risalente all’indietro la china dell’indifferenziato. Se il Deleuze di Ronchi non né simbolico né immaginario è perché è un’esperienza pura, un’intuizione come simultaneità delle due direzioni contrarie e una penetrazione insieme impossibile (per la rappresentazione) e necessaria (alla filosofia).
Solo nell’opportuna espressione, che è inevitabile esplicatio, di questa esperienza e complicatio riecheggia quell’unico ritornello che intona ciò che tutti vogliamo e siamo: unitas multiplex. Ed è questo rumore di fondo, che è quello del processo ‒ per dirla con Whitehead ‒, dell’atto in atto – per usare un lessico caro a Gentile ‒ e/o della molteplicità illimitata e mouvante di forme finite, che sono le immagini mobili di Bergson e le figure atletiche di Deleuze, che bisogna allenarsi a ascoltare trasformando l’occhio in orecchio. Si tratta di esercitarsi a stazionare presso questo brusio fino a fare tutt’uno con esso, fino a sentirsi divenire quel rumore e quel fondo. Solo così si è degni dell’istante pulsionale in cui Alfa cortocircuita Omega.
Se questo, come rimarca Ronchi, è il programma di ogni ontologia è perché è anzitutto il compito primo della filosofia, della philosophia perennis et bona: «arrivare alla formula magica che cerchiamo tutti. Pluralismo=monismo, passando per tutti i dualismi che sono il nemico, ma il nemico assolutamente necessario, il mobile che non cessiamo di spostare» (p.79). Millepiani = un piano: questo è il sesamo per una filosofia dell’immanenza assoluta.
di Alessandra Campo
-
CRUDELTÀ, SOVRANITÀ, RESISTENZA NELLA PSICANALISI
Longform / Luglio 2015[…] gli Stati generali sono sempre convocati nei momenti critici, quando una crisi politica richiede una scelta, e prima una liberazione della parola in vista di una decisione d’eccezione che dovrà impegnare l’avvenire (Derrida, 2013, p. 56)
Stati d’animo della psicanalisi è il titolo della conferenza tenuta alla Sorbona da Jacques
 Derrida nel luglio 2000, in apertura degli Stati generali della psicoanalisi, occasione straordinaria di confronto tra psicoanalisti di tutto il mondo appartenenti alle diverse correnti del movimento psicoanalitico. La conferenza, uscita in Francia nel 2000 (Derrida 2000), è stata pubblicata in Italia alla fine del 2013 dalla casa editrice ETS, nella pregevole traduzione di Claudia Furlanetto, che ha curato il volume arricchendolo con un’agile e chiara introduzione e con un’ampia intervista a René Major, filosofo molto vicino alla psicanalisi di orientamento lacaniano e amico personale di Derrida. È proprio Major a ricostruire la lunga gestazione degli Stati generali, da lui stesso promossi e organizzati con tre anni di lavoro preparatorio, ma concepiti sin dalla fine degli anni Settanta, ai tempi delle dittature in Brasile e in Argentina. L’esigenza più urgente di Major era stata allora quella di denunciare le opacità dei rapporti tra la psicoanalisi e il potere, che andavano dalla complicità vera e propria di alcuni analisti nei crimini commessi dagli apparati di stato, alle azioni dissuasive messe in atto da una parte delle istituzioni psicanalitiche per insabbiare lo scandalo. In seguito lo spazio del confronto si sarebbe ampliato, fino a portare in primo piano la questione del senso politico della psicoanalisi. Alla caduta dei regimi sudamericani non fece infatti seguito un’epoca di pace e rispetto dei diritti umani nel mondo; d’altra parte i primi a violarli erano e restavano in molti casi i cosiddetti baluardi della democrazia, data la presenza della pena di morte in diversi stati americani. Anche in questo caso, le dichiarazioni di denuncia da parte delle istituzioni psicanalitiche rimanevano vaghe, come se, al di là dell’opportunismo, si volesse evitare di assumere una precisa posizione di condanna. Come se la psicanalisi, rispetto al potere – in particolare al potere di far soffrire – dovesse mantenersi a distanza.
Derrida nel luglio 2000, in apertura degli Stati generali della psicoanalisi, occasione straordinaria di confronto tra psicoanalisti di tutto il mondo appartenenti alle diverse correnti del movimento psicoanalitico. La conferenza, uscita in Francia nel 2000 (Derrida 2000), è stata pubblicata in Italia alla fine del 2013 dalla casa editrice ETS, nella pregevole traduzione di Claudia Furlanetto, che ha curato il volume arricchendolo con un’agile e chiara introduzione e con un’ampia intervista a René Major, filosofo molto vicino alla psicanalisi di orientamento lacaniano e amico personale di Derrida. È proprio Major a ricostruire la lunga gestazione degli Stati generali, da lui stesso promossi e organizzati con tre anni di lavoro preparatorio, ma concepiti sin dalla fine degli anni Settanta, ai tempi delle dittature in Brasile e in Argentina. L’esigenza più urgente di Major era stata allora quella di denunciare le opacità dei rapporti tra la psicoanalisi e il potere, che andavano dalla complicità vera e propria di alcuni analisti nei crimini commessi dagli apparati di stato, alle azioni dissuasive messe in atto da una parte delle istituzioni psicanalitiche per insabbiare lo scandalo. In seguito lo spazio del confronto si sarebbe ampliato, fino a portare in primo piano la questione del senso politico della psicoanalisi. Alla caduta dei regimi sudamericani non fece infatti seguito un’epoca di pace e rispetto dei diritti umani nel mondo; d’altra parte i primi a violarli erano e restavano in molti casi i cosiddetti baluardi della democrazia, data la presenza della pena di morte in diversi stati americani. Anche in questo caso, le dichiarazioni di denuncia da parte delle istituzioni psicanalitiche rimanevano vaghe, come se, al di là dell’opportunismo, si volesse evitare di assumere una precisa posizione di condanna. Come se la psicanalisi, rispetto al potere – in particolare al potere di far soffrire – dovesse mantenersi a distanza. -
La macchina ineludibile
Longform / Aprile 2015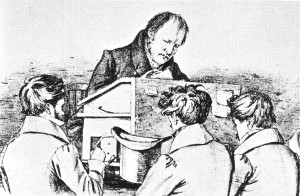 In un testo apparso nel 1992 in un volume collettivo, «Nous autres Grecs», Jacques Derrida, riferendosi all’intero gruppo dei filosofi oggi noti come post-strutturalisti, osserva che essi si raccolgono «sotto il segno della differenza, e di una differenza, così come di un simulacro, non dialettizzabile». Dopo aver sottolineato quella che definisce «tale resistenza, io direi quasi tale allergia, ma non opposizione, tale risposta testarda (differenziale, non dialettica) alla dialettica», conclude:
In un testo apparso nel 1992 in un volume collettivo, «Nous autres Grecs», Jacques Derrida, riferendosi all’intero gruppo dei filosofi oggi noti come post-strutturalisti, osserva che essi si raccolgono «sotto il segno della differenza, e di una differenza, così come di un simulacro, non dialettizzabile». Dopo aver sottolineato quella che definisce «tale resistenza, io direi quasi tale allergia, ma non opposizione, tale risposta testarda (differenziale, non dialettica) alla dialettica», conclude:Questa resistenza è in comune non soltanto a Deleuze e a me […], ma anche a Foucault, Lyotard e altri ancora. È stata conquistata, si potrebbe dire strappata, sempre senza fine, a un dialetticismo ereditato. Ciò che essa ha – piuttosto che rovesciato – spostato, deformato, non è stata soltanto la dialettica hegeliana, neo-hegeliana o marxista, è stata in primo luogo la dialetticità di provenienza platonica. (Derrida, 1992a, p. 257-258).[1]
-
La modernità di NietzschePer capirci qualcosa di più del mondo in cui viviamo bisogna leggere Nietzsche.
 Sapere che il Fascismo di Mussolini e il Rock psichedelico di Jim Morrison sono nati nel segno del filosofo tedesco – se coerentemente o meno è un altro discorso – spinge in questa direzione, ed è il motivo dell’interesse di Maurizio Ferraris per questa figura e la ragion d’essere di Spettri di Nietzsche. Un’avventura umana e intellettuale che anticipa le catastrofi del Novecento (anche se i Doors più che una catastrofe sono una benedizione). Non c’è dubbio, il Novecento (ma anche questo primo scampolo di nuovo millennio) è un secolo nietzscheano, il secolo della volontà di potenza, quella volontà, essenza dell’individualismo, che contraddistingue i contemporanei – che cosa sarebbero altrimenti i Talent Show? È Ferraris stesso ad aprire il suo libro con questa precisazione, umanizzando e attualizzando – che più attuale non si può – il pensiero di un uomo che ha vissuto sulla sua pelle e sui suoi nervi il tempo che annunciava: «fuori dalle trincee la volontà di potenza è anzitutto volontà di presenza e ansia di riconoscimento. Nietzsche coglie, esprime e anzitutto incarna una caratteristica essenziale della modernità, l’aspirazione collettiva a essere straordinari» (p. 15). Perché «aveva ragione sua sorella Elisabeth, Fritz voleva diventare famoso, e lo desiderava con la stessa mancanza di decoro di un ammalato di celebrità» (p. 7). In una lettera a Paul Deussen dell’11 dicembre 1888 egli scrive che si sentiva «come se il destino dell’umanità fosse nelle [sue] mani» (p. 9). In un certo senso ci aveva preso. Considerato che oggi siamo ancora qui a parlare di lui, se avesse pensato e agito diversamente forse in questo momento ragioneremmo altrettanto diversamente.
Sapere che il Fascismo di Mussolini e il Rock psichedelico di Jim Morrison sono nati nel segno del filosofo tedesco – se coerentemente o meno è un altro discorso – spinge in questa direzione, ed è il motivo dell’interesse di Maurizio Ferraris per questa figura e la ragion d’essere di Spettri di Nietzsche. Un’avventura umana e intellettuale che anticipa le catastrofi del Novecento (anche se i Doors più che una catastrofe sono una benedizione). Non c’è dubbio, il Novecento (ma anche questo primo scampolo di nuovo millennio) è un secolo nietzscheano, il secolo della volontà di potenza, quella volontà, essenza dell’individualismo, che contraddistingue i contemporanei – che cosa sarebbero altrimenti i Talent Show? È Ferraris stesso ad aprire il suo libro con questa precisazione, umanizzando e attualizzando – che più attuale non si può – il pensiero di un uomo che ha vissuto sulla sua pelle e sui suoi nervi il tempo che annunciava: «fuori dalle trincee la volontà di potenza è anzitutto volontà di presenza e ansia di riconoscimento. Nietzsche coglie, esprime e anzitutto incarna una caratteristica essenziale della modernità, l’aspirazione collettiva a essere straordinari» (p. 15). Perché «aveva ragione sua sorella Elisabeth, Fritz voleva diventare famoso, e lo desiderava con la stessa mancanza di decoro di un ammalato di celebrità» (p. 7). In una lettera a Paul Deussen dell’11 dicembre 1888 egli scrive che si sentiva «come se il destino dell’umanità fosse nelle [sue] mani» (p. 9). In un certo senso ci aveva preso. Considerato che oggi siamo ancora qui a parlare di lui, se avesse pensato e agito diversamente forse in questo momento ragioneremmo altrettanto diversamente.Nietzsche, un’interpretazione
Ferraris – si avverte pagina dopo pagina – nutre un certo affetto per Nietzsche, come fosse un amico, forse vecchio rivale, comunque molto stimato. D’altronde non c’è filosofo del Novecento che non abbia fatto i conti con quest’uomo geniale. I conti, questo libro ne è la resa: Ferraris ripercorre l’intera vita filosofica del collega tedesco, i suoi lasciti, le sue micce, poi accese da qualcun altro, e la dinamite che è esplosa lontana dai suoi occhi. È lui, in fin dei conti, il padre del postmoderno, l’autore di quella frase: “non ci sono fatti, solo interpretazioni”, contro cui lotta il nuovo realismo ferrarisiano. Con questo concetto Ferraris ci mostra come per Nietzsche «la realtà [sia] socialmente costruita, nulla esiste fuori dal testo, il sapere è solo un effetto di potere, il mondo si guarda da infinite prospettive che corrispondono ai nostri bisogni vitali in conflitto tra loro, non ci sono cose in sé, ma solo in relazione a osservatori» (p. 83). È questo cambio di paradigma la vera catastrofe di cui parla Ferraris nel sottotitolo del libro? Quella da cui sono potute nascere tutte le catastrofi reali che hanno segnato il XX° secolo? E sarà davvero giunto il tempo di voltare pagina? Difficile a credersi. Ma come la mettiamo allora con il global warming, lo spread, il cancro, l’Olocausto? Sono solo interpretazioni?

Volontà di potenza e di politica
Anzitutto bisogna fare i conti col Nietzsche politico, una storia che non finirà mai, perché impossibile da chiarificare. Chi lo vuole di destra, ideologo del nazionalsocialismo di Hitler – o colui che contribuì alla sua nascita – e della sua sfrenata volontà di dominio; chi lo vuole invece di sinistra, rivoluzionario – non a caso le sue opere, oltre che in quella di Hitler, comparivano nella biblioteca di Mitterrand. Dice Lukács che gli «intellettuali potranno sostituire al socialismo l’annuncio di Zarathustra, cioè la promessa di un cambiamento ancora più grande e più indeterminato, di un futuro e di un dio a venire» (p. 45). Chi considera la sua nazificazione un errore dettato dal travisamento del suo pensiero allegorico o semplicemente dalle interpolazioni faziose apportate all’opera dalla sorella Elisabeth. Una cosa è certa, Nietzsche è morto nel 1900 e non ha mai sentito parlare di Hitler. Ciò, ovviamente, non significa che i nazisti non abbiano avuto alcun appiglio per rifarsi al padre di Zarathustra: Ferraris, considerate l’opera di Nietzsche, ci dice che era davvero reazionario, e che i pensieri di cui si appropriarono i nazisti non provenivano dalla tanto discussa e postuma Volontà di potenza, ma soprattutto dalle opere edite. In realtà ci dice anche che l’unica vera falsificazione della sorella è stata quella di spacciarsi per principale interlocutrice del fratello, quando invece lui la odiava. Come si sa, l’unica obiezione di Nietzsche all’eterno ritorno erano proprio loro, la madre e la sorella.
Per Ferraris «Nietzsche è stato tutto, tranne che un impolitico», i suoi «principi risultano iper-fungibili dal punto di vista politico, appunto perché l’essere diviene anzitutto un fare, un combattere, un trasformare. Il che, in una fase rivoluzionaria, può risultare allettante sia per una squadra di spartachisti che per dei Freikorps antibolscevichi» (p. 43). Inoltre «il pensiero di Nietzsche non porta a un prospettivismo radicale, bensì a una gerarchizzazione dei valori» (p. 130), perché per lui «[…] il vero filosofo è colui che forgia nuovi valori» (p. 131). Zarathustra/il superuomo ha trovato la verità, ovvero che non esiste verità, ma solo volontà di potenza. Di qui la sua autorità.
Nichilismo e imipramina
Il libro di Ferraris, che si muove a salti spaziali e temporali, in una connessione di idee trasformata in elegante opera letteraria, a un tratto ci proietta nel 1956, all’interno dell’ospedale di Münsterlingen, dove lo psichiatra Roland Kuhn stava scoprendo, per caso, l’effetto antidepressivo dell’imipramina. E se quello che Nietzsche chiamava “nichilismo” fosse stata solo una sorta di depressione curabile coi farmaci, si chiede provocatoriamente Ferraris? E se Nietzsche avesse incontrato Kuhn, oggi cosa leggeremmo sui libri di storia della filosofia? Di sicuro nel nichilismo di cui parla il filosofo tedesco c’è molto di suo, di quello che avvertiva dentro di sé – e qui siamo di nuovo a fare i conti con la modernità nietzschena di cui si parlava all’inizio.
Eterno ritorno, eterno disguido
A Silvaplana sulla soglia di una casa, nel 1993, Ferraris scoprì questa scritta in retoromanzo: “Tieu destin tũ poust amer e perfin sch’el es amer”. Bisogna amare il proprio destino anche se amaro. Ecco qui l’eterno ritorno, “la suprema formula dell’affermazione che possa mai essere raggiunta”, frutto della profonda trasformazione spirituale nietzscheana avvenuta nel 1881, appunto, a Silvaplana, vicino Sils Maria, in Svizzera. Ma quest’idea, ripresa dai greci e dal pensiero orientale, può avere una qualche scientificità?
 Borges, in Storia dell’eternità (1936), rifacendosi alle teorie degli insiemi di Cantor, prova a rispondere a questa domanda, concludendo che «se l’universo consta di un numero infinito di termini, è rigorosamente capace di un numero infinito di combinazioni; e la necessità di un ritorno viene annullata» (p. 135). Ferraris sembra concordare con Borges. Va però detto gli atomi dell’universo sono oggi valutati dalla scienza in 10 alla 80: numero altissimo, ma pur sempre finito, che non smentisce quindi l’ipotesi nietzscheana. Tuttavia l’eterno ritorno rimane una contraddizione all’interno del pensiero di Nietzsche, e questo Ferraris lo spiega bene: da una parte vuol essere l’abbandono di ogni finalismo, contro la teleologia occidentale, una proclamazione della libertà di movimento della Terra, astro tra gli astri; dall’altra però «propugna un finalismo iperbolico, per il quale il filosofo, in veste di istitutore di valori, “crea” – leggiamo nello Zarathustra, “Di antiche tavole e nuove” – “la mèta dell’uomo e dà alla terra il suo senso e il suo futuro”» (p. 140).
Borges, in Storia dell’eternità (1936), rifacendosi alle teorie degli insiemi di Cantor, prova a rispondere a questa domanda, concludendo che «se l’universo consta di un numero infinito di termini, è rigorosamente capace di un numero infinito di combinazioni; e la necessità di un ritorno viene annullata» (p. 135). Ferraris sembra concordare con Borges. Va però detto gli atomi dell’universo sono oggi valutati dalla scienza in 10 alla 80: numero altissimo, ma pur sempre finito, che non smentisce quindi l’ipotesi nietzscheana. Tuttavia l’eterno ritorno rimane una contraddizione all’interno del pensiero di Nietzsche, e questo Ferraris lo spiega bene: da una parte vuol essere l’abbandono di ogni finalismo, contro la teleologia occidentale, una proclamazione della libertà di movimento della Terra, astro tra gli astri; dall’altra però «propugna un finalismo iperbolico, per il quale il filosofo, in veste di istitutore di valori, “crea” – leggiamo nello Zarathustra, “Di antiche tavole e nuove” – “la mèta dell’uomo e dà alla terra il suo senso e il suo futuro”» (p. 140).Che cos’è allora, per Nietzsche, l’eterno ritorno? È anche questo frutto della sua modernità, del suo essere interiore che non può che traboccare nel mondo per renderlo a sua immagine? Ferraris, candidamente, risponde: l’eterno ritorno è «una religione per il mondo secolarizzato, un mito qualunque, quasi un pretesto per predicare, di certo un gesto per scacciare l’orrore un po’ più in là» (p. 144).
Illuminismo + LSD = catastrofe
Un mito, appunto. Proprio come scrivono Adorno e Horkheimer in Dialettica dell’illuminismo (1947), l’“illuminismo nietzscheano” è un ritorno al mito, alla tragedia, al dionisiaco, volto a distruggere il nesso sapere-progresso-felicità figlio del racconto socratico riproposto nella modernità proprio dall’illuminismo “classico”, quello di Kant e Rousseau. Nietzsche, che detestava Rousseau, invece, guarda più a Sade, a Laclos, a Crébillon. La volontà di potenza è tutto quello che c’è da sapere per capire il mondo: «ogni forma di sapere va guardata con sospetto, appunto in quanto espressione di una qualche forma di potere» (p. 152), e quindi il sapere, che dovrebbe emancipare, produce allo stesso tempo potere, cioè subordinazione e dominio. La soluzione? Non sapere (ovviamente non alla maniera socratica), rituffarsi nel mito, nel dionisiaco perduto. Insomma, il Nietzsche che emerge qui non è un illuminista, ma un dispensatore di segreti per “imparare a vivere” secondo la sua “dottrina”. Altro che spronare a pensare con la propria testa!
E questo dionisiaco dove lo troviamo? Ferraris, ancora una volta, immagina gli effetti che avrebbe prodotto l’LSD, sintetizzato soltanto nel 1943 a Basilea (stessa città in cui venne concepita La nascita della tragedia) da Albert Hoffman, su Nietzsche. Ma dovremo accontentarci degli effetti, non affatto malvagi, prodotti su Jim Morrison, ma anche su Foucault.
Qui Ferraris azzarda e finalmente fa esplicito riferimento a quello a cui tutti noi pensiamo quando sentiamo pronunciare la parola catastrofe in riferimento al Novecento. Ovvero Hitler. Il sottotitolo del libro significa proprio quello che intuitivamente credevamo. È però al plurale – catastrofi – per cui riempitelo come preferite, avete l’imbarazzo della scelta. Ad ogni modo i nazisti, a Nietzsche, non “rubarono” solo concetti, ma anche la necessità dell’esperienza del superamento del limite razionale, verso l’immortalità (o la morte): «tra la patria mitica e la catastrofe il passo è breve, e se Hitler ha saputo incantare i tedeschi, e non solo loro, è perché nel suo orizzonte c’era qualcosa di straordinariamente simile al “corteo dionisiaco” di cui parla Nietzsche» (p. 179).
Ma le responsabilità di Nietzsche e di Hitler sono molto diverse fra loro; Ferraris lo mette in luce citando le parole di un uomo che ripugnava entrambi, Primo Levi: «[in Nietzsche] mi pare che non compaia mai il desiderio della sofferenza altrui. L’indifferenza sì […], ma mai […] la gioia per il danno del prossimo, né tanto meno la gioia del far deliberatamente soffrire. Il dolore del volgo […], degli informi, dei non-nati-nobili, è un prezzo da pagare per l’avvento del regno degli eletti; è un male minore […]; non è desiderabile in sé. Ben diversi erano il verbo e la prassi hitleriani» (p. 196).
***
Spettri di Nietzsche non è un libro per chi è digiuno del pensiero del filosofo tedesco, che non saprebbe come raccapezzarsi tra gli sbalzi temporali di Ferraris, il quale mostra una profonda conoscenza delle tematiche che tratta. In realtà è proprio questo che rende la lettura stimolante: lo star dietro a un brillante incedere tra connessioni di idee di cultura “alta”, prettamente filosofico-accademica, e cultura pop. D’altronde, abbiamo imparato a conoscerlo, è esattamente questa la cifra di Ferraris.
di Stefano Scrima
-
Aut Aut vol. 361 – La condizione postumana
Recensioni / Luglio 2014 L’intento del numero 361 di “aut aut”, intitolato La condizione postumana, come si legge nella Premessa del curatore Giovanni Leghissa, è quello di esplorare con prudenza le potenzialità filosofiche della prospettiva postumanista. In tal senso, gli articoli presenti nel fascicolo hanno l’obiettivo di cartografare una «specifica costellazione teorica» (p. 5) in grado di licenziare l’uomo dal mestiere di «unico custode della casa dell’essere» (p.5), ponendolo invece sullo stesso piano degli altri viventi e degli oggetti inanimati. Per comprendere appieno le implicazioni di tale prospettiva, Leghissa indica tre passi in avanti che risultano necessari: 1) un posizionamento letteralmente radicale dell’umano entro la dimensione dell’animalità, in modo tale che l’uomo possa «cominciare a leggere la propria storia nell’ottica di un darwinismo dotato di valenze quasi-trascendentali» (p. 6); 2) correlatamente al primo, la declinazione del postumano in una cornice etica che giustifichi un rapporto paritetico con le altre specie animali; 3) la messa in questione dell’autonoma produttività dell’umano, specchio dell’infinita produttività della Natura, al fine di «ripensare il sociale come ambiente in cui umani e artefatti (e, ovviamente, animali) interagiscono formando vari livelli di realtà» (pp. 6-7). Gli articoli presentati dal curatore, come ricorda egli stesso, non hanno l’ambizione di coprire integralmente la portata di questi tre passi, ma rappresentano, ciascuno a suo modo, dei validi strumenti per una ricognizione assolutamente non superficiale della questione postumana.
L’intento del numero 361 di “aut aut”, intitolato La condizione postumana, come si legge nella Premessa del curatore Giovanni Leghissa, è quello di esplorare con prudenza le potenzialità filosofiche della prospettiva postumanista. In tal senso, gli articoli presenti nel fascicolo hanno l’obiettivo di cartografare una «specifica costellazione teorica» (p. 5) in grado di licenziare l’uomo dal mestiere di «unico custode della casa dell’essere» (p.5), ponendolo invece sullo stesso piano degli altri viventi e degli oggetti inanimati. Per comprendere appieno le implicazioni di tale prospettiva, Leghissa indica tre passi in avanti che risultano necessari: 1) un posizionamento letteralmente radicale dell’umano entro la dimensione dell’animalità, in modo tale che l’uomo possa «cominciare a leggere la propria storia nell’ottica di un darwinismo dotato di valenze quasi-trascendentali» (p. 6); 2) correlatamente al primo, la declinazione del postumano in una cornice etica che giustifichi un rapporto paritetico con le altre specie animali; 3) la messa in questione dell’autonoma produttività dell’umano, specchio dell’infinita produttività della Natura, al fine di «ripensare il sociale come ambiente in cui umani e artefatti (e, ovviamente, animali) interagiscono formando vari livelli di realtà» (pp. 6-7). Gli articoli presentati dal curatore, come ricorda egli stesso, non hanno l’ambizione di coprire integralmente la portata di questi tre passi, ma rappresentano, ciascuno a suo modo, dei validi strumenti per una ricognizione assolutamente non superficiale della questione postumana.Invece di descrivere sinteticamente tutti i saggi del numero, si preferisce in questa sede lasciar parlare gli autori i cui saggi sono sembrati, agli occhi del lettore che scrive, più intimamente intrecciati tra loro. Prima però di cominciare una sorta di trailer cinematografico, pare comunque necessario segnalare le linee di fuga dal discorso maggiore che gli altri studiosi, singolarmente, hanno intrapreso – anche perché i temi, le prospettive e gli autori coinvolti risultano euristicamente importanti al fine di un arricchimento di quella costellazione teorica segnalata dal curatore.
Innanzitutto, proprio per evitare frettolose ingenuità rispetto al significato della prospettiva postumanista, risulta importante il saggio di Marina Maestrutti, Potenziati ma inadatti al futuro. Dal cyborg felice al cyborg virtuoso, per la sua disamina critica del rapporto tra postumano e potenziamento somato-cognitivo che – essendo spesso declinato nei termini del superamento dei limiti umani – ha finito per produrre visioni al confine con l’escatologico. Discorso, quello dei limiti, che in un’ottica postumanistica pare più proficuo emendare nella prospettiva ibridativa delle soglie, perfino tra vivente e non vivente, sia essa impersonata dal cyborg o, come nel caso del suggestivo saggio di Rocco Ronchi, Figure del postumano. Gli zombi, l’onkos e il rovescio del Dasein, dallo zombi, che viene condotto fino al varco della casa heideggeriana per bussare alla porta del Dasein.
Due autori sicuramente importanti, per comprendere la natura ibridativa e letteralmente tecno-logica dell’uomo, sono poi Hans Blumenberg e il suo dialogo differenziale – in quanto sempre al tempo stesso critico, seguace e prosecutore – con l’antropologia filosofica tedesca, e Gilbert Simondon, il quale, forse più acutamente di chiunque altro, ha sviluppato un’autentica filosofia della tecnica volta a indicare un nuovo rapporto ontologico tra psiche, società e oggetti tecnici. I saggi a loro dedicati, entrambi puntuali, lucidi e ben argomentati, sono di Francesca Gruppi (Animal symbolicum e uomo toolmade. Hans Blumenberg tra umanesimo e post-umanesimo) e di Fabio Minazzi (“Salire sulle proprie spalle”? Simondon e la trasduttività dell’ordine del reale). Francesco Monico, in Premesse per una costituzione ibrida: la macchina, la bambina automatica e il bosco, sulla scorta di Latour – ma anche di Deleuze e Guattari, che a ben vedere risultano tra i più interessanti in-formatori della prospettiva postumanistica – prova in modo anche originale a tracciare una riformulazione delle categorie dell’agentività in favore di una coabitazione politica dei collettivi formati da umani e non-umani e, perciò, in vista di un’ecologia tecno-sociale tanto necessaria quanto ancora distante dall’essere esaurientemente formulata.
A chiudere il volume, un interessante dibattito guidato da Marco Bacini e intitolato Il sapere nella rete, che vede protagonisti Stefano Moriggi e Raffaele Simone; la discussione, arricchita dalle esperienze didattiche personali, cerca di superare la contrapposizione tra tecno-entusiasti e apocalittici del XXI secolo – un approccio farmacologico direbbe Bernard Stiegler – e, pur nelle differenze non occultabili tra gli interlocutori, il tentativo sembra riuscito.
Veniamo ora al trailer del discorso cosiddetto maggiore, anche se, come vedremo, è fruttuosamente lungi dal risultare unitario. Il composito e articolato saggio di Leghissa, Ospiti di un mondo di cose. Per un rapporto postumano con la materialità, ha la seria intenzione di rileggere il rapporto tra l’uomo e gli oggetti di cui il suo mondo è costellato. Il punto teorico generale da cui parte l’argomentazione di Leghissa è che, se la riflessione filosofica ha articolato la questione della posizione dell’uomo nel cosmo nei termini di un privilegio nei confronti tanto dell’animale non umano quanto della sfera degli oggetti materiali, la componente essenziale, di una prospettiva postumanistica va ricercata nella costruzione di alternative a questa tesi. In particolare, se l’umanismo ha fatto suo il motto protagoreo che vuole l’uomo a misura di tutte le cose, Leghissa suggerisce di rileggere tale prospettiva «nel quadro di un “darwinismo trascendentale”» (p. 11) che scalzerebbe l’animale umano dalla posizione di osservatore esterno, distaccato e, perciò, privilegiato: «L’uomo, in virtù delle strutture cognitive di cui si è dotato nel corso della propria evoluzione biologica, si pone come il solo osservatore in grado di conferire senso a quell’insieme di fenomeni che le suddette strutture cognitive rendono visibili. […] Si tratta, più profondamente, di prendere sul serio il fatto che il mondo che appare a un rettile (tanto per nominare un vertebrato a noi filogeneticamente prossimo) non ha le stesse caratteristiche del mondo che appare a homo sapiens – pur restando, ontologicamente, lo stesso mondo» (pp. 11-2). Intrecciando con sicurezza la riflessione heideggeriana sulla cosalità con la teoria dell’attore-rete di Latour, e distillando una folta schiera di riferimenti antropologici, psicologici, biologici, neurologici e archeologici, Leghissa prova a far emergere una prospettiva ecologica filosoficamente forte che sia in grado di legare umani, animali non umani, oggetti tecnici e istituzioni per fornire una strada politica, dunque sempre da rimettere in discussione, alternativa a qualsiasi teleologia della modernità e rivolta invece alla sperimentazione di nuovi rapporti tra gli attori umani e non, in vista di «scenari istituzionali inediti» (p. 33).
Roberto Marchesini, da anni e con straordinari risultati teorici, porta avanti la prospettiva postumanista in chiave filosofica, ragion per cui le poche citazioni qui riportate non possono in alcun modo restituire la genuinità dei suoi lavori. Punto di partenza di Alla fonte di Epimeteo è che la questione postumana, piuttosto che indicare l’uscita dalla dimensione umana da parte dell’uomo, segnala la necessità di «una riflessione sull’evoluzione della condizione umana» (p. 35). In modo brillante l’autore si impegna altresì a chiarire e a distinguere il termine postumanistico rispetto ai programmi o ai progetti di transumanazione o di iper-umanesimo, «attribuibili più alla fantascienza che all’analisi filosofica» (p. 36) e fondati su di una concezione amniotica e depurativa della tecnologia. In tal senso, la prospettiva filosofica che Marchesini definisce postumanista «si propone una nuova lettura dell’umano che va oltre il qui e ora dell’emergenza informatica e biotecnologica, […] per offrire una versione differente di una storia, quella umana, ormai non più credibile nei canoni mitopoietici della frontiera» (p. 38); una storia, dunque, che mette al centro le alleanze interspecifiche e le soglie di mutazione.
Il postumanismo, lungi dall’essere un processo di epurazione, è infatti per Marchesini una prospettiva ibridativa e coniugativa, fondata sulla contaminazione con le alterità, tanto a livello biologico ed ecologico, quanto epistemico e, appunto, filosofico. Il ruolo della tecnica e della tecnologia è allora emancipativo, non nei confronti della Natura e delle alterità animali, bensì rispetto all’uomo stesso – sul piano epistemologico – nella stretta misura in cui «l’ibridazione con uno strumento tecnologico è già una messa in mora della prospettiva antropocentrata perché consente all’essere umano di andare oltre il modello interpretativo filogenetico» (p. 47), il quale non è assolutamente oggettivo né tanto meno universale, bensì parziale e specializzato, in quanto espressione di «un particolare posizionamento sul mondo» (p. 47). La parola d’ordine della prospettiva postumanista è allora antropodecentrarsi, ossia «riconoscere tanto nell’antropopoiesi quanto nella propria identità individuale il concorso contaminativo delle alterità» (p. 51).
In Al di là del principio di realtà: sulla Vita Artificiale, Davide Tarizzo mette al centro del suo intervento la nozione di Vita astratta e lo fa partendo dalla considerazione di Ivan Illich, secondo cui saremmo «di fronte all’apparizione di una sorta di giustificazione ultima che serve a farci amministrare da un nuovo clero, un clero manageriale, pianificatore, dittatoriale, peggiore di tutto ciò che finora eravamo riusciti a immaginare» (p. 72). La giustificazione a cui Illich fa riferimento è la Vita, proprio quella con la V maiuscola, e che Tarizzo personifica nella Vita Artificiale. Invece di scovare il segreto della Vita Artificiale nell’informatica, Tarizzo propone di leggere tale fenomeno con le lenti della biologia e dell’economia. Del resto, «la Vita è quel costrutto scientifico, o quella moderna astrazione scientifica, sullo sfondo della quale l’idea stessa di vita artificiale diventa concepibile per gente come noi» (p. 73). Partendo allora da una prospettiva neodarwiniana, che tiene comunque come punto saldo lo studio delle popolazioni a scapito dei singoli, Tarizzo afferma in primis che «qualcosa di vivo è qualcosa che può comportarsi male e può correggere il suo comportamento. In un certo senso, qualcosa di vivo è qualcosa che già sempre si sta comportando male e già sempre sta lottando per comportarsi meglio, per migliorare le sue performance comportamentali» (p. 74), a partire dai propri errori, come ha saputo mostrare magistralmente Canguilhem. Prendendo atto che il comportamento risulta essere la categoria imprescindibile e fondamentale per comprendere la vita in termini di evoluzione, e che dunque la scienza della vita è essenzialmente una scienza del comportamento, Tarizzo mette in atto una strategia comparativa, per cui, sulla scia di Christopher Langton, descrive la Vita artificiale come lo studio dei sistemi costruiti dall’uomo i cui comportamenti risultano analoghi a quelli dei sistemi viventi naturali; come per la biologia evolutiva, tali comportamenti sono frutto di processi di potenziamento del comportamento popolazionale, ossia dell’azione della Vita astratta che, seguendo in questo caso von Neumann, risulta perciò «la condizione – o la categoria a priori – necessaria per poter concepire, o immaginare, una Vita artificiale» (p. 77).
Correggere gli errori o i difetti è dunque espressione della forza autotelica della vita, e Tarizzo sottolinea come la parola più adatta a descrivere questo processo sia «ottimizzazione comportamentale» (p. 77); e ottimizzazione è la parola chiave, del resto, in biologia, nel campo della Vita artificiale e, a maggior ragione, in economia. Ecco allora sopraggiungere il dato problematico di fronte al quale si muove l’intelligente analisi di Tarizzo che, questa volta, segue le analisi dell’economista Gary Becker: «Se la vita in quanto tale si può decifrare in termini di ottimizzazione, e se l’ottimizzazione stessa è la legge generale dell’economia, allora ogni espressione della vita umana, vale a dire ogni comportamento umano, può essere letto e interpretato attraverso la lente dell’approccio economico» (p. 78) e, in tal senso, oggi può sostituire tutto ciò che, della vita naturale, non corrisponda ad adeguati criteri di ottimizzazione rispetto all’ambiente tecnologico in cui viviamo. Questo processo apre allora a considerazioni inquietanti circa «la fine della vita umana, da sacrificare sull’altare della Vita Artificiale» (p. 80). Tarizzo infine si domanda se davvero l’economia come ottimizzazione comportamentale possa descrivere la Vita; l’inizio di risposta viene dalla concezione autolesiva e sintomatologica della Vita sviluppata da Freud, il quale sembra offrire l’anticorpo adeguato al sogno/incubo della Vita artificiale. In tal senso, Tarizzo può affermare che «il sogno, o l’incubo, della Vita Artificiale sembra allora ridursi a un sintomo collettivo, sociale, storico di un malessere collettivo, sociale, storico che esprime un segreto squilibrio – il disagio e l’angoscia di una intera civiltà, la nostra, invisibile a se stessa e in lotta con se stessa, prostrata davanti a un nuovo dio oscuro, il Dio Astratto della Vita Artificiale» (p. 81).
Il saggio di Antonio Lucci, Primi passi nel Postum(i)ano, ha come punto di partenza la prospettiva della storicità degli a priori, che viene ricostruita utilizzando autori anche molto eterogenei come Konrad Lorenz, Arnold Gehlen, Bernard Stiegler e il neuroscienziato Julian Jaynes. Dalle lenti colorate, frutto di processi biologico-adattativi attraverso cui, per Lorenz, guardiamo il mondo, agli a priori acquisiti di Gehlen, dall’epifilogenesi di Stiegler, basata sull’esteriorizzazione materiale della memoria come volano antropopoietico, all’origine storico-sociale della coscienza teorizzata da Jaynes, tutto sembra convergere verso una radicale messa in questione della soggettività trascendentale o di una signoria conoscitiva del soggetto umano fondata su di una sua immutabilità, l’occhio fisso sul mondo: «Tutte le speculazioni sul “soggetto” tanto tornate in auge con la diffusione delle scienze cognitive perdono di consistenza di fronte a un impianto apriorico fluido, storico e mobile, che non solo struttura in maniera fondante le coscienze e gli apparati percettivi degli uomini (cosa scontata parlando di apriori), ma che è esso stesso in costante mutamento insieme all’orizzonte storico degli eventi» (p. 135). Lucci affronta poi un secondo elemento di analisi, quello più specificamente relativo al senso del post in postumano; non solo come prefisso problematico in sé, ma come condizione del suo stesso discorso: «come parlare da dopo l’umano, permanendo umani?» (p. 138). Passando per una breve ma efficace digressione sul (non)rapporto della lingua tedesca con il prefisso post, Lucci giunge a proporre l’espressione coniata da Sloterdijk, che dà il titolo al saggio: postumiano. Seguendo Sloterdijk, e provando anche a proseguirne lo sguardo, l’autore afferma che «il termine “postumiano” invita a riflettere su che cosa possa significare porsi in un’epoca dell’umano diversa dalla nostra, in cui persino il concetto di umanità venga “infettato” dall’aggiunta supplettiva di una protesi, di un elemento dissonante (quella “i” così inopportuna) che ci proietta automaticamente in una dimensione altra rispetto a quella che abbiamo finora vissuto» (p. 139).
Nel caricare di senso questo neologismo, l’argomentazione di Lucci è senz’altro suggestiva. Se con umano si è soliti definire quello specifico animale «che ancora vive e subisce l’influsso categoriale e percettivo delle macrorivoluzioni nel comportamento e nell’organizzazione dei gruppi avute con la rivoluzione neolitica», che ha condotto l’umanità alla stanzializzazione, all’allevamento e all’agricoltura, con tutto il corredo di condizioni di esperienza e di forme di vita che hanno caratterizzato le società, tutto questo sembra dissolversi definitivamente: «Negli ultimi trent’anni l’uscita dal Neolitico si è fatta sempre più palese, incarnandosi nella quotidianità degli individui, trasformandone le abitudini e le forme di vita» (pp. 139-40). Se fino a poco fa il singolo tendenzialmente parlava una sola lingua, viveva tutta la vita in un solo luogo, utilizzava gli stessi media da secoli o da millenni, aveva le stesse credenze e convinzioni dei propri avi, oggi è normale parlare più lingue quotidianamente, viaggiare in continuazione e coprire distanze un tempo inimmaginabili, potendo portare con sé tutta la sfera egopersonale di dati e documenti con il minimo dispendio di spazio ed energia (penne usb, smartphone, ecc.) e rimanendo connesso con una rete di contatti potenzialmente sterminata: «Tutte queste modalità di rapporto […] rappresentano una rottura con il mondo neolitico dei nostri progenitori, che permane nelle sue strutture e Weltanschauungen e che influenza anche gli abitatori del Postumiano» (p. 142), i quali soffrono e subiscono i disagi di tale transizione, che, per quanto già in atto, non ci è dato sapere se e quando sarà definitivamente compiuta.
Nel saggio Di un sintomo e alcune appartenenze, Fabio Polidori rileva una certa fretta teorica e metodologica nell’area/aria intellettuale che, seppur nella sua eterogeneità anche irrisolvibile, sembra esprimere una comune ansia di collocare l’umano nel suo futuro, nel suo post. Tale fretta, che si esprime proprio in questo prefisso, è letta da Polidori come il sintomo di «una insofferenza, addirittura di un’ansia nei confronti di ciò che avvertiamo, magari inconsapevolmente, come un assillo anche per il futuro. Come se, in altri termini, la posizione di una nuova linea di demarcazione, di un’inedita soglia oltre la quale staremmo per saltare, riuscisse immediatamente a liberarci dai vincoli di tutte quelle altre soglie e differenze a partire dalle quali si è articolata la riflessione sull’“identità” dell’umano e dell’uomo, quanto meno a partire dal momento a vario titolo inaugurale della modernità» (p. 165-6). Ecco allora che l’autore moltiplica le precauzioni per non cadere nella trappola della fretta; precauzioni, del resto, assolutamente necessarie all’inquadratura della condizione postumana, tra cui chiaramente quelle relative ai due termini che compongono tale significante. In particolare, Polidori sostiene che «dietro a parecchio di ciò che si racchiude nel “postumano” e lo alimenta, continui a lavorare in maniera ancora più massiccia […] l’istanza dell’“umano” per eccellenza, l’istanza dell’identità con se stesso, della propria immagine, della propria riconoscibilità» (p. 168).
Al tempo stesso, però, Polidori riconosce che negli ultimi decenni si è verificata la necessità teorica di un «progressivo avvicinamento» tra uomo e animale, così come tra uomo e tecnologia, che deve essere inteso come il segnale di una coappartenenza letteralmente essenziale, e non accessoria. In tal senso, inoltre, l’autore sottolinea che «la diversa modalità di coappartenenza alla tecnica è difficilmente pensabile come del tutto avulsa da una diversa modalità di coappartenenza alla dimensione animale» (p. 177). Nietzsche aveva già in qualche modo prefigurato questa trasformazione, sebbene senza poterne trarre le dovute conseguenze, in particolare per ciò che concerne la natura biologicamente condizionata del logos, dunque evolutiva ed essenzialmente instabile. Con Nietzsche, ma anche oltre Nietzsche, ci sarebbe allora data l’opportunità di «pensare l’uomo (e l’umano) come ciò la cui stabilità è data dal suo essere instabile, dal suo appartenere a un costante e progressivo prendere le distanze da sé» (p. 178). Se tali considerazioni autorizzano con molta probabilità a parlare dell’uomo, sulla scia di Sloterdijk, come di un acrobata, Polidori mette in luce il rischio che si corre a far saltare troppo in alto l’umano, ossia slegarlo una volta di più dalla sfera animale. Tale rischio si corre se consideriamo l’acrobatico una dimensione esclusiva dell’uomo, mentre la prospettiva postumana, come i vari autori hanno cercato di mettere in evidenza in questo numero di “aut aut”, dovrebbe considerare «l’uomo come ciò che appartiene all’acrobatico: ossia al corpo, al vivente, al potenziamento di sé, insomma all’animale e al vitale» (p. 179). Quest’ultimo suggerimento, sottile e ben calibrato, sembra convergere con la critica mossa nel contributo di Marchesini all’antropotecnica di Sloterdijk, che risulta un’auto-proiezione elevativa dei destini umani, dal momento che «ci mostra un uomo artista, acrobata lungo un filo che lo innalza e lo allontana, lui da solo perché lui solo capace di ergersi, sorretto dalla sua arte e non dalla sua corda» (p. 41).
di Paolo Vignola




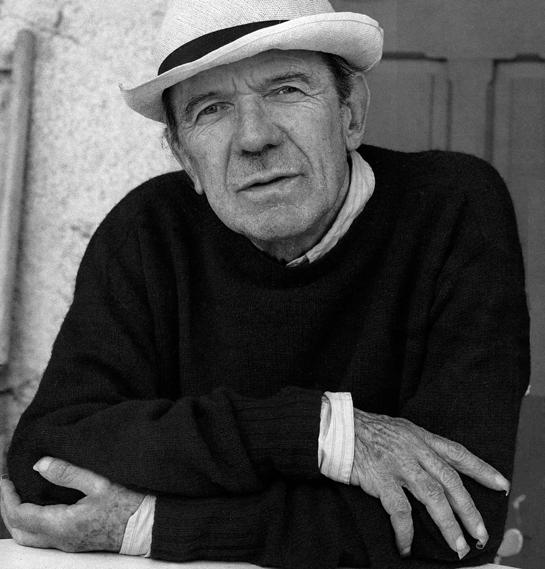

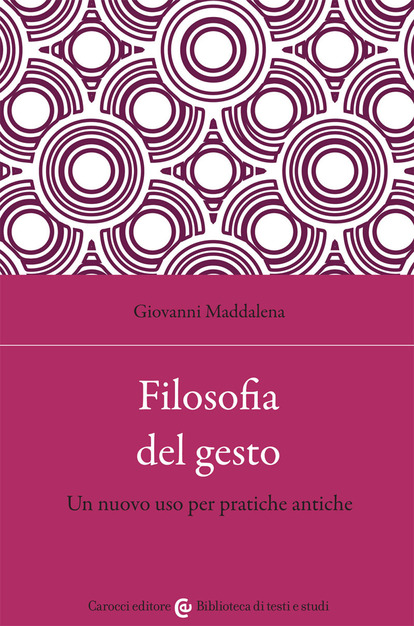

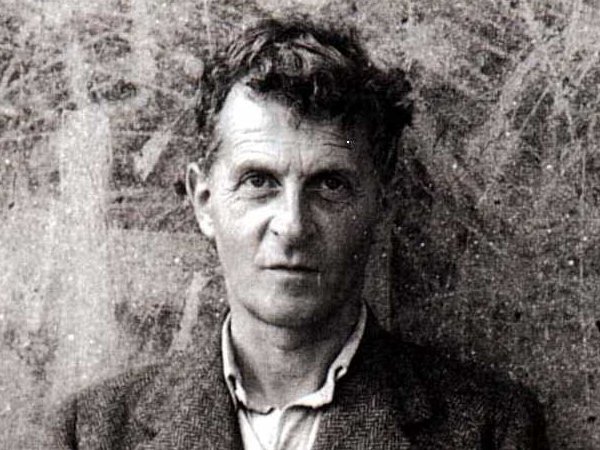




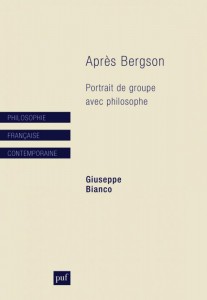

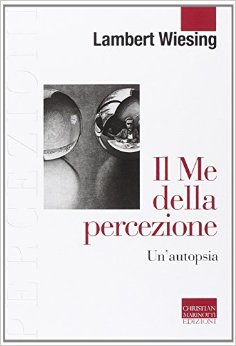

 zione ridisegnata da Wiesing, il trittico soggetto/oggetto/percezione si riconfigura, portando in primo piano la percezione come suo centro propulsore, in maniera non dissimile da quanto portato avanti, in un altro contesto, da Gilbert Simondon prima e da Bernard Stiegler oggi: nel passaggio all’individuazione non bisogna concentrarsi né sull’origine né sul termine, ma sul processo trasduttivo e relazionale in grado di articolare i due momenti. Al di qua della sclerotizzazione tra un soggettivismo autoreferenziale e un oggettivismo semplicistico, Simondon, Stiegler e Wiesing, in modi ovviamente differenti, propongono uno sguardo “terzo”, bergsonianamente orientato sui movimenti che riconfigurano le essenze statiche in poli di un processo.
zione ridisegnata da Wiesing, il trittico soggetto/oggetto/percezione si riconfigura, portando in primo piano la percezione come suo centro propulsore, in maniera non dissimile da quanto portato avanti, in un altro contesto, da Gilbert Simondon prima e da Bernard Stiegler oggi: nel passaggio all’individuazione non bisogna concentrarsi né sull’origine né sul termine, ma sul processo trasduttivo e relazionale in grado di articolare i due momenti. Al di qua della sclerotizzazione tra un soggettivismo autoreferenziale e un oggettivismo semplicistico, Simondon, Stiegler e Wiesing, in modi ovviamente differenti, propongono uno sguardo “terzo”, bergsonianamente orientato sui movimenti che riconfigurano le essenze statiche in poli di un processo.