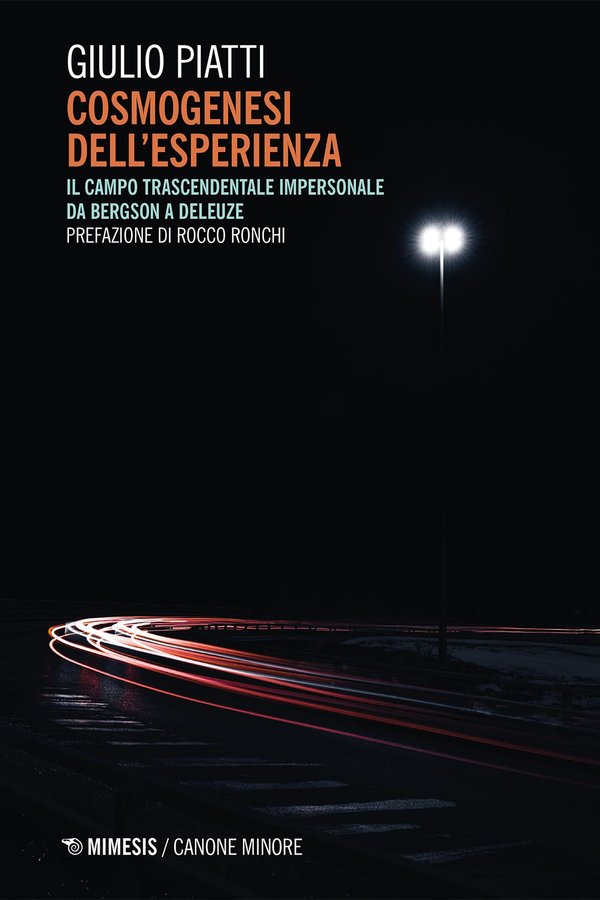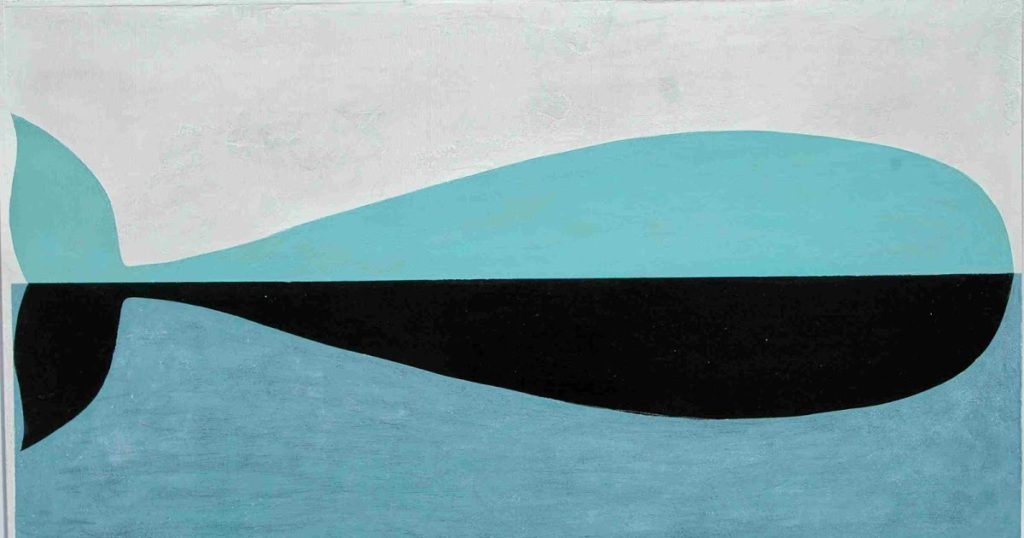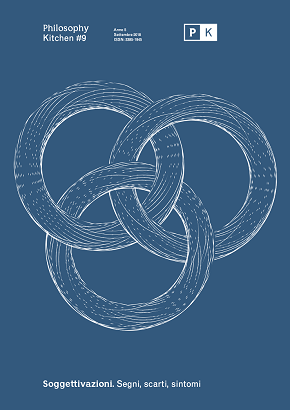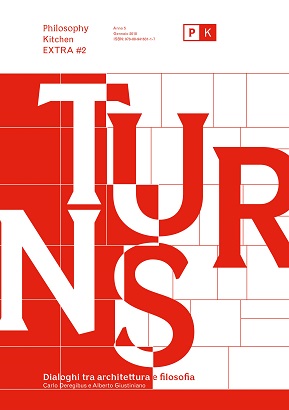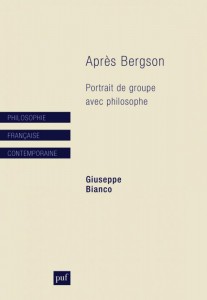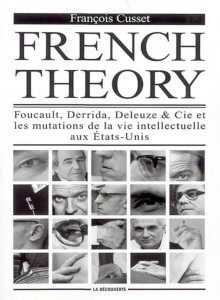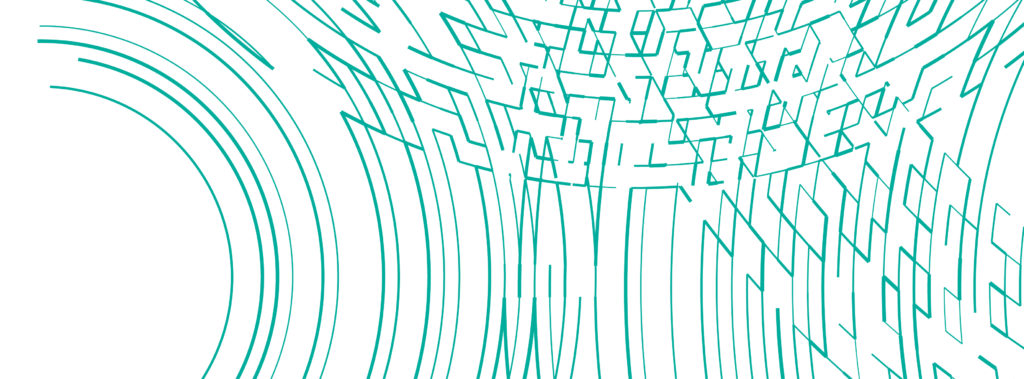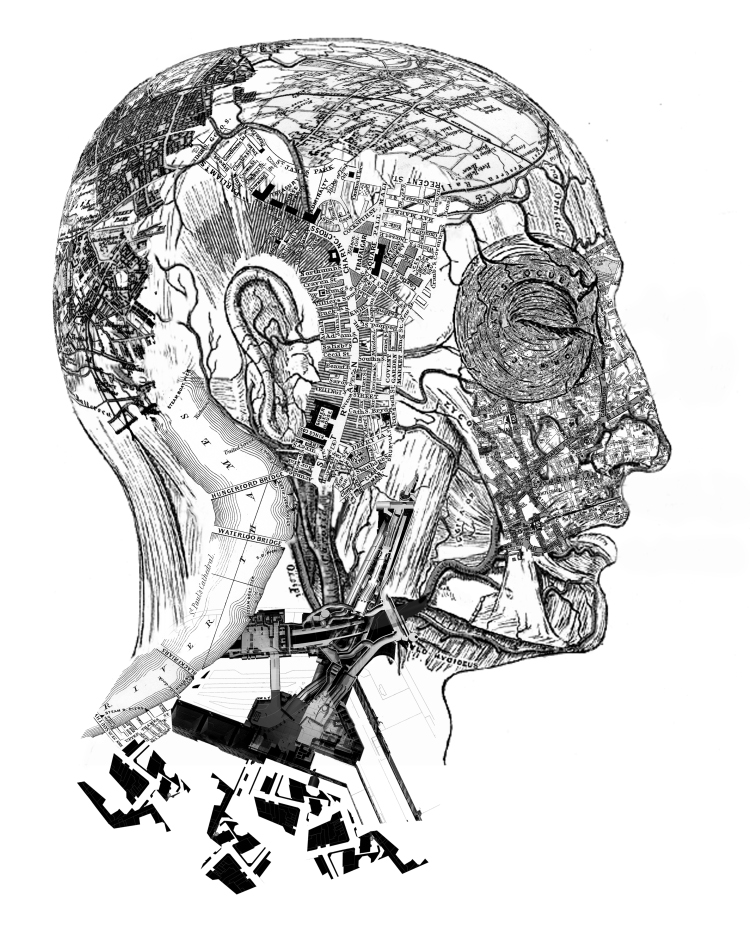-
M49. Filosofie per fughe animali
Longform / Ottobre 2023A Juan Carrito, benché sia morto libero
Basterebbe un colpo d’occhio al panorama filosofico più recente per ammettere che la critica dell’antropocentrismo sia diventato un tema comune a molteplici orientamenti di pensiero, anche divergenti fra di loro: dal posthuman al realismo speculativo, dal new materialism all’ecopessimismo fino ai pensieri queer e decoloniali, la protesta contro le pretese di centralità ed eccezionalità umana sembrano proliferare alla stessa velocità con cui la minaccia d’estinzione – per lo più rappresentata dal global warming, benché la guerra atomica sembri aver conquistato una nuova giovinezza – si abbatte sulla specie homo sapiens. La sincronia non è casuale e non è soltanto il prodotto di un qualche senso di colpa collettivo per la distruttività dell’azione antropica. È piuttosto il pianeta stesso inteso come tessuto di forze e agentività aliene a fare irruzione s’una scena per millenni ritagliata a misura umana. Va da sé che non ogni critica all’antropocentrismo è anche una critica antiumanista nel senso in cui l’abbiamo conosciuta nel secolo scorso, cioè di quell’Uomo prodotto da sapere-poteri recenti o da una lunga tradizione metafisica e per tagli sacrificali (l’Uomo è sempre maschio, bianco, occidentale, adulto, eterosessuale e cisgender, abile); né, tanto meno, un antispecismo. Ma anche dove manca un’esplicita convergenza, affinità, limitrofie e promiscuità restano innegabili e l’innesto sempre possibile. In qualche modo tutte queste tensioni, vecchie e nuove, sembrano spingersi a vicenda. Sarebbe per esempio difficile negare che la riflessione di Derrida sull’animale non abbia avuto, pur con picchi discontinui, un ruolo da detonatore generale: se nell’opera del filosofo franco-algerino l’avvio di una decostruzione esplicita dell’umanismo risale almeno alla fine degli anni sessanta del secolo scorso, la pubblicazione postuma della conferenza sull’animale autobiografico sotto il titolo L’animale che dunque sono (Derrida, 2006), ha scoperto, per così dire, tutte le carte del gioco critico e insieme rovesciato sul tavolo il rimosso della tradizione antiumanista. Già il concetto (ma qui ne va della concettualità del concetto stesso) di traccia, come delineato fin da Della grammatologia (Derrida, 1998), precedendo e eccedendo le opposizioni tradizionali della metafisica trasmesse alla linguistica, sollecita dalle fondamenta la centralità assegnata al linguaggio umano: la traccia infatti non esiste né come linguaggio né come sistema di segni generale, né come significato né come significante, né come fonema né come grafema, non esistendo in generale secondo i principi dell’ontologia tradizionale che informa anche quei saperi che se ne vorrebbero immuni. Precedendo tutto il sistema delle opposizioni classiche, la traccia, cancellandosi, ne permette l’emersione e al tempo stesso le eccede come un tutt’altro intrinseco e necessario che decostruisce la fondazione della presenza a sé della coscienza attraverso l’autoaffezione della phoné, senza con questo fare a sua volta origine: un sistema di tracce si configura infatti come un gioco di derivazione alla deriva e senza inizio, priva di significante trascendentale; gioco d’iterazione differenziale di simulacri e supplementi. Perciò con scrittura non si deve intendere qualcosa di semplicemente opposto al linguaggio orale: Derrida utilizza questo lessema perché nella tradizione fonologocentrica la scrittura è sempre considerata derivata rispetto alla vocalità costituente del soggetto umano, e, in questo senso, impura e minacciosa; ma è quello stesso predicato della scrittura ad essere generalizzato in maniera da incrinare la presunzione d’origine in generale: scrittura in Derrida non è la parola scritta (che resta pensata sul calco di quella parlata), ma l’essere-derivato di ogni origine. È chiaro dunque che traccia e scrittura precedono ogni soggettività umana, aprendone costantemente la crisi. Ma tale crisi è complessa: nella conferenza intitolata ai Fini dell’uomo (Derrida, 1997, 153-185), la parola fine, nella sua equivocità, indica al tempo stesso la fine e il fine che intrecciano, nella tradizione, critica e rilancio del concetto di Uomo, provocando periodicamente una rottura dialettica della tradizione stessa: non una morte dunque, ma un rilevamento (Aufhebung) dell’Uomo. Molti testi (Derrida 2004; 2009-2010; 2010; 2011) disegneranno da qui in poi una traiettoria dall’andamento carsico, fino ad una sorta di resa dei conti con quello stesso antiumanismo che nell’annuncio ripetuto della morte dell’Uomo occulta ciò che, posto in opposizione ad esso, ne permette l’autocostituzione e il ciclo dialettico delle resurrezioni: l’Animale come singolare generale e indifferenziato, separato dall’Uomo da un confine unico e non suddivisibile, iscritto ancor prima che nel linguaggio, nella capacità di rispondere piuttosto che di reagire secondo il catalogo programmato di un etogramma inderogabile; nel pudore e dunque nella nudità e nella capacità di simulare e dissimulare (il lacaniano fingere di fingere: l’Animale non cancellerebbe le proprie tracce); e perciò di rapportarsi all’ente, a sé, alla morte, secondo la modalità dell’in quanto tale. Proprietà esclusivamente umane che, concatenate in una stessa serie, aprirebbero selettivamente l’accesso alla verità, al mondo, alla presenza a sé della coscienza, all’intenzionalità e alla libertà. Se la strategia di Derrida è quella di una redistribuzione di tale esclusività in violazione all’interdetto a suddividere il confine, permettendo così di riconoscere, nell’identità forzata dell’Animale, una molteplicità di forme di organizzazione della vita e singolarità irriducibili, è lo stesso proprio dell’Uomo (anche quando il proprio designa una carenza o una mancanza) ad venirne così colpito in maniera irreversibile, disseminandosi in un’improprietà comune e non dialettizzabile che piega il potere (nel suo valore sostantivale e verbale) verso una certa passività e dunque vulnerabilità condivise fra i viventi. A venirne scossa non è soltanto l’ontologia, ma insieme l’etica, il diritto, le scienze, la politica: e perciò la legittimazione implicita di ciò che, in riferimento alla zootecnica, Derrida chiama sterminio per moltiplicazione. filosofie per fughe animali

Janko Ferlic, Fotografia in primo piano dell'orso (Pexels) Ma la rottura evenemenziale prodotta dalla gatta (una gatta reale, insiste Derrida) che, esistenza singolare irriducibile a specie, genere e persino regno, attraversa il testo del filosofo in uno scambio e inseguimento di sguardi tanto asimmetrici quanto reciproci, fa da attrattore per il baccano infernale di animali demoniaci e antiedipici che vengono a infestare il proscenio umano, producendo ibridazioni di corpi e affetti in blocchi di divenire, macchine celibi e orfane e alleanze mostruose. Non si tratta di semplici fantasie umane, né di metafore filosofiche: perché il divenire-animale di Deleuze e Gattari non è un processo linguistico di significazione o produzione simbolica, ma un’operazione reale di ibridazione deterritorrializzante. Nel celebre esempio della vespa-orchidea, l’orchidea si deterritorializza formando un’immagine della vespa, che si riterritorializza sulla prima, ma così dererritorializzandosi: diviene parte dell’apparato riproduttore dell’orchidea; la vespa riterritorializza l’orchidea portandone il polline. Non è un fenomeno di mimetismo o somiglianza, ma l’esplosione di due serie eterogenee in una linea di fuga. Questo è ciò che Deleuze e Gattari chiamano rizoma. La vespa-orchidea non si riproduce, non ha genealogia, discendenza è, come blocco, al tempo stesso sterile e proliferante. Il piano di consistenza che accoglie vespa e orchidea non imita a sua volta nulla e non tende verso nulla, ma non è definito nemmeno dalle loro posizioni, come in una struttura: piuttosto da modificazioni di velocità e intensità di affetti. Il piano non cresce e non diminuisce se non all’aumento e alla riduzione delle intersezioni dei blocchi di divenire che gli sono immanenti (Deleuze & Guattari 2017). Movimento contronatura della natura stessa, contromovimento trasversale e non arborescente dell’evoluzione: involuzione reciproca senza regressione. Frammento di DNA catturato da un virus e trasportato nella doppia elica di un altro corpo. Divenire-animale dell’uomo, come per tutti i divenire minoritari (divenire-donna del maschio, divenire-bambino dell’adulto) non significa che l’uomo imiti l’animale, che vi s’identifichi, che lo diventi: ciò arresterebbe il divenire stesso in un divenuto come filiazione; ma il divenire non si arresta, piuttosto entra in un altro divenire, intersecandosi s’uno stesso piano di consistenza a n dimensioni. In gioco non c’è rassomiglianza o differenza, né corrispondenza, di caratteri, forme o funzioni: tutto questo serve semmai allo Stato per le sue classificazioni. L’uomo può sempre immaginare di essere un animale, ma ciò che è reale del divenire è il divenire stesso come divenire tra eterogeneità. Ha a che fare con una muta, una banda, una popolazione e un popolamento, una molteplicità; espansione, propagazione e contagio, in cui le nozioni classificatorie arborescenti e seriali (dall’inferiore al superiore, dall’indifferenziato al sempre più differenziato) non hanno pertinenza. Si è presi in un divenire-animale come Achab e la balena, patto con un demone. Come il piccolo Hans e il cavallo nel caso di Freud, ma senza che il cavallo diventi un simbolo e gli affetti di Hans sintomi. Le linee di fuga di questo concatenamento (Hans, cavallo, omnibus, letto, strada, ecc…) non sono rappresentazioni in un triangolo edipico, ma affetti in un divenire che non nasconde niente, tanto meno un significante trascendentale, dispotico. E se ci sono animali tendenzialmente edipici e familiari (il mio gatto, il mio cane) e altri demoniaci (la zecca, la muta di lupi, il topo, la balena), a certe condizioni tutti gli animali possono divenire demoniaci, stringere un patto innaturale con l’umano, entrare in divenire con esso e con altro, indipendentemente dal regno in cui sono classificati. Di nuovo: in ragione di differenziali d’intensità e accelerazione di affetti.
Nonostante l’amicizia e le affinità con Deleuze e Guattari (benché a volte esagerate ex post da chi ha tentato di incasellare e binarizzare la tradizione recente, opponendo, per esempio, decostruzione e pensiero biopolitico, impoverendo la ricchezza e il dinamismo di quadri concettuali ben più complessi e fecondi), sembrerebbe difficile trovare qualcosa di altrettanto “animale” nelle genealogie dell’invenzione dell’Uomo in Foucault. Eppure è proprio nella costellazione di quel nuovo potere che si configura nell’eclissi della sovranità classica, massimizzando su scala di popolazione gli effetti dei poteri disciplinari e normalizzanti (Foucault 1978; 2005a; 2005b), che un certo pensiero ha trovato il punto d’accesso per una riflessione biopolitica sulle pratiche di domesticazione e potenziamento della vita in cui le vicende delle specie s’intrecciano in maniera differenziale ma insolubile. In particolare è la stessa scoperta del campo di ciò che Foucault chiama ontologia selvaggia, ossia una concezione della vita che ne travolge le forme in direzione di trasformabilità infinita, in cui la teoria darwiniana e le pratiche zootecniche di ibridazione e selezione s’inseguono a vicenda, a rendere non più delimitabile lo stesso campo di azione biopolitico. È uno zoopotere a venire così allo scoperta in maniera irrimediabile per ogni genealogia del vivente: non si potrà più parlare di pratiche di disciplinamento senza rendere conto di ciò che avviene nello spazio dell’allevamento e dello stabulario con i loro recinti, il governo dei corpi, l’intensificazione della produttività attraverso le pratiche empiriche e i saperi scientifici (questi ultimi mai immuni dai primi). Il lavoro di Benedetta Piazzesi ha, da questo punto di vista, aperto prospettive immense: la rottura imposta dal capitalismo al giardino come wunderkammer degli exempla di specie, microcosmo che rispecchia il macrocosmo di una natura stabile e invariante, e dell’utopia della Villa in cui ogni animale è utile per natura, in direzione di una manipolabilità della vita che solo successivamente le scienze giustificheranno de iure con la teoria dell’evoluzione e i suoi flussi morfogenetici, è un evento onto-storico che non si può spiegare solo in termini economici. A annunciarsi qui è infatti una nuova economia del vivente e della vita in cui la funzione dei corpi degli animali non umani non muta in relazione a un solo vettore del potere, ossia quello, estrattivo, del capitalismo marxista. Benché l’opposizione netta fra Uomo e Animale non tramonti mai né nei saperi né nei discorsi diffusi, a sovrapporvisi è una griglia continua e differenziata attraverso la quale l’Uomo è sì riassorbito nell’alveo del vivente – dal quale l’alleanza fra platonismo e cristianesimo l’aveva sottratto, facendone uno straniero nel mondo dei corpi e della carne – ma in posizione di eccezionalità (Piazzesi 2015). Parallelamente la stessa vicenda si ripete in ambito infraumano, dove il sapere biologico differenzia gerarchicamente il continuum della specie secondo le magnitudo dei popoli e degli individui, aprendo la strada alle scienze razziali (Foucault 2009a). Anche in psichiatria (fattore attivo nello stesso processo), all’epoca del grande internamento dei folli succederà il controllo capillare della gamma infinita delle anomalie, proiettando la psichiatria stessa fuori dai manicomi ad allagare ogni sfera dell’esistenza sociale e producendo ampie zone di indistinzione con altri poteri, a cominciare da quello giuridico (Foucault 2009b). I fasci di sapere-potere eccedono insomma i confini di specie, provocando continue retroazioni da una parte all’altra della frontiera.
Agamben ha fissato questa paradossale continuità discontinua nel dispositivo onto-politico della macchina antropologica, che nel tentativo di fissare il proprio dell’Uomo permette il transito di interi gruppi umani nell’animalità, esponendoli così alla sacertà come uccidibilità senza crimine (Agamben 2002). Tale dispositivo antropo-zoo-genico, che corrisponde alla tradizione stessa del pensiero occidentale, tenta infatti, nel suo moto incessante, di risolvere il mysterium conjuntionis fra zoé e bíos, vita animale e vita umana, ossia dell’emersione stessa della seconda dalla prima. Producendo però inevitabilmente una zona di indistinzione ed eccezione, nel modo dell’inclusione di un fuori (il barbaro e lo schiavo, l’enfant sauvage, insomma l’animale dalle fattezze umane, nella macchina antica), o dell’esclusione di un dentro (l’uomo animale, ossia l’ebreo e i suoi sostituiti, ma anche l’oltrecomatoso, nella macchina moderna). In entrambi i casi, il centro della macchina è perfettamente vuoto come lo è ogni spazio di eccezione, e il missing link della conjunctio che essa dovrebbe elaborare rilancia all’infinito un’operazione di cesure e riarticolazioni il cui risultato non è mai né una vita animale né umana, ma una nuda vita, ossia un vita separata da sé stessa. Ogni tentativo di far funzionare la macchina altrimenti produrrebbe allora lo stesso risultato: la proposta messianica di Agamben è allora di applicare la dialettica in arresto di Benjamin; non tentare più di risolvere il mistero della congiunzione, ma indagare le procedure della disgiunzione biopolitica, così da arrestare la macchina e impedire una nuova operazione dialettica tra Natura e Uomo. Ciò che allora più conterà in tale coppia sarà proprio il tra che la separa impendendone la congiunzione, e, sospendendo reciprocamente i due termini, apre a qualcosa che, insediandosi nell’intervallo, non è più né Uomo né Animale, Umanità o Natura. Secondo un altro topos benjminiano, vita insalvabile nella notte salva, abbandonata e inoperosa, consegnata al gioco e alla voluttà.
M49 cancella le sue tracce, finge e finge di fingere: traccia percorsi depistanti, doppi del suo stesso sviamento, della sua deriva gioiosa. Perché ancora più che sulle fughe e sui depistaggi, sull’agency soggettiva e attiva che l’Uomo non gli riconosce, è sull’agentività passiva, sul fare blocco con le forre e le stagioni, le pendenze della luce nella selva o nelle radure, i muschi, mille altre tracce non umane, che insiste Massimo Filippi nel volume omonimo di recente pubblicazione: M49. Un orso in fuga dall’umanità. Certo, questa fuga è un’evasione, un intreccio di diversivi e diversioni; ma è anche qualcosa come uno svago, una vacanza e un abbandono. Abbandonando l’Uomo e le prigioni che tagliano e organizzano lo spazio della sorveglianza e della cattura, egli si abbandona al possibile rischioso e improgrammabile di una vita insalvabile e perciò esposta a connessioni, contatti, contagi. Fuga, ma insieme linee di fuga lungo le quali egli diviene muschio, diviene forra, picco, bosco, cielo, pendenza di luce, calore, pietra, decodificando in flussi il codice che lo cattura come elemento tassonomico fisso, elemento di Stato e di codice di procedura: unorso non come specimen, ma in quanto molteplicità, e in quanto tale animaux, molteplicità degli animali catturati nel dispositivo di esclusione includente dell’antropogenesi prima ancora di ogni prigionia, eppure in rivolta.
Una myse en abîme interseca qui più blocchi di divenire: unorso parla, un* uman*, parlandogli, ne parla, quando unorso è di nuovo catturato; l’autore ne scrive: l’uman* fa blocco con unorso, entrambi con l’autore; ma tutti cessano così di essere semplici soggetti narranti e/o narrati, diventano qualcos’altro secondo un divenire molecolare della scrittura: zone di attrazione e vicinanza, attraversamento, zone d’intensità variabile, pullulazione e contagio che non hanno bisogno di virgolette e note al testo. Filippi tira i fili di un’immensa tradizione, ma anche questi sono altrettante linee di fuga che estraggono rizomi da strutture ramificate, gerarchiche. Fino all’eclissi dei soggetti dell’annunciazione: linguaggio come sciami di particelle, vita di un cosmo in espansione, fuga di costellazioni e galassie. Lingua straniera, lingua aliena, divenire-impercettibile. Non sappiamo chi sogni, qui – Filippi, unorso imprigionato, un alt* uman*, un altro animale. Ma il sogno è reale, e immenso. E può sognare il passato o il futuro.
Non che si dissolvano la compassione, la simpatia, l’evento del venire di un altro irriducibile, in nome del quale si scrive, e – così, anche – si lotta: ma queste passioni, azioni, avvenimenti si dislocano per riposizionarsi o avventurarsi ad un grado più profondo e più intenso della partecipazione; di quella com-parizione che per Jean-Luc Nancy era apparizione reciproca, perché non si appare al mondo senza comparire a qualcun*, con qualcun*, l’un* all’altr*; di quel partage in cui si è già da sempre gettat*, essere-insieme che non forma alcun insieme, che sia di specie, di genere, di vicinato, gruppo o collezione, o quello generale dell’ente nella sua totalità. Ondate di vibrazioni fanno risuonare le passioni, i desideri e gli incontri di un’intensità nuova e inaudita. M49, unorso, è ormai irrimediabilmente Tra.Antonio Volpe
BIBLIOGRAFIA
Agamben, G. (2002). L’aperto. L’uomo e l’animale. Torino: Bollati Boringhieri.
Deleuze, G. & Guattari, F. (2017). Mille piani. Capitalismo e schizofrenia. Trad. It. di G. Passerone. Napoli-Salerno: Orthotes.
Derrida, J. (1997). Margini della filosofia. Trad. It. di M. Iofrida. Torino: Einaudi
Id. (1998). Della grammatologia. A cura di G. Dalmasso. Trad. It. di R. Balzarotti et al. Milano: Jaca Book.
Id. (2004). Aporie. Morire – Attendersi ai limiti della verità. Trad. It. di G.Berto, Bompiani, Milano.
Id. (2006). L’animale che dunque sono. Trad. It. di M. Zannini. Milano: Jaca Book.
Id. (2009-2010). La bestia e il sovrano (I-II). Trad. It. di G. Carbonelli. Milano: Jaca Book.
Id. (2010). Dello spirito. Heidegger e la questione. Trad. It. di G. Zaccaria. Milano: SE.
Id. (2011). «Il faut bien manger». O il calcolo del soggetto. Trad. It. di S. Maruzzella & F. Viri, Milano-Udine: Mimesis.
Filippi, M. (2022). M49. Un orso in fuga dall’umanità. Roma: Ortica.
Foucault, M. (1978). La volontà di sapere. Trad. It. di P. Pasquino & G. Procacci, Milano: Feltrinelli.
Id. (2005a). Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979). Trad. It. di M. Bertani & V. Zini. Milano: Feltrinelli.
Id. (2005b). Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Collège de France (1977-1978). Trad. It. di P. Napoli. Milano: Feltrinelli.
Id. (2009a). Bisogna difendere la società. Corso al Collège de France (1975-1976). Trad. It. di M. Bertani & A. Fontana. Milano: Feltrinelli.
Id. (2009b). Gli anormali (Corso al Collège de France 1974-1975). Trad. It. di V. Marchetti, A. Salomoni. Milano: Feltrinelli.
Piazzesi, B. (2015). Così perfetti e utili. Genealogia dello sfruttamento animale. Milano-Udine: Mimesis.
-
Game Over. Tecnologie, spazi, specchi, tramonti
Longform / Gennaio 2022
[Per la Parte 1/2, clicca qui]
Tecnologie d’assalto
La cultura cyberpunk esplicita il suo statuto essenzialmente nella rappresentazione della tecnologia e del rapporto che quest’ultima intrattiene con l’umano e il post-umano nei loro perimetri d’elezione.
Oggi, alla fine del ventesimo secolo, negli Stati Uniti esistono intere città in putrefazione, violente e dominate dalla criminalità. All’interno delle stesse megalopoli, abbiamo il fenomeno dei senzatetto in rapidissima espansione. […] Ci ritroviamo cosi periferie fiorenti di industria leggera e informatica intorno a nuclei di industria pesante e ferroviaria in putrefazione e abbandonati. […] Continuiamo a ingrandire le nostre città intorno ai margini in un complesso groviglio di centri commerciali, palazzoni e distese di monolocali (Sterling 2001, 50).
Tempo, spazio, tecnica. Secondo gli arguti esponenti del cyberpunk, dal futuro suonano le sirene d’allarme. Quel territorio metropolitano, una macchia di compatte concentrazioni di vetro e cemento è un’emergenza, non una possibilità. Un enorme campo di battaglia in cui si combatte l’incessante guerra tra macchine e umanità inverando la distopia di Frankenstein che rende le persone altro da sé stesse modificandone la composizione organica e l’essenza. La funzione eterotopica di questo esperimento discorsivo, enunciati disgregati nella semantica di controdeduzioni della realtà, replica e esorcizza i fantasmi di un avvenire che occhieggia dalla faglia tremolante sui bordi della quale il giorno trascolora nella notte. Se di fantascienza si tratta, lo è per comodità espositiva, un attimo prima di far deflagrare il presente in migliaia di luci stroboscopiche che segnali elettrici affamati lumeggiano ovunque. Un’attività profetica, tutto sommato, in cui l’immaginazione funge da catalizzatore. La cibernetica ha incontrato il punk e lo ha sposato fondendo assieme bellicosità eterogenee: da una parte la scienza dei sistemi ricorsivi, che associamo solitamente all’Informatica, dall’altra l’estetica dei ribelli della tradizione letteraria canonica che traggono ispirazione da una tendenza musicale “deviante” con attitudini antisociali e antipolitiche. Scrive Lorenzo Palombini (2019):
La cibernetica, […] a partire dal lavoro di Ashby, Wiener, Bateson costituisce la base teorica di una rivoluzione tecnoscientifica che ha rivoluzionato negli ultimi decenni la nostra prospettiva sull’organizzazione e la sistemica. La storia filosofica della cibernetica non è priva di tensioni, né di incursioni, o di clandestine relazioni anonime. La riscoperta di autori come Simondon, l’individuazione di traiettorie che uniscono la filosofia francese post-strutturalista alle correnti cibernetiche ed ecologiche americane – per esempio l’ampio debito di Deleuze nei confronti dei concetti batesoniani, come quello di “piano di immanenza” e “doppio vincolo” – segnano la tendenza contemporanea a recepire anche in chiave filosofico-teoretica il portato della cibernetica. (98) [1]
La cibernetica non è identificabile con l’Informatica a tutto tondo. Per questo il fenomeno cyberpunk, e il “paesaggio culturale” che esso evoca, può essere descritto come narrazione dello spazio urbano, e della Rete, dilaniato da una crescita irresistibile e dal consolidarsi di scarti minimi, di equilibri instabili. Non esiste alienazione nel cosmo “programmato” delle mega-multinazionali, ma vita disumanizzata in un biosistema magmatico. I labirinti urbani cyberpunk non portano alla redenzione ma alla disperazione del reietto, che cerca di emanciparsi da un destino infelice.
Nella surdeterminazione in cui sprofonda il presente prefigurando un futuro tenebroso, il rizoma molecolare cyberpunk assomiglia sempre di più a una “iper-realtà”, proiezione fantasmatica di attese “virtuali” geneticamente collusive. L’apocalisse della tecnica e dell’economia, ultima epifania di un capitalismo giunto al termine della sua esiziale azione nel mondo, ha dissolto Stati, governanti e ceti borghesi. Le Corporazioni spadroneggiano incontrastate, come nel Blade Runner di Rick Deckard insidiato da Replicanti letali e vendicativi, macchine che cercano riscatto dalla morte consapevoli che non lo troveranno mai. Il potere, negli e sopra gli agglomerati urbani, non ha nemmeno bisogno di stabilire una linea di demarcazione tra legalità e illegalità se non per pura convenienza e vigila in concreto su una cibernetica formazione di vita meta-umana, un sistema para-biologico dotato di memoria e volontà che non dipende dalla durata dei propri componenti organici, rimpiazzabili in qualsiasi momento e per un numero imprecisato di volte.La cultura cyberpunk ci lascia in eredità una società a venire che rincorre in maniera ossessiva i suoi incubi peggiori. Eterotopia del nostro presente, essa è immaginazione simbolica estrema dell’“alterità” che si autoriproduce costantemente. Non ci sarà che “alterità”, infatti. La periferia ne è il laboratorio per eccellenza, nutrita da un Centro che non la teme, anzi la rinvigorisce favorendo spregiudicati esperimenti antropologici, culturali e, quel che maggiormente conta, tecnologici. Le città-Leviatano del canovaccio narrativo cyberpunk divorano corpi ed esistenze dopo averli attirati nel “parco giochi con pena di morte” (Gibson & Sterling, 2001). D’altronde, in tutte le periferie che sono state e in tutte quelle che verranno è andato, e andrà, in scena lo spettacolo dell’inevitabilità della sopraffazione e, parimenti, della liberazione.
Spazi virtuali e specchi utopici
L’eterotopia è anche spazio dei contrasti stridenti e delle diversità. E perciò consente ai nostri occhi di strappare il velo delle convenzioni sociali prescritte dal codice culturale con cui le interpretiamo. La modernità stessa rimbalza nella poliformia dello specchio che decostruisce la storia personale e collettiva e le disloca in geografie inusuali. I riflessi dello specchio, distorcenti spesso, rimandano echi visivi di eterotopie, e di utopie, che ci collocano lì dove non siamo perché il corpo reale sta al di qua della superficie riflettente. Nell’immaginario cyberpunk, ne abbiamo già parlato, gli specchi, interfaccia tra il soggetto e lo spazio, sono elemento ricorrente. Molly, la protagonista femminile di Neuromante, porta lenti impiantate sul volto che sostituiscono gli occhi con un effetto di potenziamento della vista e le consentono visuali impedite agli umani che non ne dispongono; un innesto bio-tecnologico ne acuisce lo sguardo. La metafora dello specchio, la stessa utilizzata da Pat Cadigan (1996) [2] per descrivere la vertigine di un’apparente assenza di limiti che prova la sua mindplayer, una sorta di “cyberpsicanalista” impegnata a frugare nella mente dei suoi pazienti, ha una lunga tradizione nel pensiero occidentale. A questo proposito bisogna osservare che alla duplicazione del mondo che lo specchio compie, va aggiunta la sua funzione primaria, e cioè quella di includere nel medesimo raggio visivo l’osservatore stesso: guardare e guardarsi avvengono in sincronia. L’enigma dell’identità e della differenza, della verità e dell’illusione riluce sulla lastra e rimanda al mistero della soggettività e dell’“altro da sé”, quando siamo noi l’esito di quella tensione riflettente.
Il “cyberspazio”, luce virtuale, misura la distanza fra il soggetto che abbandona la materialità del corpo e ciò che si lascia alle spalle espandendo il proprio Io nell’humus digitale; è eterotopia di un luogo senza luogo, per alcuni sacralmente accessibile e per altri interdetto. Esso sovrappone spazi incompatibili tra loro e rovescia il senso comune dilavandolo in una eternità che va molto al di là di quanto l’umano è in grado di registrare e di comprendere. È cifra del tessuto connettivo alimentato dall’informazione. La coscienza si fonde con la rete elettronica mentre quella neurale si abbandona al piacere di ricorrenze deflagranti. L’impensabile complessità di una rappresentazione grafica di dati ricavati dalle memorie di centinaia di computers si irradia nel non-spazio della mente.
The main thrust of micro-electronic seduction is actually neural, in that it foregrounds the fusion of human consciousness with the general electronic network. Contemporary information and communication technologies exteriorize and duplicate electronically the human nervous system. This has prompted a shift in our field of perception: the visual modes of representation have been replaced by sensorial-neuronal modes of simulation. As Patricia Clough puts it, we have become ‘biomediated’ bodies […]. (Braidotti 2013, 90)
Nella condizione meta-umana del “cyberspazio” tutto appare effetto di una ininterrotta mutazione. E il tecnologico, avverte ancora Rosi Braidotti (2013, 94), frutto di una autopoiesi “machinica” – e aggiungiamo noi misura di quel cambiamento inarrestabile – è il luogo del divenire post-antropocentrico, ovvero la soglia di molti mondi possibili. Si organizza attorno a chi veleggia nel virtuale una composizione di opportunità multiple. In Fisica il fenomeno diffrattivo si manifesta ogni volta che un’onda incontra un ostacolo e tutti i punti dell’ostacolo si trasformano a loro volta in sorgenti di altre onde. È così che si raggiungono le zone che resterebbero in ombra se la propagazione fosse semplicemente rettilinea. Nell’eterotopia “cyberspaziale” flussi di informazione investono il nocchiero schizzandolo di plasma digitale, concreto quanto la materia abbandonata nell’altro universo da cui si proviene e imbevuta di impressioni sensoriali perdute, tutto sommato imperfette rispetto a quelle che si è capaci di sintetizzare nel cammino verso un’altra consapevolezza e verso una nuova identità, non c’è dubbio, in uno scorrere ricomposto anche del tempo che ha perso ogni riferimento tradizionale. Nel “cyberspazio”l’avvicendarsi dei minuti e delle ore non ha più ragione di segnare alcun trascorrere periodizzato. Ogni cosa è istante, verrebbe da dire “presentificazione”, accadere simultaneo. L’avvento delle eterocronie, sequenze dell’“altrove” altrimenti spazializzate, è vicino.
Quel che resta del giorno
In quella che potremmo definire la nostra “memoria frattale” [3], ridotta in parti più piccole dell’insieme di partenza capaci ciascuna di riprodurne strutturalmente l’entità originaria, la cultura cyberpunk rappresenta la porzione di un “oggetto” più grande, probabilmente identificabile con il sistema di potere occidentale tout-court in ogni sua articolazione, sociale, politica, culturale, antropologica. Proviamo a tentarne una genealogia critica.
Suggerisce Salvatore Proietti, in un lucidissimo saggio:
[…] le metafore della SF, e del cyberpunk in particolare, si sono sviluppate in dialogo con le teorie letteraria, femminista e scientifica americana. Una specificità del cyberpunk è la sua diffusione (prima ancora di una vera canonizzazione) in tutti i campi del discorso sociale. (Proietti 1998, 63)
L’interfaccia corporea dell’essere biomeccanico e la topologia sempre più inclusiva della realtà virtuale stabiliscono un complesso rapporto fra umano e macchina. Nel 1985, a un anno dall’uscita di Neuromante, Donna Haraway pubblica A manifesto for Cyborgs. Discutendo specificamente di “metafore visive”, la filosofa di Denver ci conduce per mano nei viluppi dei luoghi “altri” dello sguardo. Anche questi, eterotopie.
[…] la metafora visiva ci permette di andare oltre apparenze fisse, che sono in realtà prodotti finiti. La metafora ci invita a investigare i vari apparati di produzione visiva, comprese le tecnologie prostetiche interfacciate con i nostri occhi e cervello biologici. E qui troviamo macchinari altamente selettivi per elaborare regioni dello spettro elettromagnetico nelle nostre immagini del mondo. È nei meandri della nostra appartenenza a queste tecnologie di visualizzazione che noi troveremo metafore e strumenti per capire e influenzare i modelli di reificazione del mondo, cioè le trame delle realtà per le quali dobbiamo rispondere. (Haraway 2018, 126)
Il cyborg è epifania di un’identità che ingloba in sé l’ambiente tecnologico affermando la propria autonomia. La membrana osmotica tra naturale e artificiale rimanda a una soggettività frammentata, a un’espressione identitaria priva di limiti e a una promessa, scrive Proietti (1998, 64), “di pratiche sociali adeguate alle ansie e alle speranze della contemporaneità”. Nel campo letterario della fantascienza americana, presenti sin dagli anni Venti del Novecento, le metafore del cyborg e dello spazio virtuale trovano forma compiuta soltanto nei primi anni Sessanta e poi poco dopo l’inizio degli Ottanta. La narrazione fantascientifica problematizza l’esistente molto più della divulgazione scientifica orientata a legittimare una filosofia della storia d’oltreoceano. Il “secolo americano” ha bisogno di sostenersi su solide basi culturali e, se vogliamo, epistemologiche.
Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, l’apparato industriale e militare degli Stati Uniti estende la pratica dell’integrazione bio-meccanica tipica del taylorismo con la sua catena di montaggio e agisce su un piano ideologico rimontando la china della retorica nazionale per amplificarne gli effetti. La ricerca scientifica si trasforma in nuova frontiera – gli americani sono specialisti in nuove frontiere, del resto, e basterà qui ricordare la mitopoiesi del Far West – e la speculazione sull’immaterialità si sostituisce all’esaurimento dell’orizzonte territoriale, giacché in patria la geografia interna risulta ormai completamente conquistata. Rimane purtuttavia il corpo nella sua liminarità dirimente a fornire un’ulteriore ragione per giustificare il bisogno incontrollabile di impossessamento e comando. La “cibernetica” di Wiener va in questa direzione; nelle correnti impetuose dell’informazione, tecnici e “calcolatori” – siamo attorno alla seconda metà degli anni Quaranta –, sono timonieri di battelli a vapore simili a quelli che transitavano sbuffando lungo il Mississippi. Ogni cosa procede verso un avvenire caratterizzato non più dalla tecnologia squisitamente bellica – il lavoro di Wiener era nato da uno studio commissionato per migliorare i sistemi di puntamento contraereo – ma da quella dell’informazione e della sua rapida trasmissione.
Nel 1960, il progetto della Difesa che produrrà Internet parte da un saggio-manifesto in cui lo psicologo John C. R. Licklider specula che, se la tecnologia ingegneristica ha finora dato luogo al “mechanically extended man”, la possibile associazione di operatore (“cervello”) e computer potrebbe dar luogo a una vera e propria “simbiosi”. (Proietti 1998, 65)
Ancora nel 1962, uno dei maggiori esperti dell’United States Naval Research Laboratory, il fisico Robert Morris Page, ricercatore di punta che si occupava dello sviluppo del radar, conia l’espressione “estensioni dell’uomo” in riferimento a queste nuove componenti meccaniche su cui si sta alacremente studiando. La stessa idea di cranial jack della quale troviamo riferimento nei testi cyberpunk arriva da quei decenni durante i quali l’elettronica comincia ad essere sperimentalmente applicata alla medicina. Il cyborg, aspirazione simbolica e quasi archetipica, nasce in quel panorama culturale. Con l’unica differenza, in quel momento, che le varianti dell’homo sapiens dotate di componenti esogene e migliorative consentiranno di affrontare le esplorazioni interplanetarie, lo spazio “esterno”, ennesima sfida per l’umanità intrappolata nella Guerra fredda. I processi di reificazione dell’essere umano si incistano nel corpo e lo rimodellano per consentirgli di adattarsi ad ambienti extra-terrestri inospitali e sconosciuti. Tutto sommato la materialità di quell’insieme biologico che rappresentiamo finirà per evolvere, mainstream di lustri che sembrano davvero gloriosi, in qualcosa di completamente rinnovato che consentirà di alleggerirsi dai problemi derivanti dalla sopravvivenza fisica.

Cyberpunk 2077 Wallpaper - Credits: Bhautik Joshi L’ultimo spettacolo
In questa spettacolarizzazione della modernità tecnologica, l’identità è scelta infinita di opzioni e rifugge le complicazioni che possono derivare dalla concreta fenomenologia delle cose. Il cyborg è una metonimia che ripropone la dialettica servo-padrone e sembra quasi annunci un mondo nel quale la biologia si sta sostituendo in qualche misura alla politica. Il corpo manipolato da prodigiosi innesti proclama la comparsa di soggetti identitari che possono annullare conflitti e appartenenze sociali; la classificazione delle razze, cavallo di battaglia della peggior cultura occidentale, scompare nell’indifferenziato della macchina biologica modificata. Lo stesso Wiener (1964) in God & Golem, Inc. tenta di ridefinire il rapporto tra corpo personale e corpo politico. Tuttavia, l’arrivo della teoria delle comunicazioni di massa di Marshall McLuhan (1962; 1964), anticipata ampiamente dagli studi di Charles H. Cooley (1909) [4], riconfigura l’organismo sociale “super-individualizzando” il cyborg e rilegge le sue coordinate spaziali. Il medium è il messaggio e la società, di conseguenza, è in nuce un “cyberspazio”; il villaggio globale si distribuisce come un ordito di sensori umani che la tecnologia rende interdipendenti. Il computer, nella sua “traduzione” artificiale di vantaggi, origina un sistema nervoso planetario che annulla i limiti del linguaggio e del territorio, e perfino il significato dei ruoli nella società. Per questa ragione concetti quali potere o produzione appaiono irrilevanti, non più necessari; la politica si frammenta negli ingranaggi della macchina, le scelte individuali e gli afflati collettivi si disperdono nel campo unificato del simultaneo.
Negli anni Settanta e soprattutto negli Ottanta, quando questa infodemia si rinvigorisce ancor di più, il PC, la scatola magica dotata di schermo a pixel che sta facendo un’implacabile concorrenza alla televisione, stigmatizza una nuova figura di consumatore travolto da un immaginario che ha del miracoloso.
A chi lo saprà usare, il computer offre la promessa di una “democrazia diretta” e della “necessità evolutiva” di una “coscienza planetaria” della “psicosfera”. […] l’autoregolarsi del sistema cibernetico è il braccio invisibile del nuovo mercato che garantirà un destino umano deterministico e privo di conflitti. (Proietti 1998, 67)
La strada tracciata dalla rivoluzione informatica, lo ha ricordato Bill Gates, conduce a un benefico capitalismo privo di attriti e più il virtuale si dilata senza incappare in scomodi impedimenti, più una tale road ahead apparirà lastricata di buone intenzioni. Questo “iperoggetto” (Morton, 2018), all’opposto, assomiglia davvero agli intrichi reticolari, sconcertanti e fortuiti, delle città dei cyberpunks coartate dalla dominazione estensiva delle Corporazioni, i “non luoghi” di Marc Augé – la similitudine è azzardata rispetto al concetto espresso dall’antropologo francese ma ne rischieremo ugualmente l’impiego –, spazi altamente omologati nei quali si può vivere anche per lungo tempo, muovendosi all’interno di comunità capaci di favorire rapporti durevoli ma privi di radicamento alle tradizioni e alla storia, tipica esemplificazione di società globalizzata.
La frontiera del virtuale, riformulazione ancora una volta retorica di uno dei più noti refrains della dottrina americana, è centrale in questo dispositivo concettuale e viene, non casualmente, associata alle figure di contrasto che ne caratterizzano, all’apparenza, l’opposizione radicale: gli hackers sono i sacerdoti del rito visionario, per molti aspetti religioso quasi, che si consuma nelle terre del “post-umano”, il “cyberspazio” appunto, essenza esistenziale a-topica che trascende qualsiasi futuro perché ci parla, insistentemente, del “qui e ora”. E forse, la retorica cui si accennava:
[…] è quella di un ritorno a uno stadio prelinguistico, presociale e astorico: il cyberspazio è un sogno pastorale, che è […] il sogno imperialista di un’America espansa fino a coincidere col mondo. (Proietti 1998, 70)
Il mito nazionale è locuzione di senso che diventa presa, o meglio tentativo di presa, addirittura sul pianeta. Quel che resta del giorno sono tracce mnestiche, ricordi impiantati come per la Replicante Rachel in Bladerunner, che hanno sconfitto il passato; ogni passato pensabile.
Nel quadro storico-culturale che abbiamo cercato di delineare fino a qui, il congegno letterario cyberpunk va considerato non tanto un esperimento di rottura, quanto il rovello di chi, inconsapevolmente ma inevitabilmente, non poteva non esprimere, in morfologie narrative perturbanti, un disagio generazionale che colava ovunque. La cultura cyberpunk riafferma la modernità ipertecnologica, tagliente materia hi-tech di cui è fatta la società post-industriale; porta con sé la cadenza mai esausta della provocazione estetica e politica, e non di rado, basti pensare a Sterling, i clichés del liberalismo americano che ambiscono a rinascere, o continuare ad esistere, perfino nell’allucinazione virtuale. Le sue qualità e i suoi limiti sono stati quelli di una
[…] “struttura di sentimento dominante in alcune parti della cultura giovanile del ricco Nord del mondo” legata, materialmente o ideologicamente, al terziario avanzato: un gruppo significativo ma non omogeneo né maggioritario. (Proietti 1998, 76) [5]
Quel gruppo non esiste più da molti anni. Game over. Ma a noi, inguaribili romantici, piace pensare che, da qualche parte, i cow-boys del “cyberspazio” e le Amazzoni dalle lenti policrome stiano continuando a cavalcare l’impossibile.
di Mario Coglitore (UniVe)
Bibliografia annotata
La bibliografia sull’argomento oggetto di questo studio è comprensibilmente sterminata. Tuttavia possiamo cercare di proporre alcune tracce per un percorso di lettura, del tutto parziale, utile a un primo approccio con il movimento letterario cyberpunk, con alcuni dei suoi più perspicui studiosi e critici e con quanti hanno lavorato a vario titolo su nodi tematici che intersecano i temi sviluppati in queste pagine. Di seguito almeno tre diverse aree di “sguardi sostenibili”.
I testi “indispensabili” della letteratura cyberpunk sono: di Pat Cadigan, Mindplayers, edito per Shake Edizioni (1986); i testi di William Gibson Neuromante, per Editrice Nord (1986) e, editi da Mondadori, Giù nel ciberspazio (1990), Monna Lisa Cyberpunk (1991), Luce virtuale (1994), Aidoru (1997), American Acropolis (2000); quelli di Bruce Sterlin La matrice spezzata, edito da Editrice Nord (1986), Oceano, per Perseo Libri (1991) e, editi da Fanucci, Artificial Kid (1991) e Isole nella rete (1994). E I testi congiunti di Gibson e Sterling, editi da Mondadori, La macchina della realtà (1990) e Parco giochi con pena di morte (2001). Va inoltre citato Settore Giada, di Lucius Shepard, per Mondadori (1987).
Su temi “attorno al cyberpunk” sono da citare almeno Houdini e Faust. Breve storia del Cyberpunk, di Caronia e Gallo per Editrice Nord (1997); l’articolo di Palombini Note per una eterotopologia del punk cibernetico (in Philosophy Kitchen n. 10) e quello di Proietti Intorno al cyberpunk (in Ácoma. Rivista internazionale di Studi Nordamericani n. 5); Storming the Reality Studio. A Case of Cyberpunk and Postmodern Fiction, curato da Larry McCaffery perDuke University Press (1991); e molti altri testi curati da (e di) Bruce Sterling, in particolare, per Bompiani, Mirrorshades (1994) e la Prefazione a “Mirroshades” pubblicata in Cyberpunk. Antologia di testi politici, curato da Raf Scelsi per Shake Edizioni, oltre a La nuova fantascienza» (1992), per Telemaco, e Il cyberpunk negli anni Novanta (Isaac Asimov Science Fiction Magazine Edizione Italiana n. 2).
Andando “oltre” il cyberpunk, molte sono le possibili direzioni, partendo dal Manifesto cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo di Donna Haraway (2018), per Feltrinelli, The posthuman, di Rosi Braidotti (Polity press, 2013), Il cyborg. Saggio sull’uomo artificiale di Antonio Caronia (2008), per Shake, e i libri di Norbert Wiener editi da MIT Press Cybernetics (1948) e God & Golem, Inc. (1964). Si possono inoltre citare lo storico Social Organization. A Study of the Larger Mind di Charles H. Cooley (1909), i classici di Marshall McLuhan: The Gutenberg Galaxy. The Making of Typographic Man (1962) e Understanding Media. The Extensions of Man (1964); il Dizionario degli esseri umani fantastici e artificiali di Vincenzo Tagliasco (1999), edito da Mondadori; Iperoggetti di Timothy Morton (Nero, 2018); Utopie Eterotopie di Michel Foucault per Cronopio (2006) e L'individuazione psichica e collettiva di Gilbert Simondon per DeriveApprodi (2001).
Bibliografia
Braidotti, R. (2013). The posthuman. Cambridge: Polity press.
Cadigan, P. (1996). Mindplayers (1987). Milano: Shake Edizioni.
Cooley, C. H. (1909). Social Organization. A Study of the Larger Mind. New York: Charles Scribner's Sons.
Gibson, W. & Sterling, B. (a cura di). (2001). Parco giochi con pena di morte. Milano: Mondadori.
Haraway,D. (2018). Manifesto cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo. Milano: Fetrinelli.
McLuhan, M. (1962). The Gutenberg Galaxy. The Making of Typographic Man. London: Routledge and Kegan Paul Ltd.
McLuhan, M. (1964). Understanding Media. The Extensions of Man. Berkeley: Gingko Press.
Morton, T. (2018). Iperoggetti (2013). Roma: Nero.
Palombini, L. (2019). «Note per una eterotopologia del punk cibernetico», Philosophy Kitchen, 10(6), 89-105.
Proietti, S. (1998). Intorno al cyberpunk. Ácoma. Rivista internazionale di Studi Nordamericani, 5 (12), 93.
Sterling, B. (2001). La città virtuale. In W. Gibson & B. Sterling (a cura di), Parco giochi con pena di morte. Milano: Mondadori.
Wiener, N. (1964). God & Golem, Inc. A Comment on Certain Points where Cybernetics Impinges on Religion. Cambridge (MA): MIT Press.
Note
[1] Gilbert Simondon (1924-1989) è stato un filosofo francese il cui pregevole lavoro si situa tra gli anni ’50 e ’70 del Novecento. Partendo dal concetto di individuazione, Simondon si è a lungo interrogato sull’uomo come essere vivente in stretto rapporto con la tecnica, colta nella sua centralità filosofica e politica.
[2] Pat Cadigan è nata nel 1953 negli Stati Uniti. Poco dopo la fine degli studi universitari nel 1975 ha cominciato la sua attività di scrittrice. Nel 1986 il suo racconto A tutto rock (Rock On, 1984) viene inserito da Sterling in Mirroshades. Un anno più tardi pubblica il primo romanzo, Mindplayers, che ottiene un discreto successo. Ha vinto premi letterari prestigiosi come l’“Arthur C. Clarke”, e nel 2013 anche il “Nebula” e lo “Hugo”.
[3] Si propone qui la definizione di “frattale” fornita dall’Enciclopedia Treccani.
[4] L’orizzonte organicista si rinnova in quel principio di secolo e la società contemporanea assume, all’epoca, le caratteristiche di una larger mind grazie alla diffusione del telegrafo e del telefono.
[5] Tra virgolette alte una citazione tratta da Darko Suvin, On Gibson and Cyberpunk SF, in L. McCaffery (a cura di) (1991). Storming the Reality Studio. A Case of Cyberpunk and Postmodern Fiction. Durham-London; Duke University Press, 363.
-
L’Universo come cinema in sé
Recensioni / Settembre 2021Ogni appassionato di cinema lo sa: quello che cerca, guardando un film, non è soltanto una fuga dal proprio quotidiano – magari attraverso l’intermediazione delle vite altrui, immaginarie o meno che siano –, ma una certa, difficilmente definibile estraneazione dal “sé”, un modo per disaderire sic et simpliciter da quel centro gravitazionale per il resto onnipresente che è il proprio stesso “io”. Ciò che insomma seduce, sino al fanatismo, nella settima arte, non è tanto o solamente la capacità di raccontare storie, ma di immettere piuttosto lo spettatore in uno svincolamento possibile dalla sua prospettiva personale, di, in altre parole, autorizzarlo per un certo tempo ad abbandonare le rive tumultuose del proprio monologo interiore in favore di una partecipazione tendenzialmente assoluta al divenire delle cose (‘cose’ di cui faranno parte, a questo punto, persino le persone rappresentate). È per questo motivo che Gilles Deleuze, proseguendo un’intuizione che era già stata prima, perlomeno, di André Bazin («Il cinema come mummia del tempo») e di Pier Paolo Pasolini («Il cinema come lingua scritta della realtà»), ha riconosciuto nel cinema la facoltà di pensare, a tutti gli effetti, e anzi di permetterci di riconoscere come lo stesso universo possa essere a sua volta pensato alla stregua di un «cinema in sé». In quei due capolavori che sono L’immagine-movimento (1983) e L’immagine-tempo (1985), il dispositivo cinematografico assurge infatti a metodo di indagine cosmologico e persino cosmogenetico, rivelando a tutti noi che il mondo è tutto fuorché un semplice tutto, dato e costituito come un «Grande Oggetto» (Roger Chambon), ma si configura piuttosto come un complesso cangiante di processi infinitamente prolungati gli uni negli altri, come uno specchio mutevole, insomma, del pensiero in atto.
È questa allora la tesi che campeggia al centro di Cosmogenesi dell’esperienza. Il campo trascendentale impersonale da Bergson a Deleuze (Mimesis 2021, pp. 314), primo e importante libro di Giulio Piatti. Pur dedicando soltanto una parte della sua indagine al cinema (pp. 217-37), questo studio permette infatti di reperire nel cuore di una certa tradizione filosofica novecentesca una tendenza sempre più precisa e acuminata a vedere nel reale la sua stessa messa in immagine e anzi a cercare in un reale liberato di ogni ipoteca antropocentrica l’origine tanto della nostra prerogativa a rappresentarci il mondo quanto della predisposizione del mondo a divenire rappresentazione, secondo un modello di intelligibilità che eleva la genesi a forma vera dell’ontologia.
Un campo trascendentale impersonale non è quindi soltanto un concetto, ma una serie generativa di (altri) concetti. Si tratta di qualcosa che Henri Bergson interpreta, sia pure non servendosi dell’espressione, come insieme di immagini in sé e per sé (immagini di niente e per nessuno), assimilandolo a una materia in cui la percezione, ricondotta al suo stadio più puro, spogliata di ogni ricordo interpretativo, sarebbe come «già scattata» nelle cose stesse (pp. 31-72). È da qui che l’esperienza propriamente soggettiva sorgerebbe, nel momento in cui un corpo vivente comincia a deflettere un movimento materiale che altrimenti si propaga senza sosta in tutte le direzioni e su tutte le superfici. Ma si tratta anche di ciò che Raymond Ruyer, contestando a sua volta Bergson, è costretto comunque a rintracciare nella stoffa della sensazione, da pensarsi come modello di ogni coscienza e dunque di ogni essere veramente unitario (dall’elettrone all’universo). Da pensarsi come, in altre parole, una superficie che, senza poter prendere le distanze lungo una qualche perpendicolare, è comunque in presa diretta su di sé, quasi che il soggetto della sensazione fosse diffuso senza velocità limite in ogni punto del suo sentire e del suo essere al contempo la sensazione che ha (pp. 160-164). Ancora, è quanto Maurice Merleau-Ponty si troverà a ipotizzare per correggere in corso d’opera la rigidezza bipolare dell’intenzionalità husserliana e riuscire a pensare un percepire che è già sempre incarnato e co-implicato con il mondo, secondo un chiastica convergente-divergenza o divergente-convergenza che spariglia una volta per tutte la correlazione lineare tra soggetto e oggetto (pp. 149-153). E, infine, sarà il piano d’immanenza che Deleuze stesso e Félix Guattari evocheranno nella loro ultima opera, Che cos’è la filosofia? (1991), come operazione archetipale che ogni filosofo deve compiere per resistere a quel caos che dissipa altrimenti ogni pensiero e che pure bisogna poter frequentare per trarne nuova linfa, sia essa filosofica, artistica o scientifica (p. 213 e ss). Lo stesso piano che il solo Deleuze aveva già identificato appunto come la prestazione più tipica del cinema (soprattutto in alcune delle sue espressioni più tipicamente anti-narrative), quale sua capacità di restituirci a una visione che, per quanto strano possa sembrare, ci fonda senza mai essere stata nostra e senza poterlo mai essere del tutto.
Il campo trascendentale impersonale altro non è, insomma, che il cinema come reale o il reale come cinema, in quanto fattore di radicamento immediato della gnoseologia nell’ontologia, del sapere nell’ente, della ricerca nel mondo. La peculiarità di un trascendentale desoggettivizzato consiste infatti nel mettere in comunicazione, rivelandone l’irriducibile simmetria, il fulcro centripeto della conoscenza con quello centrifugo, vale a dire, nel mostrare come il presupposto di ogni apprensione conoscitiva sia anche il terminus ad quem ultimo della stessa.
Persino nei nostri traffici meno teorici, non possiamo fare a meno infatti di basarci su una cieca «credenza» nel reale che nessuno meglio di Deleuze ha saputo tematizzare, una credenza che la dialettica altrimenti interminabile di «comprensione» e «incontro», declinata in termini fenomenologici da Jean Hyppolite nel corso di un convegno Husserl delle 1957 a Royaumont (p. 155 e ss.), impone di ricollocare appunto sullo sfondo di un campo trascendentale a-soggettivo. È questa credenza che il nome di “trascendentale” significa, in ultima istanza, e che un certo gesto filosofico converte in questione esplicita, conferendogli per l’appunto lo statuto di un’implicatura a doppio senso tra pensiero ed essere, tra conoscenza e mondo, tra logica ed esistenza. Cosa altro sta ad indicare, infatti, la questione posta da Kant circa la legittimità dei giudizi sintetici a priori se non lo sforzo di un pensiero che, legiferando in maniera necessaria e universale su una materia interna al suo medesimo operare, costituisce nondimeno un incremento effettivo di conoscenza? Che cosa sta a segnalare, appunto, quest’intreccio se non la possibilità per il pensiero di toccare l’essere almeno quanto si lascia toccare da esso, restando in se stesso? Sia pure in maniera ancora insufficiente, perché troppo ancorata allo stampo dell’empiria (sostanzialmente, della coscienza), il pensatore di Könisberg ha proiettato comunque la conoscenza al di sopra di sé, nell’incrocio in cui il suo guardare si costella insieme al suo fare e in cui non si dà più alcun altro reale oltre un differire da sé intrinsecamente «autopoietico» (così lo definisce efficacemente Piatti).

Henri Bergson A parte allora la sibillina previsione foucaultiana circa l’avvenire del suo pensiero (che avrebbe dovuto informare di sé il XXI secolo), c’è forse un motivo poco avvertito all’origine dell’interesse con il quale la filosofia del presente continua, con un grado di ossessività altrimenti incomprensibile, a rivolgersi all’opera di Deleuze. La sua riflessione non si limita infatti a proporre un’ontologia tra le altre, fondata magari sul ruolo auto-costitutivo della differenza e/o su quello sovversivo dei divenire (con Guattari), ma conferisce alla stessa esigenza filosofica di totalizzazione dell’esperienza la sua ultima giustificazione. Deleuze, in altre parole, è il filosofo che più di ogni altro ha fatto della necessità in quanto tale di filosofare l’architrave della propria concezione del reale, rendendo così particolarmente arduo, ai suoi successori, proseguire su questa strada senza rendergli un ripetuto omaggio. C’è insomma una sorta di esplosione proiettiva, nella sua opera, che, per quanto per lo più non vista, ne fa uno dei luoghi in cui la filosofia, pur conservandosi del tutto realista, si ritrova comunque a contemplare la propria immagine, a vedersi insomma nel mondo come la superficie cangiante nella quale prende forma ogni realtà. La sua insistenza sulla scaturigine esternalista del desiderio di filosofia, come riposta a una sollecitazione che costringe letteralmente a pensare, è a tale proposito sintomatica: ne va della stessa situazione in cui si ritrova ciascun filosofo, quando sperimenta l’azione di un appello incessante di cui non coglie mai del tutto il senso, a meno che non ne faccia la cifra decisiva del reale stesso. Si capisce dunque il tenore quasi ossimorico di molte delle nozioni capitali della sua concezione. “Empirismo trascendentale”, “piano di immanenza”, “sintesi disgiuntiva”, solo per prendere tre esempi tra gli altri, realizzano una sorta di fusione a freddo di quanto per natura sarebbe dovuto rimanere separato: l’a posteriori e l’a priori, il liscio e lo striato, l’unario e il molteplice, ritrovando così nella “cosa stessa” la logica che anima da sempre la sua ricerca in-finita.
Per quanto si tratti infatti di una locuzione di Jean-Paul Sartre, escogitata in La trascendenza dell’ego (1936) per distanziarsi dalla piegatura egologica presa dalla fenomenologia husserliana, il “campo trascendentale impersonale” assume subito la portata di una meta-questione, atta a dare forma al gesto filosofico in quanto non si distingue più dal suo correlato paradossale. Nella prefazione, Rocco Ronchi la definisce appunto, con un’espressione di Arthur O. Lovejoy, un’«idea-unità» (p. 9), nozione distinta tanto dal singolo concetto, quanto dal principio generale, proprio dal fatto di avere una «carriera» (p. 10), un cursus specifico attraverso i pensieri di coloro che in modi sempre eterogenei pure vi si richiamano. Questo correlato non ha perciò più nulla dell’oggetto contrapposto a un osservatore, né tantomeno del soggetto che si ripiega su di sé per guardarsi guardare il mondo, come avviene per lo più in ambito fenomenologico, ma si presenta piuttosto sotto la forma di un mondo che si vede e che si costituisce mentre si vede, senza avere però mai alcun centro privilegiato da cui accedere a questa ‘visione’ che non sia il proprio stesso esistere. Leggendolo, assistiamo insomma a una lunga e sempre più decisa emersione di questa istanza teorica attraverso un corteo di filosofi che, nel corso del Novecento, si sono chiesti che cosa rendesse effettivamente possibile l’incontro conoscitivo, non più assimilabile semplicemente, dopo la débâcle kantiana della metafisica, alla forma paradigmatica di una relazione tra poli numericamente distinti e ontologicamente difformi (il soggetto e l’oggetto, la rappresentazione e la cosa, l’archetipo e il simulacro). Ne va insomma della stessa questione, come l’Autore si premura di sottolineare (pp. 288-9), sollevata da Menone, nel dialogo eponimo di Platone e che un Socrate stupefatto riassume con queste parole: «non è possibile per l’uomo ricercare né ciò che sa [perché lo sa già] né ciò che non sa [perché non saprebbe come riconoscerlo]!» (Men., 81a). In questa celebre aporia si profila un dubbio che, se spinto alle sue conseguenze più radicali, fa tremare non soltanto i polsi dei filosofi, in quanto disconnette per sempre ricerca e sapere, ma anche le fondamenta del nostro commercio quotidiano con il mondo.
L’ontologizzazione del Filosofico (con la maiuscola a capolettera) da parte della filosofia medesima è allora il vero oggetto della trattazione di Piatti. Il percorso proposto in queste pagine, nella sua ricchezza di riferimenti, è insomma una meditazione reiterata sull’inclinazione del pensiero a fare corpo con il suo altro – l’essere – e a ritrovarsi quindi nel proprio altro in forza della sua essenziale estraneità. Si badi, infatti, sotto il nome iper-tecnico di «campo trascendentale impersonale» non si intende qualcosa di adeguabile o di avvicinabile attraverso un movimento che lo supponga esistente al di là di sé. L’esperienza si rivela nella sua fattura cosmogenetica, e quindi non più come l’attributo di un qualche genere di soggettività, soltanto nel momento in cui si mostra nella sua natura pressoché artificiale, nel suo essere il prodotto di una genesi pre-individuale che la pone insieme, simultaneamente, a tutti i suoi altri prodotti (in senso stretto individuali e persino personali). L’effettuarsi dell’esperienza rimane lo stesso, che lo si trovi dal lato del soggetto o da quello dell’oggetto.
L’enunciato chiave della prospettiva di Piatti è perciò il seguente: «L’esibizione delle strutture cosmogenetiche del reale coincide insomma con la costruzione stessa del mondo che si abita» (p. 286). Questo enunciato ha infatti un’implicazione cruciale: esso stabilisce una corrispondenza tra il metodo filosofico e quello scientifico che ci permette di aggirare molte delle difficoltà che affliggono ancora il dibattito speculativo contemporaneo, caratterizzato spesso da una certa, residuale diffidenza nei confronti della scienza o da una simmetrica resa totale nei suoi confronti. Tale enunciato, in altre parole, si pone come il titolo di un programma filosofico che trova la propria scientificità, si parva licet, nel suo prestarsi a una in-finita serie di riformulazioni, ogni volta più approfondite. Il «costruzionismo» di questa concezione fa tutt’uno allora con il carattere a sua volta costruttivo del dispositivo discorsivo scientifico, il quale riconosce nel reale soltanto ciò che può ri-produrre grazie agli apparati formali e materiali delle tecnologie matematiche e sperimentali di cui si dota. Esso si identifica insomma con il non plus ultra del «naturalismo» (p. 287), ovvero, con la sostanza mutevole di una natura non-umana accessibile solo trasformandola. Ecco dunque che la ricognizione condotta da Piatti ci porta su una soglia critica con la quale la filosofia stessa ha da confrontarsi oggi, se non vuole rinunciare al suo compito propulsivo non tanto di scientia scientiarum (ruolo intenibile per tanti motivi) ma, si potrebbe dire, di tecnica delle tecniche, nella loro insindacabile e indispensabile pluralità.
Al di là della maggiore o minore confidenza che si può avere con il dibattito che il libro ricostruisce accuratamente – transitando anche attraverso l’ampia diatriba sulle aporie dell’intenzionalità fenomenologica dipanatasi tra gli anni ‘20 e gli anni ‘50 dello scorso secolo e le traversie del bergsonismo riletto da Vladimir Jankélévicth, Georges Canguilhem, Gilbert Simondon, Bento Prado Jr. e Victor Goldschmidt –, la questione in ballo è quindi immediatamente tangibile. Si sta parlando di vita – cos’altro dovrebbe essere infatti una tecnica delle tecniche? –, una vita da intendersi tanto in termini esistenziali che biologici, a questa altezza inscindibili. Si sta concependo una vita, in breve, che si concreta in una operazione sempre fallita eppure mai veramente evacuata come impossibile, una vita risolta in un tentativo di essere qualcosa di definito, e al limite di definitivo, coincidente però a sua volta con la propria costante messa in questione e quindi con la sua costante trasmutazione. Il vitalismo ostinatamente rivendicato da Deleuze (p. 240 e ss.) è in questo senso oltremodo rivelativo.
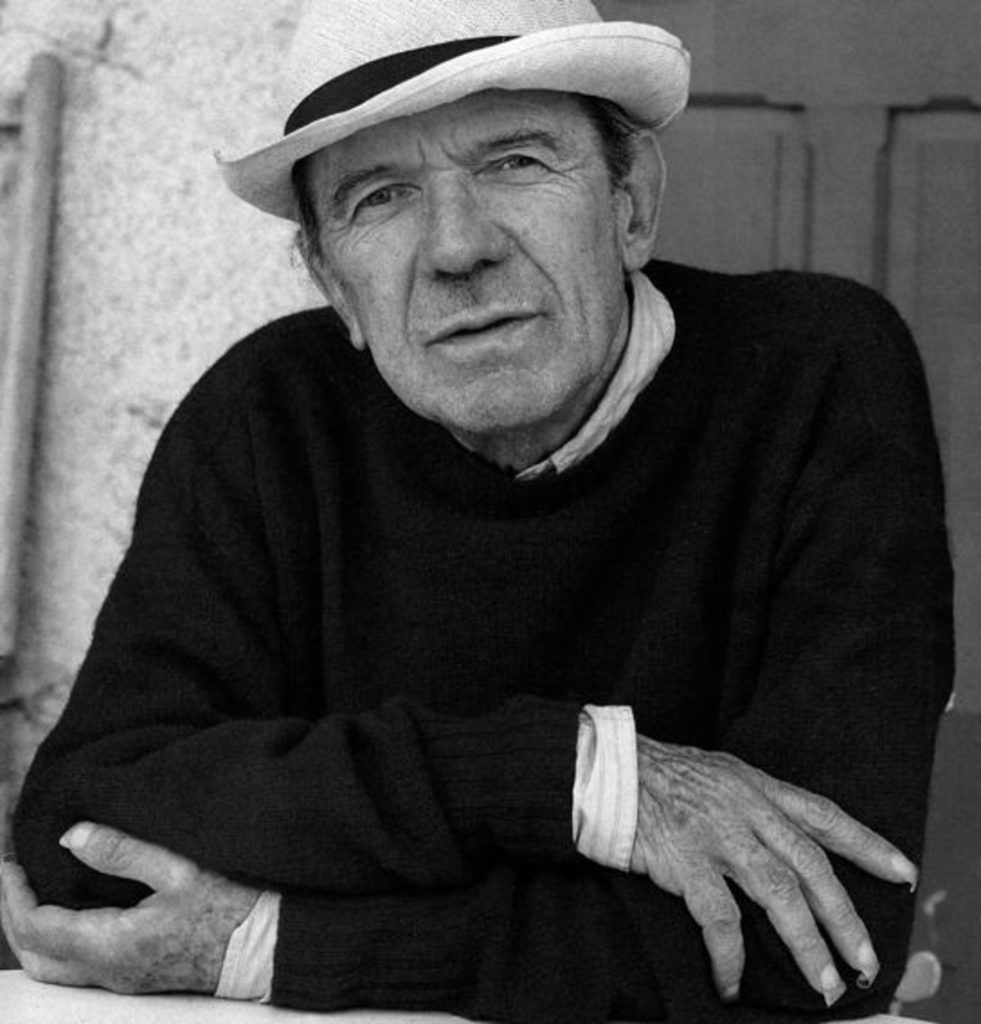
Gilles Deleuze La messa a fuoco del virtuale, nella vicenda allestita da Piatti, assume perciò un valore emblematico, capace di portare alla luce l’agentività stessa del Filosofico e della vita in generale. Il «ricordo puro» di cui parla Bergson in Materia e memoria (1896) e al quale non attribuisce nessuna efficacia determinata, se non quella di un’ipotesi teorica simmetrica a quella altrettanto «di diritto» della percezione pura, si rivela, nel prosieguo dei riarrangiamenti che subisce arrivando nelle mani di Deleuze, dotato di una sua specifica operosità, riconducibile al tentativo di fondare un’esperienza propriamente filosofica, distinta da tutte le altre esperienze di cui la nostra specie è capace. Un’esperienza che ha come sua cifra paradigmatica una certa auto-progressione, un lento procedere non verso qualcosa d’altro, ma verso se stessa, nel suo restare comunque parzialmente opaca al proprio medesimo sapere (come accade d’altronde a tutte le altre nostre attività, almeno sin quando non se ne fa carico, appunto, la filosofia). Un’esperienza che ci rivela inerenti, insomma, al cosmo in quanto è una genesi e non uno stato di cose, più o meno articolato che sia. Ecco perché Piatti, con sottile quanto significativa decisione, insiste col chiamare l’insieme delle immagini bergsoniano un «sistema» (p. 32) delle immagini. Il “sistema” (dal greco synistemi, “raccolgo”) è l’elemento elettivo dell’esperienza filosofante, in quanto resta al di qua (o al di là) di se stessa, nel mentre che ne ricava sempre ulteriori prospezioni. Il virtuale si mostra insomma quale statuto della filosofia, in quanto non riesce mai del tutto nel compito al quale non può comunque rinunciare: istruire un sistema in cui tutte le altre esperienze possano tenere e fare uno. Un’esperienza delle esperienze, insomma, che le raccordi lasciandole essere per quello che sono (e per quello che stanno diventando, soprattutto). In tal senso, le analisi di Piatti sono rilevanti anche nella misura in cui riconoscono una sorta di andamento a soffietto che contraddistingue tanto la metafisica di Bergson, quanto quella dei suoi variegati prosecutori, e che scandisce la stessa forma dinamica dell’universo come cinema in sé. Questo andirivieni conservativo e cumulativo tra presupposto e risultato, tra premessa e conclusione, dà la misura dell’estendersi delle considerazioni bergsoniane da un nucleo soggettivo-interiore (nel Saggio sui dati immediati della coscienza, del 1889) a uno sempre più apertamente cosmologico-evolutivo [in L’evoluzione creatrice e Durata e simultaneità, innanzitutto, (1907, 1922)], con un procedere che mima di fatto la vitalità dello stesso campo trascendentale impersonale. L’archetipo diventa qui simulacro del suo simulacro almeno quanto l’inverso e l’immagine si sutura infine senza scarti al suo referente. È così che viene in chiaro insomma la forma logica della progressività filosofica, manifesta soltanto allo sguardo di chi, con ritrovata consapevolezza del proprio mestiere, non si limita a guardarsi guardare, ma si si impegna a «vedersi vedersi» (Paul Valéry). Di colui, in breve, che tenta di cogliere non solamente il mondo nello specchio della sua apprensione soggettiva, ma come immagine cangiante della medesima dislocazione di sé che è necessario compiere per reperirsi nel mondo, quale essere già da sempre immerso in esso. Per dire la cosa altrimenti, che si scopre quale effetto di un’auto-differenziazione che coincide immediatamente con il divenire delle cose, quali che siano, e che le mette in comunicazione, senza alcun grado gerarchizzato o stratificato di partecipazione, con un principio sempre anche immanente a ciascuna di esse. Donde le splendide osservazioni riservate al processo di cristallizzazione (p. 250 e ss.), come modello di qualsivoglia genesi.
Allo stesso modo in cui è allora possibile leggere nella fisica relativistica un colpo di sonda nelle condizioni di osservabilità empirica del reale (fissate una volta per tutte dal valore-limite della velocità della luce) e nella meccanica quantistica un’insorgenza di quelle relative alla spiegazione scientifica in generale (come ha notato di recente Sergio Benvenuto su Philosophy Kitchen, identificandole nei paradossi della localizzazione che caratterizzano quella disciplina), così è possibile rintracciare nella direttrice di pensiero ripercorsa da Piatti un chiarimento sempre più dirimente di che cosa significa pensare e di come il pensiero non pensi mai altro che se stesso, pensando anche sempre qualcosa di altro da sé. È qui che il filosofo, guardandosi allo specchio, raggiunge il mondo stesso, esce fuori di sé e si confonde con la polvere di stelle di cui è fatto (il) tutto. Per provare quindi a rispondere a Menone, secondo questo impianto teorico, si dovrebbe dire che si cerca sempre quello che non si sa, ma solo perché si crede, si crede solamente, di saperlo già.
Ora, l’uso della scienza da parte della filosofia avviene quasi sempre sul crinale malfermo delle difficoltà incontrate dalla prima. Non è in forza delle convergenze tematiche oggettive tra funzioni scientifiche e concetti filosofici che il filosofo è chiamato a sua volta a dare una sistematizzazione di risultati per altro tra loro non necessariamente (e anzi, necessariamente non) comunicanti, ma grazie appunto alle scuciture, alle esitazioni e alle impasse che caratterizzano e forse caratterizzeranno per sempre il discorso scientifico. Il filosofo ha insomma l’ambizione di ‘curare’, per dir così, l’esperienza efficace della scienza dalla sua pur inevitabile dispersione, di farne il punto di partenza di una qualche sintesi integrale, in cui ci si possa riconoscere anche il famigerato “senso comune”.
Non è vero però l’inverso. Lo scienziato ha sì bisogno di filosofia, ma, come è stato notato per esempio da Canguilhem, non alla stregua di un ausilio finalizzato alla contestualizzazione metafisica delle proprie asserzioni. È piuttosto nella funzione di un’ideologia da scardinare, di un sistema di credenze da far saltare, che la filosofia interviene all’interno del lavorio continuativo dei saperi positivi; è come errore da emendare, insomma, che il palinsesto teorico volto alla “totalizzazione dell’esperienza” può funzionare fruttuosamente nel procedimento della ricerca scientifica, pronta a istruirsi nello spazio vuoto (nello spazio svuotato) lasciato dal primo. Anzi, quando ci si serve di ritrovati filosofici in ambito scientifico si corre spesso il rischio di dogmatizzare inutilmente quanto invece fa la forza dell’impresa scientifica moderna – la sua fallibilità esibita senza vergogna e il suo tenore auto-critico organizzato tecnologicamente e collettivamente. La scienza pretende insomma di curare a sua volta l’intelletto umano dalla sua peraltro irresistibile tendenza alla totalizzazione. A meno che, con una piroetta meta-filosofica degna di un acrobata del pensiero, il filosofo non si chieda che cosa rende concretamente possibile la sua stessa pratica e faccia persino di questa domanda, portando la propria vocazione riflessiva al suo punto critico, l’oggetto privilegiato e inesauribile della propria interrogazione. A meno che, insomma, il filosofo non arrivi a lambire direttamente il cuore della pratica che lo riguarda, cuore isomorfo, nel suo chiedere conto della possibilità medesima del filosofare, alle virtù della scienza in senso stretto, perché esposto, infine, a un continuo e felice fallimento.
Per quanto allora non si fondi su un confronto circostanziato con i risultati scientifici della contemporaneità, il lavoro di Piatti fornisce una perlustrazione preziosa tanto da un punto di vista metafisico quanto, a ben vedere, da uno epistemologico e, quindi, meta-filosofico. È infatti in questo nodo – in questo sovrapporsi vertiginoso di immagine e reale o di interrogazione e genesi – che scienza e filosofia si incontrano a loro volta, alla luce, reciprocamente, delle loro insufficienze e dunque del loro (de-)completarsi, per così dire, a vicenda. Tanto il filosofo che lo scienziato scoprono qui di aver a che fare con uno sfondo fungente di processi che li travalica, insediandoli però nella loro postura interrogativa, istituendoli anzi come interrogazione continuata che il mondo opera su se medesimo. L’universo come cinema in sé appare insomma in forma di una domanda che le cose pongono a se stesse, incessantamente (donde la deleuziana attribuzione di statuto del reale al «problematico» in quanto tale). La nostra credenza inossidabile nel reale può perciò coincidere infine con la sua incessante ri-costruzione e la cura scientifica dalla totalità diventare la stessa cosa della cura filosofica dalla disseminazione.di Daniele Poccia
-
GAME OVER. Occhiali a specchio, cibernetica e informazione
Longform / Settembre 2021.
Dietro le lenti
La narrativa cosiddetta cyberpunk nasce all’inizio degli anni Ottanta del secolo scorso. Si presenta da subito come una cesura abbastanza netta tra due epoche diverse della letteratura fantascientifica; una frattura quasi irrimediabile tra un “prima” e un “dopo” destinata non soltanto a lasciare ampia traccia di sé ma anche a contrassegnare una soglia osmotica tra una concezione della realtà – o meglio, della scrittura di quella realtà – e la sua rappresentazione, dischiusa su scenari molto suggestivi. Il cyberpunk – definito spesso in modi diversi nel corso di quegli anni: Radical Hard SF, Outlaw Technologists, Neuromantics – è premonizione di impensabili orizzonti dell’essere, di evoluzioni della società e della tecnologia che nemmeno il più ardito degli scrittori avrebbe mai osato immaginare.
Si possono individuare tre differenti date costitutive del Movimento cyberpunk: nel 1982 viene organizzata una storica tavola rotonda alla convention sulla fantascienza “ArmadilloCon” che si tiene a Austin nel Texas [1]; nel 1984 William Gibson [2] pubblica Neuromante (1986) e due anni più tardi esce l’antologia Mirroshades (1986), a cura di Bruce Sterling [3], un altro importante capofila dei ragazzi dagli “occhiali a specchio”.
Gli occhiali da sole a specchio sono stati un totem del movimento fin dai primi giorni del 1982. Le ragioni di ciò non sono difficili da capire. Attraverso il nascondere gli occhi, le lenti a specchio ostacolano le forze della normalità a comprendere che uno è impazzito e possibilmente pericoloso. Essi sono il simbolo del visionario che fissa lo sguardo al sole, il biker, il rocker, il poliziotto, e fuorilegge simili. Le lenti a specchio – preferibilmente in cromo e nero opaco, i colori del totem del movimento – apparvero in ogni novella, quasi fossero una specie di distintivo letterario. (Sterling 1990, 37)
Il cyberpunk è un prodotto schietto dell’ambiente culturale nord-americano di quel periodo e probabilmente ne è una penetrante rappresentazione. Le sue radici affondano nella tradizione della fantascienza popolare degli anni Sessanta. Ellison, Delany, Spinrad, Aldiss, Ballard, Anderson, Heinlein, senza dimenticare i “giochi di realtà” di Dick: sono questi i precursori e gli ispiratori dei nuovi romanzieri che si stanno misurando con una incipiente fine secolo superiore a tutte le aspettative, inverando senza dubbio molte delle anticipazioni che il Movimento delle lenti scure ha fatto proprie, intuendole nella filigrana della storia. Si è spesso detto dell’analogia tra punk e cyberpunk, entrambi processi di superamento e liberazione che non tagliano i ponti col passato, anzi ne assorbono gli insegnamenti e li manipolano mantenendo con esso accostamenti sonori e sintattici, riletti in chiave esplosiva e spiazzante. Insomma, come il punk scioglie il rock and roll dalle briglie sinfoniche del progressive rock, così il cyberpunk affranca la fantascienza da influenze decennali pur se i suoi rappresentanti sono cresciuti nella tradizione letteraria della Science Fiction. Il corpus narrativo classico sembra essere saturo e la realtà quotidiana sopravanza ogni fantasia possibile. Qualcosa, dunque, si libera in quel decennio e nonostante l’etichetta cyberpunk non sia stata mai scelta da nessuno dei componenti di quella geniale brigata, il termine entra in uso perché sintetizza un intero clima culturale, fatto di high-tech e di pop underground nei quali si mescolano video-rock, hacker clandestini, «tecnologia di strada dell’hip-hop e della musica scratch» (Sterling 1990, 38).
E proprio di quel milieu così particolare, fatto di visioni apocalittiche, esistenze ai margini, ibridazioni tecnologiche e oscure periferie urbane nella quali si muovono esseri umani “ai margini”, ci occuperemo nelle prossime pagine, rovistando tra “regimi discorsivi” e idiosincrasie al silicio per disegnare una cartografia, certamente imperfetta, del dispositivo culturale che la scrittura cyberpunk generò, prima di spegnersi alle soglie degli anni Novanta del Novecento, riecheggiando i motivi di una eterna rivolta contro un ordine sociale incrinato dal confondersi della macchina con la carne, mentre l’”analogico” veniva espropriato dal tumultuoso affacciarsi del “digitale”.
.
Di cibernetiche e altri movimenti
Il prefisso cyber proviene dalla parola “cibernetica”, in lingua inglese cybernetics. La cibernetica governa quella parte della sperimentazione scientifica che studia le analogie funzionali tra i meccanismi biologici di controllo e regolazione degli esseri viventi e i meccanismi artificiali delle macchine. Cybernetics è lemma coniato dal matematico americano Norbert Wiener (1948). Wiener riprendeva il concetto espresso in greco antico dalla parola “kubernetes” [κυβερνήτης], pilota di navi, anche se gli attribuiva un significato diverso dopo qualche secolo di evoluzione etimologica, assecondando parzialmente la sua distorsione. Tuttavia, nella cultura greca di allora non si trattava soltanto di saper usare il timone, piuttosto di conoscere ogni singolo componente dell’imbarcazione e il criterio con cui era stato realizzato. In aggiunta, essere un buon pilota significava anche, o forse soprattutto, sapersi orientare, e per farlo bene era necessario possedere solide conoscenze di astronomia, geografia, cartografia ed essere capaci di “annusare il mare” attenti alle variazioni meteorologiche. Con l’arrivo della civiltà latina il pilota divenne gubernator, un individuo più adatto al comando che alla conduzione, secondo il prevalente principio del controllo centrale da esercitare su un vasto territorio quale sarebbe stato l’Impero. Il gubernator svolgeva il suo compito essenzialmente sottomettendo. Wiener, quindi, in maniera più o meno inconsapevole utilizzava il termine filtrandolo attraverso l’accezione romana. La cultura cyberpunk, al contrario, recupera l’etimo greco configurando una “possibilità sociale”, chiamiamola così, affatto diversa.
Almeno sino alla fine degli anni Venti del XX secolo era stato l’orecchio a farla da padrone. Le tecnologie sviluppate fino a quel momento, il telegrafo e il telefono, avevano fatto dell’ascolto il canale privilegiato per la comunicazione. Ascolto, e vocalizzazione quando il telegrafo divenne “parlante” e si scoprì che si poteva trasferire anche la voce oltre ai segnali ticchettanti dei vari codici di trasmissione tra cui primeggiava il Morse (Coglitore 2016). Con l’arrivo negli Stati Uniti della prima, embrionale televisione, intorno al 1927, sarebbe stato l’occhio ad assumere valenza primaria con tutto ciò che ne sarebbe conseguito.
La società occidentale avrebbe dovuto attendere ancora una quarantina d’anni prima che il Personal Computer (PC), televisore interattivo stupefacente all’epoca, facesse capolino nelle case e negli uffici, dopo che Internet si era affacciata alle soglie di quella modernità a lungo covata nei laboratori militari e universitari americani. L’introduzione del PC, a partire dagli anni Settanta, provocò una serie di sensibili cambiamenti, inequivocabili con la sua diffusione di massa dal principio degli anni Novanta. Il PC è un media elettrico, ovviamente. Rispetto ai suoi ascendenti altrettanto famosi, il computer innalza in generale l’indice di produttività e consente a ciascun individuo, lo vediamo benissimo ai nostri giorni, notevoli capacità di elaborazione, di condivisione e di ampliamento della conoscenza che fino a poco tempo prima erano appannaggio di grandi gruppi industriali o di agenzie governative. Scale gerarchiche e distanze sociali si riducono notevolmente e le competenze individuali percorrono la Rete in modo trasversale scavalcando barriere che sembravano invalicabili.
L’attrezzatura informatica consente libero scambio di informazioni e una sostanziale semplicità di utilizzo del medium, che implementa nuove aggregazioni sociali, aziendali e persino politiche. Lo spazio, infine, subisce una rinnovata “conquista” perché le distanze, come era accaduto per telegrafia e telefonia, perdono di significato. L’universo digitale cancella i confini e l’idea stessa di confine. I nostri sensi e le nostre azioni possono estendersi per migliaia di chilometri, ben oltre il nostro corpo come strumento naturale di acquisizione percettiva del mondo circostante; la tecnologia si sostituisce ad esso nella sua condizione di misura della realtà che rimodula proprio attraverso l’approntamento digitale della geografia umana e fisica. Il territorio non è più essenza e presenza delle cose ma sua immagine virtuale, ancorché saldamente radicata poiché lo riproduce nei dettagli; lo ombreggia in una assenza che il medium rende irrilevante, alterando il senso dello spazio materiale e sociale.

Bruce Sterling Interagire attraverso il computer, senza dimenticarci dello smart-phone, ci isola dall’ambiente circostante e ci lascia sperimentare inedite emozioni. Il “cyberspazio”, luogo della virtualità assoluta, è campo d’azione e non più semplicemente una simulazione dalle qualità sorprendenti: piuttosto, suggerimento per una socializzazione differente, originata nella e dalla relazione di reciprocità che la tecnologia suscita. L’abbandono della tradizionale tridimensionalità degli oggetti fisici, corpi compresi, comporta la sostituzione di una obsoleta “spazialità” con simbologie all’inizio meno rassicuranti ma d’appresso evocatrici di una dimensione della mente che introduce a rappresentazioni sceniche degne di un’allucinazione crudele e curiosa, radicalmente “altro” da tutto ciò che finora avevamo sperimentato. Di più, la morfologia del “cyberspazio” cancella una volta per tutte l’oggettività dell’interpretazione. Si presenta, cioè, come artefatto che sfugge alle regole consuetudinarie, si sottrae a qualsiasi classificazione, muta continuamente nella sua complessità diversificante.
La “cybercultura” (termine con il quale ci riferiremo, in forma contratta, alla cultura cyberpunk) consiste, quindi, quando la indaghiamo dal punto di vista della ricaduta nel sociale, nell’interiorizzazione di queste nuove “estensioni”, comprendendone il potenziale interattivo nella consapevolezza che non potremo che riadattare i sensi a questa modificata condizione. Nuovi fenomeni conoscitivi germogliano attorno a noi e ci riaggregano in un diverso “stato”, lasciandoci galleggiare negli oceani del digitale.
.
Informazione/informazioni
La cultura cyberpunk, a questo punto, si definisce in quanto “agente” che si appropria dell’informazione, la trasforma, e per mezzo del suo rimaneggiamento interviene nel mondo cui ci siamo abituati sin dalla tenera età indicando seducenti alternative. La notazione punk, che fa da spalla quasi alla congerie cibernetica in questo gioco delle parti che continuamente si rimescolano, conferisce quella robusta aura di “non regolare” che rompe gli schemi tradizionali rigenerandoli in altro. E cos’era stato il Punk se non divorzio dalla musica “colta”, abbandono dello spartito del “rock progressivo”, involuzione estetica contro ogni dogma della buona società borghese che aveva persino tentato, in piccola parte, una pallida ribellione nei dintorni degli anni Sessanta del Novecento? Cos’era stato se non rivendicazione di una unicità individuale nella produzione artistica? Ben al di là della classica concezione di computer e di Rete in qualità di “arnesi” che facilitano l’attività lavorativa oppure di sistemi di controllo di fiacche volontà, la tecnologia vista nell’ottica cyberpunk diventa snodo del ricondizionamento della realtà. Gli hackers e i più abili esperti di Informatica altro non sono che esploratori di sconosciute lande digitali, apparati di comunicazione e insieme di tecniche d’uso oggetto di una sacralizzazione laica.
La “cybercultura”, in sostanza, non è che il venire in evidenza dell’evoluzione della tecnologia. È già successo altre volte nel dipanarsi discontinuo della storia occidentale degli ultimi duecento anni. La letteratura cyberpunk imprime una particolare connotazione all’idea di cibernetica, approntando nuove grammatiche per la fantascienza, e immagina una società non troppo distante nel futuro zeppa di bizzarri personaggi, a dire il vero molto punk, che lascia agire in canovacci narrativi degni di un viaggio lisergico alla Timothy Leary “prima maniera”. Questa celebrazione dello straordinario e del cupamente introspettivo, in una dolenza che pulsa costante come un battito di cuore artificiale, è un racconto del presente, l’interpretazione verosimile di cose che stanno accadendo o che stanno per accadere. Si tratta di un coacervo di stilemi linguistici e cognitivi che quasi per forza si imbeve di politica, utilizzando il termine in accezione ampia. Perché è davvero la pòlis ad essere oggetto di un’anatomia dissacrante, un frugare arroventato tra le innervature della società occidentale per richiamare l’attenzione su scenari del probabile: lo strapotere delle multinazionali, l’assenza praticamente totale delle istituzioni, l’ossessione per la tecnologia, i linguaggi volutamente oscuri, le “sculture sociali” decisamente pop. Tant’è che una caratteristica di questa letteratura d’arrembaggio è lo studio approfondito dei cambiamenti socio-tecnologici, delle loro cause e degli effetti che producono sugli umani o su ciò che di loro resta. Sui loro corpi “trasformati”.
I corpi. La cultura cyberpunk ne propone l’apologia. Elemento-chiave di questo appuntamento microfisico con la fantascienza è il cyborg. Vediamolo da vicino. Quanto di meccanico deve esserci perché si possa parlare di organismo cyborg invece che di essere umano? (Tagliasco 1999; Caronia 2008, 41-55). Tentiamo una “tassonomia”, e concentriamoci sulle corrispondenti tecnologie di sostituzione che possono essere: “re-integrative”, con il ripristino di funzionalità perdute o di sostituzioni di organi e arti; “normalizzanti”, che riportano ad uno stato originario, riparando anomalie organiche; “riconfiguranti” che danno origine a creature post-umane una volta concluso l’intervento di ricostruzione; e infine, “potenziatrici”, che a scopo militare o industriale generano esseri talmente forti da risultare invincibili.
Al rimodularsi della percezione della realtà con il rafforzamento delle capacità sensoriali, il “cyberorganico” ci proietta in un mondo alieno, diverso sotto ogni rispetto. Il cambiamento si radicalizza ancor più quando il mezzo diventa una nostra estensione, e parti del corpo ci inducono a “sentire” diversamente, a toccare diversamente, a ricevere stimolazioni che mai avremmo immaginato. Il corpo non è più “luogo” di relazioni sociali e mentali; è, semplicemente, “struttura” da modificare e collaudare. Le conseguenze non saranno banali: ciò che siamo individualmente si muoverà su una scala post-evolutiva con esiti scioccanti e inaspettati, segnando sentieri che portano all’inconoscibile. Per il momento in questa attuale, prosaica contemporaneità, ci accontenteremo di rimedi a “bassa intensità”: una correzione della curvatura della cornea per migliorare la vista, un bypass per cuori “ballerini” o un trapianto d’organi che ci permette di sopravvivere.
In verità, la constatazione che attualmente il cyborg è ancora di là da venire, non ci esime da un’altra riflessione, e cioè che potremmo almeno considerarci dei borgs. In una delle tante serie televisive sui viaggi di una celebre astronave, Star Trek-Next Generation, i borgs si spostano negli spazi interstellari in vascelli a forma di cubo e quando entrano in contatto con una specie sconosciuta tendono ad assimilarne componenti e conoscenze facendone dei droni, simulacri di cyborgs connessi al resto della collettività in una indissolubile unione. Ogni singolo individuo pensa a se stesso al plurale, l’Io si è fatto Noi imprescindibile per la stessa sopravvivenza della comunità. E non è questo che siamo diventati negli ultimi decenni utilizzando i media come facilitatori di un pensiero collettivo che si diffonde inarrestabile nella Rete? Molteplicità e unicità convergono assieme attraverso i mezzi di comunicazione con i quali contribuiamo giorno per giorno all’evoluzione di un general intellect che ci trascina fuori dal corpo dopo aver maturato le prime esperienze di spostamento cognitivo suggerite da radio e televisione, embrionali surfs per cavalcare le onde dell’informazione.
È pleonastico rammentare cosa rappresenta Internet oggigiorno con motori di ricerca che danno accesso a miliardi di dati sull’intero scibile umano. Così, ci siamo abituati a percepire il Web come luogo dell’intelligenza filogenetica dove si può sperimentare qualsiasi tipo di conoscenza e dove ciascun processo discende dall’attività comune di milioni di menti collegate in un densissimo tramaglio di modalità esistenziali.
I soggetti performanti non sono più definibili con esattezza. Le famose “agenzie di socializzazione” (Parsons 1956) sono scomparse; le organizzazioni istituzionali hanno perso centralità e valore, non sono più “camere di compensazione” delle istanze che interessano la cittadinanza virtuale, giacché essa è ormai governata dalla Rete. Software e hardware costituiscono il milieu “informativo” che plasma questo spazio sociale. La “cibercomunità”, l’occasione è propizia per sfatare uno dei miti di Internet, non è affatto una piazza: l’interazione cui siamo indotti in chat, o tramite un computer, facilita conversazioni che dipendono dall’uso simultaneo di unità al silicio custodite in bunker sotterranei a basse temperature. Il combinato-disposto di programmi e macchine assicura l’incontro in un luogo de-materializzato che esiste in tanto in quanto qualcuno lo occupa. La cultura, in questo reticolo digitale, è sostrato comune per chi frequenta quell’arena virtuale e ognuno porta con sé soltanto ciò che ritiene più opportuno della propria identità, potendola modificare a piacimento o addirittura falsare: il mio avatar sarà altro da me, se lo desidero. L’individuo “cybervirtuale” è di per sé assolutamente anti-istituzionale, e non perché si oppone all’istituzione, ma perché essa non esiste. A guardar bene, c’è una netta prevalenza dell’identità sul ruolo e l’identità si manifesta in un paesaggio astratto; il “cyberspazio” appartiene alla dimensione del vedere, non dimentichiamolo, che non è pura e semplice utopia.
Abbandonato il Sé fisico, perlomeno nel senso in cui noi concepiamo la materialità, il “cyber-Sé” si afferma come costruzione di una coscienza individuale consumata all’interno della rappresentazione virtuale ed è un prodotto schietto del cosmo macchinico inaugurato dalla tecnologia del computer. Il discorso della scienza è linguaggio computazionale che irrora la nostra vita di alimento nuovo propagandolo da una molteplicità di sorgenti negli sconfinati orizzonti dell’“altrove” digitale. Vengono sostituiti i fondali del palcoscenico; l’immanenza della tecnologia ce li rinnova come segno di una evidenza, del corpo e della mente, cui dobbiamo adattarci. Luoghi-non luoghi rimescolano il presente e spalancano una porta sull’infinito.
Cronache da Altroquando [4]
Nei mille universi dell’Elsewherre di Heinlein (conosciuto anche come Elsewhen), i cinque studenti protagonisti della storia si spostano a piacimento nel tempo grazie un trattamento ipnotico. Altroquando è una migrazione nel plausibile che si rifà ad alcune teorie in voga all’epoca anche nella Fisica sperimentale, una diffrazione che la mente può causare se adeguatamente stimolata. L’“altrove” che Gibson e sodali hanno immaginato, invece, pensando più alla lettura di un presente in atto che ad una anticipazione del futuro, è uno spazio-limite debitore alla nozione foucaultiana di eterotopia. Un “altro” rispetto all’organizzazione e alla regolazione di differenze tra gli spazi; ovverossia un “altro” rispetto a tutti gli altri spazi.
Ci sono dunque paesi senza luogo e storie senza cronologia; città, pianeti, continenti, universi, di cui sarebbe certo impossibile trovare traccia in qualche carta geografica o in qualche cielo, semplicemente perché non appartengono a nessuno spazio. […] Ora, fra tutti questi luoghi che si distinguono gli uni dagli altri, ce ne sono alcuni che sono in qualche modo assolutamente differenti. Si tratta in qualche modo di contro-spazi. I bambini conoscono benissimo questi contro-spazi, queste utopie localizzate. […]
La società adulta ha organizzato anch’essa, e ben prima dei bambini, i suoi contro-spazi, le sue utopie situate, i suoi luoghi reali fuori da tutti i luoghi. […] (Foucault 2006, 11-13) [5]
1966: alla radio Michel Foucault introduce il termine “eterotopia”. Tra i cinque principi che Foucault individua come elementi essenziali e costituenti di una eterotopia, il primo, e più importante probabilmente, ci avverte che non esiste società che non promuova la sua. L’“altrove” non è soltanto la geografia della conquista europea, dispiegata nel corso di alcuni secoli, che passa sotto il nome di colonialismo – territori e popolazioni da costringere alle volontà distruttive degli Imperi del Vecchio Continente –, ma anche la necessità impellente di collocarsi da un’altra parte, nei posti appartati del desiderio e del sogno. È evidente che Foucault sta pensando a dislocazioni materiali per quanto eterotopiche: il teatro, il giardino, le case di cura, le prigioni; non avrebbe potuto, per la sua stessa formazione e per il contesto socio-culturale nel quale visse, concepire uno spazio digitale e interrogarsi su di esso. Certamente, però, egli enuclea con la consueta precisione del cartografo avvezzo a disegnare mappe di senso alcune caratteristiche fondanti dell’eterotopia che interessano ai fini della nostra disamina. In generale, la regola aurea di una eterotopia sta nel giustapporre in un luogo reale più spazi che normalmente sarebbero incompatibili (Foucault 2006, 18). Quando Case, il pellegrino del “cyberspazio” protagonista di Neuromante, passa dalle mezze ombre di maleodoranti periferie alla fantasmagoria della Rete nella quale “digita” sé stesso, non fa altro che sovrapporre alla consistenza materica del suo mondo la brillantezza della “matrice”, a prescindere dal fatto che quest’ultima appartenga o meno all’ordine dell’esperibile per come ci è stato conculcato.
Quel che è importante sottolineare, ancora sulla scorta delle osservazioni del filosofo francese, è che le eterotopie “[…] hanno sempre un sistema di apertura e di chiusura che le isola nei confronti dello spazio circostante” (p. 23). In ciascuna di esse si accede sottomettendosi a dei riti di purificazione per acquisire la debita legittimità di ospiti. Il “cyberspazio” è proprio questo, a ben guardare, un affrancarsi dal mondo da cui si proviene, fatto di materialità corrotta, attraverso l’iniziazione che si compie collegandosi alla macchina e innescando nel proprio cervello una reazione chimica che consente di “entrare” nel regno del virtuale.
Si arriva così a ciò che c’è di più essenziale nelle eterotopie. Esse sono la contestazione di tutti gli altri spazi, e questa contestazione si può esercitare in due modi: o creando un’illusione che denuncia tutto il resto della realtà come un’illusione […] oppure creando realmente un altro spazio reale tanto perfetto, meticoloso e ordinato, quanto il nostro è disordinato, mal organizzato e caotico. (Foucault 2006, 25)
Si possono, a questo punto, individuare alcune analogie. Una fra le tante, prima di proseguire: abbiamo sollevato poc’anzi la questione della colonizzazione, illusione eterotopica a sentire Foucault. In quell’universo simbolico che è costruzione di senso, il viaggio fisicamente inteso verso i luoghi “altri” è compiuto perlopiù sovrapponendo gli spazi “vaganti” dei mezzi di trasporto, il più noto dei quali è stato la nave. La nave è per la nostra civiltà uno strumento economico di forte impatto e “insieme la maggiore riserva della nostra immaginazione. La nave è l’eterotopia per eccellenza” (Foucault 2006, 28). E in Rete, infatti, “navighiamo”, per ricordare qui l’espressione con cui indichiamo il movimento negli anfratti del non-analogico.
L’eterotopia sviluppa una differenza assoluta, un contro-spazio nel quale la società si riorganizza contraddicendo l’istanza stessa della sua produzione in un assimilarsi di rimandi reciproci. L’eterotopia è, perciò, prodotto degli insiemi sociali che vanno localizzandola in un assoluto “altrove” variamente configurato e spazializzato. L’apporto della tecnologia ha favorito l’insediarsi dell’ultimissima localizzazione esterna/interna a questa comunità sociale, la nostra, che insiste sulla contemporaneità con un addensamento spazio-temporale durante il quale i cicli degli eventi hanno una durata paradossalmente non storicizzabile, perché appartengono simultaneamente al passato, al presente e al futuro. Allora, l’eterotopia scandisce il ritmo di orologi senza regolarità cronografica, è un campo, una serie di campi, del possibile, anteriore e ulteriore insieme, origine e ugualmente fine del processo di composizione dell’alterità del luogo. E basterà ripensare per un istante a La macchina della realtà di Gibson e Sterling (1992), ucronia che descrive uno spazio dell’“altrove” a partire da una diversa evoluzione della tecnica non meno efficace di quella che abbiamo conosciuto nella nostra linea del tempo.
[continua nella Parte 2/2]
di Mario Coglitore (UniVe)
.
.
Bibliografia
Caronia, A. (2008). Il cyborg. Saggio sull’uomo artificiale. Milano: Shake Edizioni.
Coglitore, M. (2016). ““Pandaemonium”. Il telegrafo elettrico come fonte per lo studio della storia contemporanea”, Storicamente, 12, 1-27.
Foucault, M. (2006). Utopie Eterotopie. A cura di A. Moscati. Napoli: Edizioni Cronopio.
Gibson, W. (1986). Neuromante. Milano: Editrice Nord.
Gibson, W. & Sterling, B. (1992). La macchina della realtà. Milano: Mondadori.
Parsons, T. & and Bales, R. F. (1956). Family Socialization and Interaction Process. London: Routledge and Kegan Paul Ltd.
Sterling, B. (a cura di). (1986). Mirroshades. A cyberpunk anthology. Arbor House: London.
Sterling, B. (1990). Prefazione a “Mirroshades”. In R. Scelsi (a cura di), Cyberpunk. Antologia di testi politici. Milano: Shake Edizioni.
Tagliasco, V. (1999). Dizionario degli esseri umani fantastici e artificiali. Milano: Mondadori.
Wiener, N. (1948). Cybernetics, or control and communication in the animal and the machine. Cambridge (MA): The MIT Press.
.
.
Note
[1] Le “ArmadilloCon” sono state organizzate a Austin sin dal 1979 e sono da sempre un punto di riferimento per gli scrittori di fantascienza, non soltanto statunitensi. Quella del 1982 si svolse tra l’1 e il 3 ottobre. È ormai passata alla storia la burrascosa tavola rotonda sul cyberpunk (in quel momento ancora definito “fantascienza punk”), organizzata in quell’occasione e intitolata Behind the Mirroshades: A Look at Punk Sf. Su questo cfr. Mark Dery, Velocità di fuga. Cyberculture a fine millennio, Milano, Feltrinelli, 1997, pp. 106 e ss.
[2] Gibson è nato nel 1948 negli Stati Uniti e vive da molti anni in Canada. Autore acclamato della letteratura fantascientifica, è diventato famoso proprio con Neuromante, considerato il primo romanzo del filone cyberpunk. Vincitore del prestigioso premio Hugo nel 1985, Gibson si è imposto fin da subito come elemento di spicco del Movimento che ha rinnovato, o comunque cambiato profondamente, il modulo narrativo della fantascienza con le sue lucide, quasi oniriche, descrizioni di un futuro dominato dall’informatica e da spietate multinazionali che governano un mondo post-industriale, preda di una sofisticata tecnologia, invaso da droghe, computers, spietati traffici e trapianti di organi umani, mentre tutt’attorno dilaga una sfrenata ricchezza in mano a pochi privilegiati. Numerosi i romanzi al suo attivo dopo Neuromante, da Giù nel cyberspazio (Mondadori, 1990; ed. or. 1986), il suo secondo successo editoriale, a Inverso (Mondadori, 2017; ed. or. 2014), fino al recentissimo Agency (Mondadori, 2021; ed. or. 2020).
[3] Sterling è nato nel 1954 negli Stati Uniti, dove ha vissuto fino a quando nel 2007 si è trasferito in Italia, a Torino. Ha curato nel 1986 l’antologia Mirroshades, nella quale venne definito il filone cyberpunk. Tra le sue produzioni più famose ispirate al genere cyberpunk, ricordiamo La matrice spezzata (Editrice Nord, 1986; ed. or. 1985), Isole nella rete (Fanucci, 1994; ed. or. 1988), La macchina della realtà (con William Gibson e appartenente al genere steampunk, Mondadori, 1992; ed. or. 1990).
[4] Altroquando (Elsewhen) è un racconto lungo di Robert Heinlein scritto in origine nel 1939 e pubblicato con alcune modifiche nel 1941 nella rivista “Astounding Science-Fiction” con il titolo Elsewhere. Nel corso della narrazione si ipotizza che la mente umana, sciolta dalla sua appartenenza alla periferia spaziotemporale del nostro “qui e ora”, riesca a muoversi liberamente nel cosiddetto “multiverso”.
[5] Si tratta del testo di una conferenza radiofonica tenuta da Foucault su “France Culture” il 7 dicembre 1966 in un programma dedicato a utopia e letteratura.
.
-

Nel presente contributo cercheremo di analizzare lo strano caso del Random Darknet Shopper, opera d’arte che, avendo come perno un meccanismo aleatorio, mette in discussione il concetto di soggetto, inteso questo nella sua accezione filosofica, a partire dalle sue risonanze giuridiche. Software programmato ad acquistare casualmente merce sul darknet, ha avuto in sorte lo scontro con alcune antinomie giuridiche. Vedremo infatti come (§1) il principio di colpevolezza alla base del regime di discorso giuridico in cui l’opera si innesta si ritrova innanzitutto sul problema dell’individuazione: cos’è (oppure – forse meglio: quale parte è) il soggetto in causa? Il software? La mostra, intesa come luogo fisico? Oppure la mostra intesa come organizzazione di eventi? Già in quest’ambiguità iniziale possiamo rinvenire il fine primo e ultimo dell’“opera” in questione, quella di perturbare. In secondo luogo, il problema filosofico sollevato è se e come è possibile ritenere l’alea (come se fosse) un soggetto. Questa necessità giuridica non può non confliggere con il carattere meramente finzionale dell’attribuzione di una volontà a qualcosa di assolutamente caotico. Così facendo, il regime giuridico non può che ritrovare il suo ‘oggetto’ al di là o al di qua dell’evento stesso, ovvero nelle istanze enuncianti o enunciate individuabili del dispositivo stesso. Ad onor del vero, questo processo è sotteso a qualsiasi giudizio e l’interruzione discorsiva, l’individuazione di un’istanza, è proprio l’effetto che il discorso giuridico produce, non ciò su cui si articola. In modo eclatante, l’opera che andremo ad analizzare non fa altro che rendere manifesto questa dinamica. Attraversandone la storia, dalle sue esibizioni (§2) alla ricezione sui rotocalchi (§3), andremo ad esaurire la bibliografia filosofico-giuridica che vi si è interessata, mostrando i tentativi e le proposte risolutive di richiudere in un discorso morale lo scandalo aperto da questo paradossale “soggetto caotico”(§4).
.
.
1. L’opera
Random Darknet Shopper (abbr. RDS) è un progetto di computer art del duo svizzero !Mediengruppe Bitnik (al secolo Carmen Weisskopf e Domagoj Smoljo) svoltosi tra il settembre 2014 e il 2016. Come anticipato, l’“opera” è costituita da un software finalizzato a selezionare sul darknet in modo casuale, quindi ad comperare, merce del valore massimo di 100$ in bitcoin. Durante le mostre, il software procede a un acquisto a settimana. Gli articoli vengono così spediti direttamente sul luogo d’esposizione e collocati in apposite teche, che si riempiono progressivamente fino al termine della mostra. Come spiegato dagli autori sul loro sito, «Once the items arrive they are unpacked and displayed, each new object adding to a landscape of traded goods from the Darknet» (https://wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.bitnik.org/r/).
Evidenziamo fin da subito un’ambiguità relativa all’identità del progetto. Con ‘RDS’ si intende, infatti, a seconda dell’aspettualizzazione: (1) l’oggetto, ovvero il software (secondo l’attorializzazione), (2) il luogo dell’esposizione e la collezione dei vari oggetti progressivamente acquistati (per spazializzazione e temporalizzazione terminativa) e (3) le sue performance, le varie acquisizioni avvenute nelle cosiddette editions (qui temporalizzazione incoativa). Poiché ogni edition è indipendente dalle altre, la raccolta del materiale inizia di volta in volta daccapo, l’acquisto degli oggetti è, come detto, casuale e il riempimento delle teche è durativo nel tempo. In breve RDS si presenta, proprio per la sua «capacità di assumere diverse impreviste strutture fisicamente inattuate», come un’opera in movimento (Eco 1980: 44).
In secondo luogo, notiamo che, se da un lato RDS è un dispositivo situato, occupando specifici punti dello spazio (il PC che gli fa da hardware e la merce esposta), dall’altro la relazione tra il suo discorso e l’ambiente rende il dispositivo sia pervasivo che – coniando un termine da aggiungere a quelli di Eugeni (2010: §3.2) – esclusivo. Infatti l’articolazione del senso di RDS gioca sul fatto che il suo automatismo non permette in alcun modo di essere partecipi dei criteri d’acquisto. Non si sa quale prossima chincaglieria troverà sul web, se non quando questa verrà direttamente portata sul luogo via posta. Si comprende allora come i !Mediengruppe Bitnik abbiamo potuto concepire RDS come «a landscape of traded goods» provenienti dal darknet cui si aggiungono nuovi elementi una volta «unpacked and displayed».
Una pervasione, dunque, dovuta a una collezione che riempie gradualmente l’intera sala dedicata. Wunderkammer contemporanea, RDS ostenta il privato e il proibito nel pubblico, funzionando così da dispositivo di sacrificio (Agamben 2005: 84).
Inoltre, l’aspettualizzazione temporale presenta RDS come una performarce artistica, confermando in questo modo l’«ipotesi» di lettura secondo la quale le avanguardie siano la «lucida e spesso consapevole ripresa di un paradigma essenzialmente liturgico», da leitourgia: «‘opera, prestazione pubblica’» (Id. 2017: 24 e 21). Si spiega dunque il motivo per il quale il duo svizzero possano definire RDS «a live Mail Art piece».
Ma “live piece” tematizza chiaramente l’Unheimlichkeit di Freud (1919), condizione – banalizziamo – in cui si ha terrore che prenda vita un oggetto inanimato, che gli oggetti rimossi possano (ri)attivarsi e (ri)entrare nella nostra vita cosciente. Era questo un meccanismo già presente nelle Wunderkammern: qui «lo statuto dell’esperienza museale attuale» vacilla, avendo davanti un «processo di accumulo quasi automatico di cui si fa fatica a comprendere la logica» cui deriva quell’«effetto di senso particolare, quello della meraviglia» da cui il nome (Donatiello 2016: 64). In breve, RDS è una macchina enunciativa automatica di un contenuto oscuro come il darknet, dispositivo hauntologico (Derrida 1994) grazie al quale il fantasma di una parte remota della rete si manifesta nella “casa” infestandola di simulacri, a mostrare il caos che alberga ogni cosmos, come suo rovescio e suo fuori.
Considerando che non permette di anticipare nulla sui suoi acquisti, RDS presenta un «regime» di interazione «dell’incidente», nel quale l’alea si costituisce come soggetto. Da un lato !Mediengruppe Bitnik programmano RDS per fargli ottenere una «motivazione in qualche modo concessiva», poiché l’esecutore, il Destinatario, obbedisce ciecamente alla volontà del Destinante che l’ha programmato; dall’altro, però, la programmazione è assolutamente autoneutralizzante, poiché, come già detto, l’oggetto di valore cui deve tendere il bot è, al di là dei limiti materiali imposti, un oggetto qualunque (Landowski 2005: 43).
Il ‘soggetto’-RDS emerge come se marchiato da una perversione della massima agostiniana «Dilige et quod vis fac», “ama e fa' che vuoi” (In Io. Ep. tr. 7, 8), dimostrandosi vera e propria forma-di-vita (Agamben 2011 : 17). In altre parole, esso è un’attorializzazione dell’alea. La macchina randomica apre quindi alla «minaccia del rischio puro al di sopra di tutti i sistemi di sicurezza», installando serenamente l’«attesa dell’inatteso» (Landowski 2005: 74). Come «se all’origine tutto fosse [...] discontinuità», RDS «non consent[e] alcuna forma di comprensione, ci pon[e] davanti all’insensato; escludendo ogni possibilità di anticipazione, non ci offr[e] moralmente alcuna sicurezza» (Greimas 1987: 89 e 74-5). Questo regime è ciò cui tende la ricerca dei !Mediengruppe Bitnik: «Randomness implies a loss of control. Loss of control is something we intentionally seek in our works: we create situations and let them play out». In RDS, infatti, «loss of control is part of the concept by delegating the buying decision to a software bot» (2015: 41).
RDS, “soggettivando l’alea”, incarnandola come attore e riproponendone le dinamiche costitutive, apre a una serie di paradossi. Innanzitutto «è solo nella sua manifestazione, realizzandosi[,] che il caso si auto-istituisce, in atto [...] in quanto legge di se stesso», andando così a coinvolgere la responsabilità indiretta dei suoi Destinanti solo ad azione compiuta (Landowski 2005: 80). Allo stesso modo, è solo tramite l’ostensione dei suoi acquisti che RDS si autocostituisce, retroattivamente, come un tipo particolare di soggetto. O – meglio – ha avuto modo di autocostituirsi.
.
.
2. Il caso
Tre sono state le editions di RDS: alla galleria non profit Kunst Halle di San Gallo in Svizzera nella mostra “The Darknet – From Memes to Onionland. An Exploration” (14/10/2014-15/01/2015), alla Horatio Junior Gallery di Londra (11/12/2015-05/02/2016) e, infine, all’Aksioma Institute for Contemporary Art di Lubiana (24/02/2016-25/03/2016).
Ripercorrendo la prima edition attraverso l’ironico commento di Jon Lackman (2016), scopriamo che a san Gallo, «città svizzera dalle forti radici religiose» (ivi: 3), RDS si è collegato all’Agora shop, il più grande negozio illegale al mondo, dove ha acquistato ed esibito, nell’ordine: una chiave universale dei vigili del fuoco, 40$ di stecche di Chesterfield Blue provenienti dalla Romania, una borsa falsa di Louis Vuitton, la trilogia completa de Il Signore degli Anelli in ebook, altre 200 sigarette, una carta di credito VISA dorata, 120 mg di ecstasy in pillole dalla Germania prese a soli 48$, delle sneakers (false) della Nike firmate da Kanye West comprate a 75$ (le originali andavano sui 245$), un cappello da baseball con telecamera nascosta, una lettera di richiamo, un contenitore per farmaci a forma di lattina di Sprite, dei jeans, e infine la scannerizzazione di un passaporto.
La pietra dello scandalo è stata certo la partita di droga. I !Mediengruppe Bitnik constatano con sorpresa, sul loro sito, come «The parcel was sent from Germany and crossed the border and customs to Switzerland without any problems», problemi giunti solo il 12 gennaio 2015, a mostra appena conclusa, quando la polizia svizzera sequestra il bot e tutta la merce esposta.
Soltanto il 15 aprile, dopo aver testato che le pillole contengono MDMA (90 mg, non i 120 promessi), la polizia le distruggerà – così ha dichiarato –, restituendo invece tutto il resto. I !Mediengruppe Bitnik hanno così esultato sul loro sito:
At the same time we also received the order for withdrawal of prosecution. [In it] the public prosecutor states that the possession of Ecstasy was indeed a reasonable means for the purpose of sparking public debate about questions related to the exhibition. The public prosecution also asserts that the overweighing interest in the questions raised by the art work [RDS] justify the exhibition of the drugs as artefacts, even if the exhibition does hold a small risk of endangerment of third parties through the drugs exhibited. We as well as the [RDS] have been cleared of all charges. This is a great day for the bot, for us and for freedom of art!
Sebbene ci sia stato un acquisto di droga, questo non è stato voluto. Sebbene ci sia stata detenzione di droga, ciò è avvenuto a fini artistici: RDS ha creato dunque un vuoto giuridico dove, generando un illecito come evento, non è stato possibile attribuirgli un autore come responsabile. Solo la cornice artistica ha potuto rendere impunibile l’ostensione di questo gesto. In questa sede ci soffermeremo analiticamente solo sulla prima mostra. Della seconda, i curiosi sappiano che RDS, connesso questa volta ad Alpha Bay, ha acquistato: una t-shirt Lacoste falsa, due devices per l’estrazione di Bitcoin comprati con 25$, una copia elettronica di un libro di cucina francese in inglese del 1961, un cellulare con distorsore vocale, 1.825.380 indirizzi email a 100$, la scannerizzazione di una bolletta del gas inglese, concludendo con un PDF su come Hacking a Coca Cola machine.
.
.
3. La ricezione
La notizia è salita subito agli onori della cronaca, dove si è scherzato sul fatto che il computer abbia una personalità umana e sia soggetto giuridico di diritti e doveri. Su The Guardian Kasperkevic balbetta che la polizia svizzera abbia «arrested – er, confiscated» un computer (2015); Kharpal le fa eco su CBSN (2015). Per Grey del Daily Mail RDS è addirittura un «cyber criminal!» che è stato «ARRESTED» (2015), mentre Grant dell’Indipendent sente l’imbarazzo di dover spiegare come «the consumer behind these purchases is not actually a human, though – it is an internet “bot”» (2015). RDS sembra quindi essere un soggetto pieno. Come «example of a nearly autonomous thing that bought things», esso desidera, acquista e commette crimini come tutti noi: questa è la novità su cui apre in modo clamoroso (Noto La Diega & Walden 2016: 4 nota 15).
Tant’è che a RDS si attribuisce un nome proprio, se non addirittura un genere. Come ha infatti raccontato Smoljo degli stessi !Mediengruppe Bitnik, «People also call him Randy. Normally, we try to give it a female name but this is what came out in this case» (https://exposingtheinvisible.org). Lackman invece, cercando inutilmente di non risultare sessista, attribuisce al bot il genere maschile: «For me [RDS] is not an /it /but a /he/.//Why not a /she/? I'm not sure. Only a sexist would assume an obsessive shopper is a she, right? Plus: men quail in stores, they choose stuff at random just to be done» (2016: 3). Ciò che vorremmo in ogni caso evidenziare è come la questione del soggetto giuridico comporti quella del genere e il binarismo sottesi, altrimenti non pertinenti.
.
.
4. L’anomia
Galati ha commentato l’episodio delle pasticche evidenziando come, al di là «del risvolto potenzialmente ironico, [RDS] genera evidentemente delle domande che segnalano dei buchi giuridici sulla responsabilità degli algoritmi» (2018). La questione etico-morale è stata da subito sollevata, a partire da Power (2014), fonte di tutta la bibliografia successiva su questo «provocative example of such a shopping bot» (Gal & Elkin-Koren 2017: 315).
Una risposta viene tentata da Alves de Lima Salge e Berente (2017). Rifacendosi al kantismo di Rawls, per valutare il valore morale di un algoritmo come RDS, essi propongono un algoritmo di livello logico superiore, ovvero un meta-algoritmo. È già chiaro il pericolo della regressione all’infinito (critica avanzata da subito da Shaw 2018). Rischio, quello della regressio, contro il quale la giuscibernetica, fin dalle sue prime teorizzazioni, ha sempre invocato la necessità di un limite (Losano 1969: 169 ss).
Alves de Lima Salge e Berente, in ogni caso, si chiedono: sebbene sia stata violata una legge di Stato (il bot ha acquistato della droga vietata sul mercato regolare e un passaporto falso), si può ritenere il suo comportamento «unethical»? Per questo motivo, gli autori ritengono necessario un giudizio sulla sua attività. Il meta-algoritmo che propongono si articola di tre domande: (1) l’azione del social bot ha infranto la legge?, (2) la sua azione è ingiustificabile? (3) è coinvolto qualche inganno? Un bot, ma più in generale qualsiasi soggetto morale, non si comporta eticamente se la sua azione risponde affermativamente in progressione alle tre domande. La conclusione e il fine cui vogliono tendere gli autori – vero e proprio imperativo categorico – è che i «Social bots should always act truthfully» (ivi: 30).
Poiché il fine era artistico e l’ecstasy «in this presentation was safe», come indicato dalla polizia, gli autori dell’articolo possono ritenere il comportamento del bot «not unethical» poiché giustificabile con la moralità diffusa della comunità. Qui, però, l’impasse: per i due studiosi, che si rifanno all’Etica Nicomachea (III, 1111a), un soggetto-bot etico emerge come tale se e solo se la sua azione è allo stesso tempo saputa e voluta. Come già evidenziato, RDS si comporta come l’alea, alla quale è assolutamente finzionale attribuire una qualunque consapevolezza della propria volontà. Il bot sembra quindi muoversi a latere del meta-algoritmo, nello spazio di un vuoto giuridico.
Sorge inoltre un ennesimo problema, sollevato da Turner, per il quale RDS sarebbe un “Case Study” sulla domanda: «Could a Robot Commit a Crime?» (2019: §4.5). Per il principio del habeas corpus, anche se si individuasse la volontà del bot, questa resterebbe un carattere di una mera ψυχή (RDS è un software), cui non sarebbe relato alcun corpo punibile di reato. È il motivo di clamore del Washington Times (2015) per il quale è sorprendente che sia stato arrestato un «moving conglomeration of bits and bolts, conceived and fashioned by flesh and blood men».
Non resta dunque che dare la colpa agli sviluppatori: «Therefore, culpability rests on the knowledge of the developers» (ivi: 31), ovvero i Destinanti. Ma, anche in questo caso, si tratta di una soluzione particolare, che solo a volte può essere attuata. Si attribuisce la sostanza di soggetto al firmatario, in quanto primo riferimento fisso della catena di enunciazioni che si è venuta a creare. Ma in questo caso non si tratta di una colpa, al massimo un dolo. Si mostra così un conflitto tra due regimi discorsivi, quello del Diritto che cerca un elemento primo cui ricondurre la catena di enunciazioni (Latour 1998: 92 ss), come ad esempio un firmatario che emerge retroattivamente dalla sua firma (Derrida 1997: 393-424), e il regime discorsivo della tecnica che si articola in débrayages attanziali dove ogni attore così proiettato vive di una sua autonomia (Latour 1998: 82). Allo stesso tempo, però sono proprio i diritti d’autore, correlati della responsabilità autoriale (Franceschelli 2019), a permettere al duo svizzero di rivendicare per sé la genesi dell’opera. In breve, la funzione-autore è un «oggetto di appropriazione» la cui forma è storicamente seconda, in rapporto a ciò che di potrebbe chiamare l’appropriazione penale. I testi , i libri, i discorsi hanno cominciato ad avere realmente degli autori […] nella misura in cui l'autore poteva essere punito, vale a dire nella misura in cui i discorsi potevano essere trasgressivi. Il discorso, nella nostra cultura (e in altre probabilmente) non era, all’origine, un prodotto, una cosa, un bene; era essenzialmente un atto – un atto posto nel campo bipolare del sacro e del profano, del lecito e dell’illecito, del religioso e del blasfemo (Foucault 1971: 9).
Abbandonando così l’ipotesi d’“accusare delle cose di un crimine”, la colpa è dei programmatori, in quanto si prendono la responsabilità delle azioni del loro bot che hanno previsto. Si darebbe colpa a un bot se e solo se si potesse dimostrare che questo abbia deviato volutamente dal proprio programma, ovvero dal volere dei propri destinanti: «In such absence of deviation, it is easier to prove human involvement in the AIS’ illegal conduct. In other words, the programmer of [RDS] may also be held liable because it creates an AI to shop in the illegal market» (Andrini 2018: 79). Per lo stesso motivo, «si tratta di un reato punibile a titolo di dolo» poiché il «bot non è stato progettato o impiegato con l’intenzione di commettere il reato, ma il programmatore e/o l’utente hanno irragionevolmente accettato una serie di rischi che hanno portato al verificarsi della condotta criminosa», motivo per il quale «l’utilizzatore e/o il programmatore saranno ritenuti penalmente responsabili per il reato commesso dal bot» (Lagioia 2016: 126 e 129).
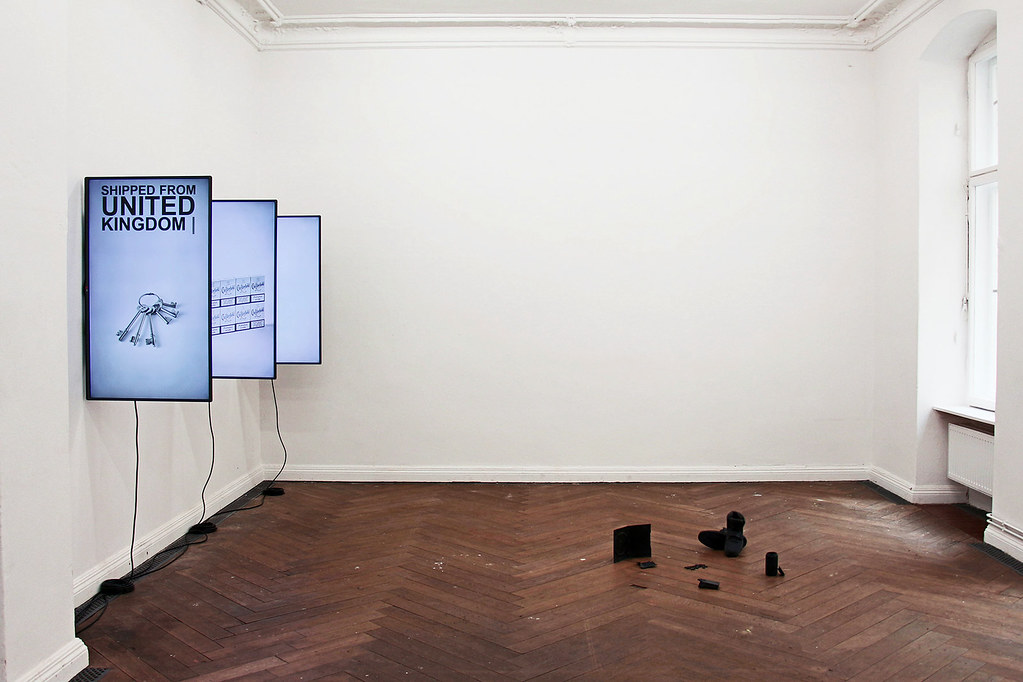
Ribadiamo: che siano colpevoli, gli artisti ne sono ben consci: «We are the legal owner of the drugs – we are responsible for everything the bot does, as we executed the code», ammette Smoljo. «But our lawyer and the Swiss constitution – continua – says art in the public interest is allowed to be free» (Power 2014).
È proprio il mondo dell’arte (Danto 1964) che infine si instaura come terzo discorso che permette di neutralizzare qualsiasi tipo di colpa da parte di RDS o dei suoi autori. I !Mediengruppe Bitnik infatti rivendicano di appartenervi.
.
.
Conclusione
Perniola (2015) aveva individuato nell’arte più recente una certa svolta fringe, secondo la quale «Nulla è di per se stesso arte» ma «lo diventa attraverso molti fattori» in un processo detto di «artistizzazione». Evidenziamo come RDS si muova nella direzione opposta, poiché esso è da sempre costituito come opera d’arte. È il vuoto giuridico che crea a far scoppiare un conflitto discorsivo tra il mondo dell’arte e quello legale. RDS non è un’opera fringe verso altri domini: sono gli altri domini ad implodere su di esso.
Coglie bene l’essenza di RDS Volkart Schmidt nell’inserire il progetto nella cosiddetta Ästhetik der Störung, «disturbo» dato nello specifico dalla «Kollision der Systeme». Abbiamo visto come questo progetto artistico utilizzi il proprio dominio per generare cortocircuiti in quelli altrui, innanzitutto giuridico e, conseguentemente, sociale. Ciò è stato possibile grazie alle possibilità offerte dalla rete, non intesa qui ingenuamente solo come «spazio libero dal diritto», a richiamare «vagamente le origini euforiche di Internet» (2015: 4). Come spiega Boris, «Aquella emancipación del ciberespacio [...] nos parece hoy un poco ridícula». La rete non è più – o, meglio, non è mai stata – quel grande spazio orizzontale di chissà quale regno dei cieli sulla terra. Si necessita dunque di «entender el horizonte digital como un campo fundamental de esta hipergeografía que estamos habitando», per stabilire così «Términos y Condiciones de una ontología digital libertaria» (2017).
In conclusione RDS si presenta come emblematico «example of hacktivist guerrilla communication» (Delmas 2018: 75), la cui sola ragione d’esistenza, «l'esecuzione dell’atto di semplice consumo» (Volkart Schmidt 2015: 4), è una «reflection on the shadowy parts of the Internet without calling for any specific legal change, or articulating any specific political claim» (Delmas 2018: 75). RDS non vuole portare al cambiamento in nessuna legge corrente, ma sollevare una riflessione sui limiti delle legislatura stessa. Considerando che «c’è arte solo se e quando (resiste)» (Carmagnola 2019: 156), RDS è arte proprio nella sua rivendicazione.
Derrida (1996: 14 nota 1) era convinto che «la democratizzazione effettiva si misura sempre con questo criterio essenziale: la partecipazione e l’accesso all’archivio, alla sua costituzione e alla interpretazione». Se ormai la rete è la sostanza esterna del nostro inconscio tecnologico, grande produzione archiviale costantemente riattualizzata (Galati 2017: §3), RDS ne è macchina da guerrilla semiotica (Eco 1967) che, a partire dal territorio specifico dell’arte, può portare a rimetterne in discussione confini e geografia.
di Francesco Di Maio
.
.
Bibliografia
!Mediengruppe Bitnik (2015). The Random Darknet Shopper wasting time on the darknet. In L. Catania et al. (a cura di). WTi2.0: Wasting Time on the Internet 2.0 (41). Düsseldorf: TFGC.
Agamben, G. (2005). Profanazioni. Roma: nottetempo.
Agamben, G. (2006). Che cos’è un dispositivo. Roma: nottetempo.
Agamben, G. (2011). Altissima povertà. Regole monastiche e forma di vita. Homo sacer, IV, I, Vicenza: Neri Pozza.
Agamben, G. (2017). Creazione e anarchia: L’opera d’arte nell’epoca della religione capitalistica. Vicenza: Neri Pozza.
Alves de Lima Salge, C. & Berente, N. (2017). Is That Social Bot Behaving Unethically?. Communications of the ACM, 60 (9), 29-31.
Andrini, L. (2018). Redesigning Indonesia Copyright Act to Accommodate Autonomous Intelligent System: Status Quo and Room for Improvement. Asian Journal of Law and Economics, 9 (3).
Boris (Mariano López Hermida) (2017). H.H.H: Una introducción a la hipergeografía y la dimensión política del horizonte digital. Estudios Curatoriales, 6 (4).
Carmagnola, F. (2019). Essere e gadget. La macchina del sentire. Milano: Meltemi.
Danto, A. (1964). The Artworld. Journal of Philosophy, 61 (19), 571-84.
Delmas, C. (2018). Is Hacktivism the New Civil Disobedience?. Raisons politiques, 69 (1), 63-81.
Derrida, J. (1994). Spettri di Marx: Stato del debito, lavoro del lutto e nuova Internazionale. Tr. It. di G. Chiurazzi. Milano: Raffaello Cortina.
Derrida, J. (1996). Mal d'archivio: Un’impressione freudiana. Tr. It. di G. Scibilia. Napoli: Filema.
Derrida, J. (1997). Margini – della filosofia. Tr. It. di M. Iofrida. Torino: Einaudi.
Donatiello, P. (2016). L’osservazione da un punto di vista etnosemiotico: Alcune osservazioni. INTRECCI d’arte, 5, 61-85.
Eco, U. (1973). Il costume di casa: Evidenze e misteri dell’ideologia italiana. Milano: Bompiani.
Eco, U. (1980). Opera aperta: Forma e indeterminazione nelle poetiche contemporanea. Milano: Bompiani.
Eugeni, R. (2010). Semiotica dei media: Le forme dell’esperienza. Roma: Carocci.
Eveleth, R. (2015). My Robot Bought Illegal Drugs. BBC, http://www.bbc.com/future/story/20150721-my-robot-bought-illegal-drugs.
Foucault, M. (1971). Scritti letterari, A cura di C. Milanese. Milano: Feltrinelli.
Franceschelli, G. (2019). I, Artist: Opere d’arte e intelligenza artificiale: il curioso caso del diritto d’autore, Senigallia: ventura.
Freud, S. (1919). Das Unheimliche. Imago. 5 (5-6), 297-324.
Gal, M.S. & Elkin-Koren, N. (2017). Algorithmic Consumers. Harvard Journal of Law & Technology, 30 (2), 309-53.
Galati, G. (2017). Duchamp Meets Turing: Arte, modernismo, postumano. Milano: postmedia•books.
Galati, G. (2018). Arte, modernismo e postumano. Cronache letterarie, http://cronacheletterarie.com/2018/04/07/arte-modernismo-e-postumano-intervista-a-gabriela-galati/
Grant, K. (2014). Random Darknet Shopper: Exhibition featuring automated dark web purchases opens in London. Indipendent, https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/random-darknet-shopper-exhibition-featuring-automated-dark-web-purchases-opens-in-london-a6770316.html
Greimas, A.J. (2004). Dell’imperfezione. Tr. It. di G. Marrone. Palermo: Sellerio.
Grey, R. (2015). Now that's a cyber criminal! Robot is ARRESTED by police for buying ecstasy on the dark net. Daily Mail, https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3047317/Now-s-cyber-criminal-Robot-ARRESTED-police-buying-ecstasy-dark-net.html
Kasperkevic, J. (2015). Swiss police release robot that bought ecstasy online. The Guardian, https://www.theguardian.com/world/2015/apr/22/swiss-police-release-robot-random-darknet-shopper-ecstasy-deep-web
Kharpal, A. (2015). Robot with $100 bitcoin buys drugs, gets arrested. CBSN, https://www.cnbc.com/2015/04/21/robot-with-100-bitcoin-buys-drugs-gets-arrested.html
Lackman, J. (2016). RANDOM DARKNET SHOPPER. Ljubljana: Aksioma – Institute for Contemporary Art.
Lagioia, F. (2016). Responsabilita Penale e Automazione nell’E-Health. Tesi di dottorato, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Bologna, Italia.
Landowski, E. (2010). Rischiare nelle interazioni. Tr. It. di M.C. Addis. Milano: FrancoAngeli.
Latour, B. (1998). Piccola filosofia dell’enunciazone. In Basso, P.L. & Corrain, L. (a cura di). Eloquio del senso: Dialoghi semiotici per Paolo Fabbri (71-94). Genova: Costa&Nolan.
Losano, M.G. (1969). Giuscibernetica. Macchine e modelli cibernetici nel diritto. Torino: Einaudi.
Noto La Diega, G. & Walden, I. (2016). Contracting for the “Internet of Things”: Looking into the Nest. Queen Mary School of Law Legal Studies Research Paper, 219.
Power, M. (2014). What happens when a software bot goes on a darknet shopping spree?. The Guardian, https://www.theguardian.com/technology/2014/dec/05/software-bot-darknet-shopping-spree-random-shopper
Perniola, M. (2015). L’arte espansa. Torino: Einaudi.
Shaw, J. (2018). Evil: The Science Behind Humanity's Dark Side. NY: Abrams.
Turner, J. (2019). Robot Rules: Regulating Artificial Intelligence. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Volkart Schmidt, Y. (2015). Sichtbarmachen, Verdunkeln, Materialisieren: Für eine Ästhetik der Störung. Springerin, 2, 4-5.
Washington Times, A ’bot with a rap sheet: Even if you're made of bits and bolts, selling drugs is not a good idea, https://www.washingtontimes.com/news/2015/apr/26/editorial-internet-robot-random-darknet-shopper-ar/
-
Con Lacan, ancora
Recensioni / Marzo 2021Nel settembre del 2020 si chiude il terzo tempo dell’incontro di aut aut con Lacan: si tratta in realtà di una chiusura-apertura, potremmo dire una chiusura-cerniera, il cui effetto è di lasciare il “problema Lacan” aperto. La prima tappa di questa riflessione – affidata al volume A partire da Lacan, numero 177-178 del 1980 – accoglieva il gesto di “dissoluzione” inferto alla psicoanalisi e alla filosofia dall’ultimo seminario lacaniano inedito (Dissolution). Il primo fascicolo pare aver agito après coup: dissolvendo, Lacan mostra di aver fondato la possibilità di una nuova attualità, di un pensiero che continua a scriversi – temi a cui è dedicato Leggere Lacan oggi, numero 343 del 2009. Ma vale la pena chiedersi quale sia l’urgenza di Ripartire con Lacan, che muove il terzo numero. Non esageriamo col dire che la filosofia contemporanea ne farebbe volentieri a meno, in quanto la pratica psicoanalitica è una “scienza senza sapere”, un pensiero senza Weltanschauung, un’immistione spuria e ibrida nel rigore argomentativo del discorso. Il numero 387 di aut aut “stressa” la tendenza onnicomprensiva a cui certa filosofia ambisce, che in termini lacaniani definiremmo un tutto-sapere immaginario. E lo fa interponendosi a una logica forte, ossia barrandola. I diciassette interventi del volume si misurano infatti con il buco della comprensione di un pensiero: non lo suturano, con nuove interpretazioni o “scritture”, ma consegnano, con esso, dei percorsi concentrici di approssimazione, secondo il movimento del desiderio.
Non Un Lacan – declinato secondo le rigidità del lacanismo – né il Lacan dell’Uno, ma i molti Lacan che proliferano, articolati soggettivamente dai margini del discorso. Condizioni liminali in cui le paranoie (sforzi di fare Uno) delle varie Scuole lacaniane e dell’Università si indeboliscono. Da qui, la scelta di parlare ancora, e con più vigore di quarant’anni fa (1983), di pensiero debole, con effetti di spazi di gioco imprevisti: la cifra del contributo di Pier Aldo Rovatti in questo volume (pp. 44-56) sta nell’aprire una «reciprocità di sguardi» tra lacanismo e pensiero debole per abbassare ironicamente tonalità “alte”, smascherando la complicità di queste col discorso del padrone (cfr. p. 49). L’ironia stempera anche il tragico di quel manque-à-être che sostiene le nostre esistenze: sfuggire, abbassare, oscillare sono i significanti di un re-tour a Lacan che ha tanto di un ritorno quanto di un giro attorno, con l’eventualità che possa trattarsi di un giro a vuoto, come spesso ci accade in analisi. Ma attorno al vuoto del re-tour si crea la condizione di possibilità di un ri-pensamento dell’impensato. Che fare? Tagliare la corda. Interrompere la sequenza. Lasciare uno spazio bianco, per non turare buchi costitutivamente non suturabili. “Saperci fare con” ciò che non si riempie sarà un “saperci fare con” la soggettività (p. 53).
Rilanciare la soggettività non è una sfida scontata, oggi, in filosofia. Rispetto allo spopolare di ontologie nude e pure nel dibattito contemporaneo, il contributo di Massimo Recalcati ha il merito di ri-centrare i processi di soggettivazione sul soggetto, che non è mai un oggetto tra gli oggetti. Come «fare a meno del soggetto» se «è l’esistenza del soggetto a innescare il processo di soggettivazione» (p. 59)? Il sospetto è che se si avanza verso i «territori impersonali di un godimento Uno» si facciano dei tagli, che colpiscono direttamente l’etica della psicoanalisi, che è un’etica del desiderio. Il sospetto, ancora, è che non solo si faccia a meno «della mancanza a essere, del desiderio e dell’Altro» ma, più radicalmente, dell’intero «riferimento alla categoria di soggetto» (p. 57). Basta aprire gli occhi sullo stato dell’arte per constatare come l’henologia (pensiamo all’Uno-tutto-solo di Jacques-Alain Miller e Antonio Di Ciaccia) e le ontologie del processo (senza soggetto) siano precipitate anche nell’analisi. Recalcati, ricordando che l’analisi non è impersonale, produce nella scrittura un «annodamento topologico del soggetto all’Altro […] che diviene essenziale per pensare il problema della soggettivazione» (p. 59). A ogni Uno va ricordato che l’Altro è condizione del suo vedersi. Qual è la dinamica che li annoda? L’identificazione, con la sua portata «non solo clinica, ma anche politica», spesso tenuta fuori dai dibattiti teorici e qui riportata al centro da Ilaria Papandrea (pp. 22-28) come operazione fondamentale del fare legame. L’analisi è un buon modo per guardarsi dal «potere narcotizzante delle identificazioni» (p. 26), dalle «passioni identitarie e dalla furia razzista che scatenano» (ibidem). Lo scandalo e la scommessa dell’analisi è, infatti, il poter far esperienza di se stessi come soggetti non identificati per vie immaginarie o insegne simboliche. La ricaduta, immediatamente politica, è di indebolire la consistenza del grande Altro: a partire dall’analista “modello” fino al grande Altro che vorremmo assumesse una posizione di comando per indirizzare le nostre vite, incarnando il verbo dell’universale. Nessuna identificazione può invece afferrare «il resto opaco di un godimento» (p. 25) che è inconscio. Da qui la portata della rivoluzione psicoanalitica, soprattutto quella lacaniana, che permette di bucare le logiche identitarie e identificatorie, i dispositivi di legame, le organizzazioni del collettivo. Ripartire con Lacan – annodando, al collettivo, il singolare – significa «fare un passo e un altro ancora, un numero incalcolabile di volte, per scavare un incavo nelle verità pretese» (p. 23), ovvero in impianti che si (sup)pongono totali.
Eppure permangono resistenze nell’accettare il ruolo politico della psicoanalisi, che è al centro dei contributi di Muni (Foucault e Lacan. L’amicizia, il discorso, il soggetto etico), Greblo (Lacan con Laclau) e Colucci (Quel muro tra Lacan e Basaglia). Andrea Muni ritesse bio-bibliograficamente le ragioni delle difficoltà di applicazione della psicoanalisi alle biopolitiche, a partire dal disamore tra lacaniani e foucaultiani, in cui ha un certo ruolo la coppia Deleuze-Guattari e il conservatorismo attribuito a Lacan per la sua militanza mancata. La militanza di Lacan si sarebbe invece giocata sul piano squisitamente foucaultiano di una materialità dell’immateriale. I significanti material-pulsionali coincidono infatti coi soggetti governati e (auto)sorvegliati: il soggetto politico lacaniano-foucaultiano è un effetto di discorso; si trova “doppiato” dal discorso come sua causa, in un’attivo-passività che è la stessa del corpo pulsionale della psicoanalisi (si veda il contributo di Andrea Muni, p. 82). Date queste premesse, soggetto (politico) e significante hanno la stessa struttura: da qui Edoardo Greblo via Laclau, e Laclau via Lacan, applicano la logica dell’inconscio strutturato come linguaggio alla soggettività politica, verificandola nella sua «discontinuità aperta» rispetto alla realtà (cfr. p. 197). Come il soggetto del significante, il soggetto politico risulta scisso, separtito, perché l’universale della società (immaginaria) in cui si dà è barrato. Non esiste, cioè, la società, se non come cornice simbolica. Ma cos’è il simbolico senza il reale? Totalità vuota. Serve un «nocciolo che resista alla simbolizzazione» (p. 200), qualcosa che impedisca la chiusura del circolo, che è condanna del definitivo e dello stesso. Ciò che resiste, che non funziona, che non chiude, è il reale, qui declinato politicamente come il negativo dell’antagonismo e del conflitto. Per una politica che rifletta il rimando (negativo)-differenziale tra soggetti-significanti, la proposta di Greblo – in linea con la sinistra lacaniana di Laclau, Mouffe, Butler, Žižek – è di una politica «non-tutta, incompleta, aperta, politicamente negoziabile» (p. 206), scommessa del negativo e delle contingenze singolari che intaccano l’universalità solo presunta della “società”.
Altro snodo del volume è il modo in cui la politicità del significante si riverbera nell’istituzione (discorsiva) di spazi di segregazione: per Lacan i muri dell’istituzione psichiatrica. Ma non solo per lui. Anche Franco Basaglia si colloca nel solco di quella corrente etico-politica ed epistemologica affine all’operazione lacaniana. Entrambi nascono come fenomenologi e arrestano, ricorrendo all’epoché, una deriva impietosa della psichiatria che andava verso la psichiatria d’organo, ottusamente (solo) biologica e iper-medicalizzante. Mario Colucci, psichiatra lacaniano, fa dunque cadere «quel muro tra Lacan e Basaglia» (p. 28), attribuendone l’esistenza alla differenza di identità culturali, laddove in Italia predominava una vocazione politica, atta a sfondare il muro dell’istituzione, e in Francia una vocazione terapeutica, estremamente ricca sul piano teorico ma incapace di mettere in crisi l’istituzione stessa. Tuttavia la vocazione politica italiana si lega a un’estrema laicità che non esclude da sé un certo scientismo: da qui la psicoanalisi lacaniana come semi-sconosciuta o preziosa rarità nei servizi di salute mentale in Italia, e l’urgenza di ripartire, non solo da Lacan, ma da Lacan con Basaglia. Oggi la presenza di Lacan nella psichiatria italiana rappresenta la possibilità di forare il recinto simbolico delle segregazioni con il reale della parola gettata – angosciosamente – al silenzio dei muri. Annodare Lacan e Basaglia significa porsi all’incrocio fra due angosce: «il comune affetto d’angoscia che li lega è la sola garanzia che non ci ingannano» (p. 43). Contro la deriva segregazionista della psichiatria dei muri, Colucci traccia un solco dove «due saperi incompleti si toccano sul punto della loro mancanza e si scoprono vulnerabili» (ibidem).
Un affondo clinico decisivo nel volume sta nella proposta della filosofa e psicoanalista Silvia Lippi di «psicotizzare la psicoanalisi» (p. 128). In linea col tardo Lacan di Le Sinthome, L’Étourdit e le conferenze del ’70, l’interesse di Lippi non è rivolto a una migliore clinica della psicosi, ma a un ripensamento radicale dell’intera pratica analitica a partire dalla psicosi, per pensare la direzione della cura tout-court, per dischiudere un linguaggio non polarizzato dal senso, dove il significante sia «vettore di godimento» (p. 134). La psicosi diventa così il luogo di lalingua, invenzione singolare, particolare a chac’Un. È infatti dal «linguaggio de-strutturato dello psicotico» (ibidem) – in termini deleuziani linguaggio senza articolazione – che si trae qualcosa di paradigmatico dell’inconscio, sottraendolo ai residui di un’ermeneutica infinita e alle maglie dell’esegesi del senso. Quale lalingua, nella psicosi? Non il linguaggio della comunicazione o della trasmissione, bensì il «linguaggio crudo del corpo […] desiderante e, certamente, godente» (p. 134). È qualcosa che non può prodursi se non in un’analisi, e mai senza corpo. Legittimo chiedersi, a questo punto, cosa abbia provocato, nella ricezione psicoanalitica, la de-corporeizzazione, la corporeità in perdita, inflitta dal cogito. Sebbene Lacan abbia dovuto smembrare il cogito in “penso dove non sono, sono dove non penso” – anzi proprio per questo – Cartesio resta tra i suoi interlocutori privilegiati. Le scienze cartesiane, vagliate nell’intervento di Antonello Sciacchitano, sono tutte quelle scienze «del dubbio e dell’incertezza», altrimenti definibili come congetturali o umane. Si tratta cioè di quelle scienze «diversamente scientifiche» (p. 161), che tendono a una certezza non dell’ordine dell’universale o dell’oggettivo, ma del soggettivo. In esse, il cogito si configura come «ipotesi di lavoro», che sostiene una logica della congettura. Ma, al di là, della congettura, c’è del sapere. Un sapere che è nel reale, è nell’inconscio. Come «l’inconscio è un sapere che non si sa di sapere», così il desiderio inconscio è un «desiderio che non si sa di desiderare» (p. 166): da qui una scienza che fa congetture su un sapere che non sa se stesso. Lacan ha così «dissotterrato dal reale – che non cessa di non scriversi – un sapere che a volte – non sempre – riesce a scriversi» (p. 168). E soprattutto, che si scriva non è garanzia del fatto che riesca a leggersi. Qui subentra l’impasse dell’ovvietà delle nostre letture e il bisogno di un gesto ulteriore.
Non potendo render conto della specificità di ogni contributo, per cui si rimanda alla lettura integrale del volume, sceglieremo di percorrere infine un crinale teoreticamente denso, che vede Lacan, Deleuze e Derrida intrecciati nel problema della rappresentazione, attraverso le letture di Raoul Kirchmayr, Sergio Benvenuto e Federico Leoni. Che cosa si rappresenta? Quello che non c’è. È propriamente quel che fa il fantasma, indice di non-rapporto, ossia del rapporto sessuale che non c’è. Non si tratta qui di un vezzo, di voler recuperare un apoftegma, un abusato motivetto tra lacaniani (“non c’è rapporto sessuale”), bensì di voler sfidare ancora la nozione di soggettività con una formazione dell’inconscio, una micro-struttura narrativa – il fantasma – che mette in crisi un certo rapporto diadico, lineare e ingenuo tra soggetto e oggetto.
Nella lettura di Leoni, prevale un’idea di fantasma come di impersonale singolare, sulla scia di una lacaniana Logica del fantasma che si incrocia con la deleuziana Logica del senso, per cui il «fantasma-bolla è una monade-simulacro» (p. 124). Il simulacro non è di qualcuno, ha una «sovrana autonomia» (p. 120) rispetto a ciò di cui dovrebbe essere rappresentazione, né si dà propriamente qualcuno che lo rappresenti. I simulacri (fantasmi in Lacan) «giocano con l’oggetto» che dovrebbero rappresentare, ma giocano anche col soggetto (cfr. ibidem). Procedendo su questa linea, perveniamo a un assunto impegnativo per lo stato dei processi di soggettivazione. Il soggetto e l’oggetto sarebbero «dispiegamento interminabile […] di una sostanza comune» (p. 125). Quanto al fantasma, «non è mai altro che la linea sempre in cammino e sempre incompiuta del suo soggettivarsi e oggettivarsi» (ibidem). Ma quanto la lettura secondo cui «soggetto e oggetto sono loro stessi le divisioni dell’impersonale» regge, se applicata alla pratica analitica?
Sergio Benvenuto rimarca come ci troviamo davanti a interi archivi di fantasmi, non solo sui lettini di analisi ma anche nei siti porno o, meglio, in quei film pseudo-pornografici (come La vie d’Adèle di Kechiche) in cui il rapporto è supposto: non si vedono penetrazioni, scambi di liquidi, organi turgidi ed eccitati, per cui ci si chiede se il rapporto, di fatto, ci sia. Cosa significa quindi supporre un rapporto? Rappresentare soggettivamente il reale – incredibile, impossibile – di ciò che è inconsciamente irrappresentabile, e fare di tale trauma – come il coito – qualcosa che sia foriero di godimento (cfr. p. 115).
La costruzione fantasmatica ha direttamente a che fare con ciò che non si può rappresentare, e che per questo si rappresenta. Differentemente da certi modi di fare ontologia forcludendo il soggetto, le hantologie (teorie generali della spettralità) tallonano il luogo del margine in cui il soggetto sembra non essere oggetto e viceversa, mostrandone lo statuto labile, poroso. Il fantasma è sì «un primo schema topologico su cui fondare una teoria della singolarità del soggetto» (pp. 94-95), ma anche una sfida a ogni idea precostituita di soggettività: fa posto a due elementi assolutamente eterogenei, legandoli attraverso il simbolo della losanga, che nella matematizzazione lacaniana delinea un buco, indice di non-rapporto ($◊a). Ripartire dal non-rapporto significa rilanciare la soggettività dal reale, «l’assente di ogni struttura psichica» (p. 93).
La portata di questo volume consiste nel fatto che esso si costruisca attorno a un centro assente e che smobiliti, attraverso la proliferazione di voci che rifuggono un neolacanismo dogmatico, la statica di qualsivoglia discorso identitario. Leggendolo, si stacca pezzo per pezzo l’identità del “lacaniano”, assieme a una forma di “dover essere” lacaniani: quel che resta è un punto reale in cui filosofia e psicoanalisi si specchiano in modo complementare e si mancano, lasciando a ogni lettore la possibilità di abitare quel buco tra due saperi con la propria invenzione teorica.
Sara Fontanelli
-
Il contrario della solitudine. Un femminismo in comune
Recensioni / Febbraio 2021Originariamente pubblicato con il titolo Feminismo em comun. Para todas, todes e todos (2018), Il contrario della solitudine. Manifesto per un femminismo in comune (2020) scritto da Marcia Tiburi è ospitato da effequ nella collana Saggi Pop. La casa editrice ha il merito di introdurre Marcia Tiburi, filosofa e femminista brasiliana altrimenti inedita al panorama italiano, selezionando all’interno della sua vasta produzione (filosofica, letteraria, artistica) un testo esplicitamente posizionato nella lotta femminista. Nella traduzione italiana, a cura di Eloisa Del Giudice, la scelta del titolo abdica a un calco letterale dell’originale portoghese, tuttavia senza alterare la proposta di un femminismo radicalmente democratico, costruito attraverso la messa in comune del dissenso di tutte, tuttə e tutti (todas, todes e todos) all’indirizzo del dispositivo patriarcale.
Ispirandosi a Foucault, Tiburi definisce il patriarcato come una forma di potere e sapere che ordina i discorsi sul criterio predicativo della verità. In altre parole, le istituzioni patriarcali autorizzano come veri i discorsi dell’ʻuomo biancoʼ (p. 52, 92), mentre dispongono su una scala di gradi gerarchici discorsi altri, a ciascuno dei quali viene negato un contenuto veritativo e di conseguenza un’autonomia politica. In ultima istanza, l’ordine veritativo della politica e l’ordine politico della verità sono una e una medesima cosa nel regime di pensiero autoritario. A ben vedere, il tema dell’autoritarismo è il denominatore comune delle più recenti pubblicazioni di Tiburi: a partire da Como conversar com um fascista: reflexões sobre o cotidiano autoritário brasileiro (2015), dove l’autrice intraprende una decostruzione dei microfascismi quotidiani; venendo all’analisi portata avanti sul piano estetico in Ridículo político: uma investigação sobre o risível, a manipulação da imagem e o esteticamente correto (2017), testo nel quale il terrorismo istituzionale è osservato nel suo carattere farsesco entro la cornice storica del golpe di Michel Temer a seguito dell’impeachment ai danni di Dilma Rousseff; approdando infine a Il contrario della solitudine (2020), diciassette brevi capitoli in cui la lotta comune per una democrazia radicalmente femminista consiste nella critica dell’autoritarismo quale si declina nella struttura patriarcale e nella sua verità grottesca (talmente terrificante da risultare ridicola, talmente ridicola da suscitare terrore): l'ideologia di genere (p. 60). Quest’ultima viene criticamente discussa nel settimo e nel decimo capitolo dopo essere stata inquadrata nel quarto capitolo fra le verità assolute del patriarcato, così riassumibili: l’identità è naturale; la sessualità è binaria; la differenza di genere stabilisce i ruoli sociali; il polo maschile gode di superiorità; il polo femminile soffre di inferiorità (p. 38).

Finché l’ideologia patriarcale pretenderà di far corrispondere i ruoli sociali a una presupposta naturalità dei sessi, a loro volta bipartiti per via assiologica, il lavoro non smetterà di essere «un vero problema di genere» (p. 27). Se il sesso è alla base della divisione del lavoro, allora il genere è la versione compiutamente socializzata del lavoro sessuale e sessualizzato. Per tale ragione, sostiene Tiburi, «non possiamo pensare al femminismo senza pensare al lavoro» (ibidem). Il binomio donna e lavoro pone la riflessione non solo sul versante politico, ma anche su quello economico. Tuttavia, Tiburi prescinde da una contestualizzazione storica e da una ricostruzione genealogica di alcuni concetti chiave a partire dai quali svolge l'argomentazione. Concetti come ʻpatriarcatoʼ e ʻcapitalismoʼ, per esempio, rischiano di risultare frettolosamente sorvolati, impedendo una più profonda comprensione del posizionamento teorico dell’autrice. Il ritmo sincopato tipico del pamphlet certamente imprime al manifesto la forza dialettica del pensiero critico, giocando però a detrimento di una riflessione sulle condizioni di possibilità della presa di parola da parte di Tiburi. Solo raccogliendo le tracce disseminate nel testo possiamo tentare di risalire alle premesse storiche e filosofiche di ʻpatriarcatoʼ e ʻcapitalismoʼ dalle quali Tiburi muove. Vale la pena riportare estesamente un passaggio:
Se pensiamo in termini di segni usati per identificare i corpi, diremo che la donna è l’essere identificato per servire al mondo del privilegio patriarcale. Sotto il segno del capitalismo, il mondo è entrato in un divenire donna così com’è entrato in un divenire nero nel senso di identificazione con lo scopo dell’asservimento generale di tutti. Alcuni femminismi sono riusciti a trasformare il segno donna in qualcosa di positivo, ma sta di fatto che, nel patriarcato – che equivale al capitalismo –, le donne sono sempre state figure negative, un ʻaltroʼ creato per l'asservimento (pp. 77-78).
Da un punto di vista storico, l’equivalenza di patriarcato e capitalismo circoscrive il focus sul patriarcato in epoca moderna, sebbene la storia del patriarcato sia notoriamente più longeva. Da un punto di vista filosofico, notiamo come Tiburi ponga l’accento sulla trasformazione impressa nel patriarcato dall’emergere del capitalismo. Tiburi non sembra chiedersi, piuttosto, come il patriarcato si trasformi a partire da se stesso: né in senso diacronico rispetto a sistemi patriarcali che precedono la modernità né in senso sincronico rispetto a sistemi altri dal patriarcato. Il sistema capitalista è indubbiamente uno di quei sistemi altri che in epoca moderna entra in accoppiamento strutturale con il sistema patriarcale. Nonostante s’intersechino, i due sistemi sono comunque operativamente autonomi.
Non converrebbe risalire a quel contratto sociale grazie al quale gli uomini si sono associati, eguali detentori di diritti civili e politici? Seguendo la pista genealogica tracciata da Carole Pateman (2015; ed. or. 1998), filosofa e femminista critica nei confronti di una certa tradizione del pensiero liberale moderno, la negatività attribuita alle donne cui si riferisce Tiburi potrebbe riconfigurarsi come diritto originario degli uomini di negare la politicità degli spazi femminili – siano essi i corpi stessi delle donne o i territori assegnati alle loro cure. Il contratto lavorativo è solo un volto del contratto sociale, quel volto che è stato negato con maggiori difficoltà dal momento che ha chiamato in causa fin da subito una classe di uomini a servizio di un’altra classe di uomini. L’altro volto del contratto sociale è il contratto sessuale, il quale ha sancito l’eguaglianza degli uomini – ognuno essendo proprietario di se stesso – al costo dell’asservimento delle donne. Dunque, potrebbe essere ricondotta alle premesse storiche e filosofiche di cui sopra la dialettica serva-signore che Tiburi ravvisa nella condizione orizzontale occupata positivamente dagli uomini in relazione alla condizione verticale che vede le donne occupare il polo negativo (Tiburi 2020, p. 45). A questo proposito, Tiburi afferma:
Il patriarcato si costituisce attraverso un’equazione: da un lato stanno gli uomini e il potere, dall’altro le donne e la violenza. Il potere che ratifica la violenza contro l’altro sta al sadismo come la sottomissione sta al masochismo. Le donne non possono esercitare il potere politico, economico e di conoscenza, e sono vittime della violenza. Gli uomini esercitano il potere e la violenza contro le donne. Per questo il movimento femminista è anche una lotta contro la violenza esercitata nell’intento di distruggere le donne quando non servono sessualmente, maternamente o sensualmente, quando non producono, non consumano e anche quando criticano questo stato ingiusto. Questo stato di cose verrà trasformato solo dirigendoci verso la produzione di una coscienza femminista veramente radicale (pp. 104-105).

Una prima questione riguarda il valore d’uso per il quale «i corpi sono stati misurati» (p. 23). Il titolo del terzo capitolo, Siamo tutte lavoratrici, rimanda infatti a «la più ampia sfera del lavoro, nella quale è in gioco ciò che si fa per l’altro per necessità di sopravvivenza» (ibidem). Questi pochi indizi ci permettono quantomeno di leggere fra le righe una concezione estesa del lavoro che, se portata alle sue estreme conseguenze, agevolerebbe una teoria generale dello sfruttamento. Le implicazioni di uno sfruttamento generale non vengono approfondite da Tiburi, mentre sono state sviscerate da Christine Delphy, sociologa e femminista francese. Nonostante si riallacci a una scuola di pensiero e a un contesto storico differente, la riflessione di Tiburi potrebbe trovare un'alleata nella definizione primaria di sfruttamento offerta da Delphy: «appropriazione del lavoro altrui» (Delphy 2020, p. 89). Alla distinzione di due economie – il modo di produzione patriarcale (o domestico) e il modo di produzione capitalista – corrisponde il vantaggio di individuare altrettanti beneficiari del profitto: da una parte, nella casa, il capofamiglia che estorce gratuitamente lavoro domestico; dall’altra parte, nella fabbrica, il capitalista che estorce plusvalore a fronte della forza-lavoro salariata. Se, al contrario, si cede all’insidiosa equivalenza di capitalismo e patriarcato – sulla quale Tiburi non fa dovuta chiarezza – si rischia di sovrapporre l’economia capitalista all’economia patriarcale. In sintesi, se il mercato viene naturalizzato come il modello privilegiato delle relazioni domestiche, la donna diventa automaticamente riproduttrice di forza-lavoro, ossia di quella merce (il lavoratore) che produce plusvalore (profitto capitalista), perdendo così per strada la violenza dello sfruttamento specificamente domestico. Riconoscendo autonomia sistemica ai diversi modi di sfruttamento non s’incorre, a nostro avviso, nella depoliticizzazione della sfera domestica: semmai, si fa luce sulla gestione politica dello sfruttamento domestico. In base alle nostre ultime considerazioni, il seguente stralcio di Tiburi può essere letto dirimendo il più possibile gli equivoci, a condizione di dare rilievo alla similitudine introdotta dalla particella ʻcomeʼ – a condizione, cioè, di cogliere il peso metaforico implicito nell’equivalenza:
Ora, il lavoratore è il servo del capitalismo, il che equivale a dire che è come la donna del capitalismo. La donna del lavoratore, dal canto suo, è come la sua serva. Questo significa che, di fronte a una donna, sia essa nella condizione di sposa o puttana, il suo sfruttatore – sia esso a sua volta sfruttato, come nel caso del lavoratore – è in un modo o nell'altro un capitalista (Tiburi 2020, p. 78).
Una seconda questione, che torna a più riprese nel testo, riguarda i marcatori di oppressione (p. 33), ovvero tutti i segni identitari che vengono eterodiretti dal patriarcato. Nella misura in cui quest’ultimo è «caratterizzato dall'associazione intersezionale di genere-razza-classe-sessualità e – aggiungiamo – età e plasticità» (p. 54), il femminismo sarà chiamato a cambiare di segno la rete di intersezioni. Le insidie della investitura dialettica sono inevitabilmente tenute in conto, pertanto un’autocritica interna al femminismo sarà una condizione necessaria (sebbene, da sola, non sufficiente) affinché la lotta non si configuri né come un'ʻutopia matriarcaleʼ né come un “femminismo di moda” (ivi p. 40). In primo luogo, allora, il femminismo è una teoria e una pratica etico-politica della coscienza di sé: mettendo in discussione una possibile deriva autoritaria del femminismo stesso, la lotta potrà resistere non solo a un'inversione della marcatura per mera sostituzione di servi e padrone, vittime e carnefici (p. 103), ma anche a una femminilizzazione del patriarcato. Con l’ultima espressione alludiamo a un femminismo di Stato, ovvero a una cattura del femminismo da parte dello Stato patriarcale, tale da sancire il passaggio dal femminismo (bistrattato) al femminile (elogiato) (p. 62).
In secondo luogo, il femminismo è una teoria e una pratica poetico-politica indirizzata al «riscatto delle parole» (p. 96), vale a dire a una risignificazione della marchiatura. Come possono le donne riscattarsi dalla sottomissione masochistica nella quale sono state collocate (anche da alcune tendenze femministe)? Come reinventare, dunque, le parole? Attraverso il dialogo, suggerisce Tiburi. Tutto l’opposto di una via pacificata al consenso, «il dialogo è un movimento tra presenze che differiscono tra loro» (p. 55). Sgravato dal bagaglio rappresentazionale della svolta linguistica, il dialogo non è medium simbolico di resoconti più o meno fallaci, più o meno devianti di una realtà patriarcale presupposta come unica e vera. Al contrario, il dialogo è il processo con cui territori di senso prima sommersi emergono per collisione.
«In quanto riconoscimento del nostro spazio nella natura e motto della costruzione politica» (p. 135), l’ecofemminismo indicato da Tiburi come «il futuro che dobbiamo conquistare» (ibidem) è un esempio emblematico della molteplicità di voci interne al femminismo. Dal lato ecologico, l’ecofemminismo pone l’accento sulla natura che è stata resa invisibile dal contratto sociale (Serres 2019); dal lato femminista, l’ecofemminismo denuncia la mossa essenzialista con la quale il naturalismo ha assimilato il polo femminile al polo naturale, concepiti entrambi come risorse infinitamente sfruttabili. Il fatto che all’interno di numerosi collettivi indigeni dell’Amazzonia, brasiliana e non, decisamente non tutte siano disposte a dichiararsi ʽecofemministeʼ la dice lunga sulla pluralità di prospettive che difficilmente si lasciano riassumere in un’unica espressione. In breve, quante sono le voci a prendere parola altrettanti sono i femminismi, quanti sono i concetti di ʻnaturaʼ e ʻcorpoʼ espressi altrettante sono le lotte ecologiche e femministe mobilitate.
Affinché lo spazio di parola dell'altra (Tiburi 2020, p. 66) non sia trasformato dall’egemonia concettuale dell’occidente in uno spazio di morte filosofica, il dialogo non potrà che far emergere, anziché negare, le differenze con le quali, agendo di concerto, pensare concetti talmente singolari da avere in comune almeno la lotta: la convergente dissonanza di molteplici istanze anti-patriarcali.
di Giulia Gottardo
.
.
Bibliografia
C. Delphy, Per una teoria generale dello sfruttamento. Forme contemporanee di estorsione del lavoro, trad. it. di D. Ardilli, ombre corte, Verona 2020.
C. Pateman, Il contratto sessuale. I fondamenti nascosti della società moderna, Moretti & Vitali, Bergamo, 2015.
M. Serres, Il contratto naturale, trad. it. di A. Serra, Feltrinelli, Milano 2019.
M. Tiburi, Como conversar com um fascista: reflexões sobre o cotidiano autoritário brasileiro, Record, Rio de Janeiro 2015.
M. Tiburi, Ridículo político: uma investigação sobre o risível, a manipulação da imagem e o esteticamente correto, Record, Rio de Janeiro 2017.
M. Tiburi, Il contrario della solitudine. Manifesto per un femminismo in comune, trad. it. di E. Del Giudice, effequ, Firenze 2020.
-
Con Pensiero istituente. Tre paradigmi di ontologia politica (2020) Roberto Esposito porta avanti la riflessione per una filosofia politica affermativa che da tempo muove le sue pubblicazioni. La presa di distanza dalle filosofie che pensano le proprie categorie a partire dal loro rovescio negativo (l’amico a partire dal nemico, la vita a partire dalla morte) è esplicito in Politica e negazione (2018) ma rintracciabile fin da Communitas (1998). D’altra parte in Pensiero istituente si chiarisce anche il distacco dell’autore dalla parte della biopolitica e da quella filosofia affermativa che dimentichi di articolare in maniera produttiva la negatività e il conflitto come caratteristiche imprescindibili del politico. La novità del saggio è proprio la definizione di una terza posizione all’interno della quale Esposito stesso si colloca: egli la delinea tornando a Machiavelli ma soprattutto attraverso l’opera di un autore di cui fin qui poco si era occupato e che, almeno per quel che riguarda la recezione italiana, rientra ancora tra i minori, Claude Lefort. È alla sua posizione, definita appunto istituente, che si riferisce il titolo del nostro testo e che costituisce la proposta positiva di Esposito.
L’articolazione del libro in tre capitoli restituisce la partizione proposta dall’autore tra un paradigma destituente che fa capo alla tradizione heideggeriana, un paradigma costituente fatto risalire all’opera di Deleuze, e infine un pensiero istituente, neo-machiavelliano o conflittualista, lefortiano. Se l’ultimo paradigma è la pars costruens del discorso di Esposito, Heidegger e Deleuze rappresentano invece due tendenze, tra loro opposte ma ugualmente degenerative, che caratterizzano la crisi del pensiero politico contemporaneo. Ripercorrerne le elaborazioni è così un modo per prendere posizione rispetto al dibattito, italiano e non, che ad essi è debitore, si pensi per esempio ad Agamben o a Nancy per il primo ed a Negri e Hardt per il secondo.
Le tre posizioni si collocano all’interno di un orizzonte che Esposito definisce «ontologico politico post-fondazionale» e corrispondono ad altrettante declinazioni possibili del rapporto tra essere, politica e differenza. A caratterizzare questa impostazione sarebbe secondo l’autore la particolare consapevolezza della dipendenza reciproca di ontologia e politica: da una parte la presupposizione di concezioni sull’essere (sullo spazio, sul tempo, sull’uomo) implicita in ogni azione politica, dall’altra il fatto che l’elaborazione di posizioni ontologiche, a partire dalla decisione su ciò che deve o meno essere considerato politico, dipende a sua volta da opzioni politiche. È su questo piano comune che riposa la possibilità di un confronto tra autori che si sono occupati in maniera quanto mai difforme di politica, sia per quel che riguarda la teorizzazione che la sua pratica concreta. L’impressione però è che ad emergere in Pensiero istituente, anche rispetto ad altri interventi dello stesso Esposito più situati rispetto a questioni di politica contemporanea, sia piuttosto l’ontologia della politica che non la concreta esigenza politica di un’ontologia.
Il primo capitolo del saggio è dedicato al paradigma destituente cui fanno capo le filosofie che, pensando la politica a partire dal suo fondamento negativo, hanno come esito una delegittimazione dell’azione politica. In questa prospettiva che vede la politica rinchiusa all’interno dei propri confini mondani, e compromessa con la violenza e il potere che ne fanno parte, ogni tentativo di realizzazione storica di qualsivoglia idea di bene o di giustizia è destinato a fallire. La critica di Esposito al pensiero heideggeriano ed al paradigma che rappresenta è che, a fronte di affermazioni teoricamente rivoluzionarie, essi finiscano per essere praticamente inerti e spoliticizzanti (p. XIII).
Benché Esposito ne ripercorra quasi interamente l’opera, non è tanto l’Heidegger degli anni Trenta a rappresentare nella maniera più chiara questo paradigma. Qui, ancora, l’adesione al regime nazista si accompagna a un discorso positivo sulla messa in opera e quindi a una possibilità positiva di politica, benché Heidegger la immagini guidata dalla filosofia in un primo tempo (cfr. il Discorso del rettorato, 1933), e in seguito la concepisca in analogia alla creazione dell’opera d’arte, condotta da parte degli individui “più unici” in grado di dare unità simbolica e politica a un popolo (cfr. i corsi del 1934-35 su Hölderlin e L’origine dell’opera d’arte, 1935). È piuttosto dagli anni Quaranta che Heidegger comincia a maturare la sfiducia nei confronti dell’azione che andrà consolidando negli scritti del secondo dopoguerra. Già nel corso del ’42 su l’Ister di Hölderlin, Heidegger non pensa più la politica come un’opera da realizzare ma come un evento che emerge dalla polis (p. 46). Se però ancora nella polis una politica sembra possibile, in un mondo sempre più dominato dalla tecnica l’azione politica non è in grado di sottrarsi alla sua razionalità: il passaggio dall’idea greca di una realtà operante alla concezione romana del reale come creato e dell’agire come causa efficiente fa sì che l’azione politica venga a far parte della stessa logica della tecnica e della macchinazione che vorrebbe contrastare (cfr. Scienza e meditazione, 1953). In questo contesto l’unica azione possibile è un lasciar essere, una revoca dell’azione e della volontà che in Heidegger si tinge di tinte poetico meditative (cfr. Gelassenheit, 1983).
Come già accennato, Heidegger non è l’unico autore ascritto al paradigma destituente. In Categorie dell’impolitico (1988), che si può dire si muova all’interno di questa prospettiva, Esposito si era rivolto tra gli altri a Weil, Broch, Bataille che anche in Pensiero istituente non manca di citare. Se la lezione di altri autori «destituenti» non porta a esiti così smaccatamente spoliticizzanti come quelli di Heidegger egli è però portatore dell’opinione condivisa sulla limitatezza, sulla non fondatezza dell’agire umano e sulla sua implicazione nella necessità del mondo. Come commenta Esposito seguendo Schürmann: «A venir meno, con la distruzione metafisica praticata da Heidegger, non è l’agire, ma la possibilità che questo continui a essere legittimato da un principio esterno. Ormai la praxis non è più fondabile da parte della theoria» (p. 65).
Un discorso specularmente inverso vale per il paradigma costituente rappresentato da Deleuze. La filosofia di Deleuze è definita costituente nel senso che essa pensa l’essere come una realtà creativa e produttiva di molteplicità. La critica di Esposito a questa posizione è che, per quanto non pacifica nel percorso di Deleuze, la coincidenza sempre più stretta di essere e differenza tenda a obliterarne la dimensione conflittuale, e il politico, che in questa dimensione si colloca, finisce per confondersi con il flusso del divenire perdendo rilievo specifico e forza critica. «Ciò che manca, in un’ontologia dell’immanenza assoluta, non è la trascendenza del potere, ma una teoria del conflitto politicamente articolata» (p. 115).
Anche in questo secondo capitolo Esposito ripercorre puntualmente l’evoluzione del pensiero di Deleuze. Secondo l’autore, in buona parte in consonanza con Žižek, il pensiero di Deleuze oscilla tra due ontologie divise dalla posizione di fronte al negativo. Ancora in Nietzsche e la filosofia il negativo viene inteso come il risultato dell’aggressività dell’affermarsi della differenza, dotato di una forza propria, e in Marcel Proust e i segni emerge come il segno di ciò che non è più, di ciò che è passato. A partire dagli anni ’60, con l’avvicinamento alle posizioni di Bergson, Deleuze tende invece a mettere da parte il negativo come falso problema. Nonostante qualche eccezione (cfr. per esempio Logica del senso, 1969), la sua ontologia si sposta interamente sul piano di immanenza cosicché l’essere stesso viene a coincidere con la differenza, ovvero con una realtà plurale e articolata in una molteplicità di organizzazioni (p. 107). Proprio quando, nella collaborazione con Guattari, l’interesse e il linguaggio di Deleuze si fa espressamente politico, la politica stessa finisce per perdere i confini del proprio ambito e viene a coincidere con il dispiegarsi del desiderio inteso come azione rivoluzionaria produttiva di realtà (p. 120). In questo contesto la critica al capitalismo che innerva i due volumi di Capitalismo e schizofrenia vede come unica azione politica possibile l’accelerazione degli stessi flussi di desiderio di cui il capitalismo è composto. La schizofrenia, la decodificazione di tali flussi e la dissoluzione degli ultimi vincoli che ancora li trattengono costituiscono l’unica strada per immaginare il superamento del capitale.
Nello stesso ordine di riflessioni si inseriscono, come già notato da Benjamin Noys (cfr. The Persistence of the Negative, 2010), autori come Lyotard e Baudrillard, ma Esposito vi fa convergere anche Negri e Hardt e per altro verso Vattimo. Il tratto che, pur nelle differenze specifiche, li accomuna è il tentativo di contrapporsi al capitale dall’interno, assecondandone la razionalità invece di contrastarla (p. 79). L’esito del paradigma costituente risulta simmetricamente opposto a quello heideggeriano, ovvero un pensiero dalla veste al contempo iperpolitica e spoliticizzante. Una nota a parte meritano invece due testi, Istinti e istituzioni (1955) e Empirismo e soggettività (1973), perché ci portano nella direzione che sarà propria del paradigma istituente. In questi testi, a partire dalla lettura di Hume, Deleuze interpreta l’istituzione come la zona d’incontro tra natura e cultura, ovvero tra il desiderio e la necessità di darvi una forma. Diversamente dalla lettura che ne è stata data dai francofortesi fino a Foucault, in questa prospettiva l’istituzione è l’affermazione di un modello possibile di soddisfazione degli istinti piuttosto che un dispositivo volto a frenarli, com’è invece la legge. Vedremo come ciò sia consonante con alcune posizioni lefortiane.

Claude Lefort A queste ultime si rivolge il terzo e ultimo capitolo di Pensiero istituente. Lefort (1924-2010) è noto per essere stato fondatore insieme a Cornelius Castoriadis di Socialismo o Barbarie. Allievo di Merleua-Ponty, ne è stato anche esecutore testamentario curando e introducendo le edizioni di molti dei suoi testi, come Il visibile e l’invisibile (1964); L’institution. La passivité (2003); e Œuvres (2010). Questa matrice fenomenologica caratterizza fortemente il terzo paradigma delineato da Esposito. Qui l’istituire viene inteso come un processo di stabilizzazione dell’esperienza che si compie su un piano intersoggettivo: se da una parte l’istituzione consiste nelle azioni dei soggetti istituenti, essa ha allo stesso tempo una validità indipendente da ognuno di essi. In questo modo i singoli la tengono in vita modificandola, ma senza per questo crearla ex nihilo né tantomeno trovandola prederminata, ricevendola da altri e restituendola ad altri.
Ad istituire per Lefort è in primo luogo la politica, dove essa consiste nella messa in forma simbolica dei conflitti che dividono il sociale. Questa prospettiva, che segna anche il distacco da Marx, deve molto all’incontro con la letteratura etnografica e con Machiavelli (cfr. Le Travail de l'œuvre Machiavel, 1972). In particolare dal confronto con quest’ultimo, in parte anticipato nel Merleau-Ponty delle Note su Machiavelli (1949) e de Le avventure della dialettica (1955), si delineano due punti centrali dell’ontologia politica di Lefort: il simbolico come luogo del politico e l’ineluttabilità del conflitto. Come ribadisce Esposito «il potere ha a che fare più col discorso – cioè con la sua costruzione rappresentativa – che con i rapporti economici all’interno dei quali s’istituisce» (p. 178), in quanto sua immagine simbolica il politico eccede dal sociale e retroagisce su di esso. Se da una parte non si dà politica al di fuori della società su cui si esercita, infatti, d’altro canto anche la società non esiste propriamente come insieme riconoscibile prima di essere resa visibile tramite la sua rappresentazione politica (p. 169). D’altra parte, la comprensione del conflitto come dato ineluttabile delle società intende affermare che l’ordine politico è sì possibile ma sempre provvisorio, ovverosia che l’operazione di simbolizzazione e di messa in forma della società non è garantita dal suo fallimento proprio perché, se il politico non coincide col sociale, neppure il sociale coincide con se stesso. Ciò che distingue le diverse società è il modo in cui in esse il potere politico rappresenta il conflitto (p. 191). Da una parte, nelle cosiddette “società senza storia” o “stagnanti” la tendenza è quella a escludere e neutralizzare per quanto possibile il conflitto, con lo scopo di mantenere intatto un certo ordine. Diversamente, secondo Lefort, la democrazia moderna è l’unico sistema politico in grado di riconoscere e rappresentare l’essenza conflittuale della società (cfr. Sur la démocratie: le politique et l’institution du social, 1971). Attraverso le sue istituzioni volte non tanto a mantenere un certo potere quanto a salvaguardare la possibilità del suo passaggio di mano tra le parti in gioco, la democrazia dà forma a un potere vuoto, cioè infinitamente contendibile. Contraddicendo una valutazione comune ai più grandi pensatori politici novecenteschi, che intendono la modernità come un’epoca di spoliticizzazione, per Lefort la democrazia moderna è al contrario politica per eccellenza. Nell’istituzione democratica, infine, viene riconosciuto il risultato del ribaltamento dell’articolazione di diritto e potere messa in atto dalle rivoluzioni moderne, dove adesso è il diritto a fondare e a limitare il potere.
Anche in questo caso Lefort non è né il primo né l’unico ad aver tematizzato l’istituzione, egli ne condivide anzi il discorso con autori come Castoriadis, Ricoeur, ma anche Hariou e Santi Romano. In particolare attraverso quest’ultimo, cui Esposito dedica l’ultimo paragrafo del saggio, il discorso istituente viene aperto a una prospettiva che superi la dimensione statale. Romano riconosce l’istituzione anche nelle collettività organizzate alternative o addirittura competitive nei confronti dello Stato, facendo dell’istituire un processo in grado di accogliere le istanze mutevoli della società. Così anche per Esposito «tutt’altro che a un ordine consolidato di regole e leggi, l’istituire rimanda piuttosto a un compito – coincidente con quello della politica – destinato a mutare continuamente il quadro normativo entro cui agisce» (p. XIX).
di Anna Draghi
-
Il libro di Manlio Iofrida, Per un paradigma del corpo: una rifondazione filosofica dell’ecologia, uscito per Quodlibet alla fine del 2019, si presenta come uno snodo ricco e importante per un approccio teoretico, etico e critico all’attuale questione ecologica. In questo senso, il libro s’inserisce nel cuore stesso del dibattito – non solo italiano – incrociando tematiche come il corpo, il concetto di Natura, lo statuto filosofico del vivente e della sua relazione con la tecnica (a questi temi si aggiungano la critica della cultura, la storia dell’arte, il dialogo tra filosofia e altri campi del sapere, i rapporti tra la cultura Europea e i suoi grandi altri ecc.).
Il libro assume quella che potremmo definire un’ottica cosmopolitica e si presenta come il crocevia d’intuizioni, idee e riflessioni che animano il gruppo di ricerca Officine Filosofiche (il gruppo gestisce anche un’omonima collana editoriale), fondato e diretto dallo stesso Iofrida assieme a Ubaldo Fadini. Molti argomenti sviluppati nel libro intrecciano le principali linee di lavoro del gruppo, contribuendo così a fare dell’ecologia filosofica uno dei campi di ricerca più innovativi e stimolanti dell’attuale panorama filosofico italiano.
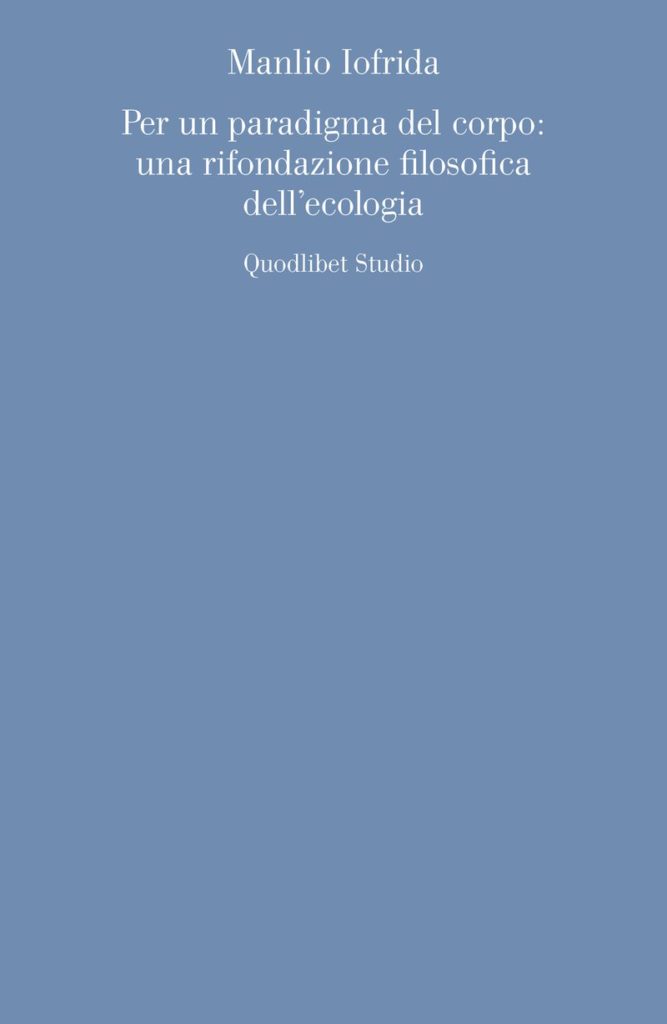
Si può dunque comprendere, sin da queste prime considerazioni, che riportare in maniera analitica o anche solo accidentale tutti gli impliciti teorici – nonché la profonda erudizione dell’autore che conferisce all’ecologia un ampio spessore culturale – è compito improbo per una recensione e, probabilmente, anche inutile. Quel che ci proponiamo di fare in questa sede è di attraversare il testo in maniera “libera” tentando di esplicitare alcuni aspetti che sembrano restituire, nella parzialità della nostra lettura, alcune delle intenzioni di base dell’autore.
Non si può non partire dalla centralità teorica del tema del corpo che, non nuova nel lavoro di Iofrida, si richiama esplicitamente all’opera complessiva di Merleau-Ponty e all’attualità del suo concetto di Natura (pp. 19-31) «come limite che la cultura non può sorpassare» (p. 30). Sotto tale aspetto, questo studio si riallaccia (pp. 9-16), pur con oltre dieci anni di distanza, al precedente lavoro dell’autore Per una storia della filosofia francese contemporanea: da Jacques Derrida a Maurice Merleau-Ponty. Dire che questo sia un libro “merleau-pontyano” è senza dubbio corretto e tuttavia rischierebbe di schiacciarne la profondità su un “arroccamento” teorico, una semplice riproposizione ermeneutica. Devono essere menzionati, infatti, almeno altri due autori classici presenti come linee di basso nell’architettura del testo: Schelling ritorna diffusamente nel testo, utilizzato in chiave anti fichtiana-attualista (pp. 38, 141) o hegeliano-sintetico (anche se Hegel resta comunque un autore importante nell’impostazione ecologica iofridiana, pp. 138-140); ma è soprattutto il Kant della Critica della facoltà di giudizio a fornire un’impalcatura teorica di primo piano (vanno, poi, almeno ricordati i nomi di Goethe, Schiller e Adorno, per completare la batteria tedesca di riferimento, cfr. pp. 47-52). Ci sia concesso dunque di entrare nel vivo del libro approcciandolo alla lontana, così da poter restituire, se non altro, il profumo della complessa architettonica di Iofrida.
In siffatta architettonica, l’ecologia non si presenta tanto, né solo, come una disciplina scientifica (pp. 45-47) ma, potremmo dire, si tratta di una questione di gusto, di istituire un paradigma del gusto ecologico. Come si può intuire, molto lessico di Iofrida è intriso di una semantica post-kantiana. Il gusto, permettendoci l’ardire di parafrasare Kant, è quella strana facoltà di giudicare secondo sentimento (leggendo in questa chiave il giudizio riflettente).
Sappiamo anche che il sentimento è un vero e proprio mondo intermedio che si situa tra la facoltà di conoscere e quella di desiderare, ossia tra l’intelletto e la ragione, tra la “necessità naturale” e la “libertà umana” (che Iofrida definisce prometeica, cfr. pp. 59-61). Dire, dunque, che l’ecologia è questione di gusto significa affermare che essa si situa nel mezzo di un’ardita relazione tra la Natura e la Cultura – dualismo principale di molte riflessioni ecologiche. Ma, altresì, ci dà delle informazioni sugli aspetti “filosofici” dell’ecologia: il gusto, sappiamo dal §40 sul senso comune della Terza Critica, va educato. L’ecologia, secondo Iofrida, non consiste né nella descrizione di uno stato di cose oggettive (ci sia concessa la banalizzazione: filosoficamente, l’ecologia non può essere ridotta a una disciplina naturalistica) né, occorre fare attenzione, nella prescrizione di massime della ragione (che si limiterebbe a un greenwashing della Ragion Pura Pratica): l’ecologia è filosoficamente fondata nella misura in cui è capace di una vera e propria educazione sentimentale. Così, l’ecologia filosofica non è né scientifica (occorre «declinare l’ecologia come critica anti-intellettualista», p. 54) né morale («non si pone come sussunzione dominante», p. 119), ma è intimamente etica (l’ecologia, ci ricorda l’autore, è un pensiero della finitezza, pp. 52-56). È a partire da una esigenza etica (e, con Merleau-Ponty, connesso a un certo spinozismo schellinghiano, da un’esigenza anche ontologica) che va letta la proposta di un paradigma del corpo. Non si tratta, così, di fondare un principio di rappresentazione, o massime pratiche, ma di sviluppare delle ipotesi etiche, per dir così, da un punto di vista pragmatico.

Maurice Merleau-Ponty Fatta questa premessa, possiamo addentrarci in alcuni aspetti concettuali. Uno dei concetti chiave per leggere la proposta iofridiana è quello di inerenza (pp. 29-31). Di matrice fenomenologica, l’inerenza è un fenomeno corporeo e rimanda a una «ontologia relazionale» (p. 41) che si pone in antitesi tanto con le ontologie costruttiviste del pensiero debole (p. 43) quanto con le ontologie realiste di certi modi di intendere il materialismo (pp. 60-61). L’inerenza è il concetto cardine di un’ecologia che si propone di lavorare in chiave ontologica sulla «nostra relazione coi milieux» (p. 41) – i riferimenti sono alla «geografia […] fenomenologica» (p. 39) di A. Berque: la relazione degli “individui” con gli ambienti (o paesaggi) «non è quella della sostanza pensante con la sostanza estesa; […] piuttosto c’è uno sconfinamento, un’interpenetrazione» (p. 41). L’inerenza ci offre una cifra filosofica importante: essa è la relazione chiasmatica – è evidente nel lessico iofridiano l’influenza di Merleau-Ponty – del vivente con i suoi dintorni, le sue Umwelten, il co-appartenersi di individuo e ambiente. Intreccio, potremmo dire, della parte con il tutto.
In quanto etica ontologicamente orientata, l’ecologia si interessa non alle partizioni sostanziali – che comportano, sul piano etico, la costruzione di un’impalcatura morale – bensì agli assunti relazionali (ci sia concessa un’assonanza col lavoro di Giuseppe Semerari 2009) che solo centrando l’analisi filosofica sulle potenze corporee possono essere messi in risalto. Questa inerenza, che è una mediazione senza soggetto – e che anzi produce soggettività – non è pensabile come Aufhebung, bensì come un’unità senza concetto (p. 115) attuata per il tramite del corpo «e la sua apprensione orizzontale del mondo» (p. 25). L’esigenza di un paradigma del corpo è dunque insito nella tematica stessa della relazione ecologica, così che, per Iofrida, ogni ecologia, sul piano etico, non può non passare – anche implicitamente, come traspare mediante la critica alla smaterializzazione postmoderna (pp. 67-68) – per il tramite di un paradigma del corpo.
Il problema del corpo è però l’altra faccia di un ulteriore assunto di Iofrida, ovvero l’idea complementare che la Natura non sia un oggetto (p. 45) e che il vivente non sia meccanizzabile (p. 30). Il rischio di interpretare in chiave puramente valoriale, facendo di tali assunti delle massime della Ragione, è grosso. Occorre dunque tentare di essere chiari, ancora una volta, sul lessico dell’autore. Siamo pur sempre, lo si è detto, sul piano del giudizio riflettente. I riferimenti sono ancora all’opera di Merleau-Ponty e, tramite lui, Schelling e Kant. In ultima istanza, l’orizzonte concettuale ci appare ancora di matrice kantiana. L’idea che il vivente non sia meccanizzabile vuol dire che lo specifico fenomeno di inerenza dell’umano agli altri viventi (che compongono i suoi dintorni) non è un rapporto conoscitivo, o intellettuale, né tuttavia un rapporto pratico. Non è conoscitivo perché, in quanto soggetti empirici, non tutti gli umani sono “scienziati”, e questo non pone particolari problemi. Ma non è neppure un rapporto pratico, perché non è possibile estrapolare una massima categorica da questa idea: non tutti i viventi possono agire conformemente a scopi (tralasciamo i motivi di tale impossibilità). L’idea che il vivente non sia meccanizzabile non è un enunciato che riguardi il regno della libertà. Concessa la formula, quella tra viventi non è una relazione tra esseri (radicalmente) liberi, situandosi, invece, nel regno intermedio tra la necessità dell’oggetto naturale e la libertà radicale del soggetto trascendentale (Merleau-Ponty 1996, 312-313).
Il problema del vivente – che possiamo anche chiamare, se ci è concesso, il problema della finalità senza scopo – è un problema sentimentale e affettivo. È ancora un paradigma del corpo che permette di comprenderlo: un corpo è il medium non solo, e non tanto, della natura e della libertà, bensì della inerenza al mondo e agli altri viventi. È mediante il corpo – un’utilità non strumentale – che si è costitutivamente aperti ad altre modalità dell’esistere e del vivere. Una mediazione senza soggetto che si fa nel mezzo delle relazioni inter-individuali: l’inerenza come vero e proprio fenomeno trans-individuale, contatti molteplici e variegati tra corporeità (cfr. Merleau-Ponty 1996, 254-261). Appare, in queste considerazioni, un altro dei concetti cardine della proposta di Iofrida, concetto che crea un ponte col suo lavoro precedente: si tratta della nozione di libertà strutturale. Una concezione strutturale – o ecologica – della libertà comporta che essa non sia la radicale assenza di limiti, bensì che trovi la propria potenza esistenziale ed espressiva nella composizione delle relazioni, nella ricchezza e varietà degli affetti e degli incontri corporei.
È una libertà che non è competenza di una filosofia della prassi, ma di un’etica, come accennato, dal punto di vista pragmatico. Un’ecologia della libertà richiede pratica e attenzione [Aufmerksamkeit] (p. 146), un’educazione sentimentale finalizzata a un uso ragionevole degli affetti. Insomma, la libertà, in una prospettiva ecologicamente orientata, presuppone una capacità tecnica. È in quest’ottica che leggiamo, infatti, la proposta di Iofrida di una tecnica ecologica (pp. 84-90). Si tratta di una formula ambigua, ma le ambiguità spariscono se non usciamo dalla semantica nella quale ci stiamo muovendo. Un tale epiteto, infatti, è lontano da un greenwashing delle attuali configurazioni tecnico-tecnologiche del tardo capitalismo: insomma, non si prospetta la necessità di una Green Economy. Si tratta, invece, di una concezione ecologica della tecnica che tenga conto del portato affettivo – cioè esistenziale e vitale – della tecnica.
In questo senso, una tecnica ecologica è di segno contrario rispetto alle attuali configurazioni produttive (si tratta di uscire dal dualismo manicheo «produzione o libertà», p. 60; andare al di là dell’alleanza demoniaca di capitalismo e schizofrenia, cfr. Pignarre & Stengers 2016) configurandosi invece come rivolta alla convivialità – tra umani e tra umani e non umani – incastonata nella complessità variegata degli ambienti di vita (fondamentale in quest’ottica il capitolo dedicato alla teoria dei sistemi, pp. 121-140). È ancora una semantica del giudizio: la tecnica rimanda all’arte, cioè una tecnica ecologica diventa una vera e propria arte dello stare in vita da parte dei viventi – ecologicamente, vi è tecnica ovunque vi sia fragilità e ostinazione della vita: occorre «concepire l’arte come un nuovo modo di rapportarsi al mondo […] poiché, già in se stessa, tale prassi priva di finalità è un’altra e superiore modalità di azione del nostro corpo vivente rispetto a quella meramente utilitaria, essa può essere punto di partenza di una prassi concreta […] e punto di arrivo di una costruzione dal basso, partecipata, intersoggettiva» (p. 152).
Senza dubbio si tratta di una concezione ottimistica della tecnica: nessuna caduta da un eden ormai perduto, né solo nichilistica distruzione della vita da accettare passivamente come un destino. Si tratta, invece, di un’arte pericolosa, quella dello stare in vita, proprio perché la vita – un vivente – è insieme ostinazione e fragilità: l’educazione sentimentale serve a saper «reggere delle crisi, saper gestire il rischio […], anche se rischio significa appunto che la crisi non è mai del tutto esclusa e che il disordine può avere sempre il sopravvento» (p. 123). È una concezione ecologica e ottimistica della tecnica, sì, ma non è il frutto di una anima bella (ecco comparire una certa ispirazione hegeliana). Rifacendosi al lavoro di Kurt Goldstein (2016), neurologo tedesco del secolo scorso, tra le fonti di Merleau-Ponty, Iofrida ci ricorda che «un organismo vivente, e l’uomo in particolare, è teso ad accrescere continuamente la propria complessità […]; esso cerca dunque la relazione e anche il conflitto, in un mondo in cui l’ordine è sempre un momento precario all’interno di una lotta di forze eterogenee che genera un perenne dinamismo» (p. 127).
Educazione sentimentale, teoria degli affetti e concezione tecnica del vivente: i tre capisaldi che istituiscono la fondazione filosofica dell’ecologia proposta attraverso un paradigma del corpo. Tale paradigma fa sì che un’ecologia filosofica si trovi a proprio agio non nel contemplare un’astratta e fondativa Natura Naturante, un’origine ormai perduta o distrutta dalla cattiveria dell’Uomo, bensì nel concepire modi possibili del vivere in comune, forme collettive di esistenza con i più ampi margini di gioco transindividuali, vincoli che non obbligano capaci di aumentare le potenze esistenziali e le capacità creative dei viventi umani e non (è questo il principale rimando al concetto di natura di Merleau-Ponty). Si tratta di una concezione minoritaria della storia, del divenire minoritario dell’umano, dei suoi affetti, delle sue ibridazioni, delle sue contaminazioni (cfr. Deleuze & Guattari 2015, 349-357). Una storia minore che non ha la Natura come Grande Altro, bensì che è caratterizzata dalla sua inerenza all’elemento naturale, alla sua imprevedibilità, alle sue complessità ontologiche (ma anche epistemologiche, dato che, ecologicamente, l’ontologia è inscindibile da un’epistemologia): si tratta di una storia universale della contingenza (Deleuze & Guattari 2002, 86).
L’ecologia filosofica proposta da un paradigma del corpo è così una filosofia artistica, un’arte, pericolosa e sublime a un tempo, del vivere insieme, del condividere la Terra con altri viventi (l’Autore parla di «un materialismo della Terra», p. 44). Un’arte, per chiudere restituendo il ruolo di Michel Foucault nel nuovo paradigma ecologico (pp. 205-211), che sia una «estetizzazione della vita come progetto condiviso di una comunità di eguali che dialogano e, esercitando la socievolezza, istituiscono con il mondo e gli altri una relazione che non è quella della ragione strumentale, brutalmente utilitaria, ma che può a tutti gli effetti definirsi ecologica: non è il bello quella dimensione sempre mobile di limite in cui ci apriamo al mondo e agli altri non in funzione di un dominio, ma per essere passivi quanto attivi, copresenti in una relazione con l’alterità che può definirsi col termine, anch’esso fenomenologico, di attenzione?» (p. 211).
Bibliografia minima
Deleuze, G. & Guattari, F. (2002; ed or. 1991). Che cos’è la filosofia?. Torino: Einaudi.
Deleuze, G. & Guattari, F. (2015; ed. or. 1980). Mille piani. Capitalismo e schizofrenia 2. Tr. it. G. Passerone. Roma: Castelvecchi.
Goldstein, K. (2016; ed. or. 1934). L’organismo. Un approccio olistico alla biologia derivato dai dati patologici nell’uomo. Tr. it. L. Corsi. Roma: Fioriti.
Merleau-Ponty, M. (1996; ed. or. 1995). La natura. A cura di M. Carbone. Milano: Cortina.
Pignarre, P. & Stengers, I. (2016; ed. or. 2005). Stregoneria capitalista. Pratiche di uscita dal sortilegio. Tr. it. di S. Consigliere e A. Solerio. Milano: IPOC.
Semerari, G. (2009; ed. or. 1961). La filosofia come relazione. Milano: Guerini.
di Gianluca De Fazio
-
Foucault e il grammatico fantastico
Sconfinamenti, Serial / Gennaio 2020 Una fotografia raffigura Jean-Pierre Brisset mentre, il 13 aprile 1913, stando di fronte al basamento della celebre statua di Rodin Le penseur (allora situata di fronte al Panthéon, a Parigi), si rivolge alla folla. L’occasione è data del fatto che, pochi giorni prima, un gruppo di scrittori burloni (tra cui Jules Romains, Georges Duhamel e Max Jacob) ha avuto l’idea di conferirgli il titolo di Principe dei Pensatori, organizzando festeggiamenti in suo onore. Brisset, però, non ha colto l’intento scherzoso dei promotori dell’iniziativa. Nella foto, ci appare come un piccolo uomo anziano, dalla barba bianca, che indossa un paltò e ha un cappello a cilindro sul capo. Gli astanti lo osservano incuriositi e, a giudicare dall’espressione di alcuni di essi, con divertito stupore. Ne hanno motivo, visto il carattere alquanto bizzarro delle idee esposte da questo singolare linguista autodidatta. Spetta soprattutto a scrittori e artisti in vario modo legati al surrealismo il merito di aver valorizzato le sue opere, in apparenza destinate ad un rapido oblio. Così nel 1934 Raymond Queneau include un’ampia scelta di passi di Brisset nella propria raccolta (apparsa postuma) di scritti dei cosiddetti fous littéraires, mentre nel 1946 Marcel Duchamp dichiara grande ammirazione per l’autore, ricordando che «l’opera di Brisset era un’analisi filologica del linguaggio – analisi condotta attraverso un’incredibile rete di giochi di parole». Lo stesso capofila del surrealismo, André Breton, nella nota con cui introduce, nell’Anthologie de l’humour noir, alcune pagine di Brisset, ne giudica l’opera «notevole fra tutte» e segnala il paradosso per cui, se essa «merita di essere esaminata nel suoi rapporti con l’humour, non può in nessun modo passare per umoristica la volontà che la informa. Infatti in nessuna occasione l’autore si discosta dall'atteggiamento più serio ed austero».
Una fotografia raffigura Jean-Pierre Brisset mentre, il 13 aprile 1913, stando di fronte al basamento della celebre statua di Rodin Le penseur (allora situata di fronte al Panthéon, a Parigi), si rivolge alla folla. L’occasione è data del fatto che, pochi giorni prima, un gruppo di scrittori burloni (tra cui Jules Romains, Georges Duhamel e Max Jacob) ha avuto l’idea di conferirgli il titolo di Principe dei Pensatori, organizzando festeggiamenti in suo onore. Brisset, però, non ha colto l’intento scherzoso dei promotori dell’iniziativa. Nella foto, ci appare come un piccolo uomo anziano, dalla barba bianca, che indossa un paltò e ha un cappello a cilindro sul capo. Gli astanti lo osservano incuriositi e, a giudicare dall’espressione di alcuni di essi, con divertito stupore. Ne hanno motivo, visto il carattere alquanto bizzarro delle idee esposte da questo singolare linguista autodidatta. Spetta soprattutto a scrittori e artisti in vario modo legati al surrealismo il merito di aver valorizzato le sue opere, in apparenza destinate ad un rapido oblio. Così nel 1934 Raymond Queneau include un’ampia scelta di passi di Brisset nella propria raccolta (apparsa postuma) di scritti dei cosiddetti fous littéraires, mentre nel 1946 Marcel Duchamp dichiara grande ammirazione per l’autore, ricordando che «l’opera di Brisset era un’analisi filologica del linguaggio – analisi condotta attraverso un’incredibile rete di giochi di parole». Lo stesso capofila del surrealismo, André Breton, nella nota con cui introduce, nell’Anthologie de l’humour noir, alcune pagine di Brisset, ne giudica l’opera «notevole fra tutte» e segnala il paradosso per cui, se essa «merita di essere esaminata nel suoi rapporti con l’humour, non può in nessun modo passare per umoristica la volontà che la informa. Infatti in nessuna occasione l’autore si discosta dall'atteggiamento più serio ed austero».SCARICA PDF
A cura di
Giuseppe Zuccarino è critico e traduttore. Ha pubblicato vari saggi:La scrittura impossibile, Genova, Graphos, 1995; L’immagine e l’enigma, ivi, 1998; Critica e commento. Benjamin, Foucault, Derrida, ivi, 2000; Percorsi anomali, Udine, Campanotto, 2002; Il desiderio, la follia, la morte, ivi, 2005; Il dialogo e il silenzio, ivi, 2008; Da un’arte all’altra, Novi Ligure, Joker, 2009; Note al palinsesto, ivi, 2012; Il farsi della scrittura, Milano-Udine, Mimesis, 2012; Prospezioni. Foucault e Derrida, ivi, 2016. Tra i libri da lui tradotti figurano opere di Mallarmé, Bataille, Klossowski, Blanchot, Caillois e Barthes. Ha inoltre curato un fascicolo monografico della rivista «Riga» (n. 37, 2017) dedicato a Maurice Blanchot.
-
 All’interno delle opere che contribuiscono ad arricchire il panorama letterario sul neoliberalismo, alcune si occupano di individuarne la genesi o di circoscriverne l’attuale fenomenologia (dalla governamentalità flessibile alla gestionalità operante tramite eccezioni e stati di crisi), altre si dedicano a una ricostruzione della sintomatologia che affligge le soggettività in perenne (dis)equilibrio tra imprenditorialità di sé e precariato, poche – dopo aver obiettivamente constatato lo stato di reale crisi in cui versa il presente – azzardano, oltre alla diagnosi, una possibile cura. In questa direzione si muove invece Per la critica della ragione europea. Riflessioni sulla spiritualità illuminista, di Giovanni Leghissa, pubblicato quest’anno da Mimesis per la collana “Spiritualità senza Dio?” diretta da Luigi Berzano.
All’interno delle opere che contribuiscono ad arricchire il panorama letterario sul neoliberalismo, alcune si occupano di individuarne la genesi o di circoscriverne l’attuale fenomenologia (dalla governamentalità flessibile alla gestionalità operante tramite eccezioni e stati di crisi), altre si dedicano a una ricostruzione della sintomatologia che affligge le soggettività in perenne (dis)equilibrio tra imprenditorialità di sé e precariato, poche – dopo aver obiettivamente constatato lo stato di reale crisi in cui versa il presente – azzardano, oltre alla diagnosi, una possibile cura. In questa direzione si muove invece Per la critica della ragione europea. Riflessioni sulla spiritualità illuminista, di Giovanni Leghissa, pubblicato quest’anno da Mimesis per la collana “Spiritualità senza Dio?” diretta da Luigi Berzano.Se l’autore presenta la proposta teorica contenuta in questo breve saggio come un manifesto, il lettore non stenterà a riconoscere in esso, oltre ai tratti dichiaratamente utopici o critico-polemici che lo connotano, la continuazione sistematica di quel progetto politico che già si intravvedeva all’interno della Conclusione Provvisoria contenuta in Neoliberalismo: un’introduzione critica, (Mimesis 2012). La necessità di interrogarsi sul tema della responsabilità in un contesto teorico in cui sembra non esserci più spazio per le teorie globali della giustizia, l’urgenza di mettere in risalto gli elementi – anche emotivi – che orientano le scelte umane all’interno di uno scenario contemporaneo che aumenta progressivamente di complessità e incertezza, e l’importanza di riflettere sulle capacità razionali che caratterizzano la conditio humana in quanto tale diventano, in questo testo, la cornice di senso – per usare un’espressione cara all’autore – all’interno del quale postulare la fondazione di una collettività d’appartenenza europea che si riconosca nella sua comune matrice culturale e, conseguentemente, politica.
L’idea di Europa, da intendersi non tanto come luogo geografico, ma come principio di legittimazione politica, consente all’autore, che da tempo si dedica allo studio del sistema neoliberale e delle sue criticità (Cfr. Leghissa & Becchio 2017), di proporre una tesi fondativa: la sovranità europea, all’interno dello scacchiere geopolitico, è a rischio e, con essa, quella concezione del mondo che, derivataci dall’Illuminismo, ha garantito per secoli la prosperità di un modo di vivere associato basato su ideali quali la libertà, la giustizia e l’uguaglianza di fronte alla legge. In quest’ottica, la proclamazione della necessità urgente di prassi politiche che ci conducano alla costituzione di una federazione europea e l’appello culturale a una “mitologia della ragione” di stampo hegeliano si pongono non semplicemente come rimedi ai sintomi di una crisi che imperversa un continente popoloso ma ormai in declino, come quello europeo, quanto come soluzioni che hanno visualizzato la crisi nella sua eterogeneità e che hanno evidenziato nell’assenza di un mito fondativo a cui radicare la propria appartenenza la causa della deriva culturale e politica insieme del continente.
All’interno della digressione sul presente che si dipana a partire dalla riflessione kantiana sull’ Aufklärung, Foucault attribuisce alla filosofia, in quanto pratica discorsiva dotata di una propria storicità, la necessità di collocarsi all’interno della propria attualità, per «dirne il senso» (2014, p .118), ma anche per sondare la modalità d’azione esercitabile all’interno di questa attualità. Facendo tesoro del monito foucauldiano, la proposta contenuta nella Critica per la ragione europea interroga il presente e, così facendo, entra nel discorso politico da un lato, producendo un’architettura del reale alternativa rispetto a quella nota, la costituzione degli Stati Uniti d’Europa, dall’altro, suggerendo un’altra modalità secondo cui costituire la soggettività e il rapporto che essa intrattiene con la sua attualità, per mezzo di una spiritualità autenticamente atea. Secondo il principio per cui ogni trasformazione, individuale o collettiva, è data dalla combinazione originale di elementi dati, il richiamo all’Illuminismo e al suo specifico uso della critica e della riflessività in quanto paradigmi fondativi del pensiero moderno, ma anche come principi d’indagine teorica, consentono all’autore di individuare preventivamente e di riflettere sulle inevitabili debolezze del suo manifesto e di renderlo così collocabile entro un orizzonte di possibilità perseguibili.

Se nella lettera a Erodoto Epicuro insisteva sulla necessità di «cogliere quello che sta a fondamento delle parole» al fine di poter giudicare su fenomeni la cui problematicità è ancora irrisolta e di radicarsi al raziocinio per l’indagine dei fenomeni, Leghissa compie un’operazione simile all’interno del suo saggio compiendo un’attività di demistificazione dei significati a carico di complessi concettuali spesso usati impropriamente. Aldilà delle similitudini di metodo, la capacità di critica, cui l’autore sembra auspicare come principio generale per la lettura del presente testo, all’interno del saggio diventa quindi il mezzo per ridefinire alcuni termini della questione europea (solo per citarne alcuni: globalizzazione, p. 68, laicità, p. 88, ragione, p. 119, spiritualità p. 139) e la ricollocazione semantica che attua, mira a liberare il lettore da un mostro a tre volti, ognuno dei quali incarna le paure che immobilizzano attualmente la cittadinanza europea, con intento analogo a quello che animava il tetrafarmaco epicureo.
La paura è un tratto emotivo facilmente riconoscibile nella moltitudine che anima la nostra società; Leghissa intravede in questa paura la causa della presente crisi europea e, all’interno del primo capitolo della Critica si occupa diarticolare i vari volti della paura in sezioni tematiche che, se connesse, si riducono di complessità. La paura dello straniero, della globalizzazione e della guerra diventano inaggirabili a meno che non si abbia la capacità di articolare intorno a queste un discorso unico e significativo. Vedere lo straniero in termini di risorsa o di pericolo da includere o escludere dalla propria comunità politica; leggere nella globalizzazione un dispiegamento assoluto e totalizzante della ragione economica pronta a invadere le vite dei cittadini, abbandonati in stati d’eccezione perenne in cui la legge è sospesa; immaginare la guerra come uno scenario pericoloso, ma da cui difendersi non nominandolo sono tutte strategie che consentono di avere sempre delle risposte che appagano l’emotività ma non risolvono in alcun modo lo stato di crisi che tutti sperimentiamo quotidianamente. Comprendere la correlazione tra mito e politica e assumersi la responsabilità (individuale quanto collettiva) di ergere la propria mitologia di derivazione illuminista a fondamento ineliminabile della propria cultura comporterebbe un posizionamento identitario che da un lato, non avrebbe più motivo di temere il confronto con un’altra realtà religiosa – che, con l’ausilio della critica e della ragione, verrebbe identificata come una narrazione significativa tra le tante possibili – dall’altro consentirebbe un’affermazione politica originale in un terreno geopolitico tendenzialmente aggressivo. Ancora, vedere la globalizzazione come una molteplicità collettiva di attori variamente costituita e distribuita su differenti livelli di gerarchizzazione che ridisegna lo spazio in cui si muove attraverso il controllo e la gestione di flussi (di denaro, di merci, di individui etc.) consente di tener presente un aspetto che depotenzia enormemente la teoria di un dominio inarrestabile dei mercati; ogni interazione si origina a partire da una cornice statale e istituzionale e ogni mediazione viene salvaguardata dalla condivisione di modelli mentali da parte di coloro che sono a capo delle organizzazioni. In altre parole, ogni interazione – per quanto disseminata sul piano globale – è normata e tende al successo, nella misura in cui «ogni istituzione, o organizzazione, persegue un unico fine: sopravvivere» (p. 45). Infine, intendere le azioni militari compiute dagli eserciti europei nei diversi scenari del pianeta e gli atti terroristici che immobilizzano le nostre città per quello che sono realmente, ossia atti di guerra, consentirebbe di volgere la discussione pubblica sulla possibilità di una comune difesa europea che renda tangibile quel senso di comunità che i membri dell’Unione Europea si ostinano a difendere almeno verbalmente e che affermi l’esistenza politica dell’Europa aldilà dei suoi confini.

E. Isgrò, Preghiera all'Europa, 2016
La seconda sezione del testo – La laicità e le forme della condivisione – si apre con una digressione riguardante il processo di decision making: essere consapevoli del fatto che le scelte vengono fatte da parte di individui razionali all’interno di «cornici di senso e istituzionali» che orientano la scelta e che «tali cornici hanno un impatto sulla sfera emotiva degli individui» (p. 75) aiuta a comprendere il perché sia importante un orientamento collettivo volto a valorizzare il terreno simbolico intorno al quale gravita la cultura europea. Nessuna scelta, per quanto razionale, viene perseguita in nome della razionalità e le argomentazioni nulla valgono di fronte a sistemi di credenze, magari erronei, ma consolidati: questo è il motivo per cui non basta indicare una via razionalmente perseguibile per uscire dalla crisi attuale e le politiche dell’inclusione non sono mai servite a scalfire l’inclinazione razzista che compare periodicamente in ogni paese. Un cambiamento rilevante si avrebbe invece riconoscendo la forza del legame che intercorre tra la sfera affettiva dell’individuo e il suo vivere politico e ponendo in primo piano la narrazione mitica in luogo dell’argomentazione razionale. In questo senso, la laicità atea che, pur consapevole dell’importanza della componente religiosa nell’esperienza umana, si impegna a spiegare i comportamenti religiosi in termini storici, può farsi mito e principio fondativo del vivere comune da far valere come fondazione politica degli Stati Uniti d’Europa «in grado di rendere inutili le controversie su chi è europeo e chi no sulla base dell’adesione a questo o quel sistema di credenze religiose» (p.98).
È possibile che una laicità atea di matrice materialista venga a costituire il mito fondativo intorno a cui articolare una modalità di vivere propriamente europea, ma è davvero possibile considerare l’ateismo una forma di religiosità? Nell’ultima sezione del saggio, Il materialismo come esperienza spirituale, l’autore indaga la relazione tra materialismo – su cui articolare una mitologia della ragione (p.125) – e il mondo degli affetti dell’individuo, consapevole di quanto non sia la persuasione cognitiva a render conto dell’agire morale o dell’attitudine spirituale dell’uomo. Forte dei risultati provenienti dalla biologia evolutiva, Leghissa rassicura tanto sulla possibilità di interazioni simpatetiche e altruistiche tra sapiensanche all’interno di un orizzonte finito e vulnerabile, come quello materialista, tanto sulla possibilità del materialismo stesso di entrare in risonanza con la sensibilità umana a tal punto da orientare significativamente il suo sguardo sul reale e costituirsi, in un’ultima analisi, come spiritualità.
Ragione, ateismo, laicità, storicità, scientificità del metodo, stato di diritto, norme, uguaglianza, libertà sono alcuni dei termini che costituiscono una rete concettuale a cui ogni europeo, a partire dalla modernità, farebbe riferimento nel tentativo di esplicitare il senso di appartenenza che lo radica al suo continente; la proposta contenuta in Per la critica della ragione europea suggerisce di articolare questa rete in una narrazione mitica che, risuonando nella sfera affettiva dell’uomo, sia in grado di dare statuto a questa appartenenza, salvaguardarla e fondarla politicamente tramite la costituzione degli Stati Uniti d’Europa. La realizzazione, spetta a noi.
di Evelina Praino
Bibliografia
Leghissa, G., Per una critica della ragione europea. Riflessioni sulla spiritualità illuminista, Mimesis, Milano-Udine 2019.
Leghissa, G., Neoliberalsimo. Un’introduzione critica, Mimesis,Milano-Udine 2012.
Leghissa, G. Becchio, The Origins of Neoliberalism. Insights from economics and philosophy, Routledge, London-New York 2017.
Foucault, M., Il problema del presente. Una lezione su “Che cos’è l’illuminismo?” di Kant, In Poteri e Strategie, Mimesis, Milano-Udine 2014, p. 115-126.
-
 Nella prefazione a La filosofia dell’Illuminismo (1932) Ernst Cassirer scriveva che per comprendere la filosofia del XVIII secolo non si dovesse tanto far riferimento all’ampiezza della produzione scientifica che aveva caratterizzato il secolo dei Lumi, bensì chiariva quanto fosse più proficuo focalizzare l’attenzione sulla profondità che caratterizzò i sistemi filosofici dell’epoca, nelle diverse sfumature e nella vasta pluralità. Illuminismo. Storia di un’idea al plurale a cura di Massimo Mori e Salvatore Veca, pubblicato quest’anno da Carocci concretizza la possibilità di confrontarsi con uno studio stimolante e approfondito sull’Illuminismo. Questa possibilità è garantita dall’intento dei curatori che anima la realizzazione dell’opera: leggere e interpretare il Secolo dei Lumi, non secondo una visione monolitica, ma, come si evince dal sottotitolo, trattarlo come la storia di una pluralità di idee, ben ancorate alle vicende storiche e culturali del tempo, ma in grado di offrire appigli teorici di grande originalità rispetto alla tradizione.
Nella prefazione a La filosofia dell’Illuminismo (1932) Ernst Cassirer scriveva che per comprendere la filosofia del XVIII secolo non si dovesse tanto far riferimento all’ampiezza della produzione scientifica che aveva caratterizzato il secolo dei Lumi, bensì chiariva quanto fosse più proficuo focalizzare l’attenzione sulla profondità che caratterizzò i sistemi filosofici dell’epoca, nelle diverse sfumature e nella vasta pluralità. Illuminismo. Storia di un’idea al plurale a cura di Massimo Mori e Salvatore Veca, pubblicato quest’anno da Carocci concretizza la possibilità di confrontarsi con uno studio stimolante e approfondito sull’Illuminismo. Questa possibilità è garantita dall’intento dei curatori che anima la realizzazione dell’opera: leggere e interpretare il Secolo dei Lumi, non secondo una visione monolitica, ma, come si evince dal sottotitolo, trattarlo come la storia di una pluralità di idee, ben ancorate alle vicende storiche e culturali del tempo, ma in grado di offrire appigli teorici di grande originalità rispetto alla tradizione.Il testo è una collettanea a cura di ben undici autorevoli studiosi, i cui interventi trattano gli argomenti più vari. Il volume è diviso in due parti: la prima ha per titolo Problemi e Metodi e la seconda Tradizioni e Prospettive.
Nella prima parte viene costruito il complesso ruolo delle scienze nell’età dei Lumi: le pagine di Paolo Casini, Vincenzo Ferrone e Antonello La Vergata contribuiscono a tessere la tela che ci permette di interpretare l’Illuminismo nei suoi complessi intrecci, da non leggere quindi secondo un’unica chiave interpretativa risolutiva, ma prendendo atto della complessità che lo caratterizza e soprattutto dell’importanza del solco tracciato in esso dalla Rivoluzione scientifica. Questo processo, a sua volta articolato e ricco di variabili, ma certamente di portata storica unica nel suo genere è stato l’evento della modernità che ha lasciato una delle più grandi eredità alla filosofia occidentale. Riguardo l’importanza del rapporto tra Rivoluzione scientifica e Illuminismo, Casini ascrive alla nascita del metodo scientifico il ruolo di aver generato la rottura con l’ipse dixit aristotelico, con la vecchia immagine del mondo, che tuttavia non vede perso per sempre il ruolo della metafisica, la quale viene ridimensionata, sulla scia del Condillac, a scienza che cerca “di vedere le cose come sono”.
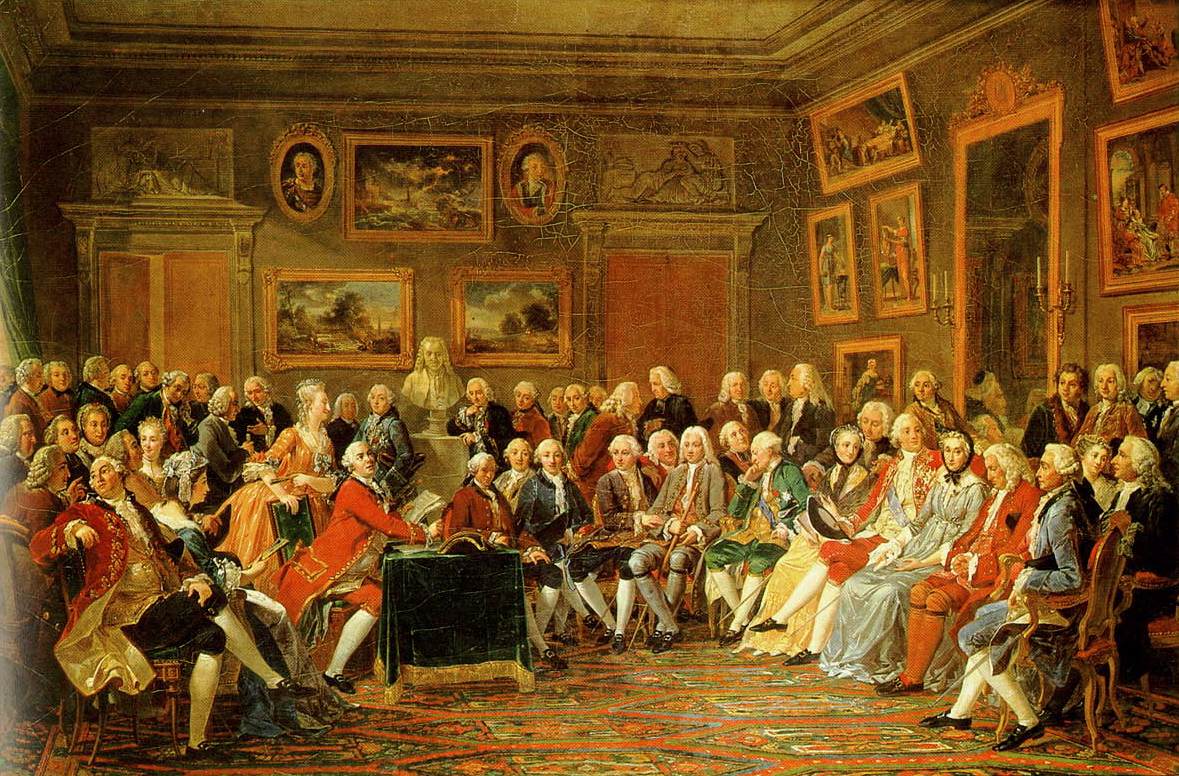
L’idea presunta di una asettica razionalità, superiore rispetto ad ogni altra facoltà conoscitiva, ha spesso avuto il suo primato nella considerazione sull’età dei Lumi. Tuttavia essa trova la sua smentita nello scritto di Ferrone, il quale sottolinea l’importanza dell’immaginazione tra le facoltà del nostro armamentario gnoseologico, così come fondamentale fu il ruolo del sogno per una figura di spicco del Settecento: l’enciclopedista D’Alembert.
Gli ultimi due scritti della prima parte, quelli di Mario Ricciardi e Giovanni Filoramo trattano del cruciale rapporto del pensiero illuministico con tematiche di natura etico politica e religiosa, dimostrando ancora una volta la variegata quantità di punti di riflessione sui quali si è focalizzata la sensibilità settecentesca.
Nella seconda parte del testo emergono questioni e problematiche differenti. Il capitolo di Giuseppe Cambiano permette subito di comprendere quanto gli autori del Secolo dei Lumi non siano stati pensatori isolati nel loro tempo storico, avendo risentito fortemente dei grandi classici, nei confronti dei quali si ponevano secondo un approccio talvolta critico, ma rispettoso, facendo così leva sull’impossibilità per i filosofi di far riferimento ai predecessori. Così dalle pagine di Gianni Paganini si può cogliere l’eredità del pensiero libertino e “clandestino”, che si caratterizzò come fonte essenziale di quel principio di autonomia e libertà che animava lo spirito dell’Illuminismo.
Quando si fa riferimento all’Illuminismo come corrente culturale permeante l’età moderna, non si può non considerare l’idea di cosmopolitismo che è stata alla base del pensiero filosofico. Questa idea è ampiamente descritta dal punto di vista storico da Massimo Mori, il quale mantiene viva la lezione degli antichi, confermando ancora una volta l’attenzione degli illuministi nei confronti della tradizione e soprattutto segnalando il valore essenzialmente polisemantico della parola “cosmopolitismo”, la quale nel Settecento aveva una molteplicità di interpretazioni e chiavi di lettura, tanto da poter essere considerata interscambiabile con quella di “filosofo” nell’Enciclopedia.
La filosofia dell’Illuminismo è eurocentrica? Una risposta pertinente e completa, che consente tra l’altro di trovare la via di uscita dai luoghi comuni e dalle errate categorie di pensiero, si trova nell’intervento di Pietro Rossi, nel quale si può notare la grande attenzione che ci fu da parte dei filosofi del XVIII secolo nei confronti dell’Oriente. I riferimenti alle pagine di Voltaire risultano eloquenti a riguardo: la sua opinione sull’Oriente, in particolar modo sulla Cina offre dei risultati più che positivi, fungendo tra l’altro da autocritica nei riguardi dell’Europa del tempo (civile, cristiana e moderna), la quale sembrava aver rinunciato ai principi del cristianesimo, con le sanguinose guerre di religione che avevano investito l’età moderna.
L’Illuminismo è un problema storiografico da relegare entro una stagione della storia conclusa? Oppure è una categoria di pensiero per potersi orientare, un “atteggiamento” adottabile per trovare un senso nella realtà?
Gli ultimi due scritti del testo tentano di rispondere a questa domanda, provando a ripensare l’Illuminismo nella contemporaneità, non soltanto per quanto riguarda i suoi aspetti storico filosofici, che possono essere collocati entro la cornice settecentesca, ma da altri punti di vista e problematiche che irrompono nella cultura contemporanea.
Nello scritto di Massimo Ferrari si rintraccia un’utile costruzione della storiografia sull’Illuminismo tra Ottocento e Novecento, dalla quale emerge quanto gli eventi storici dell’età contemporanea abbiano inciso sulle varie interpretazioni che nel tempo si sono avvicendate sulla filosofia dei Lumi.
L’ultimo intervento è a cura di Salvatore Veca il quale disegna la “silhouette” dell’Illuminismo nella cultura filosofica contemporanea. Egli non si sofferma soltanto sulla famigerata lettura negativa di Adorno e Horkheimer contenuta in Dialettica dell’Illuminismo, bensì sui tentativi di recupero dei valori trainanti dell’età dei Lumi rintracciati nelle riflessioni di Abbagnano, Putnam, Williams e Foucault. Emerge un’interessante interpretazione volta a valorizzare l’Illuminismo come “atteggiamento” nel nostro quotidiano confronto con il reale. Non si tratta di operare in favore di una fede cieca nel progresso, ma di essere mossi e di agire in virtù della credenza nella «possibilità del progresso» del genere umano verso il meglio. La ragione diviene quindi una bussola che permette di non perdersi nel mare del disorientamento postmoderno o addirittura nella negazione del pensiero come vera peculiarità dell’essere umano. Così per Veca resta valida quella che si definisce una vera e propria «educazione al pensiero», quindi all’Illuminismo stesso come ideale della ragione. A tal proposito è esplicito il riferimento a Jean Amery con il quale si chiude il capitolo: nella condizione di prigioniero ad Auschwitz aveva affermato che «chi rinnega l’Illuminismo, rinuncia all’educazione del genere umano».
Illuminismo. Storia di un’idea al plurale offre dunque al lettore l’opportunità di confrontarsi con varie interpretazioni e aspetti della filosofia e più in generale della cultura del secolo XVIII. Ogni capitolo può essere la solida base per molteplici spunti di riflessione e ulteriori ricerche, sia per lo studioso che per lo studente. Tutto ciò è permesso soprattutto dalla ricca bibliografia presente alla fine di ogni capitolo, la quale dimostra la perizia e l’attenzione che ogni studioso ha impiegato nella realizzazione del proprio intervento.
di Lucio Luceri
-
Manifesto Cyborg. Ieri e oggi
Recensioni / Dicembre 2018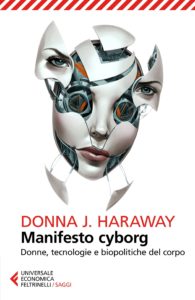 La nuova edizione di Manifesto cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo (Feltrinelli, 2018) raccoglie tre saggi di Donna Haraway, teorica femminista e storica della scienza allieva di Georges Canguilhem. I saggi in questione sono stati pubblicati la prima volta nel 1991, in Italia nel 1994, all’interno di una raccolta dal titolo Simians, Cyborgs and Women. The Reinvention of Nature (Routledge). L’importanza della riedizione di un testo considerato ormai un classico può ricercarsi nella necessità di rivalutare la portata teorica e filosofica della riflessione di Haraway, portata che fino ad ora sembra essere stata scarsamente considerata. Ciò che andrebbe messo in discussione è un inquadramento “specialistico” del testo, che lo vorrebbe di interesse unicamente per chi si occupa di “questioni legate al genere” e, ancora più nello specifico, per chi nella cornice degli studi di genere riflette sui problemi della scienza e della tecnologia. Nella rivalutazione delle implicazioni teoretiche di Manifesto Cyborg è in gioco, più in generale, la riconsiderazione dell’importanza filosofica dei cosiddetti studi di genere e postcoloniali, che normalmente trovano legittimazione solo se inseriti nella cornice dei cultural studies. Il testo di Haraway eccede queste cornici disciplinari, e con le sue incursioni “spregiudicate” nel terreno delle scienze biologiche, biomediche e delle teorie dei sistemi, può essere considerato un’argomentazione a favore della contaminazione come importante strumento di produzione e creatività teorica.
La nuova edizione di Manifesto cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo (Feltrinelli, 2018) raccoglie tre saggi di Donna Haraway, teorica femminista e storica della scienza allieva di Georges Canguilhem. I saggi in questione sono stati pubblicati la prima volta nel 1991, in Italia nel 1994, all’interno di una raccolta dal titolo Simians, Cyborgs and Women. The Reinvention of Nature (Routledge). L’importanza della riedizione di un testo considerato ormai un classico può ricercarsi nella necessità di rivalutare la portata teorica e filosofica della riflessione di Haraway, portata che fino ad ora sembra essere stata scarsamente considerata. Ciò che andrebbe messo in discussione è un inquadramento “specialistico” del testo, che lo vorrebbe di interesse unicamente per chi si occupa di “questioni legate al genere” e, ancora più nello specifico, per chi nella cornice degli studi di genere riflette sui problemi della scienza e della tecnologia. Nella rivalutazione delle implicazioni teoretiche di Manifesto Cyborg è in gioco, più in generale, la riconsiderazione dell’importanza filosofica dei cosiddetti studi di genere e postcoloniali, che normalmente trovano legittimazione solo se inseriti nella cornice dei cultural studies. Il testo di Haraway eccede queste cornici disciplinari, e con le sue incursioni “spregiudicate” nel terreno delle scienze biologiche, biomediche e delle teorie dei sistemi, può essere considerato un’argomentazione a favore della contaminazione come importante strumento di produzione e creatività teorica.Fin dalle prime pagine di Manifesto Cyborg è chiara l’urgenza teorica e politica che muove la riflessione dell’autrice: la necessità per il femminismo socialista e in generale per gli allora nuovi movimenti di sinistra di ripensarsi, alla luce del confronto con le profonde trasformazioni globali che segnavano il contesto dell’elezione di Reagan alla presidenza degli Stati Uniti negli anni ’80. Il cyborg, protagonista dell’opera, rappresentava provocatoriamente quella peculiare “creatura” contraddistinta da un’intrinseca necessità di evadere ogni forma di pensiero dicotomico, ogni forma di razionalità strutturata intorno a stringenti dualismi, in favore di un nuovo punto di vista in grado di rendere conto di una realtà infinitamente complessa ed eccedente che il suo stesso apparire metteva prepotentemente alla ribalta. A quasi trent’anni di distanza, in cui la modalità dominante di gestione della complessità (sociale, psichica, politica, scientifica) sembra ancora rimanere il riduzionismo, in cui lo scenario pare ancora caratterizzato dal riproporsi di un pensiero dicotomico e dall’intensificarsi delle logiche di dominazione patriarcale, razzista e capitalista connaturate a esso, provare a immaginare un modello di razionalità che non evade la complessità ma che se ne fa carico non si rivela meno urgente. La posta in gioco è l’elaborazione di modalità alternative e sfaccettate di gestione della complessità, rifiutando quindi anche quel pensiero che vedrebbe nella postmodernità il terreno in cui si consuma la crisi della razionalità dominante che non lascia spazio a null’altro se non alla contingenza e alla “differenza” irriducibile, intese come negazione dell’elaborazione teorica e della prassi. Manifesto Cyborg riapre invece con forza l’elaborazione teorica, etica e politica, al cuore della postmodernità e lo fa oggi non meno di ieri.
Lo sguardo attraverso cui Haraway analizza le trasformazioni che segnano il suo tempo è quello che deriva dalla sua storia in quanto biologa: in particolare, l’autrice mette in luce la profonda rielaborazione e ripensamento della biologia in relazione all’emergere di nuovi saperi, quali la cibernetica, le teorie dei sistemi, le scienze della comunicazione e dell’informazione.
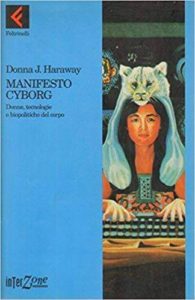 Il ripensamento della biologia in seguito alla contaminazione con nozioni, teorie e concetti provenienti da queste scienze è stato profondo al punto che, secondo Haraway, si può sostenere che l’“organismo” biologico, come oggetto della scienza, abbia cessato di esistere, e sia stato sostituito da sistemi di comunicazione completamente denaturalizzati. Gli organismi sono quindi diventati artefatti, sempre contingenti, le cui modalità di costruzione non sono vincolate da nessun’architettura naturale. Contemporaneamente, le macchine hanno preso vita: se quelle pre-cibernetiche potevano essere ancora distinte dagli organismi in quanto pensate e costruite dall’uomo, le macchine cibernetiche rendono completamente ambigua la distinzione tra autosviluppo e progettazione esterna (p.43).
Il ripensamento della biologia in seguito alla contaminazione con nozioni, teorie e concetti provenienti da queste scienze è stato profondo al punto che, secondo Haraway, si può sostenere che l’“organismo” biologico, come oggetto della scienza, abbia cessato di esistere, e sia stato sostituito da sistemi di comunicazione completamente denaturalizzati. Gli organismi sono quindi diventati artefatti, sempre contingenti, le cui modalità di costruzione non sono vincolate da nessun’architettura naturale. Contemporaneamente, le macchine hanno preso vita: se quelle pre-cibernetiche potevano essere ancora distinte dagli organismi in quanto pensate e costruite dall’uomo, le macchine cibernetiche rendono completamente ambigua la distinzione tra autosviluppo e progettazione esterna (p.43).Le ondate di denaturalizzazione e de-essenzializzazione che secondo N. Katherine Hayles definiscono il postmodernismo hanno quindi investito anche i corpi biologici: se le prime teorizzazioni degli organismi come sistemi cibernetici riposavano ancora su una concezione olistica e mantenevano intorno a questi un certo involucro, le teorie sociobiologiche di uno scienziato dalla sensibilità postmoderna come Richard Dawkins hanno radicalizzato questa tendenza, rompendo definitivamente con i paradigmi olistici e ripensando l’individualità biologica come costrutto contingente ad ogni livello. Come mettono in luce le escursioni di Haraway nel territorio delle moderne biologie della comunicazione, i processi di decostruzione e ricostruzione dei corpi occupano il centro del discorso, non solamente dal punto di vista del critico culturale o dell’archeologo delle scienze umane, ma anche dello scienziato postmoderno: le biologie moderne si occupano di tecnologie d’inscrizione e codici, di processi di disassemblaggio e riassemblaggio, di sistemi di controllo altamente tecnologizzati. La centralità delle tecnologie di scrittura emerge in modo evidente se si considerano i lauti investimenti direzionati a progetti come quello di mappatura e ricostruzione del genoma umano. Questo progetto emblematizza un “umanesimo postmoderno” in cui la ricerca biologica segnata dalla rilevanza sempre maggiore delle tecnologie d’inscrizione è messa al servizio della tradizionale ideologia umanista e del sogno ad essa associato di poter finalmente definire l’umano, di poter finalmente tracciare un confine netto e chiaro, privo di ambiguità e porosità tra il sé e il non-sé.
Il cyborg, segnalando importanti cedimenti di confine come quello tra macchina e organismo e tra umano e animale, si presenta come figurazione non dicotomica della nostra realtà sociale e corporea, che consente quindi di rompere con i dualismi che hanno strutturato la razionalità occidentale: naturale/artificiale, natura/cultura, uomo/donna, mente/corpo, materia/forma, umano/animale, soggetto/oggetto. Come ci ricorda Haraway, queste non sono mai solo opposizioni dicotomiche: attraverso questi dualismi, la razionalità occidentale ha intrecciato il suo destino a pratiche di dominio e di oppressione legate al genere, alla razza e alla specie.
D’altra parte, il cyborg in occidente è anche espressione di una cultura maschilista e guerrafondaia, che concepisce la vulnerabilità che contraddistingue la dimensione corporea come segno di una “mancanza” costitutiva, a cui far fronte attraverso un progressivo miglioramento delle strategie di difesa. Se le individualità cyborg sono per definizione contingenti e instabili, l’immagine della corsa agli armamenti e della guerra perenne lascia trasparire in filigrana il “telos apocalittico” (p. 41) di un sé finalmente libero da ogni forma di dipendenza. La realizzazione di un sé autonomo e integro, che ha “disassemblato” e digerito ogni forma di eterogeneità e alterità si accompagna al dispiegamento di un apparato di controllo diffuso e capillare, che Haraway indica come “informatica del dominio” (p. 55). Con questa figurazione si vogliono mappare i nuovi inquietanti meccanismi di controllo che attraversano il nostro tempo: alle gerarchie che contraddistinguono il “patriarcato capitalista bianco” (p. 57) si sostituisce un sistema polimorfo e reticolare, che agisce attraverso l’allacciamento di connessioni multiple. Ai vecchi sistemi di controllo centralizzato si sostituisce la delocalizzazione, la decentralizzazione, la diffusione e la moltiplicazione dei centri.

Ma il cyborg è anche un costrutto femminista, e in questo senso elicita possibilità oppositive e liberatorie. Cyborg è quel particolare oggetto di conoscenza e pratica femminista, l’esperienza delle donne, che proprio in quanto fatta oggetto di sapere, è ricostruita come aperta, non finita, contestata, vulnerabile, presa in un gioco di perenne decostruzione e riscrittura. Haraway a questo proposito da particolare importanza ai processi di decostruzione e di de-naturalizzazione che hanno interessato il femminismo in seguito al prendere voce di quelle soggettività, come le donne nere, che sfuggono al sistema di categorie attraverso cui i teorici e le teoriche occidentali hanno tentato di rappresentare il mondo degli oppressi. Questi processi hanno consentito al soggetto femminista di riarticolarsi lungo assi inediti, di immaginare e di praticare nuove forme di unità e di identità al di fuori dell’impianto dicotomico e oppositivo che ha strutturato i miti politici occidentali. La critica post-coloniale ha ricostruito le identità femministe come identità sempre parziali, contraddittorie e problematiche, definite dal non poter essere naturalizzate o essenzializzate. Haraway legge in questo senso la Sister outsider della poetessa nera Audre Lorde (p. 74), ovvero come ricostruzione letteraria dell’identità attraverso l’esclusione, la non appartenenza in quanto eccedenza rispetto a categorie prestabilite. Le identità ricostruite nelle pratiche di scrittura delle donne di colore sono identità sempre contraddittorie e frantumate, prive del privilegio dell’identità a sé, prerogativa dei corpi non marcati come quelli maschili e bianchi. Se i processi decostruttivi e de-essenzializzanti impediscono di radicare la politica nelle identità “naturali”, questo non significa che sia stata minata radicalmente la possibilità di legami: la loro ricostruzione implica politiche dell’affinità, che non ripristinano unità naturali, ma non per questo impediscono legami (parziali ma potenti) e comunità per soggetti postmoderni.
Con l’elaborazione della nozione di “saperi situati” Haraway si inserisce in un altro dibattito che attraversa il femminismo: il rapporto con l’epistemologia e la scienza e, strettamente connesso a questo, il dibattito circa lo statuto dell’oggetto di conoscenza. Proponendo “saperi situati” Haraway intende pensare una versione femminista di oggettività scientifica, che consenta di uscire dalla polarizzazione del dibattito attuale, caratterizzato dal contrapporsi di posizioni radicalmente costruzioniste ed empiriste. La rielaborazione della nozione di oggettività che Haraway propone si appoggia a un ripensamento della metafora della visione. Se quest’ultima ha significato, nella storia della razionalità occidentale, la capacità di alcuni corpi (quelli maschili, benestanti e occidentali) di “smaterializzarsi” in uno sguardo venuto dal nulla mentre si inscrivevano i corpi marcati nel mito, con la nozione di saperi situati assume un significato opposto. L’oggettività e la visione non significano più neutralità e distanza, ma corporeità, parzialità, localizzabilità, impegno e coinvolgimento. (p. 115) L’oggettività ha a che fare non con la scoperta distaccata, ma con la strutturazione reciproca e di solito ineguale; solo saperi parziali, vulnerabili e impegnati garantiscono una conoscenza oggettiva, ovvero che non sia un’illusione. Oggettività e visione non segnalano più un “trucco da dio”, che consente di scomparire arrogandosi il potere di rappresentare senza essere rappresentati, ma diventano modi per stare nel corpo, pratiche di assunzione corporea.

In How we became posthuman, Katherine Hayles sostiene che l’affermarsi di quell’entità chiamata informazione si sia accompagnata a processi di “smaterializzazione” dei corpi, di progressivo abbandono e trascendimento dei vincoli della materialità. L’approccio di Haraway ai mondi alto-tecnologici mostra una realtà più complessa: i corpi radicalmente decostruiti e ricostruiti dalle moderne biotecnologie e dalle scienze informatiche non comportano tanto la smaterializzazione di questi in puri flussi informativi, problemi di codifica e di ricerca di un linguaggio comune che permetta la perfetta comunicazione. Anche l’informazione per Haraway ha una specifica dimensione materiale, così come i testi e i codici, che dovrebbero venire ripensati attraverso la nozione di embodiment. Facendo riferimento alla dimensione corporea, Haraway non si riferisce quindi a una dimensione prettamente biologica: le tecnologie di visualizzazione sono ripensate come sistemi di percezione attivi, nelle quali siamo immersi e con le quali siamo inestricabilmente intrecciati nella costruzione di specifiche forme di vita: un aspetto del nostro embodiment.
Il ripensamento della nozione di corporeità consente ad Haraway di riprendere e al tempo stesso di andare oltre l’analisi biopolitica inaugurata da Michael Foucault, ovvero dell’analisi che fa del corpo l’entità bioculturale per eccellenza e che consente di indagare i rapporti di potere che si concentrano direttamente sul soggetto in quanto entità corporea. La decostruzione della corporeità come sistema di comunicazione tecnologico consente di indagare gli effetti del biopotere oltre la sfera organismica: oggetto delle relazioni di potere non è più un corpo organico e organizzato gerarchicamente, ma sistemi cibernetici completamente decostruiti, assemblaggi ricomposti in modo sempre parziale, costrutti contingenti. Le biopolitiche che interessano corpi ricostruiti come sistemi di comunicazione non sono quelle del sesso e della riproduzione, ma dell’immunità, legate ai processi di replicazione di un sé estremamente vulnerabile e contingente (p.159). Quali tipi di sé vengono costruiti dal discorso sul sistema immunitario? L’intento di Haraway è di risignificare il paradigma immunitario: da dispiegamento di una guerra diffusa e capillare, in cui la replicazione del sé è funzione delle sue strategie di difesa e di attacco di fronte a una minaccia costante di “invasione”, a sistema che “apre” il sé e lo mantiene aperto. In quanto dispiegamento di una rete capillare di blackout e crolli delle comunicazioni, di confusione di confini, il sistema immunitario continuamente “disfa” il sé, mantenendolo contraddittorio ed eterogeneo, impedendone la chiusura e l’autonomizzazione. In questa dimensione riposa la “promessa illegittima” (p. 42) del cyborg: la sua natura artefatta, saltando il gradino dell’unità originaria, impedisce la realizzazione del suo telos apocalittico. In quest’ottica, inoltre, la differenza irriducibile con cui obbligano a fare i conti la postmodernità e i processi a essa inestricabilmente connessi, come quelli di decolonizzazione, non segnala tanto la “morte del soggetto”, come vorrebbero alcuni, ma piuttosto ci costringe a ripensare il soggetto come non isomorfico, auto-contraddittorio e multidimensionale.
di Ambra Lulli
-
PK#9 \ Soggettivazioni. Segni, scarti, sintomi
Rivista / Settembre 2018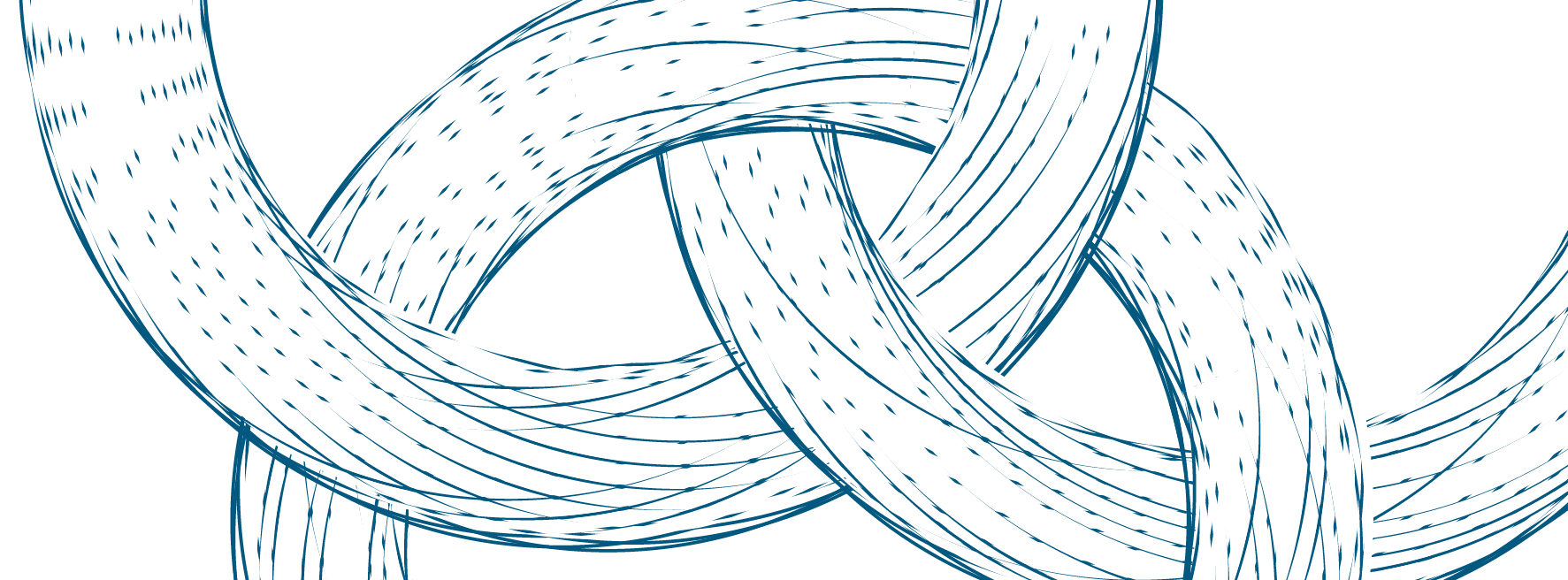
L’intento di questa raccolta, che prende il titolo di “Soggettivazioni”, è stato quello di aprire una riflessione attorno alla teoria della soggettivazione lacaniana, così per come ce l’ha lasciata in eredità Lacan, a singhiozzi, nei testi stabiliti a partire dai suoi trent’anni di insegnamento orale. Cosa può dirci una psicoanalisi asistematica, distante dalle istituzioni universitarie rispetto a problemi di una concretezza innervata di realtà? Chi frequenta i dipartimenti di Psicologia e assieme l’insegnamento lacaniano sa che è incommensurabile la distanza che intercorre tra la specificità e la settorializzazione degli strumenti istituzionali a confronto con l’universalità dei concetti larghi e volontariamente mai definiti dello psicoanalista parigino. Tra l’estremamente particolare (l’ad hoc della psicologia contemporanea) e l’estremamente universale (il concetto, unità sintetica della filosofia) si rischia di incorrere in un deragliamento del punto focale, causato da uno scontro di metodi epistemologici che si sono stabilizzati ai bordi opposti l’uno rispetto all’altro. Nella scelta di prendere in considerazione un tema vasto e generale come la teoria della soggettivazione c’era l’interesse, da parte nostra, di porlo in dialogo con il campo altrettanto vasto e generale del presente. Speriamo che questa prima ricerca possa costituirsi come un’indagine (sebbene parziale) sullo statuto del soggetto in quanto campo epistemologico aperto: attingendo dalla teoria psicoanalitica e dal dibattito che ne è scaturito, il presente volume segue molteplici sentieri analitici e sottolinea di contributo in contributo la difficoltà di giungere a un’idea organica di soggetto, per la varietà di ipotesi spesso contrastanti in merito alla sua rappresentazione, formalizzazione e interpretazione. In questa raccolta crediamo che i punti maggiormente messi in rilievo da chi ha collaborato riguardino il problema della genesi, lo statuto della trasformazione, e infine un’attenzione specifica è stata rivolta al registro del Reale e ai suoi effetti.
A cura di Lorenzo Curti e Irene Ferialdi
Scarica PDF
English version
DOI: https://doi.org/10.13135/2385-1945/9.2018
Pubblicato: settembre 2018
Indice
Editoriale
L. Curti, I. Ferialdi, Soggettivazioni: tra vuoti e contiguità [PDF It]
I. Genesi
P. G. Curti, Estrarre il soggetto [PDF It]
C. Mola, Intrecci concettuali. Il soggetto tra Hegel, Kojève e Lacan [PDF It]
A. Lattuada, L’atto reale e la genesi del soggetto nella psicoanalisi di Jacques Lacan [PDF It]
D. Tolfo, Per un'analisi non significante della soggettività: la funzione del punto-segno ne l'Anti-Edipo [PDF It]
II. Trasformazioni
L. Melandri, La parola contaminata dei movimenti non autoritari degli anni Settanta [PDF It]
R. Chiafari, Drammaturgia e metamorfosi del genio maligno: soggetti e spettri tra follie e ragione [PDF It]
M. Di Bartolo, La psicoanalisi come estetica dell'esistenza [PDF It]
A. Soares De Moura Costa Matos, Streaming Subjectivation: Two Questions and One Thesis about Netflix [PDF En]
III. Reale
F. Cimatti, La lingua c'è. Saussure, Chomsky e Lacan [PDF It]
A. Pagliardini, Verso il reale: schizofrenia/psicoanalisi [PDF It]
F. Vergine, Le origini trascendentali del mondo. Per un'ontologia topologica del reale [PDF It]
Traduzioni
A. Zupančič, Differenza sessuale e ontologia [PDF It]
F. Rambeau, La fosforescenza delle cose [PDF It]
Interviste e recensioni
Intervista a Franco Lolli [PDF It]
F. Zambonini, Una quasi-recensione a "Lacan, oggi. Sette conversazioni per capire Lacan" di Sergio Benvenuto e Antonio Lucci. Considerazioni marginali sul rapporto filosofia-psicanalisi [PDF It]
-
Bataille e la notte del non-sapere
Recensioni, Sconfinamenti / Luglio 2018 Sono molte e significative le vicende, personali e culturali, attraversate da Georges Bataille nel corso degli anni Trenta. La più singolare è forse quella legata a una rivista da lui fondata, «Acéphale», e alla società segreta che recava lo stesso nome. L’intento del duplice progetto era, in un certo senso, di tipo religioso, ma di una religiosità che prendeva atto fin da subito della morte di Dio annunciata da Nietzsche. La setta, che riuniva attorno a Bataille un ristretto numero di adepti, svolgeva un’attività di riflessione sulle opere del filosofo tedesco, ma praticava anche dei rituali di tipo cerimoniale. L’esperienza è stata importante per lo scrittore, anche se è durata solo pochi anni e se alla fine egli è sembrato giudicarla, per molti aspetti, mancata. Ha ricordato infatti, in una nota autobiografica, quanto segue: «Avevo passato gli anni precedenti [al 1940] con una preoccupazione insostenibile: ero deciso, se non a fondare una religione, almeno a dirigermi in tal senso. […] Per quanto una simile ubbia possa sembrare stupefacente, io la presi sul serio. È l’epoca in cui feci apparire con degli amici la rivista “Acéphale”. […] Voglio solo precisare che l’inizio della guerra rese decisamente avvertibile l’insignificanza di questo tentativo»
Sono molte e significative le vicende, personali e culturali, attraversate da Georges Bataille nel corso degli anni Trenta. La più singolare è forse quella legata a una rivista da lui fondata, «Acéphale», e alla società segreta che recava lo stesso nome. L’intento del duplice progetto era, in un certo senso, di tipo religioso, ma di una religiosità che prendeva atto fin da subito della morte di Dio annunciata da Nietzsche. La setta, che riuniva attorno a Bataille un ristretto numero di adepti, svolgeva un’attività di riflessione sulle opere del filosofo tedesco, ma praticava anche dei rituali di tipo cerimoniale. L’esperienza è stata importante per lo scrittore, anche se è durata solo pochi anni e se alla fine egli è sembrato giudicarla, per molti aspetti, mancata. Ha ricordato infatti, in una nota autobiografica, quanto segue: «Avevo passato gli anni precedenti [al 1940] con una preoccupazione insostenibile: ero deciso, se non a fondare una religione, almeno a dirigermi in tal senso. […] Per quanto una simile ubbia possa sembrare stupefacente, io la presi sul serio. È l’epoca in cui feci apparire con degli amici la rivista “Acéphale”. […] Voglio solo precisare che l’inizio della guerra rese decisamente avvertibile l’insignificanza di questo tentativo»Scarica il PDF
A cura di
Giuseppe Zuccarino è critico e traduttore. Ha pubblicato vari saggi: La scrittura impossibile, Genova, Graphos, 1995; L’immagine e l’enigma, ivi, 1998; Critica e commento. Benjamin, Foucault, Derrida, ivi, 2000; Percorsi anomali, Udine, Campanotto, 2002; Il desiderio, la follia, la morte, ivi, 2005; Il dialogo e il silenzio, ivi, 2008; Da un’arte all’altra, Novi Ligure, Joker, 2009; Note al palinsesto, ivi, 2012; Il farsi della scrittura, Milano-Udine, Mimesis, 2012; Prospezioni. Foucault e Derrida, ivi, 2016. Tra i libri da lui tradotti figurano opere di Mallarmé, Bataille, Klossowski, Blanchot, Caillois e Barthes. Ha inoltre curato un fascicolo monografico della rivista «Riga» (n. 37, 2017) dedicato a Maurice Blanchot.
-
La ragione del testo Che cosa si fa quando si fa filosofia?, scritto da Rossella Fabbrichesi ed edito da
 Raffaello Cortina (2017), è delineata esplicitamente nella Premessa e si articola significativamente all’interno dell’ambiente da cui prende avvio. Fabbrichesi, all’interno dell’aula universitaria milanese dove svolge la sua professione di insegnante, decide di affrontare i suoi studenti con una domanda spiazzante, nella sua apparente semplicità: “Che cos’è la filosofia?”. A partire da questa domanda, il tema della filosofia – intesa come campo di sapere determinato e, allo stesso tempo, come insieme delle procedure che la pongono in atto – viene dipanato nel corso di quindici capitoli e integrato da alcune riflessioni finali emerse a lezione e successivamente strutturate tramite un lavoro collettivo dell’autrice e dei suoi studenti. Il lavoro di conduzione seminariale, punto di partenza per la nascita del testo, è consistito in un processo di “e-ducazione” in cui l’autrice, limitandosi – a suo dire – a «orientare discorsi che venivano partoriti e circolavano tra gli astanti, alimentandosi negli scambi comuni», ha condotto con sé delle anime «insegnando loro a battere il ritmo del canto corale» (p. xiv) e, richiamandosi al modo originario di fare filosofia, l’ha posto in atto all’interno di quella comunità di studenti che, in poco, sarebbe diventata una comunità di “amici della filosofia”, una comunità di ricerca fondata su una condivisione di interessi e su una radicata volontà di attualizzarli.
Raffaello Cortina (2017), è delineata esplicitamente nella Premessa e si articola significativamente all’interno dell’ambiente da cui prende avvio. Fabbrichesi, all’interno dell’aula universitaria milanese dove svolge la sua professione di insegnante, decide di affrontare i suoi studenti con una domanda spiazzante, nella sua apparente semplicità: “Che cos’è la filosofia?”. A partire da questa domanda, il tema della filosofia – intesa come campo di sapere determinato e, allo stesso tempo, come insieme delle procedure che la pongono in atto – viene dipanato nel corso di quindici capitoli e integrato da alcune riflessioni finali emerse a lezione e successivamente strutturate tramite un lavoro collettivo dell’autrice e dei suoi studenti. Il lavoro di conduzione seminariale, punto di partenza per la nascita del testo, è consistito in un processo di “e-ducazione” in cui l’autrice, limitandosi – a suo dire – a «orientare discorsi che venivano partoriti e circolavano tra gli astanti, alimentandosi negli scambi comuni», ha condotto con sé delle anime «insegnando loro a battere il ritmo del canto corale» (p. xiv) e, richiamandosi al modo originario di fare filosofia, l’ha posto in atto all’interno di quella comunità di studenti che, in poco, sarebbe diventata una comunità di “amici della filosofia”, una comunità di ricerca fondata su una condivisione di interessi e su una radicata volontà di attualizzarli.Attualizzare i contenuti di un sapere che da lungo tempo viene messo in discussione, tanto nei suoi luoghi di tradizionale appartenenza – le accademie – tanto nella quotidianità – luogo di prassi da cui origina la filosofia – interrogandoli nelle sue parti elementari (“Che cos’è la filosofia?”, “Che cosa si fa quando si fa filosofia?”) piuttosto che ribadirli e al fine di strutturarli in un sistema nuovo, sempre ri-organizzato secondo le esigenze della contemporaneità, assume un profondo significato politico; si sceglie di riappropriarsi degli strumenti originari della filosofia, per riabitarne i luoghi, per richiamarne il ruolo di critica e di conseguente produzione creativa e alternativa del reale.
I presupposti del testo, che già dalle prime righe si mostrano articolati secondo due linee principali, una teorica e l’altra pratica, si intersecano per tutta la sua durata e, intrecciandosi intorno alle domande fondanti della filosofia – “Che cos’è?” (il “ti esti?” di socratica origine) e “che cosa si fa?” (il methodos dell’indagine) – generano un continuo rimando di livello tra il conoscitivo e il pratico. I rimbalzi di significato giungono a compiersi, senza mai concludersi per loro stessa natura, nell’Appendice – nominata significativamente L’esercizio della prassi teorica – in cui gli studenti si interrogano personalmente su che cosa fanno quando fanno filosofia, quasi a suggerire al lettore un bilancio del percorso che ha individualmente compiuto lasciandosi suggestionare e coinvolgere dalle riflessioni dei capitoli precedenti. In questo senso, se “Che cos’è la filosofia?” «Non è affatto una domanda rivolta a dei principianti» (p. xii), poiché non segna un’arché, ma anzi, presuppone un arsenale concettuale consolidato a seguito di anni di speculazione, il chiedere “Che cosa si fa quando si fa filosofia?” apre lo scenario a chiunque abbia mai sperimentato una “forza erotica”, nel senso platonico del termine, nei confronti di tutto «ciò che è insolito, stupefacente, difficile e divino» (p.74), a chiunque creda che non esista la filosofia, ma la pratica filosofica e a chiunque veda il proprio godimento alla base della ricerca filosofica potenziato dalla «crescita della ragionevolezza in un’ottica comunitaria» (p.76). In questo senso, coloro che, staccandosi dall’idea della filosofia come formazione originariamente paideutica, intendono l’attività professionale dell’insegnamento come unica e adeguata declinazione dalla formazione filosofica, difficilmente proveranno meraviglia o stupore (per richiamare – come fa l’autrice – le emozioni primarie che tradizionalmente designano i moventi originari dell’interrogazione filosofica del mondo) di fronte alla rassegna di concezioni o di visioni del mondo di filosofi noti che hanno provato, con parole diverse ma con univoca passione, ad attribuire significato alla prassi filosofica.

Considerando però che attribuire significato a una prassi significa anche, tramite interrogazione critica, fondarla trascendentalmente e dotarla di senso, la forza di questo testo consiste nella volontà di indagare il nesso che caratterizza la filosofia come insieme delle dottrine da apprendere e la filosofia come insieme delle prassi che, agite, alterano e modificano il mondo in cui ci orizzontiamo, più che nella padronanza con cui vengono richiamate e fatte dialogare le autorità filosofiche del nostro passato tramite i loro impianti speculativi. Sondare questo nesso corrisponde ad abitare il “limite” di cui parla Foucault e solo la consapevolezza della sua ineliminabile duplicità (Cfr. Amare la duplicità, pp. 57-62) ci farà progredire nella pratica filosofica; indagare un oggetto dirà tanto più sul metodo d’indagine che sulla natura dell’oggetto in sé e, d’altro canto, indagare sé non è altro che mettere in luce la verità in cui abitiamo, con un ricorso inevitabile a ciò che noi crediamo essere la verità. L’esercizio di ginnastica mentale che compiamo quindi su di noi facendo filosofia coincide – a ben vedere – con l’atto di approfondimento verso il reale per come ci si dà e nel suo non poter essere altrimenti, generando un flusso tanto più ininterrotto e dinamico tra etica e conoscenza quanto più diveniamo coscienti che «è la vita che produce la verità, e non la verità che si rivela aspirazione della vita» (p. 38).
di Evelina Praino
-
Extra#2 \ TURNS. Dialoghi tra architettura e filosofia
Extra / Febbraio 2018TURNS. Dialoghi tra architettura e filosofia è la traccia di un dialogo spesso acceso, ricco di incomprensioni e riconciliazioni, che coinvolge architetti e filosofi, docenti e professionisti, e ancora biologi, dottori di ricerca, studenti. È il racconto di due discipline, architettura e filosofia, che si voltano per guardarsi reciprocamente, provando a innescare una svolta concettuale che deve divenire un nuovo punto di partenza. Precisamente questo è il doppio significato del termine “Turns”.
Da un lato infatti, il filosofo ha sempre avuto difficoltà a interloquire con l’architetto, sia per ragioni storiche sia per ragioni strettamente legate al suo metodo e ai suoi obiettivi. L’architetto sembra infatti presentarsi allo sguardo del filosofo come un personaggio al contempo perturbante e conturbante, in un misto di attrazione e biasimo, di invidia e ammirazione: una figura tanto sfuggente da investire la riflessione filosofica con effetto retroattivo, facendo scricchiolare le sue fondamenta concettuali e mettendo in dubbio nozioni fondamentali quali verità, libertà, realtà, conoscenza, invenzione, possibilità, necessità, che hanno rappresentato per secoli il lessico base del pensiero occidentale. L’interesse verso una simile figura sembrerebbe ovvio. Eppure, quasi sempre è il filosofo che viene interpellato, utilizzato o coinvolto nel lavoro dell’architetto, in molti casi con l’intento di distillare spazialmente il senso dei suoi discorsi nel progetto. Non che ciò sia impossibile, ma, forse, dovremmo domandarci se è proprio questo quello che vogliamo: o se invece non sia compito del filosofo esercitare una sistematica e implacabile strategia di provocazione interessata, al fine di produrre un effetto, una particolare condizione dello sguardo. Creare la crisi, mettendo in discussione ciò che è dato, sapendo che, come spesso accade, l’apertura verso un nuovo oggetto di conoscenza lascia insoluti quei quesiti che lo vedono direttamente implicato per produrre un effetto retroattivo di chiarificazione nel soggetto indagatore, impegnato a leggersi ora attraverso una nuova forma di mediazione.
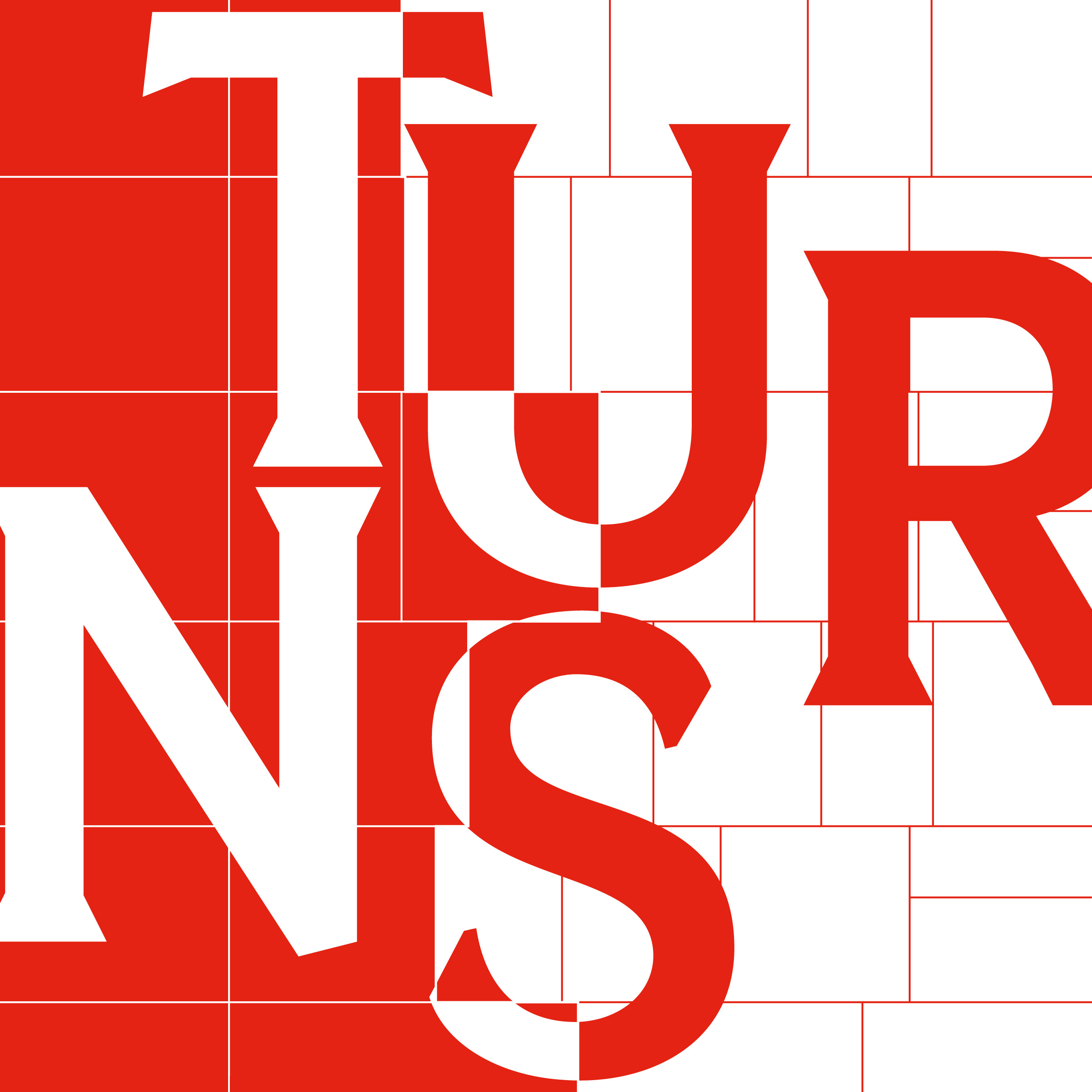
Dall’altro lato, per l’architettura il rapporto con la filosofia è storicamente naturale, quasi che questa fosse una visione complementare sul mondo rispetto al suo operato: questo era possibile perché la società si evolveva in modo relativamente lento, attraverso sedimentazioni di usi che diventavano convenzioni sociali, di pensiero, di stile. Così andava nell’architettura egizia, in quella classica, nel medioevo, nel rinascimento, finanche nel Modernismo: i significati erano decifrabili perché si condivideva un sostrato convenzionale. Ma qualcosa è cambiato. Le correnti durano pochi anni: poi passano, come le mode, spesso senza lasciar traccia – tranne edifici già superati, ovviamente. Così, spariscono le teorie dell’architettura, cioè sistemi che dicano cosa sia giusto costruire. E senza una teoria che legittimi le scelte, fioriscono le retoriche e le poetiche personali, spesso così ridicole da essere persino (e giustamente) oggetto di satira. La condizione di fragilità dell’architettura contemporanea è ormai fisiologica. Ed è qui che la filosofia diventa non solo utile, ma necessaria. A patto, certo, di non usarla in senso analogico, con derivazioni dirette che trasformano concetti in forme e pensieri in stili. Dialogare con i filosofi serve perché essi ragionano su temi che, in qualche modo, toccano gli architetti – ad esempio, lo spazio, l’invenzione, la città, la generazione della forma, il potere. Capire qualcosa di quei temi aiuterà a progettare con una maggior consapevolezza, o una più approfondita convinzione sulle ragioni del progetto, e a capirne meglio effetti ed esiti.
A cura di Carlo Deregibus e Alberto Giustiniano
Scarica PDF
English version
DOI: https://doi.org/10.13135/2385-1945/1.2018
Pubblicato: gennaio 2018
Indice
Alberto Giustiniano - ARCHITECTURAL TURN. Il filosofo e le sfide del progetto [PDF It]
Carlo Deregibus - PHILOSOPHICAL TURN. Fragilità dell’architettura contemporanea [PDF It]
(S)Block-Seminar
.
DA LASCAUX AI JUNKSPACE
Giovanni Leghissa - Da Lascaux ai junkspaces (passando per Ippodamo da Mileto) [PDF It]
Giovanni Durbiano – Descrivere il progetto dello spazio [PDF It]
Riccardo Palma – Molteplicità e non naturalità degli spazi nella produzione del progetto di architettura [PDF It]
RIFERIMENTI di Andrea Dutto [PDF It]
.
DECOSTRUZIONE, IMMANENZA, ILOMORFISMO
Giulio Piatti – Simondon e Deleuze di fronte all’ilomorfismo. Appunti sul rapporto forma-materia [PDF It]
Carlo Deregibus – Appunti su Chōra, spazio e architettura. Da Platone a Derrida [PDF It]
Paola Gregory – Le nuove scienze e la conquista dell’informale [PDF It]
Riccardo Palma – L’assenza necessaria dell’architettura [PDF It]
RIFERIMENTI di Andrea Canclini [PDF It]
.
FENOMENOLOGIA E PROGETTO
Claudio Tarditi – Fenomenologia e architettura. Introduzione al problema della percezione spaziale in Edmund Husserl [PDF It]
Alberto Giustiniano – Tempo, forma, azione. Il senso del progetto nel dialogo tra Enzo Paci e Ernesto Nathan Rogers [PDF It]
Silvia Malcovati – Per un razionalismo relazionale [PDF It]
Carlo Deregibus – L’orizzonte del progetto e la responsabilità dell’architetto [PDF It]
RIFERIMENTI di Federico Tosca [PDF It]
.
MORFOGENESI E AUTOORGANIZZAZIONE
Veronica Cavedagna & Danilo Zagaria - Quale spazio per la morfogenesi e l'auto-organizzazione? [PDF It]
Paola Gregory – Morfogenesi architettonica e “vita artificiale” [PDF It]
Carlo Deregibus – Progetto e complessità. Fascino dell’analogia e libero arbitrio [PDF It]
RIFERIMENTI di Edoardo Fregonese [PDF It]
.
ANTROPOGENESI E COSTRUZIONE DELLO SPAZIO
Roberto Mastroianni – Regimi dello sguardo. Sloterdijk e la metafora spaziale [PDF It]
Alessandro Armando – La scrittura del futuro e la promessa del progetto [PDF It]
Daniele Campobenedetto – Leggibilità e materialità dello spazio [PDF It]
RIFERIMENTI di Federico Cesareo [PDF It]
.
POTERE E SPAZIO
Luigi Giroldo – Genealogie dello spazio contemporaneo. Utopie moderne e nascita dell’urbanistica [PDF It]
RIFERIMENTI di Andrea Canclini [PDF It]
BIBLIOGRAFIA
.
-
Start-Up: liberi di sbagliare
Serial, Start up / Febbraio 2018Viviamo, suggeriscono voci diverse, in un’epoca di grande trasformazione. Nulla sarà più come prima e ciò che si trasforma non è “solo” il modo di produrre, ma i modi di vita individuali e collettivi. Questo dato, la trasformazione epocale in corso, accomuna le letture più diverse, scientifiche e non, e si presenta in questa veste come un fatto sociale interessante su cui riflettere. In altre parole, se le prognosi, ovvero ciò che andrebbe fatto per favorire, rallentare o ostacolare la “rivoluzione”, differiscono, le diagnosi che molti autori avanzano circa lo stato delle cose sembrano convergere su alcune questioni cruciali quali lo spazio e il tipo d’uomo (e soprattutto alcune sue qualità), principi della contemporaneità. Si tratta dello spazio urbano che ha sostituito la fabbrica (Florida, 2002; Hardt-Negri, 2009) e del cittadino-imprenditore di se stesso (Foucault, 2015) che ha preso il posto dell’uomo dell’organizzazione in senso lato, sia esso un impiegato o un operaio.
Abbiamo di fronte, come la conoscenza contemporanea ci insegna, un anthropos urbano. Egli (o ella, ma soprattutto, egli), senza chiedere troppo, è in grado di gestirsi e prendersi cura di sé, è fedele al proprio interesse e non prende ordini; al tempo stesso, mostra un genuino interesse verso la comunità politica di appartenenza alla quale intende dare un proprio soggettivo contributo, richiamando alla mente il cittadino della polis di Aristotele, unico vero e possibile spazio di civiltà. Il cittadino-imprenditore si adatta, si trasforma, in virtù del proprio capitale umano e del proprio senso critico e strategico, all’ambiente intorno a lui. Ciò che ha dentro di sé - che lo si pensi innato o socialmente costituito, risiedere nella mente, nel corpo o in entrambi - è una risorsa economica e politica. Egli è agito dal e agisce sul cambiamento, ma sembra disporre, forse a differenza di chi lo ha preceduto, di un certo tipo di potere.
Richard Florida, autore di un testo classico, L’ascesa della nuova classe creativa (2003), che ha, senza esagerare, dato il la a un acceso dibattito lungi dall’essersi esaurito, ha teorizzato l’emergere di una nuova classe sociale: la classe creativa. Essa mostra, tuttavia, scarsa coscienza di classe: in buona sostanza, secondo Florida, non sa, a differenza della classe operaia dell’epoca fordista, ciò che la renderebbe tale, sia in termini di diritti sia di doveri. Ovvero, essa non è consapevole del legame produttivo che accomunerebbe e distinguerebbe i suoi membri dal resto della società: la creatività in una lettura floridiana, ma più in generale, su un piano più astratto, la capacità cognitiva e affettiva che distingue i suoi membri in quanto produttori di beni e servizi e, cosa ben più rilevante, cittadini. Questa seconda e più generale lettura, relativa all’importanza delle skills cognitive in quanto risorse economiche, difficilmente troverebbe smentita nel dibattito scientifico attuale: questa è la cifra dell’anthropos contemporaneo, il suo potere. Ma qui è opportuno segnalare un passaggio importante, già presente nel testo di Florida: se è pur vero che il ricorso quotidiano a queste skills e soprattutto la capitalizzazione economica delle stesse sono ancora circoscritti ad alcune pratiche economiche, la “creatività”, dice Florida, è un attributo umano. La coscienza di classe che va dunque risvegliata non andrà in una direzione oppositiva, di una lotta di classe appunto, ma inclusiva: tutti noi siamo parte di questa classe, disponendo di default, in quanto esseri umani, di un’innata creatività e, mutatis mutandis, la stratificazione sociale risulta così “asciugata”: non ci sono più classi. Questo, credo, sia il nocciolo della straordinaria trasformazione di cui si narra da più parti. Ma dir creatività o capacità cognitiva non dice granché sulle modalità di esercizio di questo nuovo potere. Quest’ultimo si può supporre risieda in un metodo cognitivo, ovvero in un metodo che attiene tanto alle capacità soggettive di conoscere quanto a una singolare consapevolezza di ciò che si può conoscere, e dunque ai limiti della conoscenza acquisibile.

Her Majesty’s Pleasure - Daniel Horowitz (2016)
Paradossalmente, sembra affermarsi un soggetto che “può tutto”, come la massima del discorso dell’innovazione “cambiare il mondo” esemplifica bene, ma al tempo stesso riflette un particolare rapporto con la conoscenza: ovvero non solo l’uomo nuovo non ha paura di non sapere, ma non ha paura di dire che non sa e - aspetto importantissimo per le pratiche economiche innovative - di fallire. Quasi che onnipotenza e umiltà si condensassero e confondessero in questo metodo e in questo uomo.
A ben pensarci, questa attitudine riflette un mutato rapporto con tre elementi intimamente legati gli uni con gli altri: il rischio, l’incertezza e il futuro. Partendo da quest’ultimo per avviare il ragionamento, il futuro non è pianificabile poiché è ragionevolmente impensabile esercitare un controllo totalizzante su tutte le variabili che concorreranno a determinare il reale che verrà. Tale metodo mette da parte l’assioma del soggetto razionale, inteso come colui che ha il pieno controllo e si muove coerentemente rispetto a un fine noto e solo se conosce la direzione, per accogliere un uomo che si adatta ragionevolmente e intenzionalmente alla situazione rispetto un ventaglio di obiettivi, ma si muove nel non-noto e nell’incerto: ciò che l’economista Armen Alchian in un suo articolo seminale (1950) chiamò «purpusive behaviour in the presence of uncertainty and incomplete information». Fortuna o design, secondo Alchian, illuminano gli esiti del comportamento di uomo ragionevole. Si giustappongono qui una conoscenza totale a una conoscenza situata; la massimizzazione del profitto alla ricerca di profitto, la razionalità alla ragione.
Il metodo sta dunque nella “riflessione in azione”, concetto coniato da Donald Schön nel testo seminale Il professionista riflessivo pubblicato nel 1983. Si conosce agendo e auto-osservandosi nell’azione: il soggetto che descrive (e prescrive) l’autore, in buona sostanza, accoglie l’incertezza del proprio agire e da questo atto di consapevolezza si mette nelle condizioni di generare nuova conoscenza.
Facciamo un esempio pratico. Dal 2012 esiste una curiosa iniziativa che prende il nome di FuckUp Nights che si descrive come un movimento globale nato a Città del Messico da un’idea avuta da un gruppo di amici il cui intento è quello di celebrare le storie di fallimento imprenditoriale. Si tratta di una serata informale che si svolge in diverse città nel mondo, in cui personalità che “ce l’hanno fatta” raccontano i propri fallimenti e si può dire impersonino la celebre frase di Samuel Beckett: “ho provato, ho fallito. Non importa, riproverò. Fallirò meglio”. Se nomen omen, FuckUp Night combina insieme e su di sé le due pulsioni fondamentali, l’eros e la pulsione di distruzione (Freud, 1938) in un processo di distruzione creatrice schumpeteriana. Vedere per credere.
Febbraio 2016, Milano - La sala è gremita di gente, le luci sono basse, lo stile è casual, l’atmosfera è piacevole, la birra è servita. Tutto è pronto per la prima FuckUp Night milanese del nuovo anno. «Ciao, sono Lucia, sono una ricercatrice di falliti». Così introduce la serata l’organizzatrice dell’evento e prosegue: «L’obiettivo è sfatare un taboo e mostrare come il filo che unisce le storie di successo di questa sera, dei nostri fuckuppers, sia il fallimento. Per meglio dire, il coraggio di fallire e di ripartire». Si susseguono una serie di “falliti”, parlano di sé, di ciò che è andato storto, delle lezioni indispensabili imparate “facendo” e fallendo. Knowing-in-action appunto, come diceva Donald Schön rispetto all’apprendimento riflessivo: sbaglio, rifletto, imparo osservandomi, riprovo. A ben pensarci (e credo il lettore concorderà), la legittimità del proprio errare è una fonte notevole di piacere, se non altro per il sollievo che comporta dalla vergogna sociale. Ma c’è di più: errare, riconoscere i propri errori e imparare da essi è in questo caso indispensabile per l’imprenditore/innovatore. Gli stessi programmi di incubazione, la nuova frontiera formativa dell’imprenditore di se stesso, riflettono e esemplificano bene questo metodo: durante gli stessi vi è un continuo e serrato riesame del progetto imprenditoriale.
Sappiamo che dal punto di vista della storia della conoscenza, non si scopre mai davvero nulla, ma si impostano nuovi modi di conoscere, si “illuminano le cose diversamente” così da poter dire “Ah, ora ho capito come stanno veramente le cose”. Questa verità acquisita riflette la coscienza che un governo ha di sé in un dato momento storico e si traduce in pratiche. Rispetto a questa impostazione e alle riflessioni qui avanzate, emerge come siamo ben lontani oggi da un’arte di governo secondo una verità assoluta. Se così fosse, tuttavia, l’interrogativo che si apre è il seguente: secondo quale verità si articola l’arte di governo contemporanea? Prima ancora, c’è una verità che orienta, struttura la pratica di governo e l’uomo contemporaneo? Se, supponiamo, la verità è che non c’è una verità, qual potrà mai essere la portata trasformativa di una tale arte? Questo è un nodo politico importante da sciogliere, sul quale lo stesso Foucault lascia molto a intendere.
di Anna Paola Quaglia
Alchian A. (1950). Uncertainty, Evolution, and Economic Theory, The Journal of Political Economy, 58, 3, 211-221.
Florida R. (2003). L’ascesa della nuova classe creativa. Stile di vita, valori e professioni. Milano: Mondadori.
Foucault M. (2015), La Nascita della Biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979). Milano: Feltrinelli.
Hardt M.-Negri T. (2009). Commonwealth. Cambridge (MA): The Belknap Press of Harvard University Press.
Schön D. (1999). Il professionista riflessivo. Per una nuova epistemologia della pratica professionale. Bari: Dedalo.
-
Start up: le radici
Serial, Start up / Giugno 2017Varcata la soglia dello spazio, cattura l’occhio del visitatore un grande albero “fatto a mano”, co-creato dai primi abitanti del luogo con pezzi di legno di varie dimensioni. L’albero è abbastanza imponente: i rami “spingono in su” il soffitto, quasi volessero aprire un varco nel muro. Si diramano a destra e a sinistra in una libertà costretta dall’architettura. Le radici, di dimensioni più contenute, si posano su un pavimento in vetro. Elemento di natura antropizzata, l’albero è un curioso oggetto da incontrare in uno spazio di lavoro.
Questa presenza potrebbe valutarsi in modo assai semplice: siamo di fronte, né più né meno, che a elemento di design coerente con l’estetica di uno spazio di co-working molto cool. Tuttavia, l’albero merita, per alcune ragioni che saranno esposte, di essere preso sul serio. Logicamente, è utile collocare questo artefatto in relazione allo spazio e al tempo in cui esiste, proponendo, come chiave di lettura dello stesso e di ciò che evoca, una riflessione sull’atto, molto umano, di mettere radici, collocarsi e quindi prosperare. In generale, se studiato quale metafora di desideri, memoria e potere, l’albero fornisce un pretesto per dire alcune cose in merito al discorso dell’innovazione e alla trasformazione antropologica che a esso si accompagna, temi di cui si è parlato qui. Queste sono le coordinate spazio-temporali che autorizzano a individuare in esso un testo, evitando di liquidare la faccenda come poca cosa.

Fragmented Identity - Daniel Horowitz (2016)
Come interpretare, dunque, questo oggetto in relazione ai soggetti che lo hanno creato e che ne sono guardati? Per prima cosa, iniziando col riconoscere che gli oggetti alle volte occupano il ruolo di veri e propri mediatori nella formazione di legami sociali (Latour, 2005) e se non altro, incorporano narrazioni, codici e informazioni rilevanti per un collettivo (Leghissa, 2014). A quest’ultimo gruppo appartiene l’albero, il quale simbolicamente condensa su di sé desideri di stabilità e di manifesta vivacità e intraprendenza rispetto al futuro.
Proseguendo, sappiamo che un discorso è cosa assai pericolosa, e che il soggetto in questo gioco di verità è definito e si definisce, è agito e agisce mediante alcune tecnologie (Foucault, 1988). In tal senso, il discorso dell’innovazione non può che riguardare il campo della formazione del soggetto, nonostante quest’ultimo si mostri spesso restio a riconoscere qualsiasi presa o influenza sul proprio sé da parte del mondo esterno, ancor più se si sostiene che una porzione del mondo esterno, per esempio un dato culturale o una cosa, sia stato interiorizzato. Se la soggettività è un campo di battaglia e in virtù di un’analogia tra lo sviluppo del singolo e della collettività il cui esito è dato da una persistente contesa tra Io, Es e Super io (Freud, 1929), l’albero consente di osservare queste tensioni da un’angolazione interessante. Semplificando molto e riprendendo il diario del campo etnografico, «se interpreto l’albero, comprendo un po’ di più la soggettività start-up», qui intesa come un buon esempio di soggettività contemporanea frammentata poiché in formazione.
Lo spazio di cui è parte è un luogo speciale e archetipico della condizione neo-liberale: tutto, dal successo negli affetti alla raccolta differenziata, dipenderà dal modo in cui si producono beni e ricchezze. In tale stato sociale naturalizzato, ad alcuni soggetti è demandato questo compito di inventiva: l’imprenditore start-up, l’innovatore, il creativo, l’artigiano digitale. A coloro insomma che sono il proprio capitale, produttori di sé stessi e fonte dei propri redditi (Foucault, 2004, p. 186-187).
Avviatasi con il post-fordismo, questa trasformazione antropologica ha conosciuto un’accelerazione nella seconda metà degli anni Novanta e nei primi anni Duemila, per poi intensificarsi e mostrarsi in modo più evidente in seguito alla crisi economico-finanziaria del 2008. Su questo sfondo, il faticoso farsi di una nuova soggettività ha richiesto nuove tecniche: procedure, spazi, linguaggi, segni e - fatto assai importante - una riconoscibilità pubblica. A questi è seguita comprensibilmente l'esigenza di nuovi ancoraggi nello spazio e nel tempo, nuove radici che funzionino nel presente senza che tuttavia ai soggetti sia possibile sottrarsi al confronto diacronico con il passato[1]. D’altronde, sappiamo che, come il sapere psicoanalitico insegna, con le proprie radici, non si potrà che dolorosamente fare i conti. In questo senso, si può dire che l’albero sia sintomo di un desiderio - legittimo - di ancorarsi, affermarsi, radicandosi in uno spazio, ma al contempo, esso rappresenta la proiezione di un nuovo sé e in questa veste, un'istanza difensiva. A questo proposito, l’albero è piuttosto esplicito nel suo parlare. Nello spazio di lavoro osservato, esso si colloca all’ingresso e da quella particolare posizione nell’economia spaziale, informa il visitatore incuriosito su ciò che “c'è da fare”: «entra nella tua nuova casa, impegnati in progetti sostenibili, collabora con persone elettrizzanti, condividi e vivi l’entusiasmo di chi desidera cambiare il mondo». Beninteso, il desiderio di "cambiare il mondo" è una dichiarazione politica, in rottura - si può ipotizza-re - rispetto a un passato che al fondo si giudica colpevole. Per questa precisa ragione, sarebbe fruttuoso cimentarsi in un esercizio di critica à la Foucault (che richiede prima di tutto una rigorosa e sincera auto-osservazione) e interpretare i pensieri onirici latenti piuttosto che accontentarsi del contenuto manifesto del sogno raccontato (Freud, 1966): l’aspirazione di costruire un mondo radicalmente nuovo e migliore. Questo senza, tuttavia, scivolare in una “ginnastica” critica d’antan che rischia di perdere di vista il perno umano, e non già metafisico, su cui poggia l’utopia neoliberale: i soggetti pensanti e capaci di auto-osservarsi, ai quali non va svelato granché.
di Anna Paola Quaglia
Bibliografia
Foucault, M. (1988), “Technologies of the Self”, Technologies of the Self. A Seminar with Michel Foucault (a cura di Martin L.H., Guttman H. e Hutton P.H.,), London, Tavistock Publications, pp. 16-49.
Foucault M., (2012), La Nascita della Biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979), Milano, Feltrinelli.
Freud, S. (1966), “L’interpretazione dei sogni (1899)”, Opere 1989 (Opere di Sigmund Freud a cura di Mussatti C.L.), pp. 637.
Freud S. (1978), “Il disagio della civiltà (1929)”, Opere 1924-1929. Inibizione, sintomo e angoscia e altri scritti (Opere di Sigmund Freud a cura di Mussatti C.L.), pp. 555-630.
Latour, B. (2005), Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network Theory, New York, Oxford University Press.
Leghissa, G. (2012), Neoliberalismo. Un’introduzione critica, Milano-Udine, Mimesis.
Leghissa, G. “Ospiti di un mondo di cose. Per un rapporto postumano con la materialità”, La condizione postumana (a cura di Leghissa G.), aut aut, 361, 2014, pp. 10-33.
[1] Si rimanda ad una prossima pubblicazione a cura della Rivista Geografica (n. 125, 2017) in cui verranno presentati alcuni saggi relativi al seminario “Dialoghi sul concetto di radice”, organizzata a latere della VI Giornata di studio “Oltre la globalizzazione” Società di Studi Geografici dal titolo “(S)radicamenti”. In tale occasione, sono intervenuti i geografi Paolo Giaccaria e Giuseppe Dematteis, il filosofo Giovanni Leghissa e l’antropologo Francesco Remotti. Quest’ultimo, nell’ambito del suo contributo, ha evidenziato il confronto, continuato e insito nella metafora di radice, tra passato e presente, tra mobilità e fissità, precisamente con riferimento ai bananeti e alle tombe arboree dei BaNande.
-
START-UP: L’ENTUSIASMO
Serial, Start up / Aprile 2017Il presente: Palazzo di Ghiaccio, Milano, 14 dicembre 2015. Sulle note de “Gli immortali” di Lorenzo Jovanotti e “Lo stadio” di Tiziano Ferro si è svolto a Milano l’Italia Startup Open Summit. L’evento, «impensabile fino a qualche anno fa» nelle parole di Riccardo Luna, presentatore della giornata, è «la festa di Natale delle start-up italiane, un momento di celebrazione di storie di coraggio».
Luna, nuovo direttore dell’AGI e già Digital Champion italiano, dà avvio alla mattinata in un modo spettacolare: con la musica ad alto volume che lo accompagna («[…] E cambieremo il mondo, se cambierà davvero […]») e ripreso frontalmente da una telecamera, percorre di corsa il corridoio del parterre dove è disposto il numeroso pubblico lungo file di sedie, ne cerca lo sguardo e il coinvolgimento, "batte il cinque". La società civile è presente: rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali, imprenditori start-up, investitori, giornalisti, grandi aziende, curiosi. L’atmosfera è eccitante, si percepisce «una partecipazione emotiva al bene» (Kant, 1994, p. 167). E il fine comune, ideale e puramente morale qual è? «Un bel percorso che possiamo fare per l’innovazione (enfasi aggiunta) in questo paese», dichiara uno degli autorevoli ospiti della giornata.
Tutto chiaro. O forse no. «Riavvolgendo il nastro», questo frammento etnografico che ha destato una certa meraviglia in chi scrive, invita ad un’interpretazione: di che cosa stanno parlando queste persone? E che cosa stanno facendo? La percezione è di essere spettatori di qualche cosa di singolare, ma già in buona sostanza di senso comune (almeno per alcuni collettivi dotati di un certo capitale à la Bourdieu).
Nel tentativo di fare un po’ di chiarezza, si può iniziare dicendo che nella contingenza attuale un tale linguaggio non è per nulla astruso, ma al contrario assai comune. O meglio, non è astruso nella misura in cui ciò che esprime è una cosa percepita come bella e desiderabile tanto a livello di singolo quanto di collettivo. Di questi tempi, l’innovazione desta una simpatia disinteressata nel pubblico (Ivi., p. 165): d’altronde, chi si spenderebbe contro di essa o chi può non dirsi sedotto da questa parola?
Al tempo stesso però, la significazione di innovazione è oscura proprio in virtù della sua popolarità e della declinazione in campi semantici svariati. A ben pensarci, il segno linguistico “innovazione”, là dove il segno linguistico è l’atto di unificazione di un'immagine acustica ad un concetto, è ovunque. Non corrisponde più soltanto a una pratica economica specifica, ovvero la traduzione di un’idea in un prodotto acquistabile sul mercato, ma a una pratica antropologica, a un certo modo di essere che sembra andare ben al di là della sola sfera di produzione di beni e servizi. L’innovazione è precisamente una disposizione d’animo e la sua confusa significazione linguistica è una metafora, come il linguaggio sa essere, di una trasformazione culturale profonda e in corso (Williams, 1983). Ma qual è dunque il segno di tale trasformazione?

Lonesome Messiah - Daniel Horowitz (2016)
Facciamo ora un passo indietro.
Il passato: Collegè de France, Parigi, 5 gennaio 1983. Durante la prima ora di lezione, Michel Foucault situa ciò di cui intende trattare nel Corso i.e. il governo di sé e degli altri praticando un’ontologia del presente, in continuità con un breve testo di Immanuel Kant: Che cos’è l’Illuminismo? del 1784. Nell’esposizione, Foucault pone in dialogo il tema «dell’uscita dell’uomo da uno stato di minorità di cui egli è colpevole» (Kant, 2012) con un’altra questione molto cara al filosofo tedesco: se e come la specie umana sia in continuo progresso. Più precisamente, Foucault ricorda come Kant, ritornando in varie occasioni sulla questione, nel 1798 abbia posto i lumi in relazione ad un altro evento che «non si può dimenticare» (Kant, 1994, p. 169): la Rivoluzione francese. Nella parte seconda de Il Conflitto delle facoltà del 1798, Kant individua in un avvenimento che lascia un indizio storico, la condizione di possibilità del progresso: «un segno rimemorativo, dimostrativo e prognostico di un progresso costante che trascina il genere umano nella sua totalità» (Foucault, 2009). Ciò che è interessante è la lettura che Kant propone della rivoluzione: se essa è il segno di tale avvenimento, non lo è per «il dramma rivoluzionario in se stesso. […]» (Foucault, 2009) e neppure poiché corrisponde a «importanti fatti o misfatti compiuti dagli uomini. […] No, nulla di tutto ciò» dice Kant (1994, pp. 165). Piuttosto, dobbiamo ricercare una disposizione di base degli spettatori: «una partecipazione, sul piano del desiderio, prossima all’entusiasmo (enfasi aggiunta)» (Ivi., pp. 165-166). E’ propriamente questo entusiasmo che riguarderebbe la totalità di un collettivo[1], secondo Kant, ad autorizzare alcune osservazioni antropologiche.
Innovazione, dunque, quale discorso sull’antropologico e quale questione antropologica che va, cioè, a interrogare un insieme i modi di esistenza individuali e collettivi. Sotto queste spoglie, l’innovazione avanza una richiesta a chi è sensibile al richiamo del suo discorso: di crederci e soprattutto, di credere alla cifra trasformativa, intrinsecamente positiva e perciò desiderabile che lo caratterizza. In questo senso, essa non appare come un discorso tra tanti né business as usual. Al contrario, potrebbe intendersi come un nuovo discorso di tipo fondativo, che si intreccia ad altri e che avanza una precisa richiesta ai soggetti contemporanei: la richiesta di “trasformare se stessi”.
Qual è quindi il problema? «Che c’è di tanto pericoloso nel fatto che la gente parla e che i suoi discorsi proliferano indefinitamente» (Foucault, 1972, p. 9)? La parola “innovazione” è forse un pericolo?
Riprendendo Kant (1994, p. 165), si legge, a proposito del segno storico di un tempo rivoluzionario di cui sopra, quanto segue:
«Si tratta solo del modo di pensare degli spettatori che in questo gioco di grandi trasformazioni si palesa pubblicamente e manifesta a gran voce una generale e tuttavia disinteressata simpatia per i giocatori di una parte contro quelli dell’altra (enfasi aggiunta)».
Ci si può dimenticare cioè, di ciò che è politico, dunque conflittuale. Tornando all’episodio di apertura, in quella giornata di festa delle oltre cinquemila start-up italiane, il primo a salire sul palco è stato il Presidente dell’associazione Italiastartup, Marco Bicocchi-Pichi. «Il papà […] dell’ecosistema», dichiara Luna, «ma alcuni quando parlano dicono anche il Papa, per questo approccio ecumenico (enfasi aggiunta), inclusivo che ha». Ecco allora la comunione e la cooperazione capaci di superare la divisione politica e confessionale rispetto ad un fine comune che può celare il conflitto. Tale attitudine, come vedremo, si riflette bene in alcuni spazi del “discorso dell’innovazione”, per esempio gli spazi di co-working e “l’eco-sistema”, metafora biologica a indicare l’insieme e la varietà degli attori che si mettono al lavoro “per l’innovazione”.
In conclusione, si potrebbe dire che il fascino che evoca e la presa di cui è capace tale discorso rendono difficoltoso l’esercizio di de-soggettivizzazione del soggetto, arte indispensabile, scrive Foucault (2007), al fine di non essere governati eccessivamente.
Bibliografia
Kant, I. (1994), Der Streit der Fakultäten (1798); edizione italiana a cura di Domenico Venturelli: Il conflitto delle facoltà. Brescia: Editrice Morcelliana.
Kant, I. (2012),“Risposta alla domanda: che cos’è l’Illuminismo?” in Foucault, M. e Kant I., Che cos’è l’Illuminismo. Milano, Mimesis (edizione digitale).
[1] Kant parla di “genere umano” nel suo scritto e lo fa in riferimento alla Rivoluzione francese. La presente riflessione, com’è ovvio, non vuole estendersi a questa totalità. Nonostante sia verosimile che quanto argomentato mostri una certa assonanza rispetto a quanto avviene in altri luoghi nel Nord e Sud Globale, il contributo si limita a una lettura del contesto italiano contemporaneo.
* Parte di questo scritto apparirà in Anna Paola Quaglia, "Innovazione, imprenditorialità, tecnologia: la promessa di una nuova urbanità” in Ambiente, Società e Territorio, 2, 2017
Di Anna Paola Quaglia
-
Nello spazio di questa rubrica dal titolo Start Up desidero riflettere su un discorso oggi “nell’aria”, curiosamente tanto in un piccolo paesino della Sardegna quanto in una città mito come New York: il discorso è quello dell’innovazione, della pratica innovativa e del soggetto innovatore. Il discorso, come forse saprete, si dice rivoluzionario: cambierà, dice, letteralmente il mondo. Qui, intendo prendere sul serio il dispiegarsi di queste parole pericolose nello spazio - direbbe Foucault - per comprendere come un discorso, sintomo al contempo di desideri, istanze difensive e mancanze a essere, si faccia corpo. Per fare questo, la rubrica vuole occuparsi della molteplicità di spazi che la materialità di tale discorso richiede, richiama e evoca per e nel suo farsi materia. Una genealogia spaziale dell’innovazione attraverso lo spazio urbano, organizzativo, immaginario e infine, del soggetto che là dove è occupa sempre uno spazio.
Nel corso della rubrica si attingerà alle note del diario etnografico frutto dell’osservazione svolta presso un incubatore d’impresa e spazio co-working milanese nell’ambito del mio progetto di Dottorato in Urban and Regional Development, Politecnico di Torino e Università degli Studi di Torino, attualmente Visiting research student presso The New School, New York.
Contatto: annapaola.quaglia@polito.it
Su gentile concessione dell’artista Daniel Horowitz, alcune immagini di sue opere esposte a New York nelle esibizioni Totem e taboo e Civilization and its Discontents, accompagneranno le puntate della rubrica.
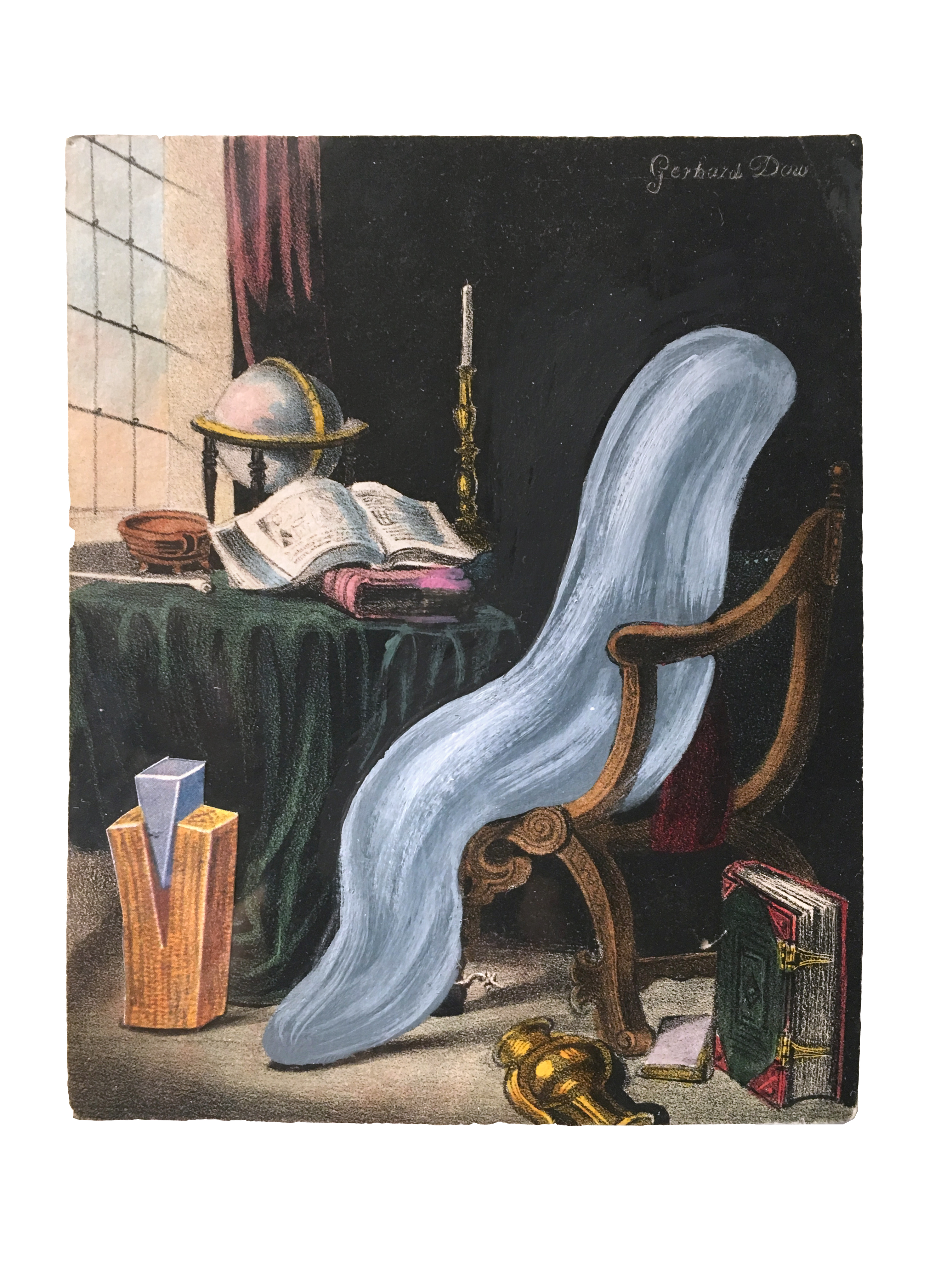
D. B. Horowitz, Lawless Boy, 2016, oil on antique hand-colored engraving
-
 Dopo avere dedicato un saggio alle origini della filosofia (Sassi 2009), Maria Michela Sassi affronta in questo libro (Indagine su Socrate. Persona filosofo cittadino, Einaudi, Torino 2015) la sfuggente e complessa figura di Socrate, nella quale tradizionalmente è stata individuata una discontinuità cruciale rispetto agli inizi di cui furono protagonisti i cosiddetti Presocratici e che costituisce dunque, per così dire, un secondo inizio rispetto a quel “prima”. Se ogni inizio pone caratteristiche difficoltà all’interprete, proporre oggi un’indagine su Socrate è impresa più ardua di altre da concepire e da impostare, considerando la vastità dei contributi esistenti sulla questione formulata fin dal 1815 da Friedrich Schleiermacher nel saggio Sul valore di Socrate come filosofo, quando si chiedeva «cosa può essere stato Socrate, al di là di ciò che racconta Senofonte», senza contraddire i tratti che lo stesso Senofonte presenta come propriamente socratici, e «cosa deve essere stato» perché Platone potesse rappresentarlo come ha fatto. La secolare sequela delle interpretazioni è altresì alimentata da un paradosso di cui Sassi dà conto in modo chiaro e articolato: resta controverso chi sia stato il Socrate storico nonostante proprio la sua persona e le sue azioni abbiano segnato un punto di riferimento cruciale – se non l’origine – del genere biografico in Grecia. A questo proposito, richiamando le tesi di Albrecht Dihle e il ridimensionamento fattone da Arnaldo Momigliano, Sassi sottolinea la centralità dei Socratici nella storia degli esperimenti biografici del IV secolo e la peculiarità dei loro scritti, che tendevano più a cogliere le potenzialità della vita del maestro che a raccontarla, facendone così una «guida per territori ancora inesplorati», come Momigliano scriveva nel saggio su Lo sviluppo della biografia greca (1974).
Dopo avere dedicato un saggio alle origini della filosofia (Sassi 2009), Maria Michela Sassi affronta in questo libro (Indagine su Socrate. Persona filosofo cittadino, Einaudi, Torino 2015) la sfuggente e complessa figura di Socrate, nella quale tradizionalmente è stata individuata una discontinuità cruciale rispetto agli inizi di cui furono protagonisti i cosiddetti Presocratici e che costituisce dunque, per così dire, un secondo inizio rispetto a quel “prima”. Se ogni inizio pone caratteristiche difficoltà all’interprete, proporre oggi un’indagine su Socrate è impresa più ardua di altre da concepire e da impostare, considerando la vastità dei contributi esistenti sulla questione formulata fin dal 1815 da Friedrich Schleiermacher nel saggio Sul valore di Socrate come filosofo, quando si chiedeva «cosa può essere stato Socrate, al di là di ciò che racconta Senofonte», senza contraddire i tratti che lo stesso Senofonte presenta come propriamente socratici, e «cosa deve essere stato» perché Platone potesse rappresentarlo come ha fatto. La secolare sequela delle interpretazioni è altresì alimentata da un paradosso di cui Sassi dà conto in modo chiaro e articolato: resta controverso chi sia stato il Socrate storico nonostante proprio la sua persona e le sue azioni abbiano segnato un punto di riferimento cruciale – se non l’origine – del genere biografico in Grecia. A questo proposito, richiamando le tesi di Albrecht Dihle e il ridimensionamento fattone da Arnaldo Momigliano, Sassi sottolinea la centralità dei Socratici nella storia degli esperimenti biografici del IV secolo e la peculiarità dei loro scritti, che tendevano più a cogliere le potenzialità della vita del maestro che a raccontarla, facendone così una «guida per territori ancora inesplorati», come Momigliano scriveva nel saggio su Lo sviluppo della biografia greca (1974).Proprio in ragione di questa circostanza c’è chi – come Olof Gigon nel saggio Sokrates. Sein Bild in Dichtung und Geschichte (1947) – ha sostenuto che quanto più si approfondisce lo studio delle fonti, tanto più ci si accorge di non poter dire nulla del Socrate storico: non avendo ereditato una biografia propriamente detta (Sokratesbiographie), ma soltanto poesia (Sokratesdichtung) su di lui, ai contemporanei non resterebbe altra possibilità che liquidare il problema della sua personalità filosofica accettando di non poterne dire nulla (cfr. Gigon 2015). L’Indagine su Socrate qui proposta si muove su un piano differente, animata da una «fiducia ricostruttiva» che l’autrice basa sulla convinzione «che la varietà e anche divergenza delle fonti si spieghi meglio presupponendo la ricchezza e le potenzialità del modello di base che liquidandole come creazioni ex nihilo» (p. X).
In tale prospettiva, la «plasmabilità del modello che ha offerto ai contemporanei e ai posteri» diventa uno degli elementi di cui dare conto, anziché un motivo a favore dello scetticismo: si può così tentare di inquadrare proprio la «natura plastica» del pensatore e del cittadino Socrate – secondo l’efficace definizione di Hegel nelle Lezioni sulla storia della filosofia – come tratto caratterizzante della sua biografia, intendendola non tanto come l’effetto indotto ex post su di noi dalle testimonianze antiche, con il loro spaziare dalla caricatura alla celebrazione, quanto come il motivo ispiratore ex ante della varietà dei ritratti giunti fino a noi. È questa l’impostazione che guida la presentazione complessiva del pensiero di Socrate proposta nel libro, che a tal fine tiene conto sia del panorama degli studi più recenti su Senofonte e sul valore della sua testimonianza, sia dei cosiddetti logoi sokratikói.
Spicca poi, naturalmente, Platone, al quale dobbiamo alcuni indizi importanti sulla percezione dei contemporanei, con le allusioni alla «stranezza» (atopia) di Socrate (Simposio, 215a-b) e alla consapevole presenza di «qualcosa di stravagante» (perittoteron) nel suo carattere (Apologia, 20c). Si può sostenere che «Socrate stesso si è costruito in vita come un modello di sapere e virtù, destinato a essere via via ri-costruito nei secoli e spesso rivissuto, ma non (nella nostra prospettiva) falsificato» (p. 12). Lo stesso Platone dà molteplici esempi di tale “ricostruzione”: oltre al Socrate de Le Nuvole di Aristofane (423 a.C.) e a quello di Senofonte o dei frammenti di Antistene, Eschine di Sfetto, Fedone di Elide, ci sono infatti il Socrate dei primissimi dialoghi (Apologia di Socrate e Critone), quello dei dialoghi del primo periodo – dalla condanna a morte del maestro alla fondazione dell’Accademia (388/387 a.C.) – e quello dei dialoghi successivi, fino al terzo viaggio di Siracusa (361/360 a.C.), caratterizzati dalla presentazione di dottrine più costruttive, la cui paternità può essere attribuita allo stesso Platone. Anche in questo caso, non mancano interpretazioni che finiscono con l’impedire di pronunciarsi sulla figura di Socrate, escludendo la possibilità di riconoscerne dei tratti specifici nella rielaborazione e, per così dire, nella “messa in scena” escogitata dal suo geniale allievo: ciò accade soprattutto quando prevale un approccio unitarista e non evolutivo all’opera platonica, come nel caso esemplare di Charles H. Kahn.
Sassi si inserisce invece tra quegli studiosi che ritengono possibile indagare negli scritti di Platone il complesso gioco di adesione, approfondimento e distacco dal maestro (p. 234) che rende possibile considerare lo stesso Socrate come «la levatrice del Platonismo» (The Midwife of Platonism), riprendendo il suggestivo titolo di un libro di David Sedley sul Teeteto. Tenendo conto di tutto ciò, questa Indagine su Socrate permette al lettore di seguire parallelamente e di mettere in relazione gli aspetti emergenti dalle testimonianze relative ora alla persona, ora al filosofo e ora al cittadino, in capitoli dedicati all’eccezione filosofica e fisiognomica di Socrate, al suo conversare vivace e scherzoso, alle sue qualità di maestro, al suo dirsi in missione per conto del dio, all’ironia, al metodo di confutazione (elenchos) e all’esigenza di chiarificazione della sfera morale attraverso la ricerca di definizioni.
Emerge peraltro proprio qui, nel nucleo della preoccupazione morale socratica, un altro motivo della stranezza del filosofo, così distante dai Sofisti eppure a essi vicino, per l’utilizzo di confutazioni in cui – come è stato rilevato da molti interpreti – non mancano aporie, fallacie logiche e mosse ingannevoli. Al riguardo è interessante soffermarsi sul fatto che «nel linguaggio non filosofico fin da Omero (e del resto anche dopo l’età classica), sia il sostantivo elenchos che il verbo elenchein indicano l’atto di “mettere alla prova” un individuo e “verificare” la correttezza della sua condotta morale, misurando l’aderenza delle sue parole all’azione compiuta, sì che quello, se venga “smentito” ovvero colto in fallo, ne provi vergogna» (p. 69).
Un singolare pregio del libro sta nel dare conto della generatività del modello proposto da Socrate sui tre piani dell’essere persona, filosofo e cittadino, facendo interagire l’analisi delle fonti più antiche con le riprese successive: incontriamo così il Socrate di Ficino, capace di ispirare a quasi due millenni dalla morte uno stile educativo problematizzante e non gerarchico, e i tanti Socrate di Hegel, Kierkegaard, Nietzsche, Strauss o del circolo di intellettuali che nella Vienna fin de siècle si dissero Neosocratici. Per ognuno di essi, il lettore potrà chiedersi se assomigli maggiormente al Socrate di Aristofane, di Platone o di Senofonte, senza che l’impressione di trovarsi in una sorta di stanza degli specchi filosofica faccia disperare della possibilità di cogliere qualche aspetto originale attribuibile al referente in absentia delle tante immagini riflesse.

Critone chiude gli occhi a Socrate (1787-1792)
Particolarmente significative risultano in tale prospettiva le pagine dedicate al modo in cui Socrate, per primo, applicò sistematicamente il paradigma delle technai all’anima (psyche), ispirando la riflessione platonica sulla paideia e sulla cura di sé (epimeleia heautou, in latino cura sui) e proiettando, attraverso essa, la propria ombra su tutto il pensiero greco, ellenistico e romano, arrivando fino alla spiritualità cristiana e a ciò che a essa è correlato in modo più o meno diretto. Si tratta di un punto cruciale per definire l’attualità di Socrate, già esemplarmente sollevato tanto dalla ricerca di Pierre Hadot sugli esercizi spirituali nell’antichità quanto dalle ultime riflessioni di Michel Foucault sull’ermeneutica del soggetto (al centro del corso al Collège de France del 1981/1982) e sulle tecnologie del sé. Socrate risulta essere una delle origini anche di questa storia e Sassi lo ribadisce, sottolineando l’importanza di alcune intuizioni di Foucault e, in particolare, della sua valorizzazione dell’Alcibiade primo o maior, come primo testo filosofico in cui viene sollevata la domanda su cosa sia l’uomo, ovvero su cosa sia il “se stesso” di cui si parla quando si pensa alla “cura di sé”, con un richiamo, seguendo Hegel, all’Edipo re di Sofocle (cfr. pp. 121 sgg.).
Il Socrate dell’Alcibiade primo di Platone, dunque, viene analizzato come testo che inaugura la questione del soggetto, ovvero delle pratiche di soggettivazione attraverso le quali un soggetto può diventare campo di conoscenza, d’azione e d’esercizio per se stesso. Tenendo conto di questo dialogo e dell’imperativo etico ch’esso ha consegnato ai posteri («Cerca di essere bello il più possibile!», Alcibiade primo, 131c-d), Sassi precisa di non ritenere in toto sottoscrivibile la critica di Hadot a Foucault sulla surrettizia trasposizione nel pensiero antico di una sorta di estetica dell’esistenza, la cui esigenza sarebbe precipuamente contemporanea: si tratta peraltro di intendersi sul senso della bellezza qui richiamata, applicabile tanto all’ars moriendi, quanto all’arte di vivere di cui Socrate fu considerato modello esemplare (oltre al saggio di Cambiano su Platone e le tecniche del 1971, si richiamano qui studi più recenti, come quello di Nehamas 1998).
L’Indagine su Socrate proposta da Sassi aiuta però a ricordare che proprio qui la persona, il filosofo e il cittadino Socrate si incontrano per il privilegio accordato al dialogare come tecnica dell’anima per eccellenza, che non permette di declinare in termini puramente individualistici l’imperativo a cambiare la propria vita, come invece sembra suggerire Sloterdijk. Il domandare socratico non riguarda infatti l’individuo che da sé assume un impegno a cambiare la propria vita, ma è al tempo stesso un fatto etico e politico, nel senso dischiuso dall’interrogativo generale sul «come si dovrebbe vivere?», che secondo Julia Annas inaugura il più ricco e caratteristico filone dell’etica greca: interrogativo attribuito a Socrate e inserito non a caso in un’opera intitolata Politeia, incentrata su sottili giochi di corrispondenze tra il destino della psyche e quello della polis (cfr. l’hontina tropon chrē zēn di Repubblica 352d e Annas 1997). In tale prospettiva, questo ritratto di Socrate aiuta a mettere a fuoco le caratteristiche peculiari del maestro di Platone anche sul piano della storia delle tecnologie del sé e delle antropotecniche, mostrando al lettore contemporaneo interessato all’argomento quanto sia proficua la rilettura delle fonti antiche a cui spesso si fa appello come esemplari, per cogliere continuità e discontinuità tra le varianti esistenti e tra quelle possibili.
di Luca Mori
Bibliografia
Annas, J. (1997). La morale della felicità in Aristotele e nei filosofi dell’età ellenistica. Milano: Vita&Pensiero.
Cambiano, G. (1971). Platone e le tecniche. Torino: Einaudi.
Foucault, M. (1992). Tecnologie del sé. Torino: Bollati Boringhieri.
Foucault, M. (2016). L’ermeneutica del soggetto. Corso al Collège de France (1981-1982). Milano: Feltrinelli.
Gigon, O. (2015). Socrate. La sua immagine nella letteratura e nella storia. Milano: Vita&Pensiero.
Hadot, P. (2005). Esercizi spirituali e filosofia antica. Torino: Einaudi.
Kahn, C.H. (2008). Platone e il dialogo socratico. L’uso filosofico di una forma letteraria. Milano: Vita&Pensiero.
Momigliano, A. (1974). Lo sviluppo della biografia greca. Torino: Einaudi.
Nehamas, A. (1998). The art of living. Socratic Reflections from Plato to Foucault. Berkeley-Los Angeles-London: University of California Press.
Sassi, M. M. (2009). Gli inizi della filosofia: in Grecia. Torino: Bollati Boringhieri.
Sedley, D. (2004). The Midwife of Platonism. Text and Subtext in Plato’s Theaetetus. Oxford: Clarendon Press.
Sloterdijk, P. (2010). Devi cambiare la tua vita. Milano: Raffaello Cortina Editore.
-
L’arte della similitudine. Foucault e Magritte
Sconfinamenti, Serial / Ottobre 2016 È piuttosto insolito incontrare, negli scritti di un pittore, riferimenti ai filosofi. Eppure, nell’ampio corpus di quelli redatti nel corso dei decenni da René Magritte, capita a volte di imbattersi nei nomi di Eraclito, Socrate, Platone, Descartes, Berkeley, Kant, Hegel, Schopenhauer, Marx, Nietzsche, Bergson, Bachelard, Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty. Inoltre, anche se i testi dell’artista belga non sono certo di carattere filosofico, in alcuni di essi si può ravvisare un’originale riflessione sul linguaggio. Ricordiamo per esempio un celebre scritto illustrato del 1929, Les mots et les images, che contiene enunciati lapidari come i seguenti: «Un oggetto non è mai tanto legato al suo nome che non se ne possa trovare un altro che gli si adatti meglio»; «Un’immagine può prendere il posto di una parola in una proposizione»; «Tutto tende a far pensare che ci sia scarso rapporto tra un oggetto e ciò che lo rappresenta»; «A volte il nome di un oggetto può sostituire un’immagine»; «In un quadro, le parole sono della stessa sostanza delle immagini»; «Si vedono in un modo diverso le immagini e le parole in un quadro». Date queste premesse, non desta sorpresa il fatto che Magritte si sia affrettato a leggere un libro di Michel Foucault dal promettente titolo Les mots et les choses, senza farsi intimorire dalla mole e dalla complessità della trattazione. Resta strano, però, il fatto che, a poco più di un mese dall’uscita del volume, un pittore anziano e affermato come lui abbia sentito l’esigenza di scrivere a Foucault una lettera al fine di comunicargli le proprie idee su una questione specifica, ossia il tema della somiglianza. In effetti nel libro, riferendosi alla cultura del Cinquecento, il filosofo aveva evidenziato l’onnipresenza, in vari campi del sapere, dell’idea di somiglianza o similitudine...Scarica PDF
È piuttosto insolito incontrare, negli scritti di un pittore, riferimenti ai filosofi. Eppure, nell’ampio corpus di quelli redatti nel corso dei decenni da René Magritte, capita a volte di imbattersi nei nomi di Eraclito, Socrate, Platone, Descartes, Berkeley, Kant, Hegel, Schopenhauer, Marx, Nietzsche, Bergson, Bachelard, Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty. Inoltre, anche se i testi dell’artista belga non sono certo di carattere filosofico, in alcuni di essi si può ravvisare un’originale riflessione sul linguaggio. Ricordiamo per esempio un celebre scritto illustrato del 1929, Les mots et les images, che contiene enunciati lapidari come i seguenti: «Un oggetto non è mai tanto legato al suo nome che non se ne possa trovare un altro che gli si adatti meglio»; «Un’immagine può prendere il posto di una parola in una proposizione»; «Tutto tende a far pensare che ci sia scarso rapporto tra un oggetto e ciò che lo rappresenta»; «A volte il nome di un oggetto può sostituire un’immagine»; «In un quadro, le parole sono della stessa sostanza delle immagini»; «Si vedono in un modo diverso le immagini e le parole in un quadro». Date queste premesse, non desta sorpresa il fatto che Magritte si sia affrettato a leggere un libro di Michel Foucault dal promettente titolo Les mots et les choses, senza farsi intimorire dalla mole e dalla complessità della trattazione. Resta strano, però, il fatto che, a poco più di un mese dall’uscita del volume, un pittore anziano e affermato come lui abbia sentito l’esigenza di scrivere a Foucault una lettera al fine di comunicargli le proprie idee su una questione specifica, ossia il tema della somiglianza. In effetti nel libro, riferendosi alla cultura del Cinquecento, il filosofo aveva evidenziato l’onnipresenza, in vari campi del sapere, dell’idea di somiglianza o similitudine...Scarica PDFA cura di:
Giuseppe Zuccarino è critico e traduttore. Ha pubblicato vari saggi: La scrittura impossibile, Genova, Graphos, 1995; L’immagine e l’enigma, ivi, 1998; Critica e commento. Benjamin, Foucault, Derrida, ivi, 2000; Percorsi anomali, Udine, Campanotto, 2002; Il desiderio, la follia, la morte, ivi, 2005; Il dialogo e il silenzio, ivi, 2008; Da un’arte all’altra, Novi Ligure, Joker, 2009; Note al palinsesto, ivi, 2012; Il farsi della scrittura, Milano-Udine, Mimesis, 2012. Tra i libri da lui tradotti figurano opere di Mallarmé, Bataille, Klossowski, Blanchot, Caillois e Barthes.
-
 Con Differenze italiane. Politica e filosofia: mappe e sconfinamenti si fa un salto nell’ossimoro. Il volume, curato da Dario Gentili ed Elettra Stimilli per DeriveApprodi (Roma 2015), è composto per buona parte dagli interventi del convegno internazionale Italian Theory existe-t-elle? tenutosi a Parigi nel gennaio 2014. Esiste una “teoria italiana”, una specificità del pensiero filosofico-politico italiano contemporaneo rispetto ad altre tradizioni e scuole di pensiero? L’Italian Theory può essere considerata una scuola o una tradizione di pensiero? “Italian Theory” e “differenze italiane”: due espressioni che sono anche i titoli degli ultimi due lavori di Gentili. Se il sottotitolo del primo, Dall’operaismo alla biopolitica, rivela il tentativo di tracciare una linea, un continuum, capace di rendere conto di una traiettoria che fa leva sulla peculiarità di una presunta Italian Theory, quello di Differenze italiane rimanda alla dispersione, al tentativo di cartografare un territorio che tende a sfuggire, difficilmente confinabile, capace di inseguire linee di ricerca inedite. Siamo nell’ossimoro appunto: confermato dal fatto che, nel volume, la locuzione “Italian Theory” è chiamata in causa per definire la specificità di un pensiero aspecifico, l’unità presunta di una fucina d’idee che è piuttosto disseminata, disomogenea e disorganica. In altre parole l’espressione “Italian Theory” cerca di definire e contenere un’attività teorica che corrode l’unità dall’interno.
Con Differenze italiane. Politica e filosofia: mappe e sconfinamenti si fa un salto nell’ossimoro. Il volume, curato da Dario Gentili ed Elettra Stimilli per DeriveApprodi (Roma 2015), è composto per buona parte dagli interventi del convegno internazionale Italian Theory existe-t-elle? tenutosi a Parigi nel gennaio 2014. Esiste una “teoria italiana”, una specificità del pensiero filosofico-politico italiano contemporaneo rispetto ad altre tradizioni e scuole di pensiero? L’Italian Theory può essere considerata una scuola o una tradizione di pensiero? “Italian Theory” e “differenze italiane”: due espressioni che sono anche i titoli degli ultimi due lavori di Gentili. Se il sottotitolo del primo, Dall’operaismo alla biopolitica, rivela il tentativo di tracciare una linea, un continuum, capace di rendere conto di una traiettoria che fa leva sulla peculiarità di una presunta Italian Theory, quello di Differenze italiane rimanda alla dispersione, al tentativo di cartografare un territorio che tende a sfuggire, difficilmente confinabile, capace di inseguire linee di ricerca inedite. Siamo nell’ossimoro appunto: confermato dal fatto che, nel volume, la locuzione “Italian Theory” è chiamata in causa per definire la specificità di un pensiero aspecifico, l’unità presunta di una fucina d’idee che è piuttosto disseminata, disomogenea e disorganica. In altre parole l’espressione “Italian Theory” cerca di definire e contenere un’attività teorica che corrode l’unità dall’interno.Il volume si divide in tre parti – la prima delle quali racchiude i saggi che cercano di definire la peculiarità dell’Italian Theory, la seconda è dedicata alle categorie preminenti nel dibattito filosofico-politico italiano contemporaneo (immanenza, dispositivo, crisi, improprietà, ecc.) e la terza esplora possibili usi di queste categorie in differenti ambiti (dalla letteratura all’architettura) – e si apre con il saggio di Roberto Esposito, un saggio programmatico che cerca di focalizzare sia la specificità del pensiero italiano rispetto ad altre tradizioni di pensiero, sia le possibili aperture. L’Italian Thought (tale espressione produce già uno scarto significativo rispetto a “Italian Theory”, ponendo l’accento sul farsi del pensiero, sulla sua attività, piuttosto che sulle griglie e gli schemi di una teoria) si costituisce non a partire da una dislocazione geografica, come è stato per la German Philosophy e per la French Theory – sorte, l’una successivamente all’emigrazione verso l’America di molti intellettuali tedeschi ebrei in fuga dalle persecuzioni razziali, l’altra dopo che alcuni filosofi francesi, già celebri in patria, furono invitati negli Stati Uniti dalle università americane – ma dalla specificità del suo fuori: la dimensione del politico. Inoltre il pensiero italiano contemporaneo «non si genera, come per la scuola di Francoforte, dal programma di un Istituto e neanche dalle teorie complesse che, a ridosso della stagione strutturalista, hanno caratterizzato i primi testi degli autori francesi» (p. 12). Il fuori che mobilita il pensiero italiano è piuttosto lo spazio conflittuale della prassi politica. Questa, però, è per Esposito una caratteristica di lunga durata (a differenze di quanto ritiene Gentili, che la fa risalire alla stagione operaista), presente nel pensiero italiano dagli albori del mondo moderno, così come è di lunga durata la centralità di un’altra categoria, che costituisce «l’orizzonte semantico del pensiero italiano» (p. 13): la categoria di vita – la quale è costantemente messa in tensione con quelle di politica e di storia. Ci sembra allora opportuno approfondire Differenze Italiane seguendo tre vettori: il fuori, la vita, il conflitto; tre categorie che troviamo intrecciate, sovrapposte, miscelate e declinate in maniera diversa negli interventi che compongono il volume.
Per Esposito, dunque, la cifra autentica del pensiero italiano sarebbe, da una parte, una forma di estroflessione intesa come tensione fattuale, evenemenziale, uno sporgersi sull’esterno storico-sociale e, dall’altra parte, una relazione più o meno conflittuale tra norme e forme di vita, tra bios e potere. Il fuori del pensiero, in questo senso, è una dimensione conflittuale, dove si trovano in tensione politica e vita. Ma è anche possibile interrogarsi sul fuori del pensiero italiano mostrando, in maniera genealogica, da quale milieu culturale provengano le categorie maggiormente in uso tra i sostenitori dell’Italian Theory. È ciò che fa Sandro Chignola prendendo in esame il decentramento attraverso il quale l’operaismo italiano ha assorbito il patrimonio teorico e concettuale della filosofia francese del dopoguerra e analizzando in che modo questo abbia permesso di «rimettere in movimento un’analisi, a un tempo stesso teorica e politica, discussa e recepita sul piano globale perché programmaticamente situata nel piano di immanenza del farsi-mondo del capitale» (p. 32). Come sottolinea Riccardo Baldissone, più che di innesto, occorrerebbe parlare di chiasmo: «il divenire francese dell’Italian Theory si incrocia, per cosi dire, col divenire italiano della French Theory» (p. 108); emergerebbe, allora, la tendenza alla contaminazione e all’ibridazione con altri paradigmi che per Esposito caratterizza il pensiero italiano fin dal Rinascimento. Questa tendenza è stata ripresa anche dal saggio di Sandro Mezzadra e discussa su un piano geopolitico. Per Mezzadra il pensiero del fuori è la forzatura delle categorie utilizzate attraverso la messa in tensione di queste con esperienze capaci di porle in discussione, magari contestandone lo statuto universale e svelandone la particolarità storica e geografica al fine di reinventarle. La tensione che così si crea è quella tra l’universalismo, che Mezzadra considera imprescindibile per creare piattaforme di comunicazione e contro-saperi, con situazioni particolari e singolari che destabilizzano questa pretesa, costringendo le categorie a ridefinirsi e articolarsi diversamente. Il pensiero italiano deve allora misurarsi con un sistema capitalistico che ha perso il suo centro occidentale cercando di ridefinire una geopolitica della conoscenza in grado di provincializzare l’Europa (p. 60). Si tratterebbe, dunque, di mettere in tensione le categorie italiane calandole in contesti distanti, per valutarne la plasticità e la capacità germinativa, aprendole all’improprio, sottoponendole a una continua contaminazione ed esponendole a una costante alterazione.
L’alterazione è chiamata in causa anche nella costruzione di un’ontologia del vivente che voglia scongiurare il pericolo di reificare, positivizzare e idealizzare la vita: è ciò che, secondo Vittoria Borsò, ha tentato di fare Esposito nella sua trilogia (composta da Communitas, Immunitas e Bios). Borsò mette in luce che per Esposito «la norma degli organismi viventi è la tendenza continua a una decostruzione del proprio» (p. 124). A differenza del diritto politico, infatti, la norma biologica non produce prescrizioni (qui Georges Canguilhem è il riferimento principale): «la sua dinamica è la plasticità del sistema, ossia la capacità di alterarsi per drift, per deviazione» (ibidem). La norma è sempre immanente alla vita ed è a partire da questa immanenza che può essere pensata una politica della vita contrapposta a una politica sulla vita. Borsò sottolinea la ricaduta che questo discorso ha sul piano antropologico: l’uomo può venire pensato a partire dal vettore deterritorializzante dell’animalizzazione, intesa anch’essa come alterazione dell’essere umano, capace di ridefinire la specie in termini non più umanistici, o antropologici, ma antropotecnici e biotecnologici. In questo senso la riflessione sulla vita s’intreccia con quella sulla tecnica.

Tale intreccio è preso in esame da Marco Assennato da una prospettiva affatto particolare, attraverso cioè la questione sulla tecnica che vede coinvolti Raniero Panzieri e Massimo Cacciari. Per Assennato il rapporto tra bios e potere, tra norme e forme di vita, è sempre tecnologicamente mediato. Se in Sull’uso capitalistico delle macchine e Plusvalore e pianificazione Panzieri invita a pensare la tecnica a partire da una critica della dialettica che mira a contestare le letture metafisico-idealistiche che fanno dell’Aufhebung l’orizzonte trascendentale di ogni determinazione reale, Cacciari, con la sua filosofia della krisis, reintroduce una lettura destinale della stessa, nella quale nessun intervento soggettivo sarebbe capace di rompere il dominio tecnologico e dove il capitale, inteso come successione di crisi, sussumerebbe qualsiasi tentativo di rottura, riconducendo al suo linguaggio ogni antagonismo. Ciò non lascia altra soluzione se non quella di propugnare l’autonomia del politico come luogo capace di contenere e pilotare il processo dall’alto. Secondo Panzieri, per il quale la scienza e la tecnica sono il luogo di una contesa di potere nel sapere, non si tratta di rivelare l’occulta razionalità insita nel moderno processo produttivo, quanto di costruire una razionalità radicalmente nuova e contrapposta a quella prodotta nel capitalismo. La tecnologia è allora un campo di tensione, il luogo di una contesa e non un destino tragico, ineluttabile e implicito nelle premesse del processo. La posta in gioco ruota intorno a un rapporto diverso tra uomo e macchina, che rimanda a un’etica emergente e a composizioni inedite.
Per Panzieri, dunque, la tecnologia, che nel biopotere contemporaneo funziona da collante tra la vita e il potere, è il luogo di un conflitto. È su quest’ultima categoria che fanno leva gli interventi di Antonio Negri e di Judith Revel. Per Negri la novità della pratica e del pensiero che si affaccia in Italia negli anni ’60 si dispone proprio all’interno di un conflitto politico: l’operaismo nasce dalla preminenza della pratica sulla teoria, dove la cassetta degli attrezzi precede tutto il resto. Si trattava, per l’operaismo, di criticare la visione storicista di stampo gramsciano-togliattiana e l’ortodossia del PCI, nelle quali si confondevano continuità dello stato e innovazione socialista. L’operaismo, invece, come afferma Revel, pone l’accento sulla storicizzazione dell’analisi e sulla soggettivazione (p. 51): non esistono soggetti politici, ma processi di soggettivazione legati al conflitto. La classe non è un’entità, non è un soggetto, ma è il prodotto della lotta, è composta dal conflitto stesso.
 Sia per Negri sia per Revel l’Italian Theory – e qui gli obiettivi polemici sono principalmente Giorgio Agamben ed Esposito – occulta questa dimensione del conflitto pur riconoscendola: se per Negri l’Italian Theory è «l’ennesimo schema storiografico debole che conduce a pacificazione le determinazioni temporali e locali del processo storico» (p. 27) distogliendo l'attenzione dalla fenomenologia contradditoria del biopotere, eliminando ogni punto di vista storicamente determinato, eticamente situato e politicamente orientato e portando a una pacificazione che esclude ogni emergenza autonoma di nuove potenze che conducono a rottura; per Revel la categoria di vita nasconderebbe un «doppio vuoto» (p. 54) nella riflessione politico-filosofica italiana contemporanea, quello della storicizzazione e della soggettivazione, che non sono solo i capisaldi dell’operaismo ma anche del pensiero di Michel Foucault, per il quale la vita è un indicatore epistemologico, sempre posto in essere da un sapere-potere, dunque inquadrabile in termini biopolitici attraverso un preciso riferimento storico, quello che vede l’emergere dei dispositivi securitari e di precise strategie di governo.
Sia per Negri sia per Revel l’Italian Theory – e qui gli obiettivi polemici sono principalmente Giorgio Agamben ed Esposito – occulta questa dimensione del conflitto pur riconoscendola: se per Negri l’Italian Theory è «l’ennesimo schema storiografico debole che conduce a pacificazione le determinazioni temporali e locali del processo storico» (p. 27) distogliendo l'attenzione dalla fenomenologia contradditoria del biopotere, eliminando ogni punto di vista storicamente determinato, eticamente situato e politicamente orientato e portando a una pacificazione che esclude ogni emergenza autonoma di nuove potenze che conducono a rottura; per Revel la categoria di vita nasconderebbe un «doppio vuoto» (p. 54) nella riflessione politico-filosofica italiana contemporanea, quello della storicizzazione e della soggettivazione, che non sono solo i capisaldi dell’operaismo ma anche del pensiero di Michel Foucault, per il quale la vita è un indicatore epistemologico, sempre posto in essere da un sapere-potere, dunque inquadrabile in termini biopolitici attraverso un preciso riferimento storico, quello che vede l’emergere dei dispositivi securitari e di precise strategie di governo.Abbiamo così un quadro che ci permette di cogliere un minimo comun denominatore tra le differenze italiane: come sostiene Baldissone, il tratto condiviso risiederebbe nell’operazione, ereditata dal pensiero francese del dopoguerra, di pensare in termini di processi e non di entità, di produzione e non di rappresentazione (p. 107). Questa operazione, però, si esprimerebbe in due modi diversi nel pensiero politico-filosofico italiano contemporaneo: da una parte il tentativo di costruire un’ontologia del vivente capace di dinamizzare la categoria di vita dall’interno con il fine di aprire alla possibilità di una politica della vita contrapposta a una politica sulla vita (mutazione, contaminazione, ibridazione ne sarebbero i vettori principali); dall’altra pensare il processo in termini storici, facendo leva sulla concretezza del lavoro vivo, della potenza costituente, del capitale variabile, della cooperazione produttiva contro la cattura del biopotere. Due modi di intendere la biopolitica che convergono nella critica della teologia politica, sia nella versione katechonica dell’autonomia del politico di Mario Tronti e del pensiero della krisis di Cacciari, sia in quella mistica ed escatologica di Agamben.
Per dirla con Federico Luisetti, da una parte troviamo un pensiero selvaggio che ha “somiglianze di famiglia” con i lavori di Gilles Deleuze e Félix Guattari, di Claude Lévi-Strauss e di Pierre Clastres e che si prepone la «ridefinizione dello stato di natura occidentale e del quarto nomos della terra» (p. 79); dall’altra un pensiero barbarico, che fa capo al testo di Foucault Bisogna difendere la società, «in grado di assorbire il naturalismo nella storia e nella critica» e che mira a una «barbarie storica costituente» (p. 73).
Le differenze italiane, allora, possono essere considerate come il prodotto di un’oscillazione tra queste due polarità, disparate ma accumunabili per analogia, che si sovrappongono senza identificarsi nella critica delle categorie politiche della modernità, della sovranità statale, e della governamentalità economicista. Non si tratta di due traiettorie inconciliabili, tant’è vero che convergono verso lo stesso oggetto critico; ci sono, piuttosto, delle ragioni strategiche per mantenerle in tensione, rintracciabili nell’esigenza di non racchiudere questa fucina di proposte nei confini di una teoria, ma facendole giocare tra di loro. Far giocare le differenze italiane contro l’Italian Theory, la quale rischia, se non lo è già, di trasformarsi in un semplice marchio, in un logo che immobilizza un pensiero vivente.
di Luca Fabbris
-
Corpi che non contano. Judith Butler e gli animali
Recensioni / Dicembre 2015 Vengono smembrati, disossati, cucinati e infine divorati. Vengono sfruttati, vivisezionati, modificati e poi sacrificati. Sono i corpi animali, i corpi che (ancora) non contano – o meglio: contano in termini nutritivi, economici e scientifici; contano, insomma, da un punto di vista antropocentrico. Sono materia prima, corpi senza vita che l’uomo plasma come vuole e di cui non piange le uccisioni. Sono piccoli blocchi, mattoncini di carne sui quali l’uomo ha fondato il suo impero, edificato e arroccato su principi di naturalità che soltanto oggi, con immensa lentezza e fatica, iniziano a essere minimamente scalfiti. La messa in discussione dei ruoli assegnati sulla base del naturalismo è un processo complicato ma necessario, in quanto mina la binarizzazione gerarchizzante di base: natura da una parte, cultura dall’altra. Compiere questo primo ma fondamentale passo porta alla ridefinizione dei ruoli svolti dagli esseri, abolendo l’assegnazione degli stessi “per natura” e sviluppando al contempo nuove concezioni e definizioni: ruolo come dimensione in cui muoversi e agire, ruolo come spazio in cui si fa e si disfa, ruolo come luogo libero che accoglie la performance dell’animale, umano e non. Il volume collettaneo Corpi che non contano. Judith Butler e gli animali (Mimesis, 2015) si pone l’obiettivo di testare, come annuncia provocatoriamente il curatore Massimo Filippi nell’introduzione, il pensiero di Judith Butler sugli animali. Se la domanda cardine del pensiero butleriano è «A chi spetta una buona vita?», quale lavoro filosofico meglio del suo può essere utile da incorporare negli Animal Studies? Nonostante la pensatrice americana non abbia mai esteso il suo ragionamento agli animali non umani, all’interno dei suoi studi sono molteplici gli strumenti e i concetti potenzialmente utili (vita precaria, performatività, lutto…) alla demolizione delle binarizzazioni oppositive e al riconoscimento dell’altro non umano. Nella breve intervista presentata all’interno del volume, è la stessa Butler a elogiare i movimenti antispecisti per lo sforzo che stanno compiendo in questa direzione: «Sono convinta che questi movimenti si stiano sforzando di mettere in rilievo le reti di interdipendenza che normalmente non vengono riconosciute». Non resta dunque che limare le derive antropocentriche del pensiero butleriano e inaugurare nuove strade che ci portino lontano dalla norma vigente, mettendola in discussione come i movimenti femministi e queer hanno fatto nei decenni passati nei confronti del pensiero eteronormato, riscuotendo successi e raggiungimenti filosofici, sociali e mediatici allora insperati.
Vengono smembrati, disossati, cucinati e infine divorati. Vengono sfruttati, vivisezionati, modificati e poi sacrificati. Sono i corpi animali, i corpi che (ancora) non contano – o meglio: contano in termini nutritivi, economici e scientifici; contano, insomma, da un punto di vista antropocentrico. Sono materia prima, corpi senza vita che l’uomo plasma come vuole e di cui non piange le uccisioni. Sono piccoli blocchi, mattoncini di carne sui quali l’uomo ha fondato il suo impero, edificato e arroccato su principi di naturalità che soltanto oggi, con immensa lentezza e fatica, iniziano a essere minimamente scalfiti. La messa in discussione dei ruoli assegnati sulla base del naturalismo è un processo complicato ma necessario, in quanto mina la binarizzazione gerarchizzante di base: natura da una parte, cultura dall’altra. Compiere questo primo ma fondamentale passo porta alla ridefinizione dei ruoli svolti dagli esseri, abolendo l’assegnazione degli stessi “per natura” e sviluppando al contempo nuove concezioni e definizioni: ruolo come dimensione in cui muoversi e agire, ruolo come spazio in cui si fa e si disfa, ruolo come luogo libero che accoglie la performance dell’animale, umano e non. Il volume collettaneo Corpi che non contano. Judith Butler e gli animali (Mimesis, 2015) si pone l’obiettivo di testare, come annuncia provocatoriamente il curatore Massimo Filippi nell’introduzione, il pensiero di Judith Butler sugli animali. Se la domanda cardine del pensiero butleriano è «A chi spetta una buona vita?», quale lavoro filosofico meglio del suo può essere utile da incorporare negli Animal Studies? Nonostante la pensatrice americana non abbia mai esteso il suo ragionamento agli animali non umani, all’interno dei suoi studi sono molteplici gli strumenti e i concetti potenzialmente utili (vita precaria, performatività, lutto…) alla demolizione delle binarizzazioni oppositive e al riconoscimento dell’altro non umano. Nella breve intervista presentata all’interno del volume, è la stessa Butler a elogiare i movimenti antispecisti per lo sforzo che stanno compiendo in questa direzione: «Sono convinta che questi movimenti si stiano sforzando di mettere in rilievo le reti di interdipendenza che normalmente non vengono riconosciute». Non resta dunque che limare le derive antropocentriche del pensiero butleriano e inaugurare nuove strade che ci portino lontano dalla norma vigente, mettendola in discussione come i movimenti femministi e queer hanno fatto nei decenni passati nei confronti del pensiero eteronormato, riscuotendo successi e raggiungimenti filosofici, sociali e mediatici allora insperati.Quando il 26 ottobre 2015 l’International Agency for Research on Cancer – agenzia facente parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità – diffonde un comunicato con cui informa che le carni rosse sono probabilmente cancerogene e le carni rosse lavorate (insaccati e salumi) sono sicuramente cancerogene, un brivido di inquietudine – nella maggioranza dei casi carico di inesattezze scientifiche e macchiato di qualunquismo e semplificazioni – getta nello scompiglio l’opinione pubblica. Il dibattito che ne consegue è, ancora una volta, unidirezionale, tecnoscientifico e antropocentrico, ma permette di mettere in luce alcuni aspetti discussi in Corpi che non contano. La reazione alla diffusione del rapporto dello IARC infatti mette in evidenzia ciò che nell’ultimo saggio Federico Zappino definisce “norma sacrificale”. Si tratta della norma che, ancora più di quella eterosessuale, è stata forclusa, resa non evidente, inintelligibile. È il sacrificio perpetuo di miliardi di animali non umani, un sacrificio dal quale è complicato liberarci se si tengono presenti i desideri che esso soddisfa (il consumo di carne a tavola, per esempio) e la soggettivazione di cui è parte integrante. Come liberare l’uomo da un desiderio senza doverlo castrare e reprimere, si chiede Zappino? Seguendo le orme di Foucault, è bene lasciare spazio a nuovi desideri, creativi e fluidi, che possano accompagnare in modo libero la critica alla norma vigente, dando vita a nuove dimensioni da sperimentare.
Quando la norma resiste agli scossoni – come ha dimostrato la reazione al comunicato dell’OMS, veicolata attraverso messaggi pregni di “orgoglio carneo” e talvolta venati da caustico umorismo – allora è necessario intaccarla alla radice; questo è l’obiettivo che si pongono James Stanescu e Richard Iveson, che firmano un saggio a testa nel volume. Entrambi pongono l’accento sull’errore di considerare l’animale quale pre-condizione dell’umano. Si tratta di uno scivolone che coinvolge anche Judith Butler in Frames of war, in cui ancora una volta viene promulgata un’idea profondamente umanista e fondata su quell’eccezionalismo umano che dovrebbe essere la prima barriera da abbattere per intavolare una discussione critica sul rapporto interspecifico. In quest’ottica, lo stesso concetto di umano diventa norma, escludendo tutto ciò che non rientra in questa categoria dalla considerazione e relegandolo a un “grado zero” (l’animalità) su cui fondare il dominio dell’uomo sul mondo. La carne degli animali è quindi soltanto meat [carne morta] e non flesh [carne viva], è altro da noi umani, è soltanto materia inerte potenzialmente cancerosa – salsicce, wurstel, salumi, braciole, costolette – e, soprattutto, non è meritevole di lutto. La morte dell’animale per mano umana non è, dunque, omicidio, cioè morte degna di essere compianta, ma mera uccisione, morte senza ricordo, perché dovuta, necessaria e, ovviamente, naturale.
Accanto al concetto di lutto, a lungo esplorato da Butler nel corso della sua carriera, si affianca quello di vita precaria, punto cardine nell’applicazione del pensiero butleriano agli Animal Studies secondo Stanescu. La precarietà – essendo prima di tutto una condizione collettiva e non individuale – pone l’accento sulle connessioni e sulla relazione ed è, secondo Butler, un luogo da cui partire per riorganizzarsi e non uno stadio da superare. Inoltre, la precarietà è sia un luogo che una questione ontologica; un concetto cruciale ma da cui non dobbiamo difenderci, perché la minaccia reale è l’immunità con cui schermiamo la precarietà stessa, operando processi di disconoscimento nei confronti dell’Altro. «Tramite un rifiuto di affrontare la nostra finitudine corpeizzata e condivisa», scrive Stanescu, operiamo la prima spaccatura che ci separa dal bios dell’animale non umano. Solo muovendo dalla nostra precarietà possiamo comprendere che la carne che consumiamo e sfruttiamo in molteplici modi prima di essere lavorata (e diventare cancerogena) si muove, si nutre e si riproduce: è viva, ed è animale tanto quanto la nostra.
Ogni anno su questo pianeta vengono uccisi circa centocinquanta miliardi di animali non umani. Dati simili sono spesso inintelligibili, nascosti agli occhi dei più e radicati profondamente nella norma sacrificale. Come ricorda Marco Reggio nel suo intervento in Corpi che non contano, il pensiero butleriano può essere fondamentale per portare alla luce i rapporti di interdipendenza fra uomo e animali non umani e per mettere in discussione il concetto stesso di umano e il suo eccezionalismo. Fra le maglie della rete che tenta di opprimere e nascondere la solidarietà interspecifica, si fanno strada studi – come questo – che portano a galla verità soggiacenti, da sempre presenti ma, speriamo, ancora per poco ignorate.
di Danilo Zagaria
-
Ancora troppo umani. Il postumano di Giovanni Leghissa
Recensioni / Ottobre 2015 Nel suo saggio Postumani per scelta. Verso un’ecosofia dei collettivi, ospite della collana “Spiritualità senza Dio?” diretta da Luigi Berzano, Giovanni Leghissa dà unitarietà a un tema che ormai lo vede occupato da alcuni anni (La fondazione, la fondazione dell’umano, il post-umano, 2013; Il postumano: un nuovo paradigma?, 2013; curatela di aut aut, La condizione postumana, 2014). Nonostante la brevità del saggio, l’autore si propone di soddisfare la duplice esigenza teorica di inquadrare da più vicino lo sfuggente dibattito sulla questione postumana e, insieme, di estrarne una possibile interpretazione critica. Così, alla messa in ordine di linee guida di una discussione spesso frammentaria, si affianca l’argomentazione di una tesi, frutto dell’incontro di assi di ricerca eterogenei ma convergenti. Le fonti e le questioni interpellate sono infatti numerose e provenienti dalle più disparate aree del sapere filosofico. Tra i “maestri” e le tradizioni di pensiero che vediamo avvicendarsi figurano l’illuminismo, l’evoluzionismo, la filosofia francese del dopoguerra, l’epistemologia, la fenomenologia husserliana, l’idea di un sapere enciclopedico alla Enzo Paci, la decostruzione e l’antropologia filosofica di Hans Blumenberg. Come dichiara l’autore, si tratterà allora di seguire questi molteplici stimoli nell’intento di definire la condizione postumana in termini filosofici, individuando e descrivendo schematicamente gli atteggiamenti caratteristici del suo approccio.
Nel suo saggio Postumani per scelta. Verso un’ecosofia dei collettivi, ospite della collana “Spiritualità senza Dio?” diretta da Luigi Berzano, Giovanni Leghissa dà unitarietà a un tema che ormai lo vede occupato da alcuni anni (La fondazione, la fondazione dell’umano, il post-umano, 2013; Il postumano: un nuovo paradigma?, 2013; curatela di aut aut, La condizione postumana, 2014). Nonostante la brevità del saggio, l’autore si propone di soddisfare la duplice esigenza teorica di inquadrare da più vicino lo sfuggente dibattito sulla questione postumana e, insieme, di estrarne una possibile interpretazione critica. Così, alla messa in ordine di linee guida di una discussione spesso frammentaria, si affianca l’argomentazione di una tesi, frutto dell’incontro di assi di ricerca eterogenei ma convergenti. Le fonti e le questioni interpellate sono infatti numerose e provenienti dalle più disparate aree del sapere filosofico. Tra i “maestri” e le tradizioni di pensiero che vediamo avvicendarsi figurano l’illuminismo, l’evoluzionismo, la filosofia francese del dopoguerra, l’epistemologia, la fenomenologia husserliana, l’idea di un sapere enciclopedico alla Enzo Paci, la decostruzione e l’antropologia filosofica di Hans Blumenberg. Come dichiara l’autore, si tratterà allora di seguire questi molteplici stimoli nell’intento di definire la condizione postumana in termini filosofici, individuando e descrivendo schematicamente gli atteggiamenti caratteristici del suo approccio. -
CRUDELTÀ, SOVRANITÀ, RESISTENZA NELLA PSICANALISI
Longform / Luglio 2015[…] gli Stati generali sono sempre convocati nei momenti critici, quando una crisi politica richiede una scelta, e prima una liberazione della parola in vista di una decisione d’eccezione che dovrà impegnare l’avvenire (Derrida, 2013, p. 56)
Stati d’animo della psicanalisi è il titolo della conferenza tenuta alla Sorbona da Jacques
 Derrida nel luglio 2000, in apertura degli Stati generali della psicoanalisi, occasione straordinaria di confronto tra psicoanalisti di tutto il mondo appartenenti alle diverse correnti del movimento psicoanalitico. La conferenza, uscita in Francia nel 2000 (Derrida 2000), è stata pubblicata in Italia alla fine del 2013 dalla casa editrice ETS, nella pregevole traduzione di Claudia Furlanetto, che ha curato il volume arricchendolo con un’agile e chiara introduzione e con un’ampia intervista a René Major, filosofo molto vicino alla psicanalisi di orientamento lacaniano e amico personale di Derrida. È proprio Major a ricostruire la lunga gestazione degli Stati generali, da lui stesso promossi e organizzati con tre anni di lavoro preparatorio, ma concepiti sin dalla fine degli anni Settanta, ai tempi delle dittature in Brasile e in Argentina. L’esigenza più urgente di Major era stata allora quella di denunciare le opacità dei rapporti tra la psicoanalisi e il potere, che andavano dalla complicità vera e propria di alcuni analisti nei crimini commessi dagli apparati di stato, alle azioni dissuasive messe in atto da una parte delle istituzioni psicanalitiche per insabbiare lo scandalo. In seguito lo spazio del confronto si sarebbe ampliato, fino a portare in primo piano la questione del senso politico della psicoanalisi. Alla caduta dei regimi sudamericani non fece infatti seguito un’epoca di pace e rispetto dei diritti umani nel mondo; d’altra parte i primi a violarli erano e restavano in molti casi i cosiddetti baluardi della democrazia, data la presenza della pena di morte in diversi stati americani. Anche in questo caso, le dichiarazioni di denuncia da parte delle istituzioni psicanalitiche rimanevano vaghe, come se, al di là dell’opportunismo, si volesse evitare di assumere una precisa posizione di condanna. Come se la psicanalisi, rispetto al potere – in particolare al potere di far soffrire – dovesse mantenersi a distanza.
Derrida nel luglio 2000, in apertura degli Stati generali della psicoanalisi, occasione straordinaria di confronto tra psicoanalisti di tutto il mondo appartenenti alle diverse correnti del movimento psicoanalitico. La conferenza, uscita in Francia nel 2000 (Derrida 2000), è stata pubblicata in Italia alla fine del 2013 dalla casa editrice ETS, nella pregevole traduzione di Claudia Furlanetto, che ha curato il volume arricchendolo con un’agile e chiara introduzione e con un’ampia intervista a René Major, filosofo molto vicino alla psicanalisi di orientamento lacaniano e amico personale di Derrida. È proprio Major a ricostruire la lunga gestazione degli Stati generali, da lui stesso promossi e organizzati con tre anni di lavoro preparatorio, ma concepiti sin dalla fine degli anni Settanta, ai tempi delle dittature in Brasile e in Argentina. L’esigenza più urgente di Major era stata allora quella di denunciare le opacità dei rapporti tra la psicoanalisi e il potere, che andavano dalla complicità vera e propria di alcuni analisti nei crimini commessi dagli apparati di stato, alle azioni dissuasive messe in atto da una parte delle istituzioni psicanalitiche per insabbiare lo scandalo. In seguito lo spazio del confronto si sarebbe ampliato, fino a portare in primo piano la questione del senso politico della psicoanalisi. Alla caduta dei regimi sudamericani non fece infatti seguito un’epoca di pace e rispetto dei diritti umani nel mondo; d’altra parte i primi a violarli erano e restavano in molti casi i cosiddetti baluardi della democrazia, data la presenza della pena di morte in diversi stati americani. Anche in questo caso, le dichiarazioni di denuncia da parte delle istituzioni psicanalitiche rimanevano vaghe, come se, al di là dell’opportunismo, si volesse evitare di assumere una precisa posizione di condanna. Come se la psicanalisi, rispetto al potere – in particolare al potere di far soffrire – dovesse mantenersi a distanza. -
 Grazie all'analisi foucaultiana sul biopotere e sul soggetto, al focus posto da Butler sul gender e all'ampia proliferazione di analisi che ne sono seguite, la capacità performativa dei discorsi di potere e di sapere dominanti in una data epoca sulla materialità umana è stata ampiamente esplorata. Il testo di Alessandro Baccarin, Il sottile discrimine. I corpi tra dominio e tecnica del sé, si inserisce in questo panorama in maniera intelligente e feconda, analizzando attentamente soggetti e corpi tipici della contemporaneità attraverso una genealogia rapida ma puntuale, capace di cogliere le svolte storiche salienti dal loro emergere, e invitando a riflettere più ponderatamente tanto sulle nuove modalità assunte dalle pratiche di dominio del biopotere sul corpo quanto sulle forme di resistenza possibile. Ciò che vi è di veramente interessante nel testo è la lente di ingrandimento che l'autore pone sul cardine su cui si articola l'assoggettamento – termine di origine foucaultiana, e approfondito da Butler per mezzo della psicoanalisi, che designa contemporaneamente sia la subordinazione sia la soggettivazione psichica e sociale di cui è capace un potere intenso, diffuso, relazionale, produttivo, totalizzante e individualizzante. Ebbene, Baccarin interroga proprio quel “sottile discrimine” caratteristico della dinamica dell'assoggettamento. Se il soggetto occidentale moderno è un effetto di dinamiche di potere, a sua volta dotato di potere proprio perché emerso dall'interazione produttiva e continua tra tecniche di dominio e tecniche del sé, bisogna allora porre al centro dell'analisi e delle controcondotte il corpo e le pratiche che su e attraverso questo vengono agite. In altre parole, è importante far emergere gli attuali processi di normalizzazione nonché le tecniche del sé corporee che costituiscono oggi l'a priori in base al quale i soggetti operano all'interno di nuove relazioni di potere, e rispetto alle quali, spesso troppo ottimisticamente o semplicisticamente, si proclamano, o vengono proclamati, autonomi. Con il suo testo Baccarin dunque chiarisce sia sotto quali vesti si presenti attualmente il biopotere neoliberale nella nostra società, sia quanto quelle pratiche, quei corpi, quei soggetti comunemente oggi assunti come esemplari delle possibilità di resistenza intrinseche ai soggetti e ai rapporti di potere che li hanno prodotti – tra i quali l'autore sceglie di occuparsi di omosessuali, transessuali, tatuati e pornostar – siano solo parzialmente tali, rilanciando la necessità di elaborare, in linea con il messaggio foucaultiano, nuove linee di fuga.
Grazie all'analisi foucaultiana sul biopotere e sul soggetto, al focus posto da Butler sul gender e all'ampia proliferazione di analisi che ne sono seguite, la capacità performativa dei discorsi di potere e di sapere dominanti in una data epoca sulla materialità umana è stata ampiamente esplorata. Il testo di Alessandro Baccarin, Il sottile discrimine. I corpi tra dominio e tecnica del sé, si inserisce in questo panorama in maniera intelligente e feconda, analizzando attentamente soggetti e corpi tipici della contemporaneità attraverso una genealogia rapida ma puntuale, capace di cogliere le svolte storiche salienti dal loro emergere, e invitando a riflettere più ponderatamente tanto sulle nuove modalità assunte dalle pratiche di dominio del biopotere sul corpo quanto sulle forme di resistenza possibile. Ciò che vi è di veramente interessante nel testo è la lente di ingrandimento che l'autore pone sul cardine su cui si articola l'assoggettamento – termine di origine foucaultiana, e approfondito da Butler per mezzo della psicoanalisi, che designa contemporaneamente sia la subordinazione sia la soggettivazione psichica e sociale di cui è capace un potere intenso, diffuso, relazionale, produttivo, totalizzante e individualizzante. Ebbene, Baccarin interroga proprio quel “sottile discrimine” caratteristico della dinamica dell'assoggettamento. Se il soggetto occidentale moderno è un effetto di dinamiche di potere, a sua volta dotato di potere proprio perché emerso dall'interazione produttiva e continua tra tecniche di dominio e tecniche del sé, bisogna allora porre al centro dell'analisi e delle controcondotte il corpo e le pratiche che su e attraverso questo vengono agite. In altre parole, è importante far emergere gli attuali processi di normalizzazione nonché le tecniche del sé corporee che costituiscono oggi l'a priori in base al quale i soggetti operano all'interno di nuove relazioni di potere, e rispetto alle quali, spesso troppo ottimisticamente o semplicisticamente, si proclamano, o vengono proclamati, autonomi. Con il suo testo Baccarin dunque chiarisce sia sotto quali vesti si presenti attualmente il biopotere neoliberale nella nostra società, sia quanto quelle pratiche, quei corpi, quei soggetti comunemente oggi assunti come esemplari delle possibilità di resistenza intrinseche ai soggetti e ai rapporti di potere che li hanno prodotti – tra i quali l'autore sceglie di occuparsi di omosessuali, transessuali, tatuati e pornostar – siano solo parzialmente tali, rilanciando la necessità di elaborare, in linea con il messaggio foucaultiano, nuove linee di fuga.Capita spesso, infatti, di veder assumere, nei dibattiti su questi temi, come soggetti liberi, autodeterminati, resistenti, coloro che sono prevalentemente stigmatizzati e discriminati nella nostra società, i cosiddetti “trasgressori” odierni, in quanto smarcati dalle norme imperanti nella contemporaneità: dell'eterosessualità obbligatoria; del corpo privo di segni – se non quelli dell'abiezione – tipico della tradizione occidentale; di una sessualità familiare, procreativa, privata, stabile. Ora, dalla lettura del testo tale elezione appare semplicistica sia perché, secondo la lezione foucaultiana e butleriana, non esiste un luogo del grande rifiuto al di là della realtà in cui noi tutti viviamo: non possiamo vivere senza un riconoscimento sociale che renda la vita del singolo, intrinsecamente precaria, una vita possibile e vivibile, sia perché il biopotere è in grado di riposizionarsi continuamente. Infatti, sebbene l'azione del potere non sia mai deterministica perché non esiste un potere assoluto e fondante, bensì si danno solo relazioni di potere tra soggetti liberi dotati di agency, e malgrado il fatto che l'assoggettamento richieda sempre una reiterazione della legge, che così per un verso si naturalizza, mentre per l'altro diviene suscettibile di alterazione, ciononostante è incessante il pericolo di una nuova e ulteriore normalizzazione delle prassi trasgressive.
 È davvero difficile individuare e percorrere una volta per tutte le strade che conducono verso un nuovo uso dei piaceri e per una denormalizzazione del corpo e del desiderio, denuncia Baccarin citando il caso del BDSM (si tratta di una pratica sessuale nata nei circoli omosessuali californiani come pratica eversiva e oggi divenuta importante genere del mercato del porno mainstream ). Ogni normalizzazione porta con sé sempre delle increspature importanti ed eversive da approfondire e perseguire, ma allo stesso tempo non bisogna mai dimenticare che il potere, proprio in virtù di tale scarto, è sempre capace di riposizionarsi a un nuovo livello. Si pensi, scrive l'autore, ai meccanismi della moda o della pubblicità, capaci di trasformare l'individuo scandaloso – per esempio i primi tatuati – in soggetto desiderante, parte del vasto catalogo di identità offerte dal sistema consumistico odierno, facendo diventare normali i corpi tatuati sui giornali di moda o negli spogliatoi calcistici. Così facendo, il corpo tatuato diviene un corpo intercettato dal biopotere, un corpo che desidera docilmente leggere su di sé la propria identità. I corpi-limite, mette in guardia Baccarin, saranno anche corpi che si mettono di traverso rispetto a una governamentalità che investe l'organicità stessa dei soggetti, ma spesso non disinnescano il meccanismo di potere che criticano, rimanendo in una posizione liminare tra norma e libertà, tra governo delle condotte ed esperienze metamorfiche autonome e resistenziali di uso dei corpi e del piacere. Questi corpi sono realmente punti di resistenza al potere, ma spesso non hanno il coraggio o la lungimiranza per esserlo davvero, riducendosi a essere punti di appoggio per una nuova azione del biopotere stesso.
È davvero difficile individuare e percorrere una volta per tutte le strade che conducono verso un nuovo uso dei piaceri e per una denormalizzazione del corpo e del desiderio, denuncia Baccarin citando il caso del BDSM (si tratta di una pratica sessuale nata nei circoli omosessuali californiani come pratica eversiva e oggi divenuta importante genere del mercato del porno mainstream ). Ogni normalizzazione porta con sé sempre delle increspature importanti ed eversive da approfondire e perseguire, ma allo stesso tempo non bisogna mai dimenticare che il potere, proprio in virtù di tale scarto, è sempre capace di riposizionarsi a un nuovo livello. Si pensi, scrive l'autore, ai meccanismi della moda o della pubblicità, capaci di trasformare l'individuo scandaloso – per esempio i primi tatuati – in soggetto desiderante, parte del vasto catalogo di identità offerte dal sistema consumistico odierno, facendo diventare normali i corpi tatuati sui giornali di moda o negli spogliatoi calcistici. Così facendo, il corpo tatuato diviene un corpo intercettato dal biopotere, un corpo che desidera docilmente leggere su di sé la propria identità. I corpi-limite, mette in guardia Baccarin, saranno anche corpi che si mettono di traverso rispetto a una governamentalità che investe l'organicità stessa dei soggetti, ma spesso non disinnescano il meccanismo di potere che criticano, rimanendo in una posizione liminare tra norma e libertà, tra governo delle condotte ed esperienze metamorfiche autonome e resistenziali di uso dei corpi e del piacere. Questi corpi sono realmente punti di resistenza al potere, ma spesso non hanno il coraggio o la lungimiranza per esserlo davvero, riducendosi a essere punti di appoggio per una nuova azione del biopotere stesso.Entrando più nello specifico, Baccarin mostra come la posta in gioco delle pratiche di libertà attuali stia nello scardinamento dei processi di veridizione (altra espressione tratta dal lessico foucaultiano) imposti dall'ermeneutica del sé propria del biopotere neoliberale, che induce i soggetti a diventare imprenditori di se stessi, creando così l'illusione dell'autodeterminazione. Egli pone prima di tutto nero su bianco quella che è la verità dei soggetti limite da lui scelti, mettendola poi sul banco degli imputati. Per esempio, la verità trans oggi vigente viene riassunta nella frase “la libertà di essere o non essere o di come essere donna/uomo”. Questa, si noti, non è la verità di un singolo particolare trans, ma la verità trans tout court, ovvero di una categoria di soggetti, di una specifica identità sociale che, per quanto considerata scandalosa, malata, trasgressiva, viene così ordinata e posizionata all'interno dell'ordine sociale vigente. Lungi dall'essere questa una pura rivendicazione dell'autonomia transessuale – come vorrebbero spesso tanto i trans quanto i teorici gender – anch'essa è da intendersi come il risultato di quell'ermeneutica del sé propria delle dinamiche del biopotere contemporaneo.
Dunque, rileva Baccarin, l'identità trans, nonché la rivendicazione della propria verità da parte dei transessuali, prodotti di una tecnica del sé congiuntamente a una tecnica del corpo che problematizza e plasma il corpo trans nel contesto di una nuova disponibilità anche plastica del corpo, è il risultato dell'ermeneutica del sé che sta all'origine del soggetto moderno. Infatti il biopotere è una razionalità di governo sorta a partire dal XVII secolo e fondata sul criterio centrifugo del laisser faire, che presuppone la libertà dei processi e dei soggetti che osserva e gestisce. Inoltre, tale governamentalità istituisce un'inedita sintesi fra potere e verità, e tra questi e i temi quali la vita, il corpo, l'individuo, il corpo sociale, che richiede a ognuno di trovare la verità del proprio desiderio: in questo caso la propria identità di genere. Di fatto, attraverso l'interazione tra tecniche di dominio e tecniche del sé, e per mezzo di vari dispositivi quali il sapere medico, psichiatrico, disciplinare, tali identità vengono più che scoperte, prodotte. Allo stesso modo funziona anche la pornografia, la quale è un caso esemplare di tale sollecitazione, estrapolazione, soggettivazione, incorporazione del desiderio sessuale. Essa è indifferente al piacere eventualmente sollecitato allo spettatore o provato dal performer – sempre e comunque solo genitale – e all'atto – meramente strumentale alla produzione di desiderio – mentre è centrale l'enorme proliferazione dei generi pornografici. Il consumo di porno suscita un desiderio che induce all'ulteriore consumo di immagini implicando, al tempo stesso, il soggetto in un processo di veridizione della propria identità sessuale, illudendo il singolo della libertà del proprio desiderio per mezzo dell'ampia scelta di generi che ha a disposizione. Nella pornografia, quindi, si congiungono a un nuovo livello processi di normalizzazione e tecniche corporee del sé secondo i binari del totalitarismo dell'esplicito e della banalizzazione del nudo e della seduzione, analogamente a quanto scriveva Foucault a proposito della moltiplicazione della philia da parte della sessuologia del XIX secolo, che reprime, mentre suscita, la discorsività sul sesso, facendola prolificare e, contemporaneamente, ampliando e specificando in questo modo la presa del potere sulle vite e sui corpi degli individui.

Il meccanismo è sempre lo stesso: si ha l'illusione che parlare di sesso e mostrarlo, ma anche scrivere sui propri corpi, plasmarli e modellarli con diete, attrezzi da ginnastica, chirurgia, sia la via per la liberazione da un potere repressivo e dall'anonimato della società dei consumi, mentre in realtà questi non sono altro che strumenti del biopotere neoliberale, il quale più che reprimere amplia la sua presa su di noi. Il biopotere suscita desideri incorporati in soggetti desideranti sotto forma di condotte che diventano oggi anche autopoiesi corporea. I tatuaggi, il piercing, le scarificazioni, la pornografia, la somatopoiesi trans – ma Baccarin aggiunge all'elenco i prodotti contraccettivi, la fecondazione assistita, i centri abbronzanti, la chirurgia estetica, le pubblicità, le diete, il nuovo valore dato alla nudità, il fitness, la moda, i corsi di strip dance – sono tutti esempi del nuovo livello di incorporazione raggiunto oggi della norma. Un'autonormazione che è anche auto poiesi, che investe il corpo a un livello mai raggiunto prima: quello della poiesi organica basato sul dovere di scoprire la propria verità e di affermare la propria unicità attraverso la cura di sé e del proprio corpo.
 Quella raggiunta non è altro che una libertà apparente, anche se autenticamente percepita. Si pensi alla donna che, ancora isterica e priva di piacere nel XIX secolo, oggi per un verso rivendica una propria sessualità attiva e autonoma, per l'altro è target per una nuova produzione pornografica al femminile e cliente di interventi estetici standardizzanti in un'autodisciplina corporea basata ancora una volta su di un desiderio suscitato, controllato, serializzato: quello di piacere, di piacersi, di prendersi cura di sé. Tutte queste pratiche si collocano all'interno delle pratiche di dominio sempre più sofisticate e intrusive attuate sul corpo dal biopotere neoliberale contemporaneo, che possono anche costituire effettive pratiche di resistenza del soggetto, ma mai in termini assoluti, e che comunque sino a oggi non hanno davvero messo in discussione la centralità del desiderio e l'ingiunzione all'ermeneutica del sé che sta alla base di tali processi. Dunque è proprio su questo “sottile discrimine” che intercorre tra gli investimenti corporei intesi come forme di controcondotta alle relazioni di potere biopolitico, e quelli che non sono altro che autonormazione, cura di sé normata, incorporata e psichicamente assimilata, che si colloca intelligentemente l'opera di Baccarin, Con le sue ricostruzioni genealogiche delle verità di corpi e di soggetti che vivono in diagonale in questo mondo, mostra come essi rappresentino delle resistenze rispetto alle norme vigenti, ma meno radicalmente di quanto spesso non si pensi. Per superare tale soglia, rilancia l'autore, è basilare superare la necessità tanto di una verità del sé quanto il mito di una libertà originaria ed essenziale da restaurare; superare la centralità accordata al desiderio, e di conseguenza al tema identitario; spostare l'attenzione sull'atto e sul piacere. Non è più tempo di rivendicare la libertà di amare persone dello stesso sesso, come recita la verità gay, bensì è tempo di rivendicare la libertà di amare tout court. Bisogna cioè concentrarsi sullo scovare nuove pratiche di libertà per inaugurare non nuovi mondi, bensì nuovi giochi di libertà in questo mondo.
Quella raggiunta non è altro che una libertà apparente, anche se autenticamente percepita. Si pensi alla donna che, ancora isterica e priva di piacere nel XIX secolo, oggi per un verso rivendica una propria sessualità attiva e autonoma, per l'altro è target per una nuova produzione pornografica al femminile e cliente di interventi estetici standardizzanti in un'autodisciplina corporea basata ancora una volta su di un desiderio suscitato, controllato, serializzato: quello di piacere, di piacersi, di prendersi cura di sé. Tutte queste pratiche si collocano all'interno delle pratiche di dominio sempre più sofisticate e intrusive attuate sul corpo dal biopotere neoliberale contemporaneo, che possono anche costituire effettive pratiche di resistenza del soggetto, ma mai in termini assoluti, e che comunque sino a oggi non hanno davvero messo in discussione la centralità del desiderio e l'ingiunzione all'ermeneutica del sé che sta alla base di tali processi. Dunque è proprio su questo “sottile discrimine” che intercorre tra gli investimenti corporei intesi come forme di controcondotta alle relazioni di potere biopolitico, e quelli che non sono altro che autonormazione, cura di sé normata, incorporata e psichicamente assimilata, che si colloca intelligentemente l'opera di Baccarin, Con le sue ricostruzioni genealogiche delle verità di corpi e di soggetti che vivono in diagonale in questo mondo, mostra come essi rappresentino delle resistenze rispetto alle norme vigenti, ma meno radicalmente di quanto spesso non si pensi. Per superare tale soglia, rilancia l'autore, è basilare superare la necessità tanto di una verità del sé quanto il mito di una libertà originaria ed essenziale da restaurare; superare la centralità accordata al desiderio, e di conseguenza al tema identitario; spostare l'attenzione sull'atto e sul piacere. Non è più tempo di rivendicare la libertà di amare persone dello stesso sesso, come recita la verità gay, bensì è tempo di rivendicare la libertà di amare tout court. Bisogna cioè concentrarsi sullo scovare nuove pratiche di libertà per inaugurare non nuovi mondi, bensì nuovi giochi di libertà in questo mondo.di Sophie Brunodet
-
Jean-Luc Nancy – Dov’è successo?
Recensioni / Febbraio 2015 Il tema dell'archivio, oggetto dell'intervista di Nathalie Léger a Jean-Luc Nancy qui proposta in traduzione italiana a cura di Igor Pelgreffi, acquista nel corso del Novecento una sempre maggiore autonomia dalle discipline che se ne sono occupate tradizionalmente, in primo luogo la storia e la filologia. Dal punto di vista filosofico, emerge così progressivamente la domanda sul senso dell'archivio e sugli effetti che esso può determinare sulle opere e sull'immagine stessa di un autore. In altre parole, come ricorda il curatore in apertura del saggio introduttivo, «come esaminare il passato del proprio lavoro? Qual è la sua materia, quali sono i suoi oggetti? Qual è la parte della cancellazione e della distruzione? Come iniziare con ciò che resta?» Innanzitutto, ogni archivio è un luogo. Non solo nel senso dello spazio fisico in cui sono raccolte le opere di uno o più autori, ma uno spazio entro cui sono possibili certe operazioni intellettuali: infatti, se da un lato l'archivio rappresenta una risorsa insostituibile nel processo di analisi del pensiero di un filosofo, nella conservazione delle sue opere e nella costruzione della sua immagine futura, dall'altro lato esso apre una serie di interrogativi filosofici inediti, relativi al funzionamento dell'archiviazione, al suo duplice carattere di mantenimento e perdita, al momento a partire dal quale si può dire di aver davvero archiviato qualcosa. In sintesi, dove e a chi (o a cosa) accade l'archiviazione? È questo l'interrogativo di fondo attorno a cui si snoda tutto il discorso di Nancy, d'ispirazione decostruttiva, qui presentato. Come osserva acutamente Pelgreffi, «non possiamo comprendere l'archivio se non immaginiamo un intreccio fra spazio dell'archivio e tempo dell'archivio così come fra spazio dell'archiviazione e tempo dell'archiviazione, cioè quello che, in termini derridiani, potremmo pensare come una différance spazio-temporale, nel senso di una spazializzazione del tempo e di una temporalizzazione dello spazio.» Ed è senza dubbio in consonanza col pensiero di Derrida che Nancy costruisce il proprio discorso sull'arché e sull'istituzione dell'archivio, col risultato - paradossale, come quasi sempre accade seguendo un approccio derridiano o,
Il tema dell'archivio, oggetto dell'intervista di Nathalie Léger a Jean-Luc Nancy qui proposta in traduzione italiana a cura di Igor Pelgreffi, acquista nel corso del Novecento una sempre maggiore autonomia dalle discipline che se ne sono occupate tradizionalmente, in primo luogo la storia e la filologia. Dal punto di vista filosofico, emerge così progressivamente la domanda sul senso dell'archivio e sugli effetti che esso può determinare sulle opere e sull'immagine stessa di un autore. In altre parole, come ricorda il curatore in apertura del saggio introduttivo, «come esaminare il passato del proprio lavoro? Qual è la sua materia, quali sono i suoi oggetti? Qual è la parte della cancellazione e della distruzione? Come iniziare con ciò che resta?» Innanzitutto, ogni archivio è un luogo. Non solo nel senso dello spazio fisico in cui sono raccolte le opere di uno o più autori, ma uno spazio entro cui sono possibili certe operazioni intellettuali: infatti, se da un lato l'archivio rappresenta una risorsa insostituibile nel processo di analisi del pensiero di un filosofo, nella conservazione delle sue opere e nella costruzione della sua immagine futura, dall'altro lato esso apre una serie di interrogativi filosofici inediti, relativi al funzionamento dell'archiviazione, al suo duplice carattere di mantenimento e perdita, al momento a partire dal quale si può dire di aver davvero archiviato qualcosa. In sintesi, dove e a chi (o a cosa) accade l'archiviazione? È questo l'interrogativo di fondo attorno a cui si snoda tutto il discorso di Nancy, d'ispirazione decostruttiva, qui presentato. Come osserva acutamente Pelgreffi, «non possiamo comprendere l'archivio se non immaginiamo un intreccio fra spazio dell'archivio e tempo dell'archivio così come fra spazio dell'archiviazione e tempo dell'archiviazione, cioè quello che, in termini derridiani, potremmo pensare come una différance spazio-temporale, nel senso di una spazializzazione del tempo e di una temporalizzazione dello spazio.» Ed è senza dubbio in consonanza col pensiero di Derrida che Nancy costruisce il proprio discorso sull'arché e sull'istituzione dell'archivio, col risultato - paradossale, come quasi sempre accade seguendo un approccio derridiano o,come in questo caso, post-derridiano - che proprio l'“oggetto archivio”, la cui istituzione è segnata da un luogo e una data, finisce per essere l'elemento meno stabile per determinare la nostra relazione col passato. Piena continuità, dunque, col testo di Derrida Mal d'archive, di cui questo discorso di Nancy rappresenta idealmente la prosecuzione. Infatti, Nancy condivide la preoccupazione derridiana di una possibile riduzione dell'archivio al mito del “ritorno all'origine”, in altre parole l'istituzione di un luogo a cui consegnare il passato dell'autore, il suo tempo perduto. Al contrario, osservano Derrida e Nancy, non esiste alcuna origine piena da poter rendere presente e disponibile, ma soltanto l'archiviazione che permette di rinvenire la traccia dell'origine. Come osserva
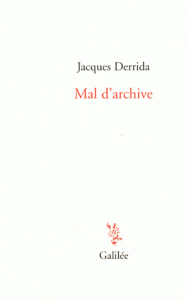 Pelgreffi, da tale confronto con Derrida emerge che il soggetto non è diviso tra due mondi, quello interno e quello sociale, ma è preso nel processo di riassorbimento e rigenerazione delle forme soggettive che dà luogo all'archivio, precedendo dunque ogni dualismo tra interiorità ed esteriorità. Ne consegue che il datum documentale non è un atomo, ma un'unità differenziata, ibrida, divisa originariamente nei suoi elementi giuridici, etici, politici ed esistenziali. Ma se Nancy richiama esplicitamente Derrida, intreccia altresì un dialogo “silenzioso” con Foucault, per il cui pensiero, com'è noto, la nozione di archeologia è di primaria importanza. Dal suo punto di vista, l'archivio permette di chiarire il nesso tra sapere e potere che si manifesta in ogni discorso: in questo senso, l'archivio non è soltanto il luogo fisico dove rinvenire tutte le informazioni su uno o più autori, ma «il sistema generale della formazione e della trasformazione degli enunciati.» In altre parole, secondo Foucault l'archivio si pone a metà strada tra il trascendentale e l'empirico, dà luogo a un ordine terzo rispetto al puramente ideale - la ragione come archetipo perfetto dell'archivio - e all'assolutamente empirico, sciolto da ogni regola discorsiva.
Pelgreffi, da tale confronto con Derrida emerge che il soggetto non è diviso tra due mondi, quello interno e quello sociale, ma è preso nel processo di riassorbimento e rigenerazione delle forme soggettive che dà luogo all'archivio, precedendo dunque ogni dualismo tra interiorità ed esteriorità. Ne consegue che il datum documentale non è un atomo, ma un'unità differenziata, ibrida, divisa originariamente nei suoi elementi giuridici, etici, politici ed esistenziali. Ma se Nancy richiama esplicitamente Derrida, intreccia altresì un dialogo “silenzioso” con Foucault, per il cui pensiero, com'è noto, la nozione di archeologia è di primaria importanza. Dal suo punto di vista, l'archivio permette di chiarire il nesso tra sapere e potere che si manifesta in ogni discorso: in questo senso, l'archivio non è soltanto il luogo fisico dove rinvenire tutte le informazioni su uno o più autori, ma «il sistema generale della formazione e della trasformazione degli enunciati.» In altre parole, secondo Foucault l'archivio si pone a metà strada tra il trascendentale e l'empirico, dà luogo a un ordine terzo rispetto al puramente ideale - la ragione come archetipo perfetto dell'archivio - e all'assolutamente empirico, sciolto da ogni regola discorsiva.Questo duplice dialogo con Derrida e Foucault induce a evidenziare anche un altro fil rouge del testo di Nancy: la questione dell'alterità. Infatti, nell'istituzione dell'archivio è già sempre coinvolto l'altro, in modo tale che la domanda sull'archivio implica anche sempre la questione del rapporto tra archiviazione, estraneità e istituzione. Come ha osservato molte volte Derrida, qualunque processo di istituzione conserva una traccia di ciò che esclude, cioè di quell'estraneità che sceglie originariamente di estromettere dall'istituzione o dall'archiviazione. In sintesi, per dotarsi di una qualche identità, l'archivio, nell'atto della sua istituzione, è costretto a relazionarsi con ciò che sceglie di non archiviare. Deve nominarlo, assumerne le sembianze, in modo tale che può accadere che sia proprio l'escluso dall'archiviazione ad assumersi il compito di conservarne la memoria. Ora, tale intreccio irrisolto tra identità e alterità è continuamente rilanciato da Nancy in questo testo, ad esempio attraverso la questione “che cos'è un'opera?” - come nota il curatore, vero e proprio contrappunto alla domanda di Foucault “che cos'è un autore?”, oggetto di una conferenza al Collège de France del 1969.
Volendo individuare la tesi portante del discorso di Nancy, attorno a cui si annodano tutti i vari temi che egli affronta in questo breve testo, si potrebbe azzardare la seguente affermazione: l'archivio sottrae l'autore stesso a qualunque forma di sapere oggettivo. Il che significa che non si potrà mai raggiungere una qualche conoscenza definitiva e cogente di «chi è diventato questa firma che offre il suo nome, i suoi tratti, il suo carattere»all'archiviazione: quest'ultima resterà sempre un processo che non consente di afferrare concettualmente la natura del proprio rapporto con un certo autore, benché lo riguardi direttamente. In altre parole, chi è diventato l’autore, una volta che transita dal proprio archivio? Nancy risponde: «Nessuno che noi possiamo nominare o circoscrivere in alcun modo. “Gli archivi di X” sono un modo di far indietreggiare X più lontano, più in profondità nei suoi archivi. Noi vediamo i suoi tentativi, le sue note, le sue esitazioni, le sue vergogne forse, le sue dissimulazioni, i suoi oblii: ma lui, “lui”, dov’è?».
di Claudio Tarditi
-
La modernità di NietzschePer capirci qualcosa di più del mondo in cui viviamo bisogna leggere Nietzsche.
 Sapere che il Fascismo di Mussolini e il Rock psichedelico di Jim Morrison sono nati nel segno del filosofo tedesco – se coerentemente o meno è un altro discorso – spinge in questa direzione, ed è il motivo dell’interesse di Maurizio Ferraris per questa figura e la ragion d’essere di Spettri di Nietzsche. Un’avventura umana e intellettuale che anticipa le catastrofi del Novecento (anche se i Doors più che una catastrofe sono una benedizione). Non c’è dubbio, il Novecento (ma anche questo primo scampolo di nuovo millennio) è un secolo nietzscheano, il secolo della volontà di potenza, quella volontà, essenza dell’individualismo, che contraddistingue i contemporanei – che cosa sarebbero altrimenti i Talent Show? È Ferraris stesso ad aprire il suo libro con questa precisazione, umanizzando e attualizzando – che più attuale non si può – il pensiero di un uomo che ha vissuto sulla sua pelle e sui suoi nervi il tempo che annunciava: «fuori dalle trincee la volontà di potenza è anzitutto volontà di presenza e ansia di riconoscimento. Nietzsche coglie, esprime e anzitutto incarna una caratteristica essenziale della modernità, l’aspirazione collettiva a essere straordinari» (p. 15). Perché «aveva ragione sua sorella Elisabeth, Fritz voleva diventare famoso, e lo desiderava con la stessa mancanza di decoro di un ammalato di celebrità» (p. 7). In una lettera a Paul Deussen dell’11 dicembre 1888 egli scrive che si sentiva «come se il destino dell’umanità fosse nelle [sue] mani» (p. 9). In un certo senso ci aveva preso. Considerato che oggi siamo ancora qui a parlare di lui, se avesse pensato e agito diversamente forse in questo momento ragioneremmo altrettanto diversamente.
Sapere che il Fascismo di Mussolini e il Rock psichedelico di Jim Morrison sono nati nel segno del filosofo tedesco – se coerentemente o meno è un altro discorso – spinge in questa direzione, ed è il motivo dell’interesse di Maurizio Ferraris per questa figura e la ragion d’essere di Spettri di Nietzsche. Un’avventura umana e intellettuale che anticipa le catastrofi del Novecento (anche se i Doors più che una catastrofe sono una benedizione). Non c’è dubbio, il Novecento (ma anche questo primo scampolo di nuovo millennio) è un secolo nietzscheano, il secolo della volontà di potenza, quella volontà, essenza dell’individualismo, che contraddistingue i contemporanei – che cosa sarebbero altrimenti i Talent Show? È Ferraris stesso ad aprire il suo libro con questa precisazione, umanizzando e attualizzando – che più attuale non si può – il pensiero di un uomo che ha vissuto sulla sua pelle e sui suoi nervi il tempo che annunciava: «fuori dalle trincee la volontà di potenza è anzitutto volontà di presenza e ansia di riconoscimento. Nietzsche coglie, esprime e anzitutto incarna una caratteristica essenziale della modernità, l’aspirazione collettiva a essere straordinari» (p. 15). Perché «aveva ragione sua sorella Elisabeth, Fritz voleva diventare famoso, e lo desiderava con la stessa mancanza di decoro di un ammalato di celebrità» (p. 7). In una lettera a Paul Deussen dell’11 dicembre 1888 egli scrive che si sentiva «come se il destino dell’umanità fosse nelle [sue] mani» (p. 9). In un certo senso ci aveva preso. Considerato che oggi siamo ancora qui a parlare di lui, se avesse pensato e agito diversamente forse in questo momento ragioneremmo altrettanto diversamente.Nietzsche, un’interpretazione
Ferraris – si avverte pagina dopo pagina – nutre un certo affetto per Nietzsche, come fosse un amico, forse vecchio rivale, comunque molto stimato. D’altronde non c’è filosofo del Novecento che non abbia fatto i conti con quest’uomo geniale. I conti, questo libro ne è la resa: Ferraris ripercorre l’intera vita filosofica del collega tedesco, i suoi lasciti, le sue micce, poi accese da qualcun altro, e la dinamite che è esplosa lontana dai suoi occhi. È lui, in fin dei conti, il padre del postmoderno, l’autore di quella frase: “non ci sono fatti, solo interpretazioni”, contro cui lotta il nuovo realismo ferrarisiano. Con questo concetto Ferraris ci mostra come per Nietzsche «la realtà [sia] socialmente costruita, nulla esiste fuori dal testo, il sapere è solo un effetto di potere, il mondo si guarda da infinite prospettive che corrispondono ai nostri bisogni vitali in conflitto tra loro, non ci sono cose in sé, ma solo in relazione a osservatori» (p. 83). È questo cambio di paradigma la vera catastrofe di cui parla Ferraris nel sottotitolo del libro? Quella da cui sono potute nascere tutte le catastrofi reali che hanno segnato il XX° secolo? E sarà davvero giunto il tempo di voltare pagina? Difficile a credersi. Ma come la mettiamo allora con il global warming, lo spread, il cancro, l’Olocausto? Sono solo interpretazioni?

Volontà di potenza e di politica
Anzitutto bisogna fare i conti col Nietzsche politico, una storia che non finirà mai, perché impossibile da chiarificare. Chi lo vuole di destra, ideologo del nazionalsocialismo di Hitler – o colui che contribuì alla sua nascita – e della sua sfrenata volontà di dominio; chi lo vuole invece di sinistra, rivoluzionario – non a caso le sue opere, oltre che in quella di Hitler, comparivano nella biblioteca di Mitterrand. Dice Lukács che gli «intellettuali potranno sostituire al socialismo l’annuncio di Zarathustra, cioè la promessa di un cambiamento ancora più grande e più indeterminato, di un futuro e di un dio a venire» (p. 45). Chi considera la sua nazificazione un errore dettato dal travisamento del suo pensiero allegorico o semplicemente dalle interpolazioni faziose apportate all’opera dalla sorella Elisabeth. Una cosa è certa, Nietzsche è morto nel 1900 e non ha mai sentito parlare di Hitler. Ciò, ovviamente, non significa che i nazisti non abbiano avuto alcun appiglio per rifarsi al padre di Zarathustra: Ferraris, considerate l’opera di Nietzsche, ci dice che era davvero reazionario, e che i pensieri di cui si appropriarono i nazisti non provenivano dalla tanto discussa e postuma Volontà di potenza, ma soprattutto dalle opere edite. In realtà ci dice anche che l’unica vera falsificazione della sorella è stata quella di spacciarsi per principale interlocutrice del fratello, quando invece lui la odiava. Come si sa, l’unica obiezione di Nietzsche all’eterno ritorno erano proprio loro, la madre e la sorella.
Per Ferraris «Nietzsche è stato tutto, tranne che un impolitico», i suoi «principi risultano iper-fungibili dal punto di vista politico, appunto perché l’essere diviene anzitutto un fare, un combattere, un trasformare. Il che, in una fase rivoluzionaria, può risultare allettante sia per una squadra di spartachisti che per dei Freikorps antibolscevichi» (p. 43). Inoltre «il pensiero di Nietzsche non porta a un prospettivismo radicale, bensì a una gerarchizzazione dei valori» (p. 130), perché per lui «[…] il vero filosofo è colui che forgia nuovi valori» (p. 131). Zarathustra/il superuomo ha trovato la verità, ovvero che non esiste verità, ma solo volontà di potenza. Di qui la sua autorità.
Nichilismo e imipramina
Il libro di Ferraris, che si muove a salti spaziali e temporali, in una connessione di idee trasformata in elegante opera letteraria, a un tratto ci proietta nel 1956, all’interno dell’ospedale di Münsterlingen, dove lo psichiatra Roland Kuhn stava scoprendo, per caso, l’effetto antidepressivo dell’imipramina. E se quello che Nietzsche chiamava “nichilismo” fosse stata solo una sorta di depressione curabile coi farmaci, si chiede provocatoriamente Ferraris? E se Nietzsche avesse incontrato Kuhn, oggi cosa leggeremmo sui libri di storia della filosofia? Di sicuro nel nichilismo di cui parla il filosofo tedesco c’è molto di suo, di quello che avvertiva dentro di sé – e qui siamo di nuovo a fare i conti con la modernità nietzschena di cui si parlava all’inizio.
Eterno ritorno, eterno disguido
A Silvaplana sulla soglia di una casa, nel 1993, Ferraris scoprì questa scritta in retoromanzo: “Tieu destin tũ poust amer e perfin sch’el es amer”. Bisogna amare il proprio destino anche se amaro. Ecco qui l’eterno ritorno, “la suprema formula dell’affermazione che possa mai essere raggiunta”, frutto della profonda trasformazione spirituale nietzscheana avvenuta nel 1881, appunto, a Silvaplana, vicino Sils Maria, in Svizzera. Ma quest’idea, ripresa dai greci e dal pensiero orientale, può avere una qualche scientificità?
 Borges, in Storia dell’eternità (1936), rifacendosi alle teorie degli insiemi di Cantor, prova a rispondere a questa domanda, concludendo che «se l’universo consta di un numero infinito di termini, è rigorosamente capace di un numero infinito di combinazioni; e la necessità di un ritorno viene annullata» (p. 135). Ferraris sembra concordare con Borges. Va però detto gli atomi dell’universo sono oggi valutati dalla scienza in 10 alla 80: numero altissimo, ma pur sempre finito, che non smentisce quindi l’ipotesi nietzscheana. Tuttavia l’eterno ritorno rimane una contraddizione all’interno del pensiero di Nietzsche, e questo Ferraris lo spiega bene: da una parte vuol essere l’abbandono di ogni finalismo, contro la teleologia occidentale, una proclamazione della libertà di movimento della Terra, astro tra gli astri; dall’altra però «propugna un finalismo iperbolico, per il quale il filosofo, in veste di istitutore di valori, “crea” – leggiamo nello Zarathustra, “Di antiche tavole e nuove” – “la mèta dell’uomo e dà alla terra il suo senso e il suo futuro”» (p. 140).
Borges, in Storia dell’eternità (1936), rifacendosi alle teorie degli insiemi di Cantor, prova a rispondere a questa domanda, concludendo che «se l’universo consta di un numero infinito di termini, è rigorosamente capace di un numero infinito di combinazioni; e la necessità di un ritorno viene annullata» (p. 135). Ferraris sembra concordare con Borges. Va però detto gli atomi dell’universo sono oggi valutati dalla scienza in 10 alla 80: numero altissimo, ma pur sempre finito, che non smentisce quindi l’ipotesi nietzscheana. Tuttavia l’eterno ritorno rimane una contraddizione all’interno del pensiero di Nietzsche, e questo Ferraris lo spiega bene: da una parte vuol essere l’abbandono di ogni finalismo, contro la teleologia occidentale, una proclamazione della libertà di movimento della Terra, astro tra gli astri; dall’altra però «propugna un finalismo iperbolico, per il quale il filosofo, in veste di istitutore di valori, “crea” – leggiamo nello Zarathustra, “Di antiche tavole e nuove” – “la mèta dell’uomo e dà alla terra il suo senso e il suo futuro”» (p. 140).Che cos’è allora, per Nietzsche, l’eterno ritorno? È anche questo frutto della sua modernità, del suo essere interiore che non può che traboccare nel mondo per renderlo a sua immagine? Ferraris, candidamente, risponde: l’eterno ritorno è «una religione per il mondo secolarizzato, un mito qualunque, quasi un pretesto per predicare, di certo un gesto per scacciare l’orrore un po’ più in là» (p. 144).
Illuminismo + LSD = catastrofe
Un mito, appunto. Proprio come scrivono Adorno e Horkheimer in Dialettica dell’illuminismo (1947), l’“illuminismo nietzscheano” è un ritorno al mito, alla tragedia, al dionisiaco, volto a distruggere il nesso sapere-progresso-felicità figlio del racconto socratico riproposto nella modernità proprio dall’illuminismo “classico”, quello di Kant e Rousseau. Nietzsche, che detestava Rousseau, invece, guarda più a Sade, a Laclos, a Crébillon. La volontà di potenza è tutto quello che c’è da sapere per capire il mondo: «ogni forma di sapere va guardata con sospetto, appunto in quanto espressione di una qualche forma di potere» (p. 152), e quindi il sapere, che dovrebbe emancipare, produce allo stesso tempo potere, cioè subordinazione e dominio. La soluzione? Non sapere (ovviamente non alla maniera socratica), rituffarsi nel mito, nel dionisiaco perduto. Insomma, il Nietzsche che emerge qui non è un illuminista, ma un dispensatore di segreti per “imparare a vivere” secondo la sua “dottrina”. Altro che spronare a pensare con la propria testa!
E questo dionisiaco dove lo troviamo? Ferraris, ancora una volta, immagina gli effetti che avrebbe prodotto l’LSD, sintetizzato soltanto nel 1943 a Basilea (stessa città in cui venne concepita La nascita della tragedia) da Albert Hoffman, su Nietzsche. Ma dovremo accontentarci degli effetti, non affatto malvagi, prodotti su Jim Morrison, ma anche su Foucault.
Qui Ferraris azzarda e finalmente fa esplicito riferimento a quello a cui tutti noi pensiamo quando sentiamo pronunciare la parola catastrofe in riferimento al Novecento. Ovvero Hitler. Il sottotitolo del libro significa proprio quello che intuitivamente credevamo. È però al plurale – catastrofi – per cui riempitelo come preferite, avete l’imbarazzo della scelta. Ad ogni modo i nazisti, a Nietzsche, non “rubarono” solo concetti, ma anche la necessità dell’esperienza del superamento del limite razionale, verso l’immortalità (o la morte): «tra la patria mitica e la catastrofe il passo è breve, e se Hitler ha saputo incantare i tedeschi, e non solo loro, è perché nel suo orizzonte c’era qualcosa di straordinariamente simile al “corteo dionisiaco” di cui parla Nietzsche» (p. 179).
Ma le responsabilità di Nietzsche e di Hitler sono molto diverse fra loro; Ferraris lo mette in luce citando le parole di un uomo che ripugnava entrambi, Primo Levi: «[in Nietzsche] mi pare che non compaia mai il desiderio della sofferenza altrui. L’indifferenza sì […], ma mai […] la gioia per il danno del prossimo, né tanto meno la gioia del far deliberatamente soffrire. Il dolore del volgo […], degli informi, dei non-nati-nobili, è un prezzo da pagare per l’avvento del regno degli eletti; è un male minore […]; non è desiderabile in sé. Ben diversi erano il verbo e la prassi hitleriani» (p. 196).
***
Spettri di Nietzsche non è un libro per chi è digiuno del pensiero del filosofo tedesco, che non saprebbe come raccapezzarsi tra gli sbalzi temporali di Ferraris, il quale mostra una profonda conoscenza delle tematiche che tratta. In realtà è proprio questo che rende la lettura stimolante: lo star dietro a un brillante incedere tra connessioni di idee di cultura “alta”, prettamente filosofico-accademica, e cultura pop. D’altronde, abbiamo imparato a conoscerlo, è esattamente questa la cifra di Ferraris.
di Stefano Scrima
-
Passeggiate urbane
Serial / Novembre 2014«La passeggiata dello schizofrenico: un modello migliore di quella del nevrotico sul divano. Un po' d'aria aperta, una relazione con l'esterno»
Così scrivevano Deleuze e Guattari nell'Anti-Edipo; questa citazione esprime non solo un'ironica, quanto spiazzante denuncia delle normatività e delle costrizioni dell'analisi freudiana ma anche una valida alternativa alla filosofia da scrittoio.
Da questo spunto nasce la volontà di scrivere una rubrica di Passeggiate urbane che si ricollega a un'eredità antica quanto la filosofia, se con questa intendiamo la tradizione socratica e cinica. Anche se da essa, per questioni probabilmente dettate dal passaggio alla modernità, se ne distacca in quanto alla conversazione preferisce la narrazione e l'indagine emotiva.
-
 Paolo Vignola, ne L’attenzione altrove. Sintomatologie di quel che ci accade, si pone un obiettivo ambizioso: praticare una critica radicale della società e del pensiero filosofico contemporanei, a partire da una prospettiva che l’autore chiama sintomatologica. La società contemporanea, caratterizzata da un’economia capitalistica sempre più pervasiva, ingenera nell’uomo, secondo Vignola, una serie di sintomi, come la sofferenza, la precarietà esistenziale, i disturbi dell’attenzione e un più generale deterioramento dei rapporti interpersonali, che, se diagnosticati con chiarezza, possono aprire la strada a un ripensamento critico del mondo odierno.
Paolo Vignola, ne L’attenzione altrove. Sintomatologie di quel che ci accade, si pone un obiettivo ambizioso: praticare una critica radicale della società e del pensiero filosofico contemporanei, a partire da una prospettiva che l’autore chiama sintomatologica. La società contemporanea, caratterizzata da un’economia capitalistica sempre più pervasiva, ingenera nell’uomo, secondo Vignola, una serie di sintomi, come la sofferenza, la precarietà esistenziale, i disturbi dell’attenzione e un più generale deterioramento dei rapporti interpersonali, che, se diagnosticati con chiarezza, possono aprire la strada a un ripensamento critico del mondo odierno.Il punto di avvio del libro di Vignola risiede nel rovesciamento di un classico filosofico del Novecento, Il disagio della civiltà. Com’è noto, Freud individua, all’origine della società umana, un processo di sublimazione e regolazione delle passioni umane, che, sebbene provochi una pesante ricaduta sulla salute psico-fisica dell’uomo, risulta in ogni caso inevitabile e necessario. Se con questa intuizione Freud, per Vignola, ha il merito di porre la possibilità di una prospettiva sintomatologica, concentrandosi sui sintomi insalubri che una società è in grado di ingenerare sui suoi individui, la posizione freudiana risulta tuttavia pericolosamente normalizzante, poiché non allarga il proprio discorso dall’individuo alla considerazione critica della società nel suo complesso, limitandosi invece a fornire gli strumenti per una forzata adeguazione dell’individuo a essa. Occorre quindi rovesciare il discorso di Freud, appoggiandosi a chi, nel corso del Novecento, ha praticato, più o meno consapevolmente, una vera e propria sintomatologia. Vignola si confronta così con un gran numero di autori – Foucault, Adorno e Horckheimer, Stiegler, Sloterdijk e Carr, tra gli altri - ibridandone con perizia i concetti: la sintomatologia non è infatti una disciplina nuova, nuovo è forse il tentativo di una sua esplicita sistematizzazione filosofica.
Per poter sfuggire alle secche che caratterizzano la posizione di Freud, serve una sostanziale ridefinizione dei concetti di normale e patologico nei confronti del dato sociale. È qui che Vignola si confronta con Georges Canguilhem e l’idea che il mancato adattamento a un ambiente sociale non sia di per sé patologico, ma che anzi manifesti un diversoorientamento del soggetto, volto a una trasformazione in senso normativo della realtà. Tale trasformazione può essere intesa, in accordo questa volta con Gilbert Simondon, come un processo di individuazione, che, in quanto tale, non riguarda tanto il singolo individuo, quanto una realtà preindividuale e collettiva. Il passaggio dal sintomo alla cura, dalla critica all’adombramento di un’alternativa, come ripete a più riprese Vignola, è infatti pensabile soltanto a partire da un noi che rifugga le componenti individualistiche e narcisistiche tipiche della società contemporanea. Il libro non si limita così a evidenziare la salute precaria che caratterizza la realtà sociale odierna nel suo complesso, ma propone anche una possibile linea di fuga, all’insegna dello stoicismo, nella versione corretta e riveduta da Gilles Deleuze: si tratta di controeffettuare il sintomo, inteso come evento, per rendersi, in questo modo, «degni di quel che ci accade» (p. 36).
Se c’è un protagonista, all’interno de L’attenzione altrove, questi è proprio Deleuze, filosofo che da sempre accompagna la riflessione di Vignola, la cui brillante scrittura sembra ormai averne introiettato il lessico. È poi proprio a partire dal Deleuze di Critica e clinica che nasce il progetto di una prospettiva sintomatologica. Secondo Deleuze, infatti, i grandi scrittori della letteratura mondiale sono al contempo i più grandi clinici e sintomatologi della civiltà a loro contemporanea. Il problema di Vignola è allora quello di traslare la possibilità di una sintomatologia da un ambito profetico-letterario a un campo transdisciplinare, che sappia includere sociologia, antropologia e riflessione filosofica.
Per analizzare i sintomi patologici presenti nella società contemporanea, Vignola si confronta a più riprese con i mezzi di comunicazione digitali. L’esplosione dei social network e, più in generale, del web 2.0 ha portato infatti a una serie di pesanti ricadute sulla capacità di attenzione dell’uomo: la velocità, la dispersione e l’overload di informazioni che caratterizzano la rete hanno infatti trasformato la capacità di concentrazione, non più in grado di sedimentarsi con pazienza, ma brevemente iperstimolata da fonti sempre più varie e disparate. Gli effetti di istupidimento collettivo, soprattutto sui cosiddetti nativi digitali, vanno così di pari passo con una mole di informazioni disponibili sempre in aumento. Da qui una captazione dell’attenzione da parte delle più avanzate strategie di marketing, attive in quella che Stiegler chiama telecrazia.
Accanto a una sintomatologia sociale, Vignola si lancia poi in una vera e propria sintomatologia filosofica: si propone cioè di utilizzare la prospettiva sintomatologica, facendola agire all’interno del pensiero filosofico, che sembra oggi attraversato da una crisi profonda. Mancano infatti uno spazio e un tempo propri al filosofare, attività che ha da sempre richiesto, come sostiene Sloterdijk, uno sguardo differente e allenato. La filosofia deve costituirsi come un esercizio di ascesi teoretica, che necessita di un intenso sforzo di concentrazione. Far agire la prospettiva sintomatologica nei confronti delle teoria filosofica, significa allora chiarire le possibilità della filosofia come disciplina che deve dirigere l’attenzione verso un altrove, verso un nuovo re-incantamento del reale, capace di liberare energie in vista di una trasformazione di se stessa e della realtà sociale.
I sintomi individuati da Vignola non sono in definitiva differenti rispetto a quelli presenti in analisi, anche recenti, che diversi filosofi hanno dedicato al rapporto tra economia capitalistica e società: sfaldamento dei legami interpersonali, individualismo esasperato, consumo reiterato, sfruttamento delle facoltà affettive. C’è da chiedersi se queste analisi, che partono spesso da una premessa empirica – e quindi passibile di un certo soggettivismo –, non insistano troppo sulla pervasività del sistema economico sull’individuo. Non esistono oggi esperienze, realtà e sentimenti autonomi o, comunque, interpretabili sotto un segno positivo? La società contemporanea è soltanto un’escrescenza del neoliberismo capitalista o possiede, al suo interno, elementi che, come l’esplosione della rete, la rendono complessa e difficilmente sistematizzabile? Al netto di questi quesiti, L’attenzione altrove si presenta certamente come un percorso affascinante tra un ricco numero di autori, capace di porre alla società di oggi una serie di domande necessarie e ineludibili, che affondano le loro radici nella richiesta di una vita migliore, a partire dalla quale ci si possa prendere cura, con nuova attenzione, della sfera affettiva.
di Giulio Piatti
-
 È con il titolo Mal fare, dir vero, lo stesso delle conferenze che lo hanno generato, che viene edito in Italia il volume contenente il corso tenuto nel 1981 da Michel Foucault all’Università Cattolica di Lovanio. Oltre al testo delle lezioni del corso – tenutesi dal 2 aprile al 20 maggio di quell’anno – il volume ospita anche due interviste a Foucault (la prima a firma di A. Berten, la seconda condotta da J. François e J. De Wit) e una lunga e interessante Situazione del corso a opera dei curatori dell’edizione francese, F. Brion e B. E. Harcourt. Il testo del corso vero e proprio è stato ricostruito grazie a tre diversi tipi di fonte: 1) cassette U-Matic contenenti la registrazione audio-visiva di gran parte del corso (esclusa la conferenza inaugurale); 2) un manoscritto foucaultiano originale della conferenza e della prima lezione; 3) un dattiloscritto, stabilito da audiocassette mai ritrovate, depositato all’Institut Mémoires de l’édition contemporaine (Imec) contenente la trascrizione delle prime cinque lezioni e della conferenza. Il volume è inoltre corredato di un ricco apparato critico, particolarmente utile allo studioso e al ricercatore.
È con il titolo Mal fare, dir vero, lo stesso delle conferenze che lo hanno generato, che viene edito in Italia il volume contenente il corso tenuto nel 1981 da Michel Foucault all’Università Cattolica di Lovanio. Oltre al testo delle lezioni del corso – tenutesi dal 2 aprile al 20 maggio di quell’anno – il volume ospita anche due interviste a Foucault (la prima a firma di A. Berten, la seconda condotta da J. François e J. De Wit) e una lunga e interessante Situazione del corso a opera dei curatori dell’edizione francese, F. Brion e B. E. Harcourt. Il testo del corso vero e proprio è stato ricostruito grazie a tre diversi tipi di fonte: 1) cassette U-Matic contenenti la registrazione audio-visiva di gran parte del corso (esclusa la conferenza inaugurale); 2) un manoscritto foucaultiano originale della conferenza e della prima lezione; 3) un dattiloscritto, stabilito da audiocassette mai ritrovate, depositato all’Institut Mémoires de l’édition contemporaine (Imec) contenente la trascrizione delle prime cinque lezioni e della conferenza. Il volume è inoltre corredato di un ricco apparato critico, particolarmente utile allo studioso e al ricercatore.Le lezioni vere e proprie seguono l’ordine cronologico: 1/ una conferenza inaugurale (2 aprile); 2/ due lezioni (22 e 28 aprile) sulla confessione nell’età antica (mondo omerico – Iliade – e tragico – Edipo re); 3/ due lezioni (29 aprile e 6 maggio) sulla confessione nel cristianesimo dei primi secoli e nel monachesimo cristiano; 4/ due lezioni finali (13 e 20 maggio) sulla modernità, concluse con una breccia finale nel sistema penale contemporaneo.
Questa edizione va ad aggiungere un nuovo tassello al mosaico dei corsi foucaultiani, e lo fa collocandosi proprio in un punto delicatissimo della pensée Foucault. Il problema della confessione, infatti, emerge all’incrocio di alcune coppie problematiche che caratterizzano il percorso foucaultiano e, proprio in virtù di questa collocazione privilegiata, si presenta come punto di osservazione particolarmente interessante dell’intero orizzonte di lavoro di Foucault.
Innanzitutto la coppia follia/prigione. Dopo la storia della follia e dopo le ricerche sulla storia dell’incarcerazione punitiva, la produzione foucaultiana sembra imboccare una terza via, una pista di ricerca interessata al problema della sessualità. È proprio nel delineare i contorni di una storia della sessualità che Foucault incappa nel problema della confessione, che rappresenta la chiave d’accesso a un’operazione di livello superiore: il progetto di una storia della verità. Su di un piano metodologico più generale il corso del 1981 ha una posizione particolare anche rispetto alla coppia sapere/potere, rapporto che appare specificarsi soprattutto a partire dall’introduzione della nozione di aleturgia: pratica che, se da un lato fa apparire «ciò che è vero», dall’altro compie tale apparizione a sua volta all’interno di una pratica, quella della giustizia. In tal modo la storia della verità si concretizza, come da programma, come storia delle pratiche del far-vero.
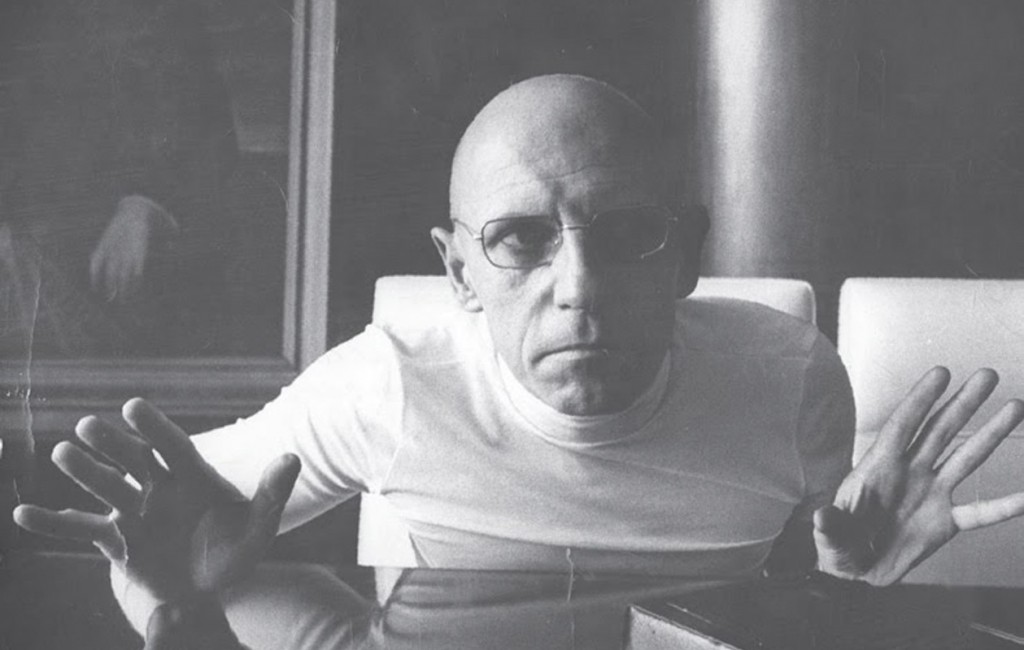
Mal fare, dir vero entra perciò di diritto in quella fase di definitivo chiarimento della dialettica che intercorre tra archeologia/genealogia come rapporto tra analisi delle forme e analisi della formazione delle forme stesse. Il corso in questione infatti, pur mantenendo il proprio valore in quanto studio tematico, risulta particolarmente interessante dal punto di vista metodologico: da un lato la ricostruzione precisa del procedere in fieri di Foucault, ormai pienamente maturo, mette a disposizione dello studioso foucaultiano un nuovo terreno di analisi; d’altro lato in questo corso forse più che in altri Foucault dedica spazio – per esempio nella conferenza inaugurale, ma non solo – a riflessioni di carattere metodologico generale. All’interno di queste riflessioni un posto privilegiato sembra essere occupato dal rapporto storia/filosofia, come se Foucault volesse in qualche modo rispondere alla domanda che tutti gli rivolgevano: «è questa impresa un lavoro di storia o di filosofia?». Ecco che Foucault, quasi sottovoce, in un corso quasi dimenticato, traccia la linea di una risposta: il suo lavoro è un lavoro storico-filosofico, anche se in un’accezione del tutto nuova; non è una storia della filosofia, né una filosofia della storia, bensì qualcosa come una pratica storico-filosofica.
Il volume non rappresenta un punto di approdo definitivo nell’elaborazione delle problematiche che si delineano intorno a questi diversi assi di articolazione anzi, come spesso si rivela esser vero per i corsi di Foucault, esso contribuisce ad aprire il ventaglio dei problemi e ad ampliare il terreno di gioco. Il corso foucaultiano assume davvero la struttura dell’«anello di Möbius» che gli riconoscono i curatori dell’edizione francese nel saggio introduttivo (p. VIII). Su di un unico lato o, meglio, su di un unico bordo collassano il problema politico e quello filosofico: da un lato la questione di come l’individuo accetti di legarsi al potere che si esercita su di esso e dall’altro la questione circa il modo in cui i soggetti si leghino alle forme di veridizione in cui sono implicati. Il pensiero di Foucault sembra subire una curvatura che, attraverso la pratica della confessione, fa svoltare l’interesse foucaultiano dalla politica all’etica.
Alcuni interpreti hanno voluto vedere in questo movimento una cesura; in realtà il corso, lungi dal confermare l’ipotesi di una frattura, evidenzia definitivamente il punto di saldatura del decorso filosofico foucaultiano: la confessione, infatti, rappresenta uno di quei ethoi che costituiscono il contorno del soggetto morale e attraverso i quali si esercita il governo della vita e della condotta dei corpi. La pratica della confessione e la sua analisi contribuiscono, secondo i curatori, a smentire l’idea di una cesura tra etica e politica, evidenziando invece come il passaggio assuma l’aspetto di una torsione quasi necessaria al discorso di Foucault, come se essa si prefigurasse – inattesa – sin dalla Storia della follia. È infatti in questo punto di curvatura che, secondo i curatori, il soggetto si inserisce tra potere e sapere «come un cuneo: se il governo passa attraverso la formazione degli ethoi nei quali gli individui si costituiscono come soggetti della loro condotta, allora il distacco da sé – rendersi in permanenza capaci di distaccarsi da se stessi – è la condizione di possibilità etica delle forme di resistenza politica a cui la sua filosofia invita».
di Gabriele Vissio