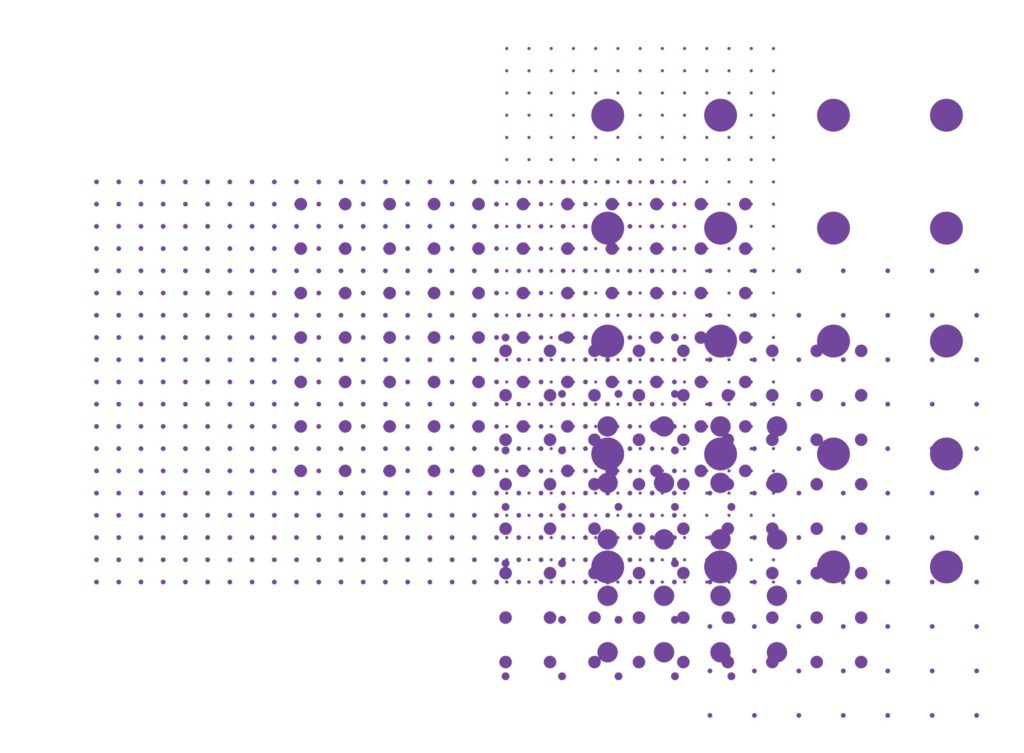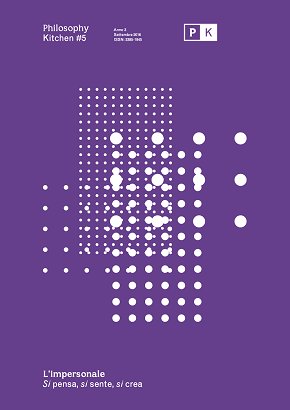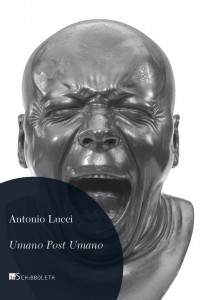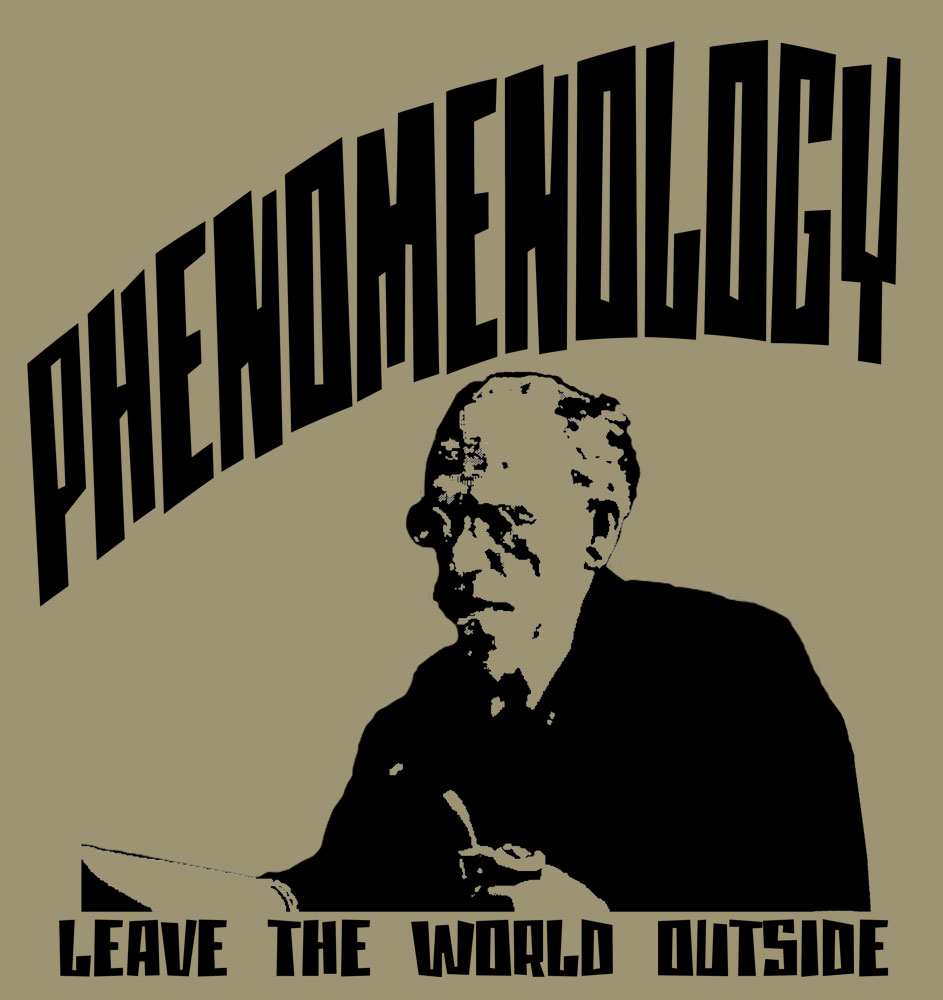Sembra che la psicoanalisi non sappia molto della soddisfazione della pulsione, e che anzi si limiti a fare qualcosa con la sua insoddisfazione strutturale. Cosa ne fa? Un percorso di cura, attraverso costruzioni più o meno artificiose di godimenti sostitutivi, spostamenti del godimento dal suo luogo mancato alla stanza del terapeuta. Quel che in Vivere la pulsione. Saggio sulla soddisfazione in psicoanalisi (Orthotes, Napoli-Salerno 2022) lo psicoanalista lacaniano Franco Lolli intende disarticolare è proprio l’ovvietà del ragionamento che ho appena esposto, col quale attestiamo, implicitamente, cosa sia godimento, cosa sia pulsione e cosa voglia dire essere soddisfatti o insoddisfatti.
Per scrivere cosa ne sappia la psicoanalisi della pulsione, dovremmo prima sapere cos’è la pulsione, il che, metodologicamente, è inarrivabile: la psicoanalisi non cerca il ti estì ed è avversa tanto a una risposta che vada nella direzione dell’appiattimento ontologico di siffatta domanda quanto a una ricerca di cause che si presenti come ultima e fondante la disciplina. Pertanto, la prima domanda che dobbiamo lasciar cadere, nel leggere il saggio di Lolli, è proprio “cos’è la pulsione?”.
Se volessimo azzardare una risposta, diremmo “un indefinibile, un indecidibile”, annullando così retroattivamente la domanda. L’indefinibilità della pulsione non è un escamotage teoretico per sottrarsi a un’indagine scientifica degli eventi e della loro etiologia, ma anzi il preciso esito di tale indagine. Esito che attesta un Reale restìo da secoli a una generalizzazione definitoria possibile. Si tratta di un Reale filogenetico, trans-storico, che affonda nelle strutture comuni del sentire e al contempo le travalica e le precede, provocando atteggiamenti pulsionali non sussumibili e di cui il soggetto non sa niente, può solo limitarsi a constatarne la ripetizione e l’assurdità: una convinta femminista gode solo immaginando di essere stuprata da una camionata di nazisti, una donna colta è incredula perché attratta solo da uomini rozzi e grossolani, un’altra ha atteggiamenti di maternage e dolcezza nei rapporti, mentre per venire deve immaginare di possedere una donna «come farebbe un uomo» e sbatterla contro il muro (cfr. pp. 19-20).
In un’affascinante ricognizione di frammenti clinici, Lolli mostra come la pulsione faccia il paio con nient’altro che la singolarità, da cui «l’impossibilità di pensare […] la sua precisione» (cfr. p. 59). È possibile un’ontologia che renda conto dell’evento singolare della clinica? E ancora, possiamo permetterci di ontologizzare uno dei quattro concetti fondamentali della psicoanalisi (inconscio, ripetizione, transfert, pulsione) senza conseguenze? Col dire che la pulsione è un concetto che resiste all’appiattimento o riduzione ontologica, non intendiamo, ovviamente, che essa eluda il corpo o che in qualche modo non parta da esso: è ricorsivo e presente carsicamente come sfondo, nella produzione di Lolli, l’interesse per il corpo come “inizio” – dalla prima esperienza come psicoterapeuta in un istituto di riabilitazione per soggetti con disabilità motorie e psichiche a opere quali Prima di essere io e L' ingorgo del corpo – inizio che è al contempo uno slittamento: dal fisiologico al pulsionale, da cui si traccia la loro co-implicazione.



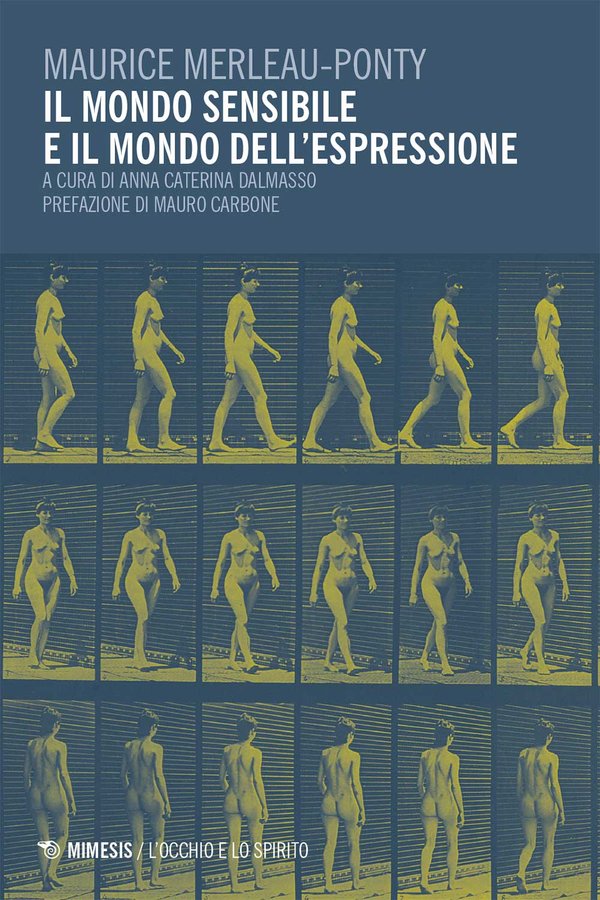




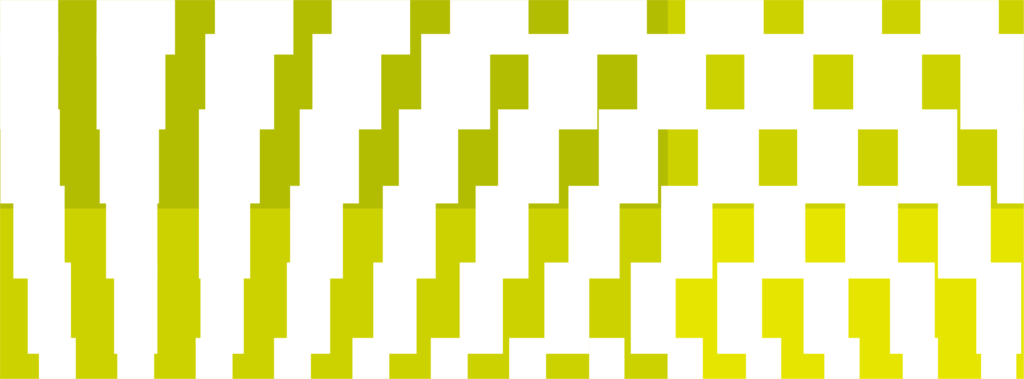
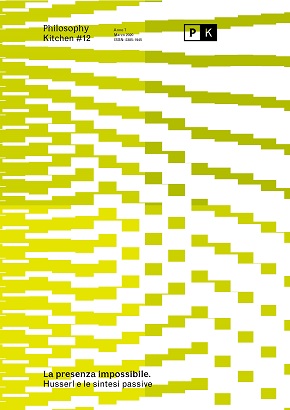

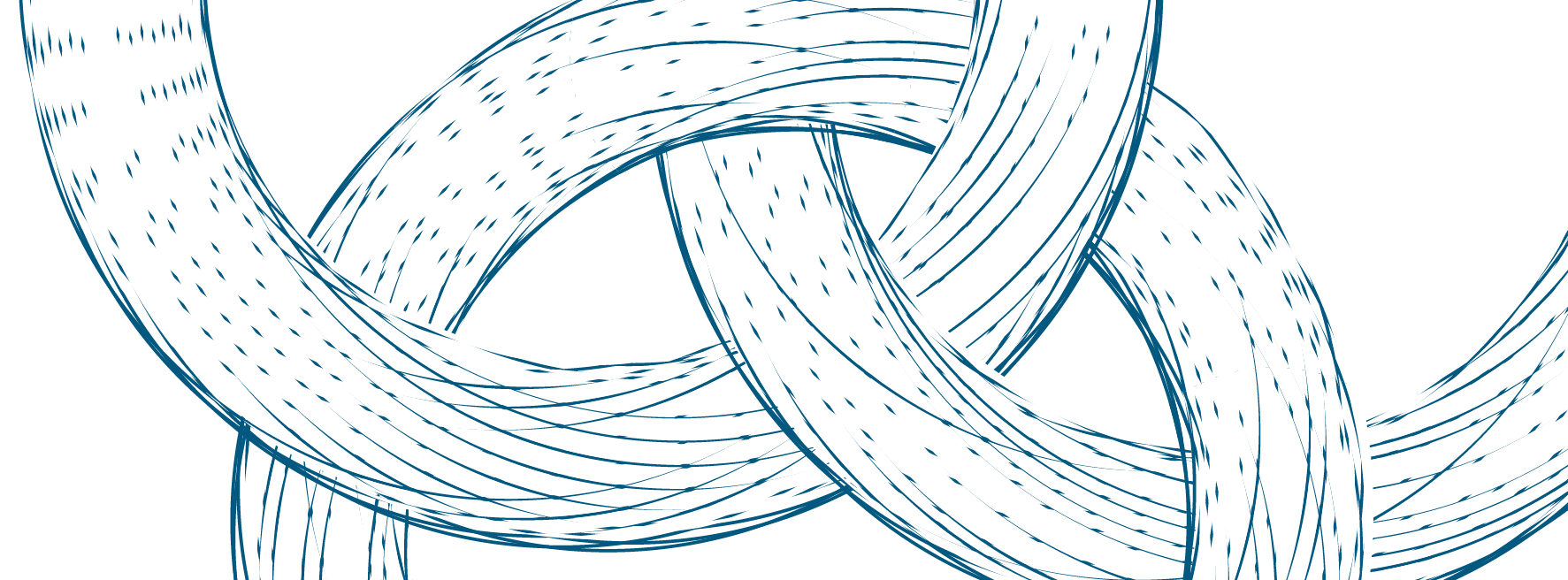
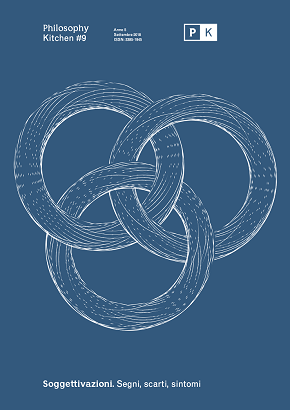
 Se volessimo individuare le idee che si collocano alla base della nascita della filosofia in India dovremmo articolare un discorso attraverso tre passaggi tra loro collegati. Innanzitutto dovremmo dire che i testi radicali della riflessione filosofica indiana, le Upaniṣad, sono interamente pervasi dalla ricerca della corrispondenza tra macro e micro cosmo. Questa istanza di unità diventò però immediatamente l’occasione per riflettere su due problemi interconnessi. Il primo problema è quello che in occidente definiremmo del “trascendentale”, intendendo con ciò un’anticipazione della visione kantiana secondo cui la realtà empirica è soltanto la forma in cui la realtà essenziale si presenta alla coscienza, ma tale realtà empirica non sussiste indipendentemente da una coscienza. In tempi antichissimi, intorno al secondo millennio avanti Cristo, tale visione della correlazione tra coscienza e mondo e insieme della necessità di un suo superamento verso una dimensione unitaria dell’esperienza divenne manifesta ai veggenti vedici assisi in meditazione nelle foreste indiane. Le Upaniṣad dettero il nome di ātman (letteralmente: “sé”) alla scoperta di questo principio trascendentale. Da un punto di vista metafisico l’ātman è un principio reggitore e ordinatore dell’universo e, quando viene considerato come Sé universale, possiede anche un aspetto psichico che lo rende auto-cosciente del tutto. Il punto centrale di questo primo aspetto della riflessione indiana delle origini è quindi l’identificazione del cosmico con lo psichico, nel senso che l’ātman si configura come un assoluto che possiede insieme i caratteri dell’essere e del pensiero. La coscienza-ātman non ha quindi niente fuori di sé, e tutti gli oggetti e le relazioni dell’universo esistono solo in quanto oggetti-di-conoscenza. Questo quadro concettuale, che possiede una innegabile connotazione trascendentalista, compare per la prima volta nella Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad (tra il IX e l'VIII secolo a.C), attraverso il punto di vista del maestro Yājñavalkya [1] e sarà una delle direttrici principali della riflessione filosofica indiana matura. Durante il periodo classico della filosofia indiana (V-VIII secolo d. C.) – in cui troviamo dei sistemi filosofici distinti che però condividono alcune idee di base che provengono dalla fase upaniṣadica – portato fondamentale di tale concezione trascendentale sarà il concetto di māyā, ovvero 1) il fatto che il mondo empirico sia “apparenza”, dal momento che non è possibile conoscere la reale essenza delle cose, e 2) che la pluralità non sia reale in senso proprio, dal momento che solo l’unità è reale, e questa unità è l’unità della coscienza, cioè dell’ātman. [2]
Se volessimo individuare le idee che si collocano alla base della nascita della filosofia in India dovremmo articolare un discorso attraverso tre passaggi tra loro collegati. Innanzitutto dovremmo dire che i testi radicali della riflessione filosofica indiana, le Upaniṣad, sono interamente pervasi dalla ricerca della corrispondenza tra macro e micro cosmo. Questa istanza di unità diventò però immediatamente l’occasione per riflettere su due problemi interconnessi. Il primo problema è quello che in occidente definiremmo del “trascendentale”, intendendo con ciò un’anticipazione della visione kantiana secondo cui la realtà empirica è soltanto la forma in cui la realtà essenziale si presenta alla coscienza, ma tale realtà empirica non sussiste indipendentemente da una coscienza. In tempi antichissimi, intorno al secondo millennio avanti Cristo, tale visione della correlazione tra coscienza e mondo e insieme della necessità di un suo superamento verso una dimensione unitaria dell’esperienza divenne manifesta ai veggenti vedici assisi in meditazione nelle foreste indiane. Le Upaniṣad dettero il nome di ātman (letteralmente: “sé”) alla scoperta di questo principio trascendentale. Da un punto di vista metafisico l’ātman è un principio reggitore e ordinatore dell’universo e, quando viene considerato come Sé universale, possiede anche un aspetto psichico che lo rende auto-cosciente del tutto. Il punto centrale di questo primo aspetto della riflessione indiana delle origini è quindi l’identificazione del cosmico con lo psichico, nel senso che l’ātman si configura come un assoluto che possiede insieme i caratteri dell’essere e del pensiero. La coscienza-ātman non ha quindi niente fuori di sé, e tutti gli oggetti e le relazioni dell’universo esistono solo in quanto oggetti-di-conoscenza. Questo quadro concettuale, che possiede una innegabile connotazione trascendentalista, compare per la prima volta nella Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad (tra il IX e l'VIII secolo a.C), attraverso il punto di vista del maestro Yājñavalkya [1] e sarà una delle direttrici principali della riflessione filosofica indiana matura. Durante il periodo classico della filosofia indiana (V-VIII secolo d. C.) – in cui troviamo dei sistemi filosofici distinti che però condividono alcune idee di base che provengono dalla fase upaniṣadica – portato fondamentale di tale concezione trascendentale sarà il concetto di māyā, ovvero 1) il fatto che il mondo empirico sia “apparenza”, dal momento che non è possibile conoscere la reale essenza delle cose, e 2) che la pluralità non sia reale in senso proprio, dal momento che solo l’unità è reale, e questa unità è l’unità della coscienza, cioè dell’ātman. [2]
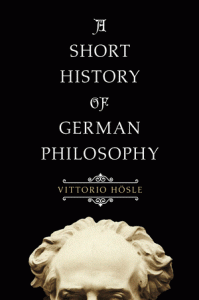 É uscita a novembre 2016, tre anni dopo la prima edizione tedesca, la traduzione inglese dell'ultima fatica di Vittorio Hösle, A Short History of German Philosophy, curata da Steven Rendall per Princeton University Press e arricchita di una nuova prefazione. L'autore, italo-tedesco e attualmente docente alla University of Notre Dame, la più prestigiosa università cattolica degli Stati Uniti, si è distinto sin da giovane grazie a una serie di pubblicazioni ambiziose, culminate nel 1987 in un poderoso studio sul sistema filosofico hegeliano (Il sistema di Hegel, tradotto in italiano nel 2012 per La scuola di Pitagora), e nel 1997 in un altrettanto voluminoso lavoro sul rapporto tra moralità e politica (Moral und Politik, non ancora tradotto in italiano). In altri libri e saggi Hösle ha coltivato interessi interdisciplinari, mostrando una padronanza di diversi campi culturali a dir poco rara al giorno d'oggi (si è occupato tra le altre cose di Darwin, di filosofia della religione e di estetica del cinema). Il tratto distintivo del suo pensiero consiste nel riconoscere la verità filosofica dell'idealismo oggettivo, seguendo la via tracciata tra gli altri da Platone, Vico ed Hegel, e tenendo conto del fondamentale contributo kantiano. Questa impostazione secondo Hösle si rivela valida ancora oggi, ma va aggiornata e confrontata con le acquisizioni del dibattito scientifico e filosofico attuale. Torna così in questo autore a essere cruciale l'istanza sistematica dell'opera hegeliana, oggi a dir poco negletta: coloro che recentemente si sono avvicinati a Hegel (si pensi solo agli americani Robert Brandom e John McDowell, o al tedesco Axel Honneth) si rapportano a essa con indifferenza, se non con sospetto.
É uscita a novembre 2016, tre anni dopo la prima edizione tedesca, la traduzione inglese dell'ultima fatica di Vittorio Hösle, A Short History of German Philosophy, curata da Steven Rendall per Princeton University Press e arricchita di una nuova prefazione. L'autore, italo-tedesco e attualmente docente alla University of Notre Dame, la più prestigiosa università cattolica degli Stati Uniti, si è distinto sin da giovane grazie a una serie di pubblicazioni ambiziose, culminate nel 1987 in un poderoso studio sul sistema filosofico hegeliano (Il sistema di Hegel, tradotto in italiano nel 2012 per La scuola di Pitagora), e nel 1997 in un altrettanto voluminoso lavoro sul rapporto tra moralità e politica (Moral und Politik, non ancora tradotto in italiano). In altri libri e saggi Hösle ha coltivato interessi interdisciplinari, mostrando una padronanza di diversi campi culturali a dir poco rara al giorno d'oggi (si è occupato tra le altre cose di Darwin, di filosofia della religione e di estetica del cinema). Il tratto distintivo del suo pensiero consiste nel riconoscere la verità filosofica dell'idealismo oggettivo, seguendo la via tracciata tra gli altri da Platone, Vico ed Hegel, e tenendo conto del fondamentale contributo kantiano. Questa impostazione secondo Hösle si rivela valida ancora oggi, ma va aggiornata e confrontata con le acquisizioni del dibattito scientifico e filosofico attuale. Torna così in questo autore a essere cruciale l'istanza sistematica dell'opera hegeliana, oggi a dir poco negletta: coloro che recentemente si sono avvicinati a Hegel (si pensi solo agli americani Robert Brandom e John McDowell, o al tedesco Axel Honneth) si rapportano a essa con indifferenza, se non con sospetto.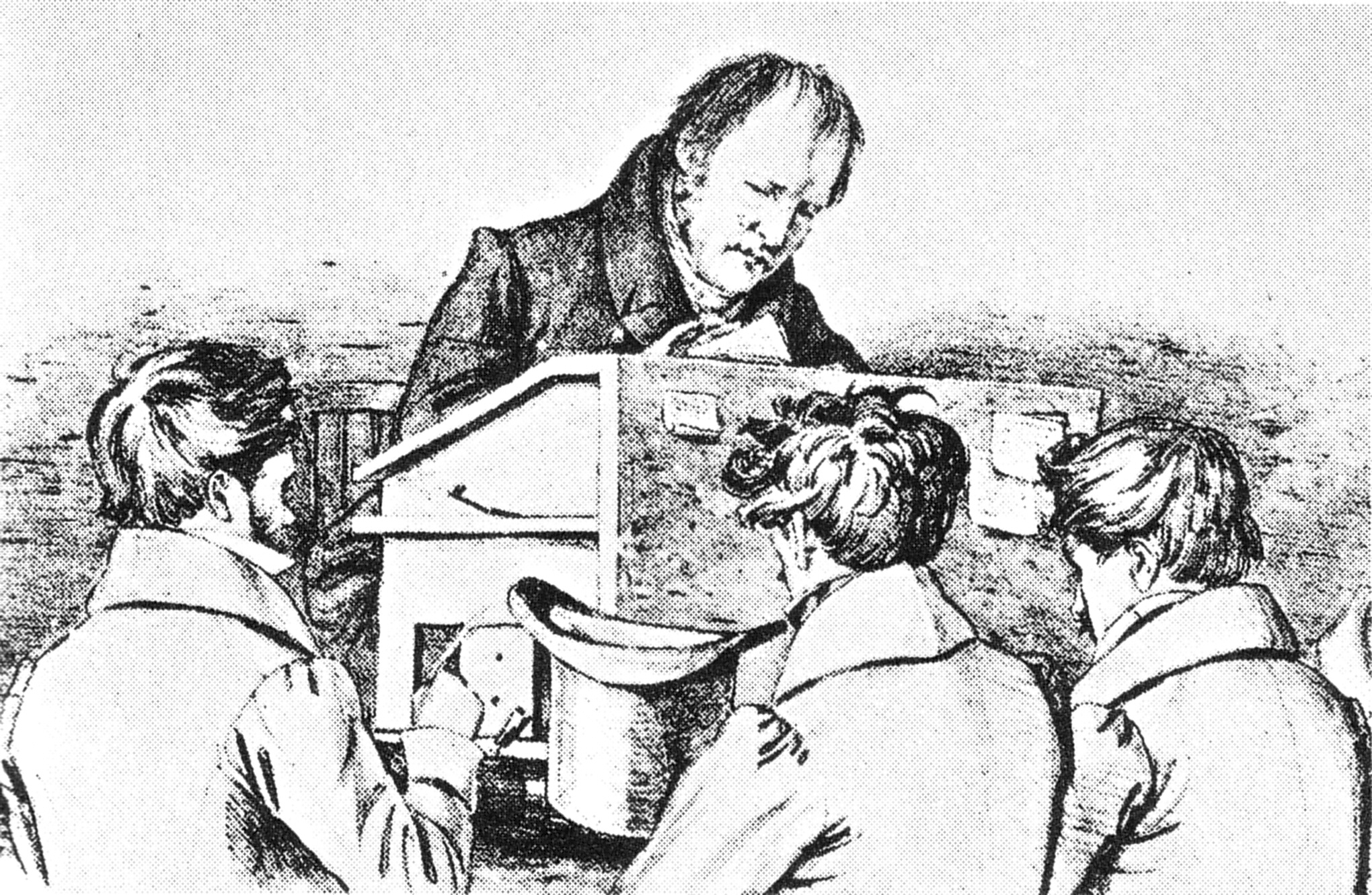
 Il rompicapo della realtà. Metafisica, ontologia e filosofia della mente in E. J. Lowe (Mimesis, Milano 2015) di Timothy Tambassi è la prima monografia dedicata interamente al pensiero di Lowe, il quale ha contribuito a impreziosirla seguendone la stesura passo per passo fino alla versione definitiva (la tesi di dottorato dell’autore) senza tuttavia potere assistere alla pubblicazione del volume, avvenuta a poco più di un anno dalla morte dello stesso Lowe. Il sottotitolo rivela il contenuto vero e proprio del libro: non ogni aspetto della ricerca di Lowe, ma quelli considerati più aderenti al suo nucleo teoretico, ossia la metafisica, l’ontologia e la filosofia della mente, a cui corrispondono i tre capitoli del libro. Più in particolare, Tambassi mira a mostrare la stretta connessione sussistente fra questi aspetti della proposta loweiana, la loro costitutiva apertura ai risultati delle scienze e, più in generale, ad altre forme di indagine della realtà. Secondo Lowe, infatti, la riflessione metafisica – focalizzata sui tre concetti cardine di realtà, di sostanza e di risorse esplicative – costituisce lo sfondo concettuale imprescindibile dell’ontologia e della filosofia della mente e conseguentemente, attraverso queste ultime, di ogni altra forma di indagine della realtà. Come vedremo, però, la scelta di presentare una sintesi coerente solo del nucleo essenziale della proposta loweiana, se da un lato abbrevia certamente la via per l’acquisizione di una certa dimestichezza col suo pensiero, dall’altro, però, rischia di contrarre nella pura dimensione dell’implicito la ricchezza di temi e questioni che pure hanno caratterizzato il lavoro filosofico di Lowe e che intrattengono un ruolo di continuo scambio col suo nucleo – e non semplicemente di mera applicazione o conseguenza.
Il rompicapo della realtà. Metafisica, ontologia e filosofia della mente in E. J. Lowe (Mimesis, Milano 2015) di Timothy Tambassi è la prima monografia dedicata interamente al pensiero di Lowe, il quale ha contribuito a impreziosirla seguendone la stesura passo per passo fino alla versione definitiva (la tesi di dottorato dell’autore) senza tuttavia potere assistere alla pubblicazione del volume, avvenuta a poco più di un anno dalla morte dello stesso Lowe. Il sottotitolo rivela il contenuto vero e proprio del libro: non ogni aspetto della ricerca di Lowe, ma quelli considerati più aderenti al suo nucleo teoretico, ossia la metafisica, l’ontologia e la filosofia della mente, a cui corrispondono i tre capitoli del libro. Più in particolare, Tambassi mira a mostrare la stretta connessione sussistente fra questi aspetti della proposta loweiana, la loro costitutiva apertura ai risultati delle scienze e, più in generale, ad altre forme di indagine della realtà. Secondo Lowe, infatti, la riflessione metafisica – focalizzata sui tre concetti cardine di realtà, di sostanza e di risorse esplicative – costituisce lo sfondo concettuale imprescindibile dell’ontologia e della filosofia della mente e conseguentemente, attraverso queste ultime, di ogni altra forma di indagine della realtà. Come vedremo, però, la scelta di presentare una sintesi coerente solo del nucleo essenziale della proposta loweiana, se da un lato abbrevia certamente la via per l’acquisizione di una certa dimestichezza col suo pensiero, dall’altro, però, rischia di contrarre nella pura dimensione dell’implicito la ricchezza di temi e questioni che pure hanno caratterizzato il lavoro filosofico di Lowe e che intrattengono un ruolo di continuo scambio col suo nucleo – e non semplicemente di mera applicazione o conseguenza.