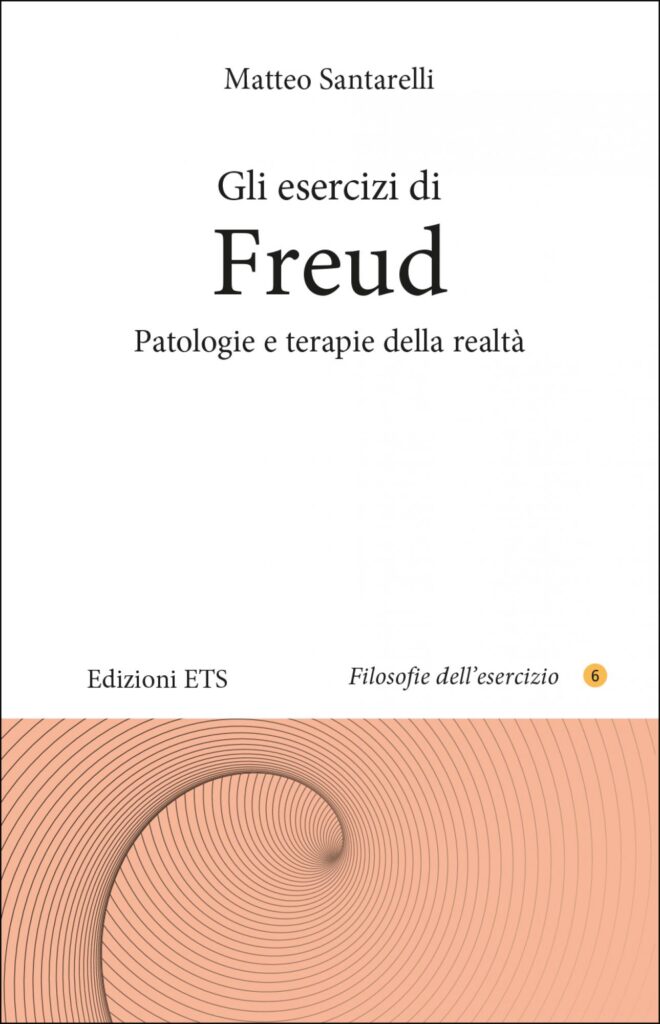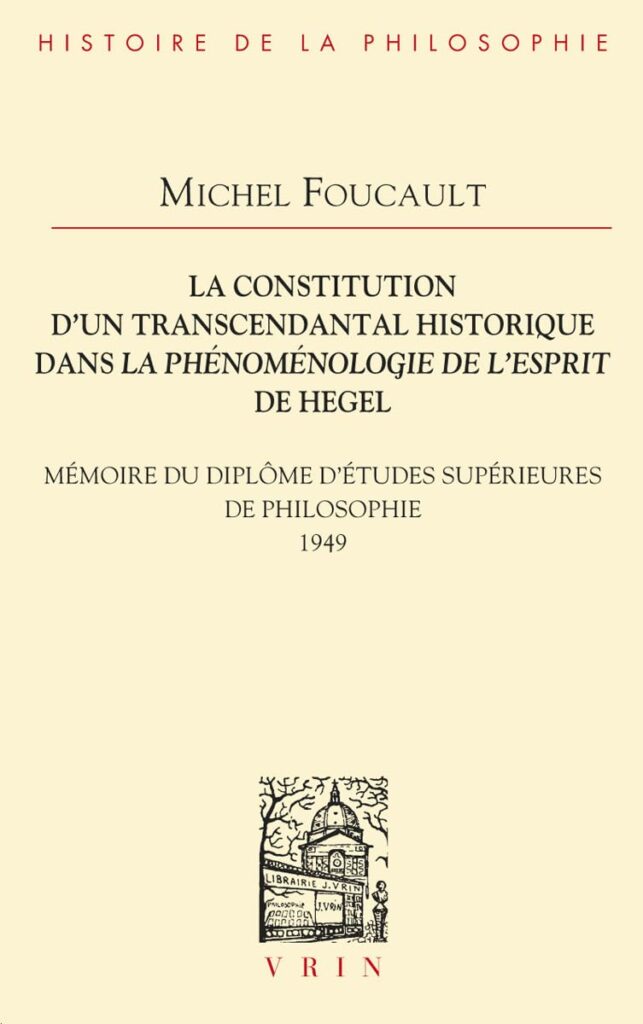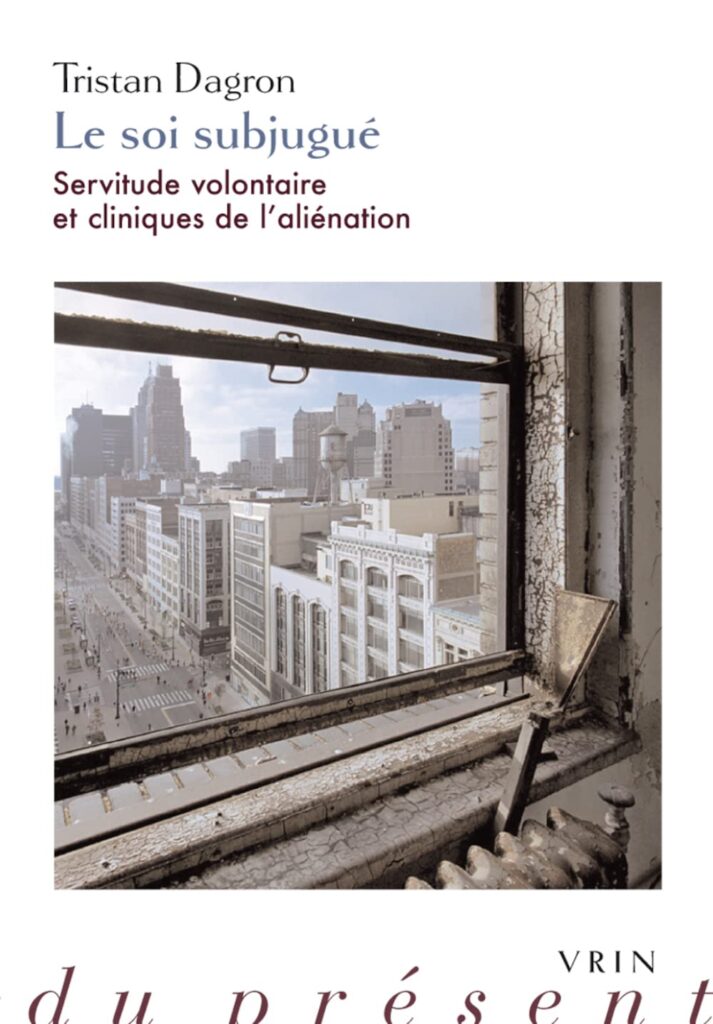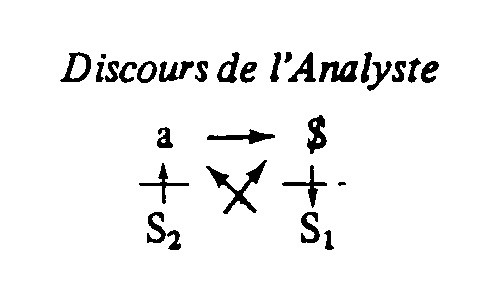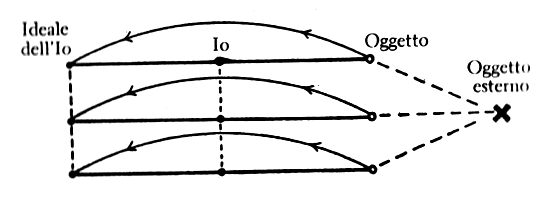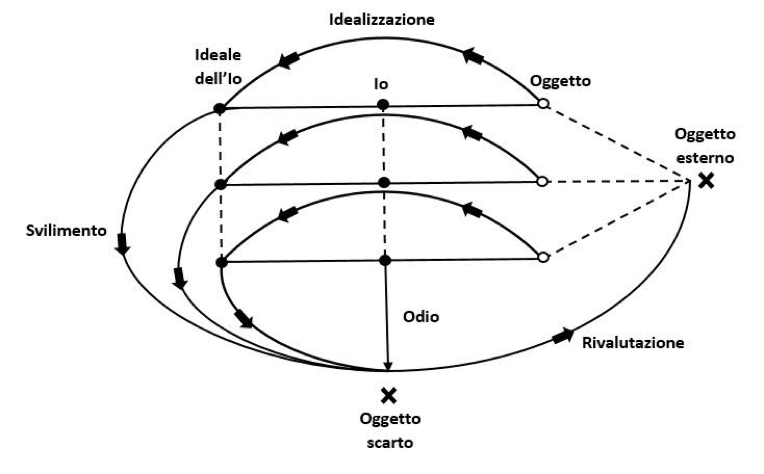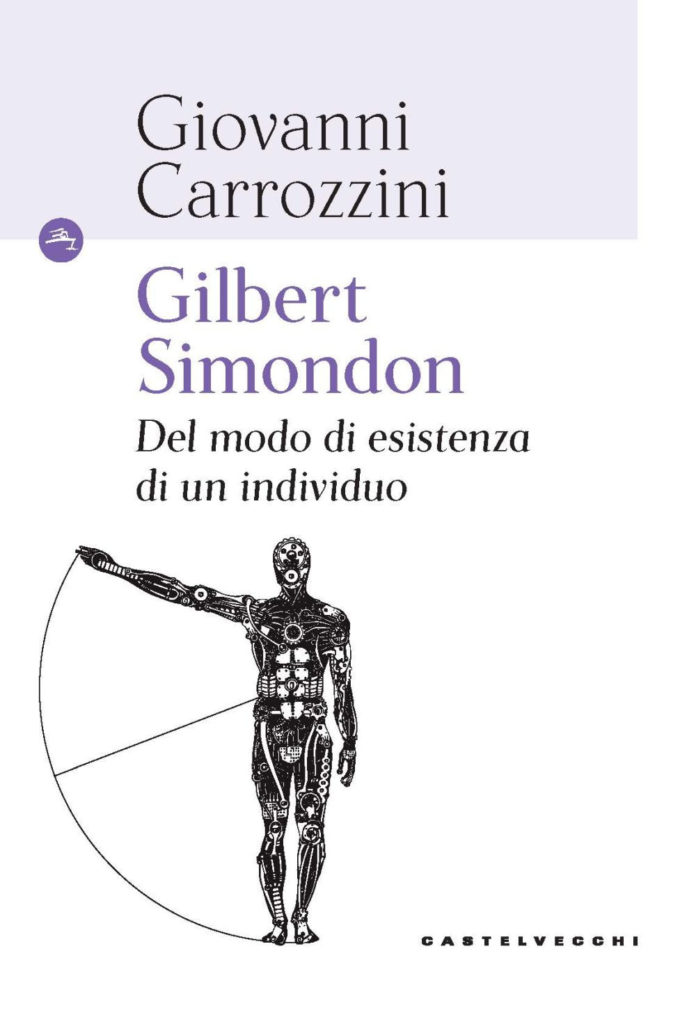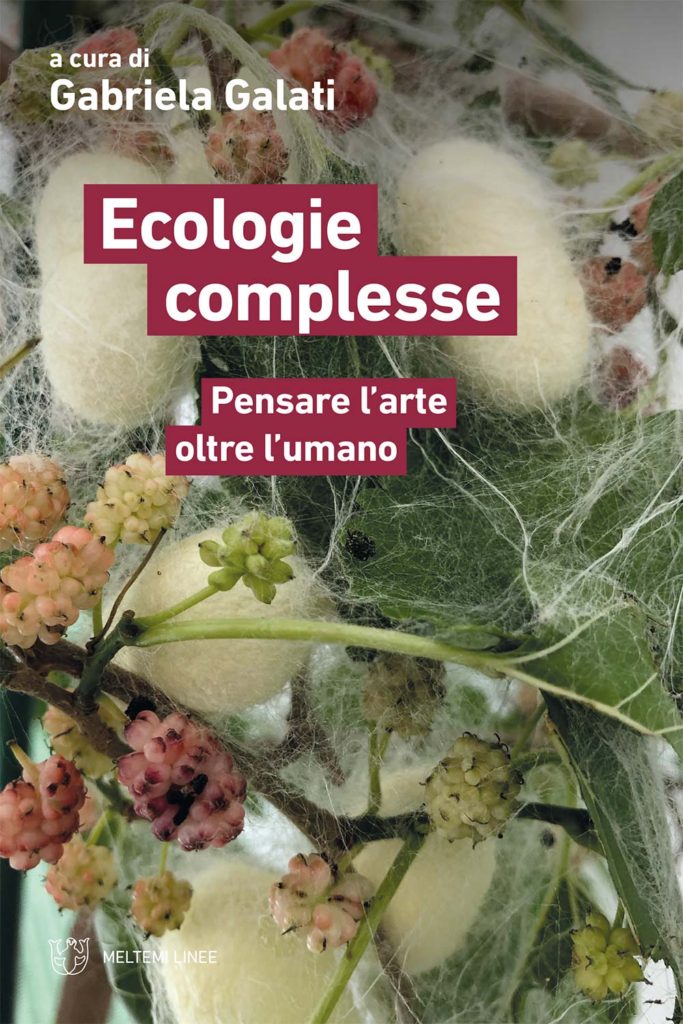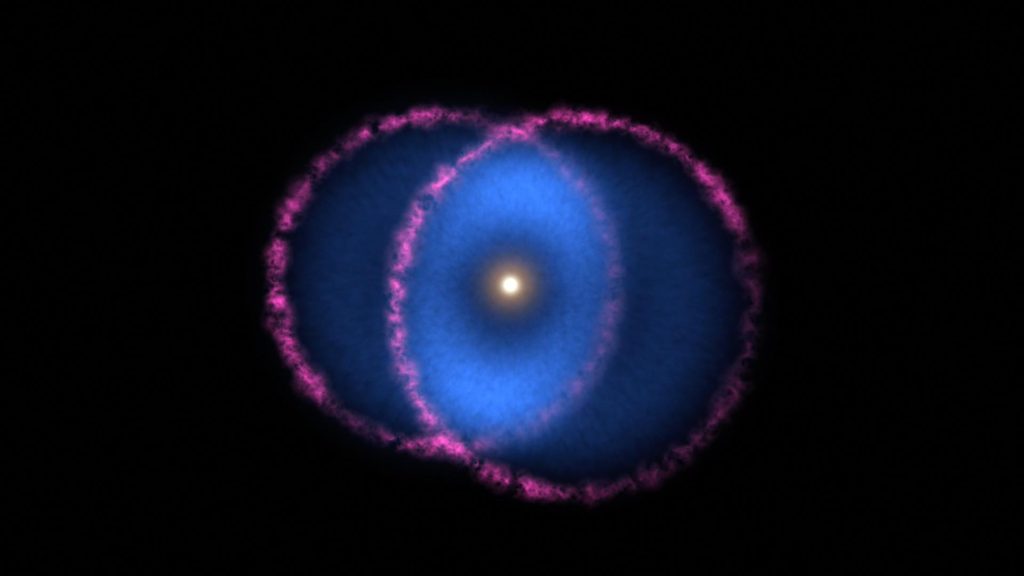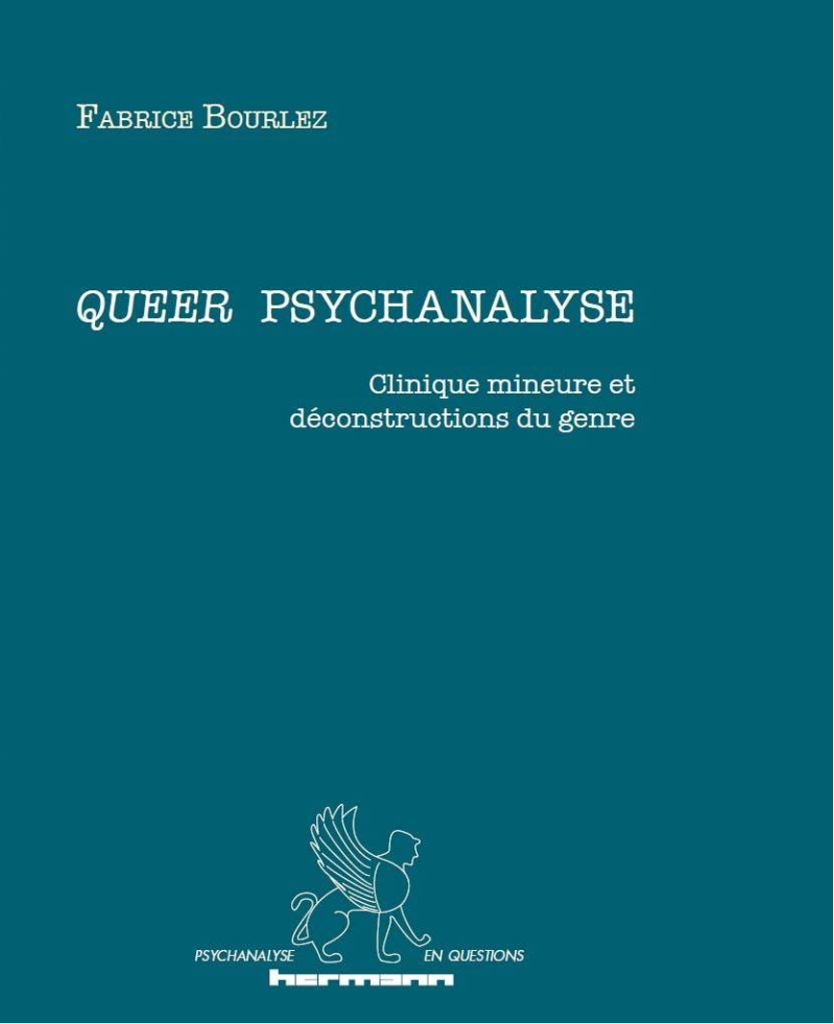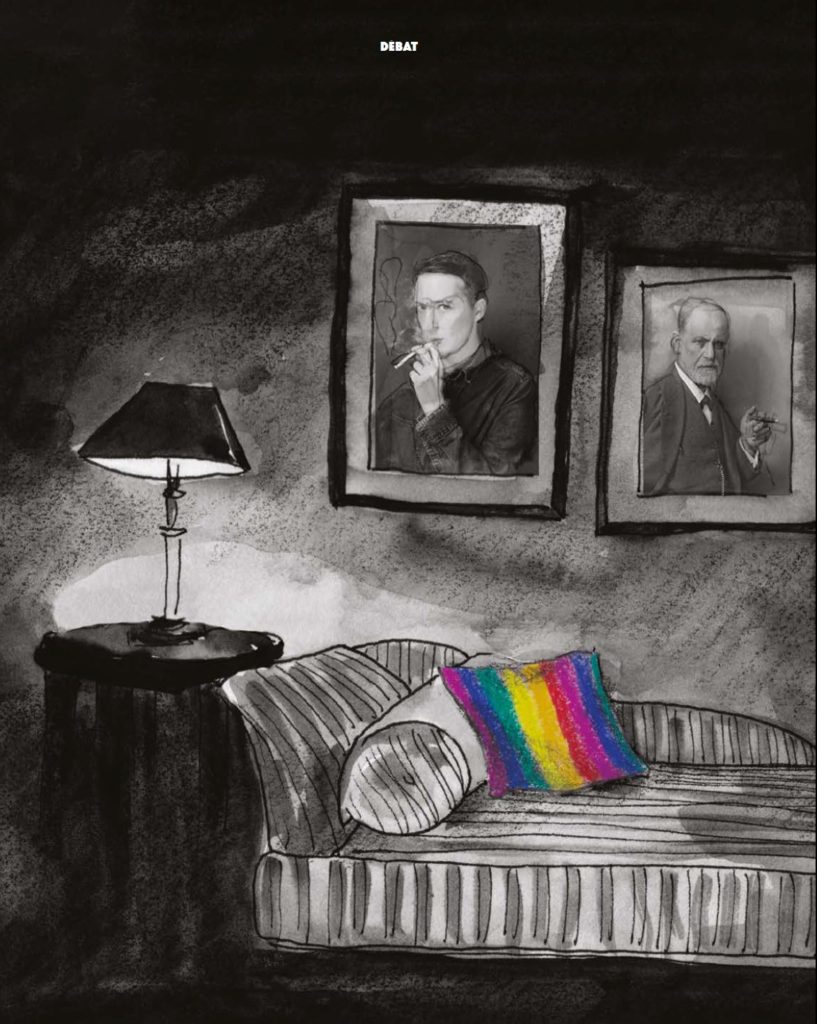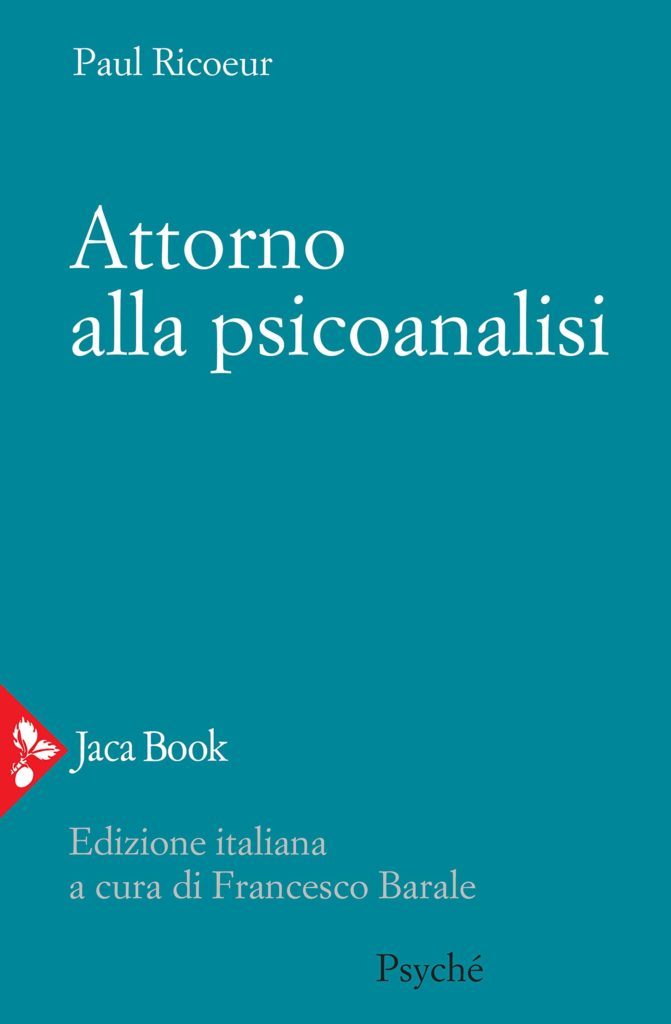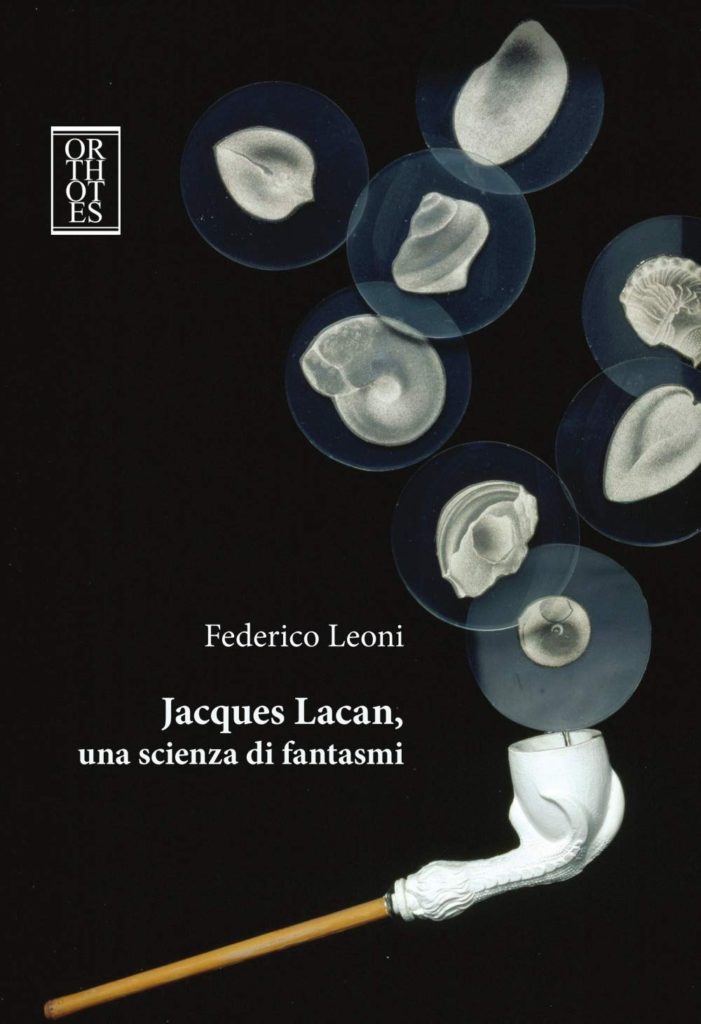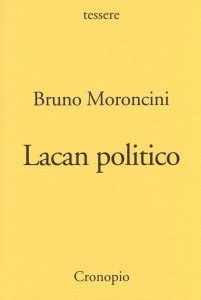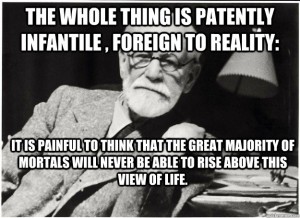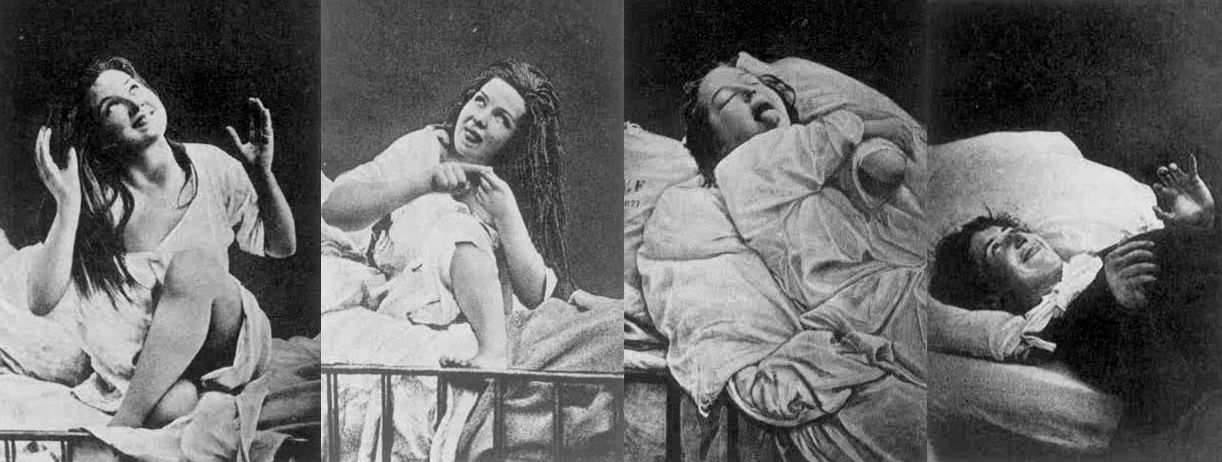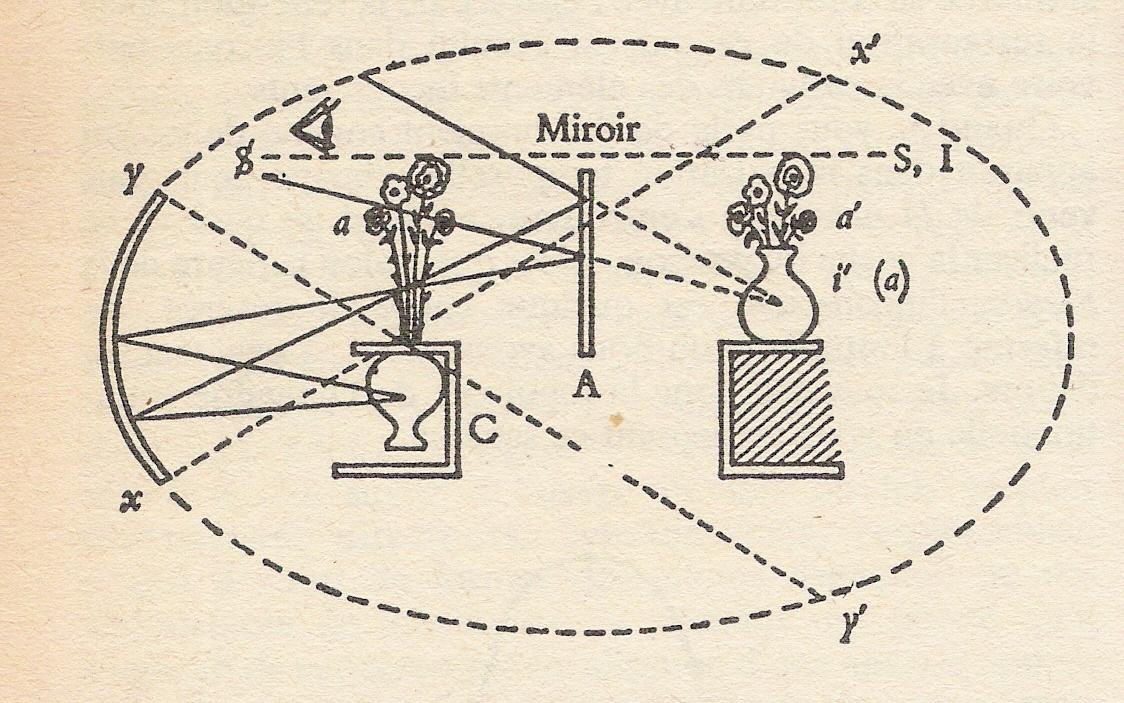-
-
Restituire una lettura esaustiva e completa del testo di Michel Foucault, La Constitution d’un transcendental historique dans la Phénoménologie de l’Esprit de Hegel (2024, 242 pp.), pubblicato dalla prestigiosa casa editrice parigina Vrin nella collana Bibliotèque d’histoire de la philosophie, ottimamente curato da Christophe Bouton, che firma anche un prezioso saggio introduttivo (7-56), richiederebbe uno studio di gran lunga più particolareggiato e approfondito in quanto esso si colloca nell’intersezione di molteplici piani di lettura, coinvolgendo tanto l’esegesi del pensiero foucaultiano quanto il ruolo della Fenomenologia hegeliana nel pensiero francese del Novecento.
Si può però senz’altro dare una ricostruzione, necessariamente parziale, del volume. Va detto subito che non si tratta di un vero e proprio libro di Foucault, bensì di un mémoire - ritrovato nella casa di famiglia del grande filosofo da Henri-Paul Fruchaud - scritto e discusso, l’11 giugno 1949, alla Sorbona davanti a una commissione composta da Henri Gouhier (storico fondatore della collana che ospita il volume in questione), Jean Wahl e, soprattutto, Jean Hyppolite, che ne è stato anche il supervisore. Il testo ha avuto lo scopo di far conseguire a Foucault il diplôme d’études supérieures (DES), percorso intermedio della formazione di un intellettuale francese e necessario, al tempo, per poter accedere all’agrégation. La discussione del DES è contemporanea al diploma in psicologia generale conseguito da Foucault il 4 luglio dello stesso anno. Siamo di fronte, quindi, a uno dei passaggi fondamentali della formazione del giovane filosofo, i cui riverberi, anche se con tante variazioni, accompagneranno e ne indirizzeranno i futuri lavori.
Pur nella enorme difficoltà di una restituzione oggettiva e fedele, partire dalla struttura del libro può rendere conto dei differenti piani che lo attraversano. Esso si compone, oltre al capitolo introduttivo, alla conclusione, a una appendice antologica (205-220) e due progetti di stesura del mémoire (227-238), di tre macro-sezioni, Le champ trascendental, Le sujet trascendental e Le trascendental et l’histoire, composte da tre (quattro, nel caso dell’ultima) capitoli che ricostruiscono l’argomento in questione. Le Remarques préliminaires (62-69) presentano una questione di metodo sulla quale è opportuno soffermarsi brevemente. Foucault apre il suo mémoire consapevole della delicatezza del tema affrontato, poiché parlare di trascendentale nella filosofia di Hegel rischia di mettere l’esegeta (e il lettore) di fronte a «une contradiction insurmontable : interroger Hegel sur un point auquel il n’a pas voulu répondre […], c’est admettre que le véritable hégélianisme ne fut pas ce qu’il apparut à Hegel» (63). Emerge subito lo stile metodologico del giovane Foucault, nel quale il lettore avvertito - in realtà - può già fiutare quello del Foucault degli anni Sessanta: interrogare un autore non sulle sue intenzioni manifeste, ma sulle condizioni del pensiero di quello stesso autore, con le parole di Canguilhem (2011: 430), «il suo sistema universale di referenza con la propria epoca». Non si tratta di cercare un hegelismo più autentico di quello professato dallo stesso Hegel, bensì di mettere in atto un vero e proprio metodo storico-genealogico. Se da un lato, come scrive Bouton nell’introduzione, «Hegel - et Foucault le sait bien - n’a pas présenté sa Phénoménologie en utilisant le terme de “trascendental”, qui n’apparaît pas une seule fois dans son ouvrage» (16), è altresì vero, dall’altro, che «Foucault fait une distinction entre la question qu’un philosophe a explicitemente posée et traitée, et le problème implicite auquel sa pensée a été confrontée, qui s’inscrit lui-même dans une problématique plus vaste» (18). Ecco il principio di metodo: distinguere tra la questione esplicita e il problema implicito che “costringe” un pensiero a mettersi in opera.
La questione del trascendentale in Hegel diventa un campo problematico, al quale egli non avrebbe mai smesso di rispondere e che si manifesterebbe nella Fenomenologia. Non si tratta, è bene insistere, di far dire a Hegel qualcosa che questi non avrebbe mai detto, ma di coglierlo alle prese con un’istanza problematica: «il faudra montrer - scrive Foucault - le passage d’un mode de l’historicité à une autre mode d’historicité, comment, par example, la philosophie du trascendental chez Kant devient, dans l’histoire, une catégorie de la pensée, comment, autriment dit, l’historicité constituée du trascendental kantien devient una historicité constituante dans le philosophe postérieure» (64). Sebbene non sia un che di empirico, il trascendentale non è neppure qualcosa che sta nella testa di Kant, come una chimera o un’intuizione intellettuale, è piuttosto qualcosa che, una volta determinato e definito in un campo di possibilità, diviene un vero e proprio agente storico che si trasforma e da oggetto puramente definito in un luogo e in un tempo, la Königsberg di fine Settecento, apre un campo storico inedito con cui tutti i filosofi successivi non potranno non confrontarsi. C’è una materialità non empirica del trascendentale, ed è solo il riconoscimento di questa dimensione ulteriore che giustifica, in ultimo, la possibilità di interrogare il modo in cui tale materia diviene e si metamorfizza nella Fenomenologia hegeliana. Sebbene, dunque, Hegel non sia esplicitamente un filosofo trascendentale, nella sua filosofia (almeno nel periodo di Jena) questo stesso piano trascendentale cambia forma - anzi, figura - e diventa occasione filosofica, non come oggetto, ma in quanto orizzonte, aperto da Kant, che esprime la necessità del pensiero di mettersi in movimento. L’analisi del trascendentale mostra, agli occhi del giovane Foucault, il modo in cui una questione storicamente posta diviene un problema filosofico: il trascendentale diviene cosciente di sé in quanto problema e si individua attraverso il processo metamorfico delle sue figure. Le figure che Foucault individua sono quelle delle tre parti che compongono il suo scritto: il campo, il soggetto e infine la storicità del trascendentale.
Il campo trascendentale assume una funzione strategica poiché permette di superare tanto la soluzione kantiana quanto quella fichtiana (76-77): se il primo ha pensato il trascendentale come un piano formale opposto a un mondo empirico, il secondo ne ha tentato una sistemazione dottrinaria autogena, dove però esso è solo presupposto e non colto nel suo effettuarsi. In entrambi i casi, rileva Foucault, si è mancato di «délimiter le champ trascendental» (78). Esso non è né mera forma vuota né corpus dottrinario autofondato, ma qualcosa di più fondamentale: un divenire fenomenologico, l’istituirsi di un campo di possibilità immanente in relazione all’alterità che ne costituisce la mediazione dialettica. Il campo esprime la verità del trascendentale intesa come sviluppo e non intuizione immediata della totalità. Contro il vuoto formalismo kantiano, la Fenomenologia gioca la capacità di automediazione del piano trascendentale: esso non rimanda a un esteriorità empirica, una Realität nel lessico hegeliano. Contro l’intuizionismo fichtiano va però rimarcato il momento della possibilità dell’esperienza trascendentale, la sua Wirklichkeit. Mai meramente in actu, il trascendentale è sempre inserito in uno sforzo continuo di raggiungere la sua realizzazione effettiva attraverso una scissione interna che ne impedisce l’ossificazione nell’identità assoluta (Hegel, 2000: 43-45).
C’è un travaglio del trascendentale, una sua infelicità, che nel cuore stesso della notte “détient la lumière par quoi seront éclairées les ténèbres” (92). Il sapere trascendentale, quindi, non è né l’intuizione dell’identità assoluta né la vacuità delle forme a priori, ma confina con il non-sapere, tenta continuamente di determinarsi e si sa sempre imperfetto, cioè finito e infelice perché separato dalle condizioni di possibilità che ne strutturano il cammino. L’esperienza fenomenologica acquista «une signification qu’elle ne possédait pas elle-même, et révèle […] le milieu du savoir, c’est-à-dire le champ dans lequel pourra se développer un savoir» (101). L’esterno del Sapere così non è un noumeno - contro l’ipotesi noumenologica di J. Wahl (96-97) - ma un negativo che determina le condizioni di possibilità del sapere stesso.
Questa installazione del sapere trascendentale in un campo è, agli occhi di Focuault, la dimensione “vitale” della Fenomenologia: il campo è la situazione in cui la coscienza del sapere e del non-sapere si determina come possibilità concreta di divenire Ragione, cioè sapere assoluto. Questo è il senso critico del pensiero hegeliano: non la determinazione a priori delle facoltà soggettive, ma - e qui emerge l’influenza di Hyppolite - la «critique conrète de la raison concrète» (110), la quale passa attraverso le tappe di un processo di individuazione. Anche qui, una torsione importante: se il trascendentale non è ciò che si oppone all’empirico, ma ha una sua materialità immanente, in che modo definire questa situazione concreta della ragione?
In quanto inserito in un campo di possibilità, il soggetto trascendentale, nella materialità della sua situazione, abita una profonda ambiguità. Esso non è né l’io penso kantiano, forma vuota e indifferente a qualsiasi contenuto del sapere e al tempo stesso autocoscienza immediata di sé, né l’Io sono di Descartes, il quale, cercando la radice di ogni sapere nell’evidenza della propria esistenza, ha continuamente oscillato, agli occhi dello Hegel foucaultiano, tra l’Io come statuto ontologico (sostanza) e l’io come fonte concreta del sapere (io penso dunque… sono certo di essere). In entrambi i casi, ancora una volta, è la Wirklichkeit che si manca, e che l’idea di campo richiede rigorosamente (118-123). L’Io penso, se vuole davvero porsi come fondamento del sapere dovrà, di nuovo e ancora, trovarsi in rapporto con ciò che fa l’effettività del sapere stesso. In questo senso il soggetto trascendentale hegeliano è un «rapport actuel» (120) che si dà nell’esperienza situata nel campo di possibilità stesso: né immediata certezza dell’Io sono né forma pura dell’Io penso, ma dinamica passionale dell’Io so (123-130).
Il soggetto è trascendentale non perché statico e avulso dalla sua realizzazione effettiva , ma poiché si esprime in un campo di esperienza possibile. È questo, per Foucault, il significato della dialettica fenomenologica (137-141). Il metodo del sapere assoluto inteso non come conoscenza definitiva, ma come passione dello Spirito (138) che si esprime attraverso il travaglio del soggetto di quello stesso sapere, passione di un sapere che è assoluto non in quanto racchiude la totalità empirica nella unità vuota di una intuizione sovrasensibile, ma in quanto è il suo stesso automovimento. Solo perché inserito in un campo che media continuamente i suoi assetti, il soggetto è trascendentale, si eleva, cioè, al di là dell’Io penso formale e dell’Io sono della certezza intellettuale. La dialettica è movimento espressivo (140), genera nel non-sapere una sfera di conoscenza che sa se stessa e la sua ignoranza, unisce assolutamente, all’interno del campo trascendentale, l’identità e la non identità. Sintesi materiale, dunque, e non formale: non sussunzione del molteplice entro le categorie astratte dell’intelletto, ma una ragione che si fa nelle cose, tra le pieghe di un reale che non è mai statica Realität ma Wirklichkeit, effettualità, realizzazione e in ultimo espressione. Proprio perché espressivo, il trascendentale nella sua materialità è connesso intimamente alla storicità, «le cours des événements pendant lequel se constitute le savoir absolu» (125).
Questo punto è delicato e teoreticamente cruciale. Come ricorda Bouton nell’introduzione, di origine kantiana, «le trascendentale n’est jamais presenté comme étant historique» (13). Anzi, per definizione, il piano trascendentale è l’elemento a-temporale che attraversa il tempo empirico - ne è condizione di possibilità. E tuttavia, proprio perché il trascendentale deve essere colto nella sua effettualità e non nella sua immediatezza, si tratta di sottolinearne l’ambiguità immanente: se da un lato, come ha giustamente visto Kant, esso è costituente, nel suo divenire fenomenologico esso si presenta altresì, e al tempo stesso, costituito. L’ambiguità del trascendentale è data proprio da questo suo momento passivo nell’attività costituente. Ed è in questo suo effettuarsi nella e con la negatività della sua situazione, che si può comprendere la storicità del trascendentale, ovvero «le résultat d’une imperfection du trascendental, qui fait qu’il n’est pas purement et simplement constituant ; elle est à sa limite l’expression de cette limite elle-même» (147).
Si tratta sempre di ricercare una materialità non empirica, che permetta di vedere delinearsi un sapere che sia assoluto non in quanto sussunzione formale totale - un assoluto, dice Foucault, «empiriquement métaempirique» (174) - ma in quanto capace di sapersi nel proprio posizionamento in un campo che ne permette l’esplicazione. Una tale materialità implica non solo, quindi, che si vedano i due “regni eterogenei”, come fece Kant, ma anche l’intervento di un terzo elemento tra l’empirico e il formale: in gioco c’è lo statuto stesso della filosofia. Una filosofia è tale quando è capace di cogliere l’unità materiale dei presupposti che ne determinano il campo di esplicazione: né oggettiva né soggettiva, la filosofia è sapere assoluto nella misura in cui riesce a cogliere la costituzione delle proprie condizioni di possibilità. Così tra l’in-sé e il per-sé di un’antinomia intellettuale (il regno delle cose e quello della libertà) emerge il per-noi, un elemento collettivo che non è l’unità algebrica o empirica di due sostanze, bensì «ce qui empêche la discontinuité totale de l’en-soi et du pour-soi, ce qui sauve la continuité du mouvement et du devenir» (180).
È così che la storia della filosofia diventa l’espressione stessa dell’emersione di una storicità del trascendentale, cioè dell’insieme delle condizioni di possibilità del pensiero filosofico, le figure del sapere assoluto che interrompono il manicheismo delle fredde astrazioni dell’intelletto (le varie dottrine della scienza) senza cedere all’unità sentimentale dell’anti-filosofia (la notte in cui le vacche sono nere). In questa storia dell’Assoluto, che attraversa le sue figure, le sue “immediatezze”, le sue “passioni”, si esplica l’idea di una filosofia che è Scienza fenomenologica. Essa non si limita solo a un sapere particolare ma costruisce, in «un mouvement de descente sur place, […] l’axiomatique de la pensée», un campo trascendentale «où les mondes miniscules d’une expérience au pluriel […] découvrent leur raison d’être dans la singularité d’un univers unique» (200). La filosofia come sapere assoluto coglie sì l’Uno, ma non l’Ens Realissimum indifferente alle proprie determinazioni di un pensiero dogmatico, bensì che «a l’ambigüité d’être à la fois élément e principe» (201). Solo il sapere filosofico in quanto scienza può posizionarsi in questa ambiguità fondamentale dell’Assoluto e pensarne non «le tracé géographique d’un univers totalement exploré ; il est seulement la possibilité ouverte de contenus en puissance» (201). Il sapere è assoluto non perché sia «plenitude de conentu» ma perché campo trascendentale, «milieu conceptual», apertura di un possibile. Il trascendentale non rimanda più, come in Kant, a una “esperienza possibile”, ma alla “possibilità stessa dell’esperienza”. In ultimo, Foucault ritrova una passione del trascendentale che fa tutt’uno con quella della filosofia: entrambe sono sempre esposte al rischio della ossificazione, della miseria (nel senso del giovane Marx [186-189]), allo scacco dell’infelicità. La riuscita o meno di questa possibilità - la Wirklichkeit del trascendentale e dell’Assoluto - è espressione della sua profonda storicità, cioè «l’histoire de ce qui […] était le moins historique» (203).
Una storicità del trascendentale non è dunque né la sua negazione “formale”, né un rifiuto idealistico, bensì il divenire concreto ed effettivo di una problematica che non è solo dentro la testa di un filosofo - inteso come esperto di una disciplina - ma l’emersione stessa di una figura del sapere assoluto, che rompe con quelle precedenti e fa emergere una nuova articolazione fondamentale del sapere e dell’Assoluto. Il trascendentale storico, partendo dall’unità di storia e ragione (Hyppolite, 2019: 63-87), diventa la condizione di pensabilità stessa di quella che, una ventina d’anni più tardi sarà, con tutte le variazioni del caso, l’Episteme, ciò che è, «per una data cultura, […] il suo sistema universale di referenza con la propria epoca» (Canguilhem, 2011: 430).
La storia così non sarà la Weltgeschichte dello Spirito trionfante, ma l’articolazione continua delle discontinuità dei vari campi trascendentali, di cui solo una filosofia storica potrà essere in grado di rendere conto. Siamo distanti da qualsiasi ideologia di fine della storia (12; 173)e al tempo stesso di fronte alla dimostrazione materiale di quanto sia estremamente difficile chiudere definitivamente con la filosofia hegeliana.
Gianluca De Fazio
Bibliografia:
Canguilhem, G. (2011), Morte dell’Uomo o estinzione del cogito?, in M. Foucault, Le parole e le cose, trad. it. di E. Panaitescu, Rizzoli, Milano, pp. 415-436.
Hegel, G.W.F. (2000), Fenomenologia dello spirito [1807], a cura di V. Cicero, Bompiani, Milano. Hyppolite, J. (2019), Introduzione alla filosofia della storia di Hegel, trad. it. di L. Calabi, ETS.
-
Esattamente vent’anni dopo la prima pubblicazione nell’originale francese (Éditions Belin, 2003), L’istituzione, la passività. Corso al Collège de France (1954-1955) di Merleau-Ponty è ora disponibile anche nella traduzione italiana, edita da Mimesis (2023) e curata da Giovanni Fava e Riccardo Valenti. Il testo rende accessibili al pubblico italiano gli appunti redatti da Merleau-Ponty per i corsi tenuti al Collège de France tra il 1954 e il 1955; corsi che, come ricorda Claude Lefort nella prefazione alla prima edizione francese, «si sovrappongono […] e al contempo scelgono vie divergenti in direzione di una nuova ontologia» (Merleau-Ponty 2023, p. 7). Difatti, nonostante sia la fenomenologia a contrarre il debito maggiore con l’opera di Merleau-Ponty – in primo luogo per la fedele lettura del testo husserliano e, correlativamente, per la sua decisiva promozione nel panorama filosofico francese – è il problema ontologico a coronare la riflessione teoretica del filosofo. A partire dalla presa d’incarico al Collège de France (1953), tale problema diviene per Merleau-Ponty sempre più urgente. Di conseguenza, a dispetto della ricezione tardiva per il pubblico italiano, tali appunti ricoprono un ruolo cruciale nella produzione del filosofo, essendo in grado di restituirci una preziosa istantanea di quella che fu la virata filosofica che interessò Merleau-Ponty a partire degli anni Cinquanta, da una prima fase più autenticamente fenomenologica – marcata dalla sua opera principale, Fenomenologia della percezione (1945) – agli ultimi scritti, in cui Merleau-Ponty prepara il terreno per la sua ontologia.
In queste pagine, è possibile, infatti, partecipare a quel cambio di prospettiva che si stava man mano consolidando nella riflessione di Merleau-Ponty, muovendo da un’analisi fenomenologica del corpo vivo (Leib) verso il carattere necessariamente anonimo o disumano dell’essere carne (chair), al di là della stessa distinzione tra soggettivo e oggettivo. Tale ristrutturazione teoretica prende le mosse da una riconfigurazione generale del contesto in cui Merleau-Ponty operava, e nel quale i presenti corsi si collocano, cronologicamente, a metà: tra la presa d’incarico come docente al Collège de France – periodo che ha come opera di riferimento il testo della sua lezione inaugurale, Elogio della filosofia (1953) – e la rottura definitiva con Sartre e con l’ideologia marxista, la quale legava i due intellettuali fino a quel momento, e che fu segnata dalla pubblicazione dell’Avventure della dialettica (1955). A partire da questi anni, le ricerche del filosofo si orientano sempre più all’interrogazione del senso e dell’espressione, al tema della verità e del rapporto tra linguaggio e mondo, nella ricerca di un terreno esistenziale originario che Merleau-Ponty, comunque, non rinuncia a voler indagare attraverso la lente fenomenologica, coniando, per l’appunto, l’espressione di “ontologia fenomenologica” o indiretta (Merleau-Ponty 2003, p. 203).
Contrariamente ad alcune letture che accusano Merleau-Ponty di ricadere nello stesso impianto metafisico o sostanzialistico che per primo criticava, è importante precisare che anche nella deriva ontologica lo sguardo fenomenologico non viene affatto abbandonato. Piuttosto, Merleau-Ponty evidenzia l’importanza di una ridefinizione dei rapporti tra fenomenologia e ontologia, nell’ottica di una loro reciproca integrazione. L’ambizioso progetto merlopontiano, che si preannuncia come uno degli itinerari filosofici più complessi e stimolanti del Novecento, rimarrà purtroppo nella forma di un discorso interrotto prematuramente a causa della morte improvvisa del filosofo. Rimettere in circolazione questi appunti risulta, perciò, un passaggio determinante per avvicinarsi maggiormente a quell’eredità che Merleau-Ponty ha lasciato in forma incompiuta e frammentaria, in modo da proseguire lungo quella traccia che avrebbe portato alla pubblicazione del suo più grande progetto redazionale, Il visibile e l’invisibile (1964), pubblicato postumo sottoforma di note di lavoro, dando così avvio a quello che appare come un cantiere ancora – e sempre – aperto.
Il perché del rinnovato interesse dopo all’incirca un ventennio per questa fase transitoria e trasformativa di Merleau-Ponty – che si evince, oltre che nel presente volume, anche nel recente progetto di traduzione del corso appena precedente, Il mondo sensibile e il mondo dell’espressione (Mimesis, 2021) – è probabilmente da attribuire al rinnovato stato di buona salute di cui gode il concetto di istituzione nel dibattito scientifico contemporaneo [1], concetto che torna ricorsivamente nelle pagine di Merleau-Ponty e che, presente fin dalle sue prime pubblicazioni, viene posto in queste lezioni come impalcatura portante di tutta la sua riflessione filosofica a venire. In particolare, è nella prima parte del volume, corrispondente al corso sull’Istituzione nella storia personale e pubblica, che si può constatare «la portata filosofica di questa riformulazione del concetto di istituzione» (p. 9), come evidenzia, con sostanziale anticipo, Lefort. In primo luogo, perché Merleau-Ponty, a discapito dell’erronea e fin troppo diffusa sinonimia, mostra come l’accezione fenomenologica di costituire risulti persino l’opposto dell’istituire: «l’istituito ha senso senza di me, il costituito ha senso soltanto per me e per il me di questo istante» (p. 61). Inoltre, un aspetto tra i più interessanti e innovativi della sua proposta filosofica risulta essere il legame imprescindibile che il concetto di istituzione intrattiene con la questione della passività. Difatti, sebbene «non dobbiamo intendere passivo e istituito come equivalenti» (p. 7), tali concetti vengono trattati da Merleau-Ponty in quanto concetti operativi strettamente connessi – indice di ciò la scelta del filosofo francese di inserire una sola introduzione a incipit di entrambi i corsi. Concetti che prendono strade diverse e, al tempo stesso, risultano in grado di chiarirsi reciprocamente, nel processo di comprensione di quella che, in quegli anni, rappresenta l’unica verità ontologica per Merleau-Ponty, a cui in seguito egli darà tanti nomi, anzitutto quello di reversibilità.
Osservando la questione da una prospettiva più estesa, ciò che, di primo acchito, accumuna istituzione e passività è la loro funzione retorica di rintegrare nel discorso tutto quello che la filosofia occidentale per secoli aveva mantenuto sullo sfondo – l’opacità del corpo, la passività istituente, l’inconscio – o, meglio, “al loro posto”, un posto subordinato a quello della trasparenza del concetto, del primato dell’attività e della coscienza intenzionale. In questo senso si configurano gli obiettivi polemici di entrambi i corsi, condensabili in quell’assolutismo del soggetto costituente che viene promosso, in primis, dal criticismo kantiano e che risulta mantenuto, in parte, dalla fenomenologia husserliana. A prescindere dalla legittimità o meno delle obiezioni teoretiche avanzate da Merleau-Ponty alla fenomenologia di Husserl – argomento vagliato ampiamente nella letteratura italiana sul filosofo, fra cui ricordiamo l’importante lavoro di Sandro Mancini [2]–, è rilevante sottolineare come uno dei principali motori dei corsi sull’Istituzione, la passività sia la volontà di Merleau-Ponty di rompere con un certo aspetto della fenomenologia, inerente, nella fattispecie, la nozione di attribuzione del senso (Sinngebung) e, correlativamente, al primato della coscienza intenzionale come coscienza costituente.
Ciò non toglie il grande debito che Merleau-Ponty riconosce a Husserl e a quello che, altrove, definisce il suo «impensato» (Merleau-Ponty 2015, p. 193), il quale sembra coincidere, in qualche modo, con ciò che lo stesso Husserl aveva formulato, anche se con poca convinzione. D’altronde, è proprio Merleau-Ponty ad affermare che, «se dobbiamo molto allo stesso Husserl, non siamo in grado di vedere esattamente ciò che gli appartiene» (Merleau-Ponty 2015, p. 187). In particolare, ciò da cui Merleau-Ponty prende le mosse per formulare la sua idea di istituzione è la nozione husserliana di Stiftung – che, significativamente, Merleau-Ponty sceglie di non usare nella traduzione più diffusa di “fondazione” –, la quale riposa a sua volta sui concetti fenomenologici di sedimentazione e sintesi passive. A tale ripresa segue subito, però, un distacco di Merleau-Ponty da Husserl e da quella che egli evidenzia essere l’incapacità di quest’ultimo di andare fino in fondo alle sue stesse intuizioni, rimanendo imbrogliato fino alla fine in quella che Merleau-Ponty definisce una «analitica degli atti» (Merleau-Ponty 2003, p. 256). A favore, cioè, di una logica della costituzione soggettiva. Al contrario, come fa notare giustamente il co-curatore Giovanni Fava nella prefazione alla prima parte del volume, per Merleau-Ponty è necessario mostrare che «l’istituzione è anzitutto istituzione di un tra, di una giuntura tra esterno e interno, ed è per questo che la parola ‘istituzione’ non ha senso per la coscienza» (p. 48). È necessario, perciò, riconoscere il carattere impersonale della genesi del senso: proprio come il cuore continua il suo battito senza di me, ossia senza che io lo voglia o lo intenzioni – esempio caro a Merleau-Ponty –, allo stesso modo il senso si istituisce, passivamente e pre-soggettivamente, a prescindere dal gesto inaugurale soggettivo e intenzionale. «Affinché ci sia coscienza di qualcosa, occorre che non si dia coscienza di tutto» (p. 202), scrive nelle ultime pagine dei suoi appunti Merleau-Ponty, il quale, prendendo sul serio lo stesso concetto husserliano di coscienza intenzionale, deve ammettere l’impossibilità di una sua universalizzazione. Restituire il carattere non-intenzionale alla coscienza significa, allora, introdurre, anzitutto, un’idea di coscienza che non si riduca al processo di Sinngebung e, poi, una costituzione del senso che non dipenda dall’attività soggettiva. Il soggetto perde così il ruolo privilegiato di agente costituente il senso, e diviene colui a cui il senso delle cose accade, marginalizzandosi rispetto a un’attività pre-teoretica e temporale, «dove non si sente più la pulsazione della coscienza costituente» (Merleau-Ponty 2015, p. 194). Proprio il tempo risulta essere il modello stesso dell’istituzione, che viene descritta efficacemente da Merleau-Ponty nel riassunto del corso come tutti quegli eventi capaci di dotare l’esperienza di dimensioni durevoli, in rapporto alle quali tutta una serie di altre esperienze avranno senso, formeranno un seguito pensabile o una storia, oppure gli eventi che depositano in me un senso […] come appello a un seguito, come esigenza di un avvenire (p.176).
È, quindi, nella struttura fenomenologica del tempo che l’istituzione si esplica, ossia nell’istituirsi del futuro attraverso il passato che «conserva nell’istituito un’efficacia dell’istituente» (p.8), di modo che, «se l’istituzione è apertura a, quest’ultima si produce sempre a partire da» (p.9). La sedimentazione fenomenologica svolge, in questo senso, un ruolo fondamentale nell’economia dell’intero discorso, permettendo un circolo continuo tra passato-presente-futuro che, per Merleau-Ponty, ha la forma della simultaneità, in cui il pensare è, al tempo stesso, sempre un ri-pensare, alla luce di quell’archivio di pensieri già istituiti.
Nell’intima non-coincidenza tra produzione e ri-produzione, si immette quella tra attività e passività, concetti che convivono nella stessa definizione ambigua di istituzione, a un tempo stato di cose stabilite e atto di cominciamento. Al chiasmo passività-attività Merleau-Ponty decide di dedicare il corso del lunedì parallelo a quello sull’istituzione che, in questo volume (analogamente all’edizione francese), si colloca nella parte seconda. Come ricorda Riccardo Valenti – a cui si deve la prefazione al corso su Il problema della passività, arricchita da riferimenti cinematografici che, nell’ottica di un’ibridazione tra filosofia e non-filosofia, rimane piacevolmente coerente con l’insegnamento di Merleau-Ponty – il tema della passività «permea non solo le poche ma densissime pagine che compongono questa lettura, ma anche l’intera opera e riflessione – precedente e posteriore – del filosofo francese» (p. 180).
La passività, infatti, non si limita a rappresentare uno stato del soggetto, ma corrisponde, invece, alla sua propria modalità di relazionarsi con il mondo; rivelazione, questa, di «un genere dell’essere in relazione al quale il soggetto non è sovrano, senza tuttavia che vi si trovi inserito» (p. 333). Tale modalità risulta particolarmente evidente in quei casi limite da cui Merleau-Ponty sceglie di prendere le mosse nel suo discorso: il sonno, il sogno, la memoria e l’inconscio, dimensioni che «sembrano, per principio, escludere la ‘decisione’ di un Soggetto» (p. 22).
Se nel corso dedicato al tema dell’istituzione Merleau-Ponty compie il passaggio dalla frontalità del rapporto soggetto costituente/oggetto costituito alla lateralità propria del soggetto in quanto coscienza incarnata, istituente-istituita, è nella seconda parte delle sue lezioni che si interroga sulla morfologia di tale lateralità soggettiva. In questo contesto il sonno ha un ruolo fondamentale, in quanto è proprio nello stato di coscienza del dormiente-sognante che risulta evidente come il senso si produca autonomamente rispetto a una presa della coscienza intenzionale. La questione che emerge a questo punto è se tale autonomia nella genesi del senso onirico debba essere comunque rimessa a un agire soggettivo, quindi a un’attività di coscienza, oppure no. Interessandosi a tale tematica, Merleau-Ponty è consapevole di inserirsi in un dibattito già aperto, rispetto al quale richiama, nei suoi appunti, le posizioni di Freud e di Sartre (a cui seguiranno Bergson e Proust in merito alla questione, a questa connessa, della memoria involontaria). Sartre e Freud, pur partendo da presupposti teorici differenti, risultano concordi nel riconoscere nello stato assopito della coscienza una spiccata attività soggettiva, che, essendo lontana dal mondo, risulterebbe libera di agire al di là delle sue predeterminazioni fattuali. Non d’accordo con questa tesi, Merleau-Ponty rinviene, sia nella psicoanalisi freudiana sia nella filosofia coscienzialistica sartriana, un presupposto errato, che riguarderebbe, ancora una volta, l’indiscusso monopolio della coscienza: in Sartre, nell’assenza del mondo percettivo, che sarebbe soppiantato da un mondo onirico immaginario o irreale; in Freud, attraverso la traduzione della produzione passiva del senso inconscio e onirico nell’attività sotterranea di un “secondo io”. È chiaro come la questione del sonno, negazione o conservazione del mondo, si traduca, in tal senso, nel problema più generale del rapporto tra immaginario e reale, che per Merleau-Ponty risultano ambiti intrecciati nel campo comune dell’essere in quanto carne, nella contemplazione tanto di una “veglia del sonno” – data dal legame indissolubile tra corpo e mondo – quanto di un “onirismo della veglia”, dato in primis dalla nostra capacità immaginativa [3]. L’immaginario, quindi, non ha una minore rilevanza ontologica rispetto al reale, ma diviene esso stesso trama della realtà percettiva, invisibile tessitura di ogni visione possibile. È proprio in questo clima di “riabilitazione ontologica” dell’immaginario che Merleau-Ponty crea un legame tra fenomenologia e psicoanalisi, attribuendo a Freud il merito di aver scoperto un «simbolismo positivo» passando dall’idea di una trasparenza della verità all’idea di una sua stratificazione, per la quale «l’analisi di una condotta vi trovi sempre più livelli, più strati di significato, i quali hanno tutti una loro verità» (p. 336). Utilizzando lo stesso resoconto delle sedute che Freud riporta a sostegno della propria concezione di psiche, Merleau-Ponty mostra, con e oltre Freud, come la questione dell’inconscio si risolva attraverso la questione del corpo: «l’inconscio come coscienza percettiva è la soluzione che Freud cerca» (p. 263). Per Merleau-Ponty, infatti, è il corpo in quanto luogo dell’inconscio a dettare quel simbolismo primordiale di cui parlava Freud e che per il fenomenologo si articola sempre a partire da un campo percettivo, collocandosi quindi non più dietro o al di sotto dello stato cosciente, ma davanti a noi, come modalità del nostro vivere nel mondo, non prima ma tra gli atti intenzionali, «come l’intervallo degli alberi fra gli alberi, o come il loro livello comune» (Merleau-Ponty 2003, p. 205).
In una coincidenza quasi paradossale, per Merleau-Ponty l’inconscio non è altro che l’essere della coscienza corporea e percettiva, per mezzo di cui facciamo esperienza del mondo, la quale si origina sempre da quel puntum caecum, o in-conscio, dato dall’essere incarnato della coscienza in un corpo. Il contatto tra istituzione e passività è stabilito, in definitiva, dal materiale inconscio come “sedimentazione percettiva” che si radica nel nostro schema corporeo, venendo a costituire, secondariamente, una sedimentazione di matrici simboliche in grado di influenzare la stessa genesi del senso del mondo percepito.
In conclusione, questi appunti ci parlano della necessità di Merleau-Ponty di attingere alla teoria dell’inconscio come via d’accesso privilegiata per parlare di quella passività della nostra attività che, in quegli anni, lo costringeva alla riflessione. La passività si installa nel cuore della attività attraverso il riconoscimento dell’inconscio come modalità del nostro fare esperienza del mondo in modo essenzialmente corporeo e percettivo. Questa idea – introdotta da Merleau-Ponty nei corsi che, grazie a questa traduzione, sono ora disponibili in italiano – resterà fino alla fine della sua riflessione, rappresentando uno dei guadagni teoretici più importanti della sua ontologia.
Guardare ancora una volta ai corsi del Collège de France rappresenta, allora, un passaggio imprescindibile per gli attuali studi su Merleau-Ponty. Da un lato, questo è dovuto al fatto che L’istituzione, la passività consente di mettere in discussione gli assolutismi di un Merleau-Ponty fenomenologo o di un Merleau-Ponty onto-metafisico, per guardare a quella che fu l’idea rivoluzionaria di filosofia ambigua, fondata sulla reversibilità tra il piano ontologico e quello fenomenologico. Dall’altro, questo testo permette di evidenziare l’importanza che ebbe il contatto tra fenomenologia e psicoanalisi per costruire quella che ad oggi possiamo considerare una filosofia dell’immaginario e dell’invisibile, sforzandoci di intravedere la direzione che, da queste premesse, Merleau-Ponty avrebbe dato alla sua ontologia fenomenologica.
Marta Gailli
Note
[1] Dell’ampia letteratura sul tema, ci limitiamo a citare il recente fascicolo dal titolo Il problema dell’istituzione. Prospettive ontologiche, antropologiche e giuridico politico, a cura di E. Lisciani-Petrini e M. Adinolfi, in “Discipline filosofiche”, 29, n. 2, 2019; e il penultimo numero della rivista “Humamente” curato da F. Buongiorno e X. Chiaramonte e dedicato proprio al tema dei nostri corsi, Institution and Passivity: Rethinking Embodiment and Social Practices in the Contemporary Debate, in “Humanamente. Journal of Philosophical Studies”, 41, 2022.
[2] Su questo tema in particolare, si veda S. Mancini (2001). Sempre di nuovo. Merleau-Ponty e la dialettica dell’espressione. Milano: Mimesis.
[3] Sul medesimo terreno battuto da Merleau-Ponty si muoverà circa vent’anni dopo il filosofo greco-francese Castoriadis, nella sua ricerca teoretica-politica – che chiama in causa la stessa psicoanalisi – intorno al concetto di istituzione, legato intimamente al tema dell’immaginario. Cfr. C. Castoriadis (2022), L’istituzione immaginaria della società. Milano-Udine: Mimesis.
Bibliografia
Merleau-Ponty, M. (2003). Il visible e l’invisibile. Milano: Bompiani.
Id. (2015). Il filosofo e la sua ombra in id., Segni. Fenomenologia e strutturalismo, linguaggio e politica. Costruzione di una filosofia. Milano: Il Saggiatore.
Id. (2023). L’istituzione, la passività. Corso al Collège de France (1954-1955). Milano-Udine: Mimesis.
-
La servitù volontaria dell’io soggiogato
Recensioni / Maggio 2023«Se il testo di La Boétie è incontestabilmente un testo politico, tuttavia affronta le relazioni di potere e di dominio sotto una prospettiva specifica, dal punto di vista dell’ombra proiettata dalla realtà sociale sul funzionamento mentale dei soggetti, per mettere in rilievo i danni identitari e narcisistici tipici della sofferenza sociale. Interroga anche, per converso, gli effetti sociali di questo funzionamento mentale, la sua capacità ad alimentare condotte di sottomissione e ad alimentare il sistema di dominio»
– T. Dagron, p. 380
Da qualche mese, sugli scaffali dedicati alla filosofia moderna e contemporanea della celebre libreria «Vrin» di Place de la Sorbonne a Parigi, è comparsa una sezione «La Boétie». Segnale dell’ottima salute di cui gode tanto il Discours de la servitude volontaire quanto il fenomeno che il suo autore definisce. Entrambi continuano a interessare studiosi, studiose e case editrici (tra le edizioni più recenti, questa in lingua spagnola è assai pregevole). Tra i volumi della sezione, spicca Le soi subjugué. Servitude volontaire et cliniques de l’aliénation (Librairie Philosophique J. Vrin, 2022, pp. 405) di Tristan Dagron, direttore di ricerca al CNRS di Lione.
Il nome di Dagron è legato a quello di La Boétie ormai da diverso tempo: suo è uno dei contributi che si trovano nell’edizione Vrin del Discours del 2002, che si proponeva come alternativa all’edizione Payot del 1975, a cura di Miguel Abensour e Marcel Gauchet. È sua anche l’introduzione al Discours della nuova edizione Vrin del 2012. Un’introduzione che merita di essere citata: Dagron vi sanziona la specificità della «riattualizzazione della nozione della servitù volontaria» (p. 18) avvenuta negli ultimi anni, quale strumento euristico adoperato da sociologia e psicologia per esplorare le forme di dominio nel mondo del lavoro (cfr. Dejours 2006).
Le soi subjugué prosegue le ricerche che Dagron ha avviato con Pensée et cliniques de l’identité. Descartes, Cervantès, Montaigne (Librairie Philosophique J. Vrin, 2019). La prospettiva adottata è la medesima: coniugare il lavoro di storico della filosofia con la psicoanalisi. Lo sguardo di Dagron sul Discours non è solo quello dello specialista in storia della filosofia; il suo spettro di domande e di interessi è rivolto verso «processi mentali che sono in fondo assai ordinari» (p. 16) e nutrito dell’approccio psicoanalitico di René Roussillon e dall’ambiente lionese (cfr. Roussillon, 1991). Narcisismo, identità, riflessività, alcuni dei termini chiave.
Se mai fosse necessario prevenire qualsiasi esitazione in merito a un simile approccio, la lettura di Dagron si tiene ben lontana da freudismi spiccioli o selvagge interpretazioni psicoanalitiche della vita degli autori. Il lettore, al massimo, potrà risentire un certo spaesamento a causa di un percorso argomentativo talvolta complesso, che si sposta rapidamente da discussioni storico-filosofiche a discussioni psicoanalitiche e che lascia implicite alcune definizioni tecniche. Questo non intacca la rilevanza de Le soi subjugué, nel contesto del rinnovato interesse per La Boétie degli ultimi due decenni.
Nel primo dei dieci capitoli del volume, Dagron si occupa, per l’appunto, mettere in luce l’attualità del Discours, in particolare rispetto alla tematica della cosiddetta «sofferenza sociale», quella forma specifica di sofferenza che deriva dall’effetto prodotto da determinate situazioni sociali sull’individuo (cfr. Renault 2008). Nel secondo capitolo, l’autore esplicita l’interesse del proprio approccio pluridisciplinare che propone d’integrare la prospettiva psicoanalitica sul narcisismo alla problematica dell’identità secondo i termini della psicologia sociale.
Conclusa questa sorta di preambolo, Dagron orienta gli altri capitoli sui temi canonici connessi al Discours: amicizia, libertà, memoria, abitudine, volontà e patto. Qui svolge un lavoro di analisi storico-filosofica per rendere conto del rapporto di La Boétie con autori quali Aristotele, Cicerone o Marsilio Ficino, o per confrontare la «servitù volontaria» con l’ethelodouleia del discorso di Pausania nel Simposio o, ancora, per ricostruire la psicologia della memoria di Avicenna, che è uno dei sostrati teorici del Discours. Tuttavia, la finalità di Le soi subjugué non si esaurisce in quest’ordine di discussioni.
L’obiettivo di Dagron, in effetti, è dimostrare che il Discours presenta «una ricca riflessione clinica sulla posta in gioco della socializzazione e della soggettivazione» (p. 383). Più esattamente, La Boétie offre «un bilancio della violenza sociale» e dei fenomeni che essa induce dal punto di vista delle capacità mentali e riflessive degli individui. Sicché, il vero e proprio asse su cui si articola Le soi subjugué è l’interesse per il Discours in quanto testo che concerne una «realtà clinica» assai precisa: la «disorganizzazione identitaria» della psiche individuale dalla società e le sue conseguenze sul giudizio d’attribuzione di ciò che suscita piacere e dispiacere.
Stando alla lettura de Le soi subjugué, la servitù volontaria indica non tanto una forma di governo quanto una relazione di dominio. Per descriverla, Dagron sembra voler adoperare il termine di «subjugation», ma non è chiaro a riguardo: l’espressione che dà il titolo al volume non è oggetto di una discussione specifica che la definisca. Alla voce «subjuguer», però, il dizionario Robert riporta: «mettere qualcuno nell’impossibilità di resistere, per ascendente, all’influenza che si ha su di lui». E tale pare essere la condizione dei servi volontari.
La celebre paradossalità della formula laboetiana della servitù volontaria (il dominio si sostiene sul decisivo e volontario contributo dei servi: allora perché, pur potendo smettere di servire, non lo fanno?) si riflette nell’insieme di caratteristiche che si rinvengono nell’interpretazione di Dagron: la servitù volontaria è tanto estorta e indotta quanto spontanea e non deliberata, cioè frutto di un’azione volontaria ma i cui moventi sono per lo più inconsci. Infatti, essa è un risultato che il tiranno ottiene dai sudditi e corrisponde a una «strategia di difesa, tra le altre possibili, che può essere mobilitata dalla psiche per far fronte all’impatto disorganizzatore della violenza sociale» (p. 96).
Questo è un dato fondamentale che va sottolineato: per Dagron la servitù volontaria non si spiega con una «sete di obbedienza» presente nei servi né indica una delle cause prime del dominio. È un adattamento difensivo che alimenta e mantiene il dominio che lo induce. In altri termini, occorre ricercare la servitù volontaria non a monte di dinamiche politico-sociali, in qualità di loro principio causale; al contrario, la servitù volontaria è un fenomeno che sta a valle, portato di un «mondo perseguitato dalla morte sociale e psichica» (p. 305).
Dagron si serve allora della psicoanalisi per sondare i «moventi interni, ma non per questo meno oscuri ed enigmatici» (p. 38) degli individui. Posto il narcisismo quale meccanismo di difesa dell’io dalle esperienze negative e di integrazione di queste ultime (cfr. Freud 1921 [1975]), alla vulnerabilità sociale corrisponde la «precarizzazione psichica» (p 63). La sottrazione di alcuni «oggetti sociali» (quali l’impiego, il reddito, e l’alloggio, secondo gli esempi proposti da Dagron) che l’individuo investe narcisisticamente, spinge l’individuo a un «tentativo, tanto strano quanto oneroso, di restaurazione narcisistica» (p. 49) che si configura come una «relazione addittiva» nei confronti dei «frammenti» di quegli oggetti che «tiranno sa bene come far scintillare» (p. 50). In questo modo si innesta il suo comportamento di sottomissione e di asservimento nei confronti di chi domina.
Questo è un altro aspetto dell’interpretazione di Dagron che va tenuto in considerazione: la servitù volontaria non è dovuta all’ignoranza, all’inganno o all’illusione dei servi. Al contrario, è la disillusione, cioè «il riconoscimento, in sé doloroso, della verità» (p. 50), a giocare un ruolo cruciale. Gli individui adottano la strategia di adattamento in cui consiste la servitù volontaria proprio in quanto consapevoli del pericolo dell’esclusione sociale della precarietà: a tal proposito non si sbagliano. Sono particolarmente interessanti le pagine in cui Dagron definisce la servitù volontaria come una condotta di «auto-inclusione» in una relazione di sottomissione e la confronta con la strategia della «auto-esclusione» di cui rinviene il modello in Diogene (cfr. pp. 305 e ss.).
Dunque, secondo la prospettiva che propone Dagron, il fulcro del Discours de la servitude volontaire si trova sul piano clinico: un’opzione interpretativa particolare (per un approccio per alcuni aspetti simile: cfr. Renault 2016) e non certo l’unica possibile (cfr. Provini, Rees, Vintenon 2016). In Le soi subjugué, però, Dagron non si spende in alcuna discussione polemica con altre interpretazioni del Discours. In particolare, risalta il totale silenzio su Miguel Abensour, il principale artefice della riscoperta di La Boétie negli anni Settanta e uno dei massimi interpreti del pensiero laboetiano (cfr. Abensour 2011). Palese è la distanza tra loro: per Dagron, La Boétie non fornirebbe «alcuna teoria filosofica del potere politico» (p. 127), laddove per Abensour La Boétie non fonda niente di meno che una nuova teoria del dominio (cfr. Abensour 2018).
Un confronto tra le loro interpretazioni del Discours eccede certamente i limiti di una recensione. Tuttavia, questo permette di rilevare un merito importante de Le soi subjugué, su cui vale la pena concludere. Con questo volume, Dagron consolida e contribuisce a definire un certo approccio alla questione della servitù volontaria e, pertanto, Le soi subjugué diventa un valido termine rispetto a cui confrontare le altre forme assunte dalla riattualizzazione del Discours de la servitude volontaire.
Bibliografia
Abensour, M. (2011). Per una filosofia politica critica (a cura di Pezzella, M.), Jaca Book, Milano.
Abensour, M. (2018). La Boétie prophète de la liberté, Sens & Tonka, Paris.
Dejours, C. (2006). Aliénation et clinique du travail, in «Actuel Marx », 39, pp. 123-144.
Freud, S. (1921). Psicologia delle masse e analisi dell’io, Bollati Boringhieri, Torino, 1975.
Provini, S., Rees, A., Vintenon, A. (dir.) (2016). Cahiers La Boétie. La parole de La Boétie : approches philosophiques, rhétoriques et littéraires, Classique Garnier, Paris
Renault, E. (2008). Souffrances sociales. Sociologie, psychologie et politique, La Découverte, Paris.
Renault, E. (2016). Domination et pathologie sociale chez La Boétie, in Gerbier, L. (dir.). Cahiers La Boétie. Lectures politiques de La Boétie, Classique Garnier, Paris, pp. 137-151.
Roussillon, R. (1991). Paradoxes et situations limites de la psychanalyse, P.U.F., Paris.
Armando Arata
-
Filosofe di età moderna tra corpo e mente
Recensioni / Aprile 2023Nei libri di storia della filosofia è raro incontrare donne, con qualche sporadica eccezione confinata al Novecento (Hannah Arendt è forse l’esempio più emblematico); ciò non significa che non siano esistite filosofe nel corso della storia, ma piuttosto che esse non hanno trovato spazio nel canone storico-filosofico occidentale. Il pregiudizio secondo cui la filosofia non sarebbe fatta né per le donne né dalle donne trova un’efficace smentita nel volume Corpo Mente. Il dualismo e le filosofe di età moderna (enciclopediadelledonne.it 2022), che attraverso un’interessante rassegna di autrici e testi ha il merito di mettere in luce il contributo delle donne alla storia della filosofia in un periodo in cui tradizionalmente trovano spazio soltanto filosofi. Le quasi quattrocento pagine di quest’antologia, arricchita da puntuali presentazioni delle autrici e delle opere considerate, rappresentano un tassello importante di quel «lavoro di riscrittura della storia della filosofia sulla base di un canone più inclusivo rispetto a quello che ha prodotto le narrazioni tradizionali» (p. 11), iniziato alcuni decenni fa.
La scelta dei curatori è ricaduta su quattordici autrici vissute nel periodo compreso tra il XV e il XVIII secolo, di diversa provenienza, oltre che su un autore – François Poullain de la Barre – degno di attenzione in qualità di singolare precursore del femminismo. Molte di queste scrittrici sono oggi sostanzialmente dimenticate; eppure, i testi qui selezionati testimoniano una consapevole partecipazione ai dibattiti filosofici del tempo. Se la consueta esclusione delle donne dal canone storico-filosofico affonda senz’altro le sue radici in una questione culturale, per cui «alle donne per molti secoli è stato precluso l’accesso all’ampio strumentario di cui disponevano gli uomini, che avrebbe consentito loro di coltivare e affinare le doti intellettuali» (p. 13), tale innegabile svantaggio di partenza non ha impedito ad alcune di loro di sviluppare un proprio pensiero filosofico e di confrontarsi con i filosofi più autorevoli, come dimostrano le loro prese di posizione sul rapporto mente-corpo, cruciale nella filosofia di età moderna.
La prima parte del volume (Da Christine de Pizan a Camilla Erculiani), a cura di Sandra Plastina, si apre con Christine de Pizan, pioniera della scrittura femminile come professione, dell’irrompere del soggetto sulla scena letteraria e del protofemminismo francese. Nata a Venezia intorno al 1365 e trapiantata ben presto in Francia (dove il padre, medico e astrologo, era al servizio del re Carlo V), Christine de Pizan ha consacrato buona parte della sua ampia produzione letteraria, in prosa e in versi, alla questione dell’educazione femminile, interrogandosi anche sulle ragioni dell’esclusione delle donne dal campo della letteratura. Celebre per aver preso fermamente posizione nell’acceso dibattito sul Roman de la Rose, sfociato nella querelle des femmes che avrebbe continuato a infiammare gli animi per secoli, tra il 1404 e il 1405 scrisse il Livre de la cité des dames, incentrato sulla convinzione che nessun ambito dell’attività umana è per natura precluso alle donne.
L’opera è degna di attenzione per molte ragioni; in particolare, merita di essere sottolineato – sulla scia della curatrice – l’abbandono dell’espressione di ascendenza scolastica «nature de femme» a favore di «conditions de femme somme toute» («somma totale delle condizioni femminili», p. 26), che riconduce l’identità femminile all’esperienza e alla storia, lungi da ogni essenzialismo. Aiutata da Dama Ragione, la protagonista della Cité des dames prende coscienza dell’infondatezza dei giudizi di biasimo nei confronti delle donne che gli uomini disseminano copiosamente nei loro libri. Tali giudizi sono definiti contro ragione e contro natura; inoltre, Christine de Pizan non esita a fare appello alle Sacre Scritture per sostenere l’uguaglianza tra uomo e donna: «Dio fece addormentare Adamo e creò il corpo della donna da una delle sue costole, nel senso che gli doveva essere al fianco come compagna e non ai suoi piedi, come una serva, e che egli la doveva amare come la sua stessa carne» (p. 40).
I rapporti sociali generalmente conflittuali tra uomini e donne, con le loro inevitabili implicazioni sulla ricerca della propria identità da parte di queste ultime, sono centrali nell’opera dell’autrice patavina Giulia Bigolina (c. 1518 – c. 1569). Scritto intorno al 1556-1558, in prosa, Urania, nella quale si contiene l’amore d’una giovine di tal nome è «il primo romanzo scritto da una donna nella storia della letteratura italiana» (p. 45), ma è rimasto inedito fino ad anni recenti: una prima edizione, presto seguita da due traduzioni inglesi, è stata curata da Valeria Finucci nel 2002. Ben inserita nell’ambiente culturale del tempo, Giulia Bigolina mostra nel suo romanzo una notevole profondità psicologica e filosofica, nonché un’indubbia familiarità con la filosofia neoplatonica. Al di là dell’attenzione al tema amoroso, strettamente intrecciato a quello della bellezza dell’anima e del corpo, ampio spazio trova la riflessione sul posto delle donne nella cultura italiana rinascimentale, sulla necessità della loro educazione e sulle molte difficoltà che incontrano quando decidono di consacrarsi alla scrittura.
Un più spiccato interesse per questioni squisitamente filosofiche – e per il rapporto tra mente e corpo – si manifesta nell’opera di Luisa Oliva Sabuco de Nantes Barrera (1562 – c. 1622), autrice della Nueva filosofia della naturaleza de l’hombre (1587) in sette trattati. Mettendo abilmente a frutto gli studi di medicina, botanica e scienze naturali svolti con il padre, Sabuco ha elaborato una riflessione originale dal punto di vista sia della filosofia naturale sia della storia della medicina, senza esitare a prendere apertamente le distanze dal galenismo e dalla medicina a lei contemporanea, di cui critica l’inefficacia. Ai suoi occhi, l’essere umano è un’unica entità psico-fisica e l’alterazione della relazione armoniosa tra il corpo e la psiche – spesso frutto delle passioni – è causa della malattia, della follia e, nei casi più estremi, della morte. L’interpretazione della malattia in chiave psicosomatica – così come la proposta di servirsi della musica come terapia – sono particolarmente innovative. D’altronde l’autrice, nella lettera dedicatoria a Filippo II, non esitò a rivendicare con orgoglio il valore della propria opera, presentandola come necessaria perché «migliora il mondo in molti modi» (p. 98).
Lungi dall’assumere così apertamente la propria autorialità, molte scrittrici nel corso dei secoli hanno cercato di tenersi al riparo dall’esposizione pubblica ricorrendo all’anonimato o a uno pseudonimo. È questo il caso di Modesta Pozzo, vissuta a Venezia tra il 1555 e il 1592 e nota come Moderata Fonte, «una spiritosa trascrizione letteraria, nonché versione eufonica, del vero nome dell’autrice, che faceva pensare a un “modesto pozzo”» (p. 119). Autrice di diverse opere e ben inserita negli ambienti culturali veneziani, Moderata Fonte è oggi ricordata soprattutto per il dialogo Il merito delle donne, pubblicato postumo nel 1600, nel contesto della polemica suscitata dall’opera di Giuseppe Passi I donneschi diffetti. Nel dialogo, prima presa di posizione sulla questione femminile da parte di una donna nell’Italia di fine Cinquecento, l’autrice si avvale di argomentazioni paradossali per confutare la tesi della maggior eccellenza dell’uomo, insistendo sul ruolo fondamentale dell’educazione ai fini dell’emancipazione femminile.
Già da questi primi esempi emergono con forza alcune costanti: la difficoltà per le donne di prendere pubblicamente la parola, l’inadeguatezza della loro educazione, il tentativo di rivendicare la propria parità (talvolta anche la propria superiorità) rispetto agli uomini. Sulla sponda orientale dell’Adriatico, precisamente a Ragusa (odierna Dubrovnik) a farsene portavoce è Marija Ivan Gundulić, o Maria Ivan Gondola. Nella sua sola opera superstite, la lettera di dedica ai Discorsi (1584) scritti dal marito Nicolò Vito di Gozze, ella prese le difese della poetessa Cvijeta Zuzorić e, più in generale, delle donne e delle loro capacità intellettuali, attraverso un curioso rovesciamento del paradigma aristotelico. A suo avviso, infatti, proprio per la mollezza del loro temperamento (a cui solitamente si attribuiva la loro subalternità intellettuale), le donne avrebbero una maggior predisposizione a occuparsi di questioni filosofiche e scientifiche.
La stessa fiducia nelle doti intellettuali femminili si ritrova in Camilla Gregetta Erculiani, «l’unica donna italiana nel XVI secolo a pubblicare un libro di filosofia naturale» (p. 165). Questa speziale padovana, nelle Lettere di Philosophia naturale (1584), dichiarava espressamente di voler «far conoscere al mondo, che noi siamo atte a tutte le scientie, come gli huomini» (p. 166). Lei stessa scrisse di filosofia naturale in volgare, elaborando un’originale teoria sul diluvio universale (attribuito a cause naturali) e ipotizzando la possibilità della generazione spontanea degli uomini in seguito a catastrofi naturali. Sospettata di eresia e interrogata dall’Inquisizione, si difese sostenendo la piena legittimità della sua riflessione, che non riguardava il piano teologico, bensì si limitava a quello puramente filosofico.

Meister der 'Cité des Dames' (Wikimedia) L’attiva partecipazione delle donne al dibattito filosofico del loro tempo, anche attraverso il dialogo epistolare con i suoi principali esponenti, emerge ancora più nettamente nella seconda parte del volume (Da Lucrezia Marinella a Catharine Cockburn), a cura di Emilio Maria de Tommaso. In particolare, si rivela cruciale il sostegno di familiari di sesso maschile (si tratti del padre, di un fratello o del marito) per colmare lo svantaggio educativo legato alla condizione femminile e avere l’opportunità di assecondare le proprie aspirazioni. Proprio grazie a un ambiente familiare intellettualmente vivace, Lucrezia Marinella (1571 – 1653) poté dedicarsi alla scrittura e farsi apprezzare nella Venezia del tempo. Ella fu tra coloro che reagirono ai Donneschi diffetti di Passi, dimostrando, nel suo saggio Le nobiltà et eccellenze delle donne (1600), l’erroneità delle conclusioni dell’avversario fino a sostenere la superiorità ontologica, fisiologica e morale della donna, in cui ravvisa l’immagine più nobile della divinità. A tal fine riprende – come già Christine de Pizan – il racconto della Genesi, sulla base del quale «suggerisce che l’uomo sia funzionale alla generazione del corpo femminile, nella misura in cui fornisce la degna materia della produzione della donna» (p. 189).
Marie Le Jars de Gournay (1565 – 1645), nota per il suo stretto legame con Michel de Montaigne, che la considerava la propria figlia spirituale, riprese nei suoi scritti Egalité des hommes et des femmes e Grief des dames le tematiche tipiche della querelle des femmes, esprimendo la convinzione che la disuguaglianza tra uomini e donne non sia biologica ma culturale; «la sua idea filosoficamente più forte, che opera in filigrana negli scritti egualitari, è la neutralità della mente, ossia la sua mancanza di connotazione di genere» (p. 211). L’idea che la mente non abbia sesso è centrale anche nella riflessione di François Poullain (o Poulain) de la Barre (1647 – 1723), filosofo di impostazione cartesiana che in ben tre opere (De l’éducation des dames, De l’égalité des deux sexes, De l’excellence des hommes) denunciò con fermezza l’assurdità dei diffusi pregiudizi nei confronti delle donne. Proprio una donna, Elisabetta di Boemia, discusse alcuni degli aspetti più controversi della filosofia cartesiana – in particolare l’annosa questione dell’interazione tra anima e corpo – in un avvincente carteggio con il suo autore, inducendolo a precisare meglio la propria posizione nel saggio Le passioni dell’anima.
In ambito anglosassone, Anne Finch Conway (1631 – 1679) fu aiutata a coltivare le proprie ambizioni intellettuali prima dal fratello, poi dal marito. Fu allieva – inizialmente per via epistolare – di Henry More, esponente di spicco del platonismo di Cambridge, da cui prese tuttavia le distanze in merito al rapporto tra corpo e spirito. Fautrice di una tripartizione ontologica (Dio, Cristo, le creature, distinti perché diversamente esposti al cambiamento), elabora una nozione di corpo piuttosto originale, sia rispetto al maestro sia rispetto all’ontologia cartesiana, di cui rifiuta il dualismo. Il medico Franciscus Mercurius von Helmont, che la introdusse al cabalismo e al quaccherismo, alla sua morte fece stampare i Principia philosophiae antiquissimae et recentissimae de Deo, Christo et Creatura id est de materia et spiritu in genere (1690), redatti sulla base di un taccuino su cui Lady Conway aveva annotato a matita le proprie riflessioni filosofiche.
La familiarità con l’ambiente del platonismo di Cambridge, a cui il padre Ralph Cudworth apparteneva, si ritrova in Damaris Cudworth Masham (1659 – 1708). Ella intrattenne intensi scambi intellettuali con John Norris, ma anche con Leibniz (di cui criticò il sistema dell’armonia prestabilita) e Locke, con cui condivise una lunga e solida amicizia. Proprio a Locke alcuni attribuirono erroneamente la sua prima opera, pubblicata anonima nel 1696 e intitolata Discourse Concerning the Love of God. Nella sua seconda opera filosofica, Occasional Thoughts in Reference to a Vertuous or Christian Life (1705), Lady Masham prese posizione sulla condizione femminile, attribuendo alle donne un ruolo centrale in ambito educativo e mettendo in luce l’assurdità di non istruirle adeguatamente. La filosofia di Locke influenzò significativamente anche Mary Astell (1666 – 1731), considerata la prima femminista inglese. Non si tratta tuttavia di un’accettazione acritica, come dimostra The Christian Religion, as Profess’d by a Daughter of the Church of England (1705), in cui l’ipotesi lockiana della materia pensante è messa in discussione. Una sintesi dei fondamenti dell’epistemologia lockiana e di alcuni elementi del platonismo di Cambridge trova spazio, infine, nell’opera di Catharine Trotter Cockburn (1679 – 1749), che pubblicò vari scritti in forma anonima, tra cui Remarks upon the Principles and Reasonings of Dr. Rutherforth’s Essays on the Nature and Obligations of Virtue (1747).
La ricca panoramica di testi e autrici di cui si è cercato di dare un’idea in queste pagine (che vorrebbero essere soprattutto un invito a una più approfondita esplorazione) dimostra efficacemente che anche le donne si sono occupate di filosofia, malgrado circostanze poco favorevoli al loro fiorire intellettuale e contrariamente a quanto si tende a pensare sulla base della lettura dei manuali canonici di storia della filosofia. Il contributo delle donne alla storia delle idee europea merita perciò di essere riscoperto e rivalutato; in questa prospettiva, come ha sottolineato Nuria Sanchez nella sua Postfazione, il presente volume rappresenta una «pubblicazione di grandissima utilità per avvicinare studenti e studentesse a opere di donne intellettuali quasi sconosciute nei programmi didattici abituali» (p. 376). Ciò vale anche per un pubblico più ampio: Sandra Plastina ed Emilio Maria de Tommaso, curando questo libro nell’ambito del pregevole progetto enciclopediadelledonne.it, hanno reso accessibili a qualsiasi lettore interessato – non soltanto, dunque, a studenti o specialisti – testi a lungo trascurati. Disseppellirli dall’oblio a cui sono stati ingiustamente condannati, permettendo loro di essere conosciuti e apprezzati, sembra il modo migliore per iniziare a restituire alle donne quel posto nella storia della filosofia che per secoli è stato loro negato.
di Debora Sicco
-
Psicoanalisi: una strana antropotecnica
Longform / Novembre 2022Psychoanalyse als Anthropotechnik, psicoanalisi come antropotecnica, potrebbe benissimo essere – perché no? – il titolo di un immaginario saggio disperso nel mare della vasta produzione del filosofo tedesco, tuttora vivente, Peter Sloterdijk. Se non fosse per la sua nota tendenza a irridere la concettualità psicoanalitica, con quell’ironia di chi non è in fondo così distante da ciò che intende allontanare, potremmo quasi immaginarcene un abbozzo in attesa di pubblicazione tra le sue carte. Dunque, perché no? Porsi la domanda “è la psicoanalisi un’antropotecnica?” potrebbe non essere un passatempo del tutto ozioso. Stando alla definizione più recente che il filosofo di Karlsruhe ha offerto del concetto, vale a dire quella contenuta nel magnum opus del 2009 Devi cambiare la tua vita, si definiscono antropotecniche tutte le condotte mentali e fisiche basate sull’esercizio, con le quali gli esseri umani delle culture più svariate hanno tentato di ottimizzare il loro status immunitario sia cosmico sia sociale, dinnanzi ai vaghi rischi per la propria vita e alla certezza di morire (Sloterdijk 2010, 14).
Laddove con “esercizio” si intende ogni sorta di routine abituale e operazione ripetuta tramite la quale «la qualificazione di chi agisce viene mantenuta o migliorata in vista della successiva esecuzione della medesima operazione, anche qualora essa non venga dichiarata esercizio» (Sloterdijk 2010, 7) e con “immunità” un’immunità culturale, risultante di «pratiche simboliche ovvero psicoimmunologiche […] di prevenzione immaginaria ed equipaggiamento mentale» (Sloterdijk 2010, 13). Esercizio e immunità, dunque, come i due cardini della definizione del concetto, sotto il quale ricade uno spettro di fenomeni amplissimo. Dai monaci del deserto ai filosofi greci, dagli asceti indiani ai moderni scienziati, dai biocosmisti russi agli atleti olimpionici, dai funamboli ai fenomenologi. Quanto alla psicoanalisi, si tratta di verificare se, nella sua dimensione pratica come in quella teorica, sia in grado di superare il duplice requisito antropotecnico.
Partendo dal primo punto, l’esercizio e la dimensione abitudinaria che esso comporta, nulla sembrerebbe più estraneo alla scena dell’esperienza analitica. È quanto suggerisce Lacan nel suo Seminario dedicato all’etica della psicoanalisi quando afferma, allo scopo di mostrare lo scarto che separa la dimensione etica inaugurata dalla psicoanalisi dall’etica nel suo sviluppo storico e dall’etica aristotelica in particolare – scarto che permette di misurare tutta l’originalità dell’invenzione freudiana – che l’etica dell’analisi comporta «la cancellazione, la messa in ombra, persino l’assenza di una dimensione di cui basta il temine per cogliere ciò che ci separa da tutta l’elaborazione etica prima di noi – è l’abitudine, la buona o cattiva abitudine» (2008, 14). Se di ripetizione si parla, in analisi, è sempre dal lato del sintomo, della coazione a ripetere un’esperienza traumatica che comporta una certa sofferenza per il soggetto, nulla a che vedere insomma con quel continuo gioco di rimandi tra ἔθος ed ἠθος, di azione buona come frutto di un addestramento alla buona scelta, che è il fulcro dell’etica aristotelica. La psicoanalisi è tutt’altra cosa, perché «l’essenza stessa dell’inconscio si inscrive in un registro diverso» (Lacan 2008, 14) – quello del desiderio e della sua interpretazione. E il desiderio, come ben si sa, non si sceglie.
In analisi infatti si tratta di venire a capo di una domanda, di quella domanda di felicità che l’analizzante pone all’analista, una felicità tuttavia peculiare, né comoda né accomodante, che potrebbe certo non coincidere con le immediate aspettative del soggetto. «La questione etica» dice infatti Lacan «nella misura in cui la posizione di Freud ci fa compiere un progresso, va articolata a partire da un orientamento dell’individuazione dell’uomo in rapporto al reale» (2008, 15), vale a dire in rapporto a quel Reale che nella formulazione lacaniana non coincide con la realtà, ma con ciò che nella realtà costituisce un’impasse, una contraddizione, un inciampo, ciò che, in altre parole, il soggetto non riesce a soggettivare, ciò che rimuove come altro da sé e che ritorna a reclamare i suoi diritti ma anche ciò che il soggetto non simbolizza (Benvenuto & Lucci 2014) e che «non può inscriversi che per un’impasse della formalizzazione» (Lacan 2011, 87).
La posta in gioco dell’analisi è, detto altrimenti, porre in contatto il soggetto con il Reale, con ciò che in esso fa problema, con quell’estimità che lo caratterizza. Proprio perciò Lacan (2008, 11 sgg.), nelle volute che caratterizzano il Seminario VII, procede a distinguere con una certa nettezza l’etica che si esprime nella pratica analitica, nello spazio che separa analizzante e analizzato, dalla triplice serie di ideali analitici i quali, dice Lacan, emergono in abbondanza laddove si intende la pratica analitica come un servizio di asilo e conforto per supplici e sofferenti di vario genere. Vale la pena richiamarli brevemente alla memoria. L’ideale dell’amore umano, l’ideale dell’autenticità, l’ideale della non-dipendenza – mancano tutti il punto circa i fini dell’analisi, o perché si basano su un supposto primato della pulsione genitale, cui dovrebbe essere ricondotta la brulicante pluralità delle pulsioni parziali, o perché introducono una tacita dimensione normativa che sfocia in una concezione dell’analisi come armonizzazione psichica, o perché, infine, ricadono in una dimensione banalmente ortopedica (Lacan 2008).
Di contro a tutto questo si tratta invece di prendere le mosse da ciò che qui Lacan (2008) chiama curiosamente l’ascesi freudiana – sorta di lapsus che conferma il ritorno di quel rimosso che è l’esercizio – condensata nella massima Wo Es war, soll Ich werden. Essa viene interpretata da Lacan attraverso un rovesciamento di prospettiva che ne fa non un’impresa di colonizzazione dell’inconscio da parte della coscienza, un rafforzamento dell’Io alle spese dell’estraneità che lo abita, «un’opera di civiltà, come ad esempio il prosciugamento dello Zuriderzee» (Freud 2012, 489), bensì, nella misura in cui l’analisi comporta una certa tecnica di smascheramento che tiene infaticabilmente dietro agli alibi del soggetto, una ricerca di quella «verità liberatrice» che «non è quella di una legge superiore» ma «una verità particolare» la quale «si presenta per ciascuno nella sua intima specificità con un carattere di Wunsch imperioso» (Lacan 2008, 28-29). Il vero desiderio, insomma dell’analizzante. Perciò Lacan afferma
Questo Ich, infatti, che deve avvenire là dove Es era, e che l’analisi ci insegna a misurare, non è altro che quello di cui abbiamo già la radice nell’io (je) che si interroga su ciò che vuole. Esso non è solo interrogato, ma mentre avanza nella sua esperienza, si pone tale interrogativo, e se lo pone proprio rispetto a degli imperativi spesso estranei, paradossali, crudeli propostigli dalla sua esperienza morbosa (2008, 10).
Così, con l’andamento circolare che caratterizza il Seminario VII, dopo quell’immenso détour che passa per l’interpretazione dell’Entwurf del 1895, la dialettica tra principio di piacere-principio di realtà-pulsione di morte, lo strutturarsi del campo di das Ding, la Cosa nel suo rapporto con la sublimazione e con l’oggetto, l’amor cortese come anamorfosi, il sadismo di Kant e il kantismo di Sade quale cifra della paradossalità del godimento, il tragico fulgore di Antigone, quell’apparente digressione, dunque, che assume la forma di un lungo periplo attorno al vuoto centrale di das Ding, tutta la questione dell’etica della psicoanalisi si riduce – ed è forse poco? – alla domanda «avete agito conformemente al desiderio che vi abita?» (Lacan 2008, 364).
Una domanda, questa, che esprime tutto lo iato che sussiste tra la prospettiva della psicoanalisi e quella funzione che Lacan chiama il «servizio dei beni» – tema privilegiato della riflessone sull’etica da Aristotele a Bentham – perché nell’analisi non ne va né di una coincidenza tra il bene e il piacere, negata dalla condizione di quell’$ che è il soggetto dell’inconscio, né di una rettifica del rapporto tra il desiderio e la dimensione sociale dei beni, «beni privati, beni di famiglia, beni della casa, e altri beni ancora che ci sollecitano, beni del mestiere, della professione della città» (Lacan 2008, 351). Pensare che un’analisi di successo si riduca al raggiungimento di «una posizione di agio individuale», il «farsi garante» da parte dell’analista «che il soggetto possa in qualche modo trovare il suo bene anche nell’analisi è una sorta di truffa» (Lacan 2008, 351).
L’analisi, in quanto fondata sull’ipotesi freudiana dell’inconscio, la quale presuppone che tanto il sintomo quanto l’agire per così dire normale dell’uomo abbiano un senso nascosto che il lavoro analitico può scoprire, configurandosi come un «ritorno al senso dell’azione» contiene in sé «la forma embrionale di un antichissimo γνῶθι σεαυτόν» che tuttavia, a differenza di tante sue forme antiche e moderne, dà adito a un’«esperienza tragica della vita» (Lacan 2008, 362 -363). Laddove tragico assume il senso di irrisolto e indecidibile.
Lo si può apprezzare meglio guardando a quel motore della seduta analitica che è il sintomo. Esso coincide sempre con una soluzione di compromesso ad un conflitto pulsionale, con una soluzione quantomai soggettiva e particolare ad una contraddizione, pur sempre risolta nonostante la sofferenza che tale “soluzione” comporta: di fronte a ciò il lavoro analitico interviene non tanto per appianare la contraddizione, ma per portarla alla luce, per consentire al soggetto di riconoscerla come propria e prendere attivamente posto in essa (Zupančič 2018, cfr. 102 sgg.).
È precisamente in questo punto che si percepisce lo scarto tra la prospettiva analitica condensata nel ritorno a Freud di Lacan e tutte le altre prassi psicoanalitiche post-freudiane e, ancor di più, ogni altra forma di psicoterapia cognitivo-comportamentale, uno scarto che deriva da orientamenti etici di fondo tra loro inconciliabili. Se queste ultime si propongono di consolidare le labili forze dell’Io, di portare il soggetto a gestire e amministrare i propri sintomi – si pongono, in breve, dal lato della padronanza – l’analisi di orientamento lacaniano – fondata fin dalle origini sull’approfondimento dell’intuizione freudiana della vasta estensione del soggetto dell’inconscio (je), nella quale l’Io (moi) non è che una tra le varie istanze in gioco, peraltro risultato di una configurazione immaginaria, dunque aggregato di successive identificazioni (Recalcati 2012, 1-10) – passa, come implicito nelle formulazioni precedentemente citate, per una presa di posizione rispetto alla totalità, molteplice, conflittuale, e sempre irrisolta di se stessi.
Quanto acquisito finora è espresso, quale attento testimone, dalla formalizzazione del discorso analitico.
In esso troviamo l’oggetto a ad occupare la posizione dell’agente, sostenuto dal significante del sapere che si situa, sotto la sbarra della rimozione, nel posto della verità. Da qui, dalla posizione dell’agente, interpella il suo altro, vale a dire il soggetto barrato, il soggetto dell’inconscio e il tutto sfocia nella produzione di S₁, quel significante, dice Lacan (2011, 86), per cui si possa risolvere il rapporto del soggetto con la verità. Con la verità, è ormai chiaro, discordante, eccedente, talvolta persino inaccettabile del proprio desiderio.
A questo punto parrebbe legittimo chiedersi, che resta qui di antropotecnico? Il quadro finora delineato sembra infatti avvalorare l’idea che la psicoanalisi operi in un territorio, la vasta geografia dell’inconscio, in cui viene negato ogni potere all’influenza dell’abitudine. Il che non deve certo sorprendere. Tuttavia non bisogna dimenticare né la grande elasticità intrinseca al concetto sloterdijkiano di antropotecnica, che permette di sussumere sotto di esso i fenomeni apparentemente più disparati, anche ciò che in prima battuta pare l’opposto di un esercizio, né il fatto, invero piuttosto banale, che la dimensione stessa del setting analitico, il susseguirsi delle sedute, l’instaurarsi del transfert, presuppongono tacitamente l’inscriversi di routines e abitudinarietà, una tacita ripetizione di esercizi da entrambe le parti.
È qualcosa che emerge nella domanda freudiana sulla terminabilità dell’analisi, perché nonostante Freud (1977) ritenga la questione della fine di un’analisi un affare prettamente pratico – legato al raggiungimento di obiettivi minimi quali l’imbrigliamento egosintonico delle pulsioni e il loro farsi permeabili agli influssi che promanano le altre tendenze del soggetto – l’intero testo di Analisi terminabile e interminabile, con la sua insistenza sui problemi e gli ostacoli che si frappongono al termine della terapia, sta lì a dichiarare l’implicita adesione all’idea dell’analisi quale percorso interminabile, interminabile esercizio, incessante prodursi di Costruzioni nell’analisi – come recita il titolo del breve articolo coevo – le quali peraltro, nella loro provvisoria precarietà, esprimono tutta la refrattarietà della teoria come della pratica analitiche a una chiusura definitiva. A quella chimera, dunque, che è la «liquidazione permanente di una richiesta pulsionale» (Freud 1977, 31).
Certo, tornando all’etica della psicoanalisi proposta da Lacan, è innegabile la presenza in essa di una certa disposizione dionisiaca, come di un certo determinismo rispetto alla presa del significante su di noi (Benvenuto & Lucci 2014) ma è altrettanto innegabile – e qui si trova uno spiraglio di libertà – che «possiamo cambiare la nostra posizione soggettiva rispetto a quel che siamo» (Benvenuto & Lucci 2014, 105).
Si diceva che quell’Io che noi siamo, o meglio, quell’Io che è parte di noi e con cui noi tendiamo esclusivamente ad identificarci, altro non è che un aggregato di identificazioni, legato al registro dell’immaginario e alle dinamiche di alienazione narcisistica che pertengono, inevitabili, all’esperienza di ciascuno. Ed è proprio a questo livello che si manifesta un’altra possibile accezione della psicoanalisi intesa antropotecnicamente, cioè il suo configurarsi come pratica di critica gestione delle nostre identificazioni. In questo campo infatti – campo in realtà più esteso delle sole dinamiche identificatorie, perché bisogna sempre ricordare come il campo della libido dell’Io, delle identificazioni e dei rapporti tra Ideal-Ich e Ich-Ideal, sia in realtà un continuum del quale i fenomeni dell’innamoramento, degli investimenti d’oggetto e della libido oggettuale, sono l’esatto rovescio speculare – si può rintracciare il secondo lato della definizione sloterdijkiana di antropotecnica, l’incremento dell’immunità del soggetto.
Ma da che cosa è utile che il soggetto diventi immune? Dalle proprie identificazioni o, il che è lo stesso, dall’illusione della propria consistenza, della propria monolitica unità, che il lavoro analitico spazza via mostrando al soggetto il suo essere attraversato dal discorso e dal desiderio dell’Altro, da un’eccentricità che deborda il suo semplice identificarsi con un significante – «penso dove non sono, dunque sono dove non penso» (Lacan 2002, 512). Ma anche dalla dimensione fantasmatica, anch’essa in fondo ineliminabile, dell’esperienza amorosa, rispetto alla quale Lacan, con il consueto stile gnomico non privo di ironia, sembra dire l’ultima parola sentenziando – non c’è rapporto sessuale. Non si può porre il rapporto sessuale perché è impossibile, in breve, che due facciano Uno. Si tratta di mettere in discussione, innanzitutto, l’idea che il godimento sessuale – espressione tautologica – si identifichi con l’amore. «Il godimento dell’Altro» afferma Lacan «[…] del corpo dell’Altro che lo simbolizza, non è segno dell’amore» (Lacan 2011, 5). Ma, sotto la lente d’ingrandimento della psicoanalisi, anche il godimento del corpo si sfalda e si pluralizza, sfociando in una miriade di rivoli:
come sottolinea mirabilmente quella specie di kantiano che era Sade, si può godere soltanto di una parte del corpo dell’Altro, per il semplice motivo che non si è mai visto un corpo avvolgersi completamente, fino a includerlo e fagocitarlo attorno al corpo dell’Altro. […] Il godere ha questa proprietà fondamentale, che insomma è il corpo dell’uno a godere di una parte del corpo dell’Altro (Lacan 2011, 23).
Di qui il doppio genitivo implicito nell’espressione godere del corpo in cui si gioca, nel Seminario XX, la distinzione tra il godimento fallico e il suo al di là, la nota estatica del godimento femminile. Si tratta, infine, di mettere tra parentesi quell’idea, cruciale nella tradizione occidentale, per cui amare sarebbe fondersi in un’unità indistinta.
Siamo una cosa sola. Tutti sanno, naturalmente, che non è mai capitato che due facessero uno, ma insomma, siamo una cosa sola. È da qui che parte l’idea dell’amore. È veramente il modo più rozzo di dare al rapporto sessuale, a questo termine che evidentemente sfugge, il suo significato. L’inizio della saggezza dovrebbe consistere nell’iniziare a rendersi conto […] che l’amore, se è vero che ha rapporto con l’Uno, non fa mai uscire nessuno da se stesso (Lacan 2011, 45).
Dopo questa traversata, inevitabilmente parziale, è bene ancorarsi a qualche punto fermo, ben sapendo che ogni approdo non è che un provvisorio punto di partenza. Che cos’è, dunque, la psicoanalisi? La psicoanalisi è quella strana antropotecnica, che ci immunizza – di un’immunità che è essa stessa immune dal sogno illusorio di un’immunità totale e definitiva – dal credere che l’amore e il godimento siano la stessa cosa, che desiderio e godimento coincidano sempre giungendo a soluzione, che l’amore sia fondersi in un’unità inscindibile e cannibalesca, che l’in-dividuo sia realmente tale…immunizzarsi, in fondo, dal fantasma dell’Uno in ogni sua forma, dalla credenza che la sintesi del molteplice nell’unità sia chiusa una volta per tutte.
È quindi assodata l’appartenenza della psicoanalisi al campo dell’etica, nel quale apporta una prospettiva originale, che è in fondo, come notava un osservatore ad essa estraneo quale Foucault (2011, cfr. 26-27), una riemersione di una forma di cura di sé e direzione spirituale interamente focalizzata sui rapporti tra soggetto e verità, sul prezzo che il soggetto paga per dire il vero su se stesso e sull’effetto che ciò comporta. Ed è altrettanto assodato che il tutto si traduca in un saperci fare con le proprie identificazioni. Può tutto questo avere a che fare con una dimensione latamente politica? Occorre rammentare la centralità che Freud attribuisce, in Psicologia delle masse e analisi dell’Io, saggio cruciale perché contiene il nucleo della «dottrina socio-politica della psicoanalisi» (Benvenuto 2021, 10), ai meccanismi identificatori come base della formazione dei collettivi.
Tale grafico è il risultato dell’enunciazione della «formula della costituzione libidica di una massa», la quale prende corpo quando «un certo numero di individui» è giunto a porre «un unico e medesimo oggetto al posto del loro ideale dell’Io» identificandosi in tal modo «gli uni con gli altri nel loro Io» (Freud 2011, 234-235). I membri di un collettivo, dunque, dal partito fascista allo stesso movimento psicoanalitico, si riconoscono e si amano l’un l’altro in quanto tutti fanno riferimento a quello stesso oggetto esterno, opportunamente idealizzato, che è il capo.
Per Freud infatti non c’è Masse senza capo, perché ogni formazione collettiva rappresenta una regressione, seppur parziale, a quello stadio arcaico di soggezione che Freud indica con il mito dell’Urhorde e dell’uccisione del padre primordiale e che testimonia della «funzione costitutiva del politico rispetto al sociale» (Benvenuto 2021, 55). Ciò equivale a riconoscere, anche pensando agli aggregati umani dichiaratamente più aperti e tolleranti, che «per Freud ogni collettivo è nel fondo fascista» (Benvenuto 2021, 37). E ciò accade anche, come sottolinea Benvenuto (2021) operando una rilettura in chiave lacaniana della Massenpsychologie, quando a unire il gruppo non è tanto un individuo fisico ma un’idea-guida: basta infatti guardare alla formula del discorso del maître per notare come ogni capo individuale sia tale in quanto occupa il luogo del capo, identificandosi con quell’S₁, significante-padrone, identificandosi e facendosi identificare con una visione statuaria di sé che rimuove il suo essere dotato d’inconscio, attraverso un’operazione che ricorda la kantiana sussunzione del molteplice della sensibilità sotto la categoria che, a priori, chiede riempimento.
Che dire, dunque? Se è implicita nella psicoanalisi la possibilità di una prassi di disinnesco, attraverso esercizi reiterati di affinamento dello sguardo critico, delle proprie identificazioni – di cui le identificazioni politiche sono una parte preponderante – è allora giustificato un uso mediatamente politico della stessa. Mediatamente perché la psicoanalisi, figlia dell’età delle democrazie liberali, è quel legame sociale sciolto da ogni altro legame sociale, nella dimensione a tu per tu tra analizzante e analista, che consente di rimettere in scena sempre di nuovo il dramma originario del parricidio, dell’emersione della psicologia individuale dal magma della psicologia collettiva, emancipando così il soggetto dai rapporti densi e immediati della Gemeinschaft e introducendolo in quell’ambito, forse un po’più freddo e dominato dalla mediazione tra istanze contrapposte che è la Gesellschaft (Benvenuto 2021). Si può così insegnare al soggetto a stare in guardia – a immunizzarsi, sempre nel senso di un’immunità mai garantita fino in fondo e perciò bisognosa di un esercizio interminabile, dall’essenza fascista di ogni collettivo. E a immunizzarsi, ancora, da tutta una serie di dinamiche, quantomai attuali, spiegabili attraverso quell’integrazione alla Massenpsychologie freudiana che è il diagramma del circolo dell’alienazione politica proposto da Benvenuto (2021).
Se l’immagine ideale del capo-S₁, nel corso del processo di idealizzazione, tende sempre a scindersi espellendo da sé il suo contrario, l’anti-ideale come oggetto-scarto su cui si riversa l’odio e l’aggressività che contribuisce a tenere unito il collettivo, coalizzato contro ogni possibile nemico esterno o interno, ecco che si presenta la possibilità, per tramite della psicoanalisi, di una profilassi da ogni inevitabile dinamica settaria, da ogni nazionalismo, sovranismo e populismo…da tutti quegli -ismi che, nel dibattito pubblico come in quello accademico, contribuiscono a irrigidire e polarizzare la discussione sfociando in una triste «miseria identitaria» (Benvenuto 2021, 121). Una contrapposizione, insomma, tra posizioni identitarie dimentiche della loro labile natura immaginaria e del loro essere, come tutti, soggetti dell’inconscio – dimenticanza, questa, che quella strana antropotecnica che è la psicoanalisi, in quanto ci insegna qualcosa sul politico, può contribuire a colmare.
di Luca Valsecchi
Bibliografia
Benvenuto, S. (2021). Soggetto e masse. La psicologia delle folle di Freud. Roma: Castelvecchi.
Benvenuto, S. & Lucci, A (2014). Lacan oggi. Sette conversazioni per capire Lacan. Milano-Udine: Mimesis.
Foucault, M. (2011). L’ermeneutica del soggetto. Corso al Collège de France (1981-1982). Trad. it. di M. Bertani. Milano: Feltrinelli.
Freud, S. (1977). Analisi terminabile e interminabile. Costruzioni nell’analisi. Trad. it. di R. Colorni. Torino: Bollati-Boringhieri.
Id. (2011). Psicologia delle masse e analisi dell’Io. Trad. it. di E. Panaitescu. Torino: Bollati-Boringhieri.
Id. (2012). Introduzione alla psicoanalisi. Trad. it. di M. Tonin Dogana & E. Sagittario. Torino: Bollati Boringhieri.
Lacan, J. (2002). L’istanza della lettera dell’inconscio o la ragione dopo Freud. In Scritti (I). A cura di G. Contri. Torino: Einaudi.
Id. (2008), Il seminario. Libro VII. L’etica della psicoanalisi (1959-1960). A cura di A. Di Ciaccia. Torino: Einaudi.
Id. (2011). Il seminario. Libro XX. Ancora (1972-1973). A cura di A. Di Ciaccia. Torino: Einaudi.
Recalcati, M. (2012). Jacques Lacan. Desiderio, godimento, e soggettivazione. Milano: Raffaello Cortina.
Sloterdijk, P. (2010). Devi cambiare la tua vita. A cura di P. Perticari. Milano: Raffaello Cortina.
Zupančič, A. (2018), Che cos’è il sesso? Trad. it. di P. Bianchi. Milano: Ponte alle Grazie.
-
Vita e potenza. Marco Aurelio, Spinoza, Nietzsche
Recensioni / Novembre 2022Scopo dichiarato dell’ultima opera di Rossella Fabbrichesi, Vita e potenza. Marco Aurelio, Spinoza, Nietzsche (Cortina 2022), non è tanto una ricostruzione storiograficamente rigorosa quanto la delineazione (e la messa in atto di un pensare-con) di un canone filosofico alternativo a quello, maggioritario, che ha tradizionalmente separato la filosofia dalla pratica di vita. Proprio questa impostazione rende il lavoro meno disponibile a essere recensito e più atto – in una compulsione al pensare, e dunque al vivere, che è tra i maggiori pregi del libro – a suscitare ulteriori interpretanti che spazino sull’uso delle sue idee.
I tre nomi che corredano il titolo e che scandiscono il succedersi dei capitoli – Marco Aurelio (adottato come simbolo dello stile di pensiero stoico), Spinoza e Nietzsche – infondono a questo rimando un carattere marcatamente etico: non si tratta di ottenere qualche conoscenza filologica, ma di saper incorporare una certa comprensione della verità, di «dare uno stile» al proprio pensiero e quindi alla propria vita, nella convinzione – trasudante già dalle pagine del lavoro precedente di Fabbrichesi, Cosa si fa quando si fa filosofia? (Cortina 2017), ma qui portata a tema e sviluppata attraverso il confronto con le sue radici più autentiche – dell’inseparabilità di filosofia ed ethos. La pratica filosofica è intesa come askesis, esercizio al servizio della vita. Con un termine foucaultiano che ricorre in queste pagine, la filosofia è prima di tutto etopoietica. In due passi che sintetizzano efficacemente il tono generale del pensiero di Fabbrichesi: «il fine della vita, la massima felicità (eu-daimonia), è lavorare a costruirsi un carattere (ethos), riconoscendo, affermando, volendo ciò che in esso è destinato (il proprio daimon)» (p. 21); «La filosofia come modo di vita orienta dunque verso uno strenuo lavoro di rimodellazione del sé, una trasformazione che sappia creare soggetti non più assoggettabili, soggetti che sappiano disporre dei dispositivi che normalmente li incatenano» (p. 58).
Del suo maestro, Carlo Sini, l’autrice mantiene l’idea che il rapporto col mondo consista in una ripetizione e modulazione a partire da qualcosa che ereditiamo e che ci dà forma in maniera essenziale: non è il pensiero a essere nella nostra testa, siamo noi a essere nel pensiero. A questa consapevolezza, Fabbrichesi affianca però la lezione di una tradizione filosofica che – sulla scorta di intermediari ermeneutici come Hadot, Foucault e Deleuze – sottolinea il ruolo che la potenza può ricoprire nel superamento della dicotomia tradizionale tra soggetto e assoggettamento, polo, il secondo, sul quale Sini tende ancora ad ancorarsi. Il concetto di potenza è ciò che rende l’agente non solo soggetto alle pratiche, ma anche, in una misura che si tratta di scoprire volta per volta, soggetto delle pratiche, che possono essere modificate, progressivamente e con un duro esercizio, proprio perché esse hanno bisogno di passare attraverso l’agente per perpetuare la propria realtà. Pratica non è più solo l’insieme di dispositivi nel quale siamo immersi, ma un compito che può riarrangiare questo stesso campo. La potenza è qualcosa che innanzitutto troviamo come dato, su cui dobbiamo lavorare, che infine raggiungiamo in maniera nuova.
Il cuore teoretico del libro potrebbe essere localizzato in una rilettura etica della massima pragmatica di Peirce, pensatore cui Fabbrichesi ha dedicato i suoi primi anni di studio: stando a Peirce, un’entità (un’idea) è identica a quell’insieme di effetti condizionali che possiamo immaginare seguano dalla sua esistenza (dalla sua assunzione). Leggere eticamente questa massima significa prescrivere che questa somma condizionale di effetti (che, con la mediazione di Spinoza, divengono piuttosto affetti) venga spostata nella direzione che più si accorda a un aumento di potenza dell’entità considerata. Ciò significa che, Peirce con Spinoza, il conatus curvato verso l’habitus, la potenza diventa il dispositivo ontologico fondamentale, sostituendo la forma come il concetto definente le entità nel modo più profondo, in un rovesciamento, silenzioso ma totale, del modo di pensare maggioritario (quello di matrice aristotelica) all’interno della tradizione occidentale. Il «pragmatismo raffinato» (pp. 42, 103) che l’autrice ascrive agli autori di questo canone è un pragmatismo etico, che mira all’esercizio delle nostre possibilità vitali più profonde. L’idea non è più un generale, come in Peirce, ma un’essenza singolare e vitale, la cui determinazione, rimandata a «una visione intrecciata a una pratica» (p. 120), va intesa meno in termini descrittivi che di sperimentazione e scoperta. Un’etologia che è inseparabile da una trasformazione, che riguarda non «un’essenza pensata come avviluppata in possibilità inespresse, riferita a un generale universale cui conformarsi, ma […] un’essenza che non è che singolarizzazione in un’espressione costantemente attiva e in via di definizione» (p. 111). Si tratta, con le parole dell’autrice, di «trasformare gli affetti passivi in affetti attivi, ampliare le zone di dominio, anzitutto su di sé, ordinare gli spazi passionali dove fluttuiamo in un mare di oscurità e ambiguità» (p. 82).
Dal punto di vista storiografico, il grande spostamento individuato da Fabbrichesi riguarda il nodo problematico che si forma tra la dialettica libertà-necessità – gli autori di riferimento, come noto, tendono a vedere la prima come consentimento alla seconda – e la gestione delle passioni. La tendenza, di cui Fabbrichesi mostra tutta la bontà nonché una sorta di inevitabilità evolutiva, sta nello scivolamento dalla recisione stoica delle passioni, viste con tinte quasi tumorali come un intralcio alla conformazione al logos, alla via spinoziana della selezione, tra le passioni, di quelle che sono atte ad aumentare la nostra potenza. Dalla battaglia quale modello di rapporto al mondo si passa alla danza; dall’imperturbabilità quale fine ultimo della pratica filosofica si passa alla gioia. Lo spostamento è del massimo peso teoretico per quanto riguarda l’immagine della libertà che ne emerge. Il paradigma stoico – ben reso dall’immagine aureliana della «cittadella interiore», che Fabbrichesi evoca spesso insieme a Hadot – vedeva l’animo umano come qualcosa che, pur partecipando della corporeità universale, restava in qualche modo separato da essa: proprio nell’identità tra separazione (imperturbabilità) e conformazione stava l’ideale del saggio stoico, il suo consentire al fatalismo cosmico. Da questo punto di vista, i sostenitori del fatalismo e quelli del libero arbitrio di matrice cristiana mostrano la stessa ingenuità nel ritenere l’agente in qualche modo un’eccezione rispetto al resto del cosmo, pur in due direzioni opposte: i secondi assegnano un’agency completa al soggetto proprio come i primi lo privano di ogni possibilità fuori da quella di acconsentire a un divenire di matrice esterna. La teoria stoica, mai sviluppata con rigore, dei «confatali» puntava già nella direzione che poi sarebbe stata sviluppata da Spinoza: proprio perché l’agente non è un’eccezione rispetto al resto del cosmo, esso non è del tutto libero, ma è una parte di quella libertà cosmica che forma la necessità individuale, e può pertanto interferire, curvare, selezionare: come spiega Fabbrichesi, «nel senso etimologico del termine, de-cisione è taglio, una selezione» (p. 47). L’agente non è una cittadella che deve tagliarsi fuori dal mondo esterno; esso è piuttosto una membrana che può filtrare una concatenazione di eventi, che vengono così a dipendere, in una misura e solo se questi sarà in grado di rendersi «causa adeguata», anche da lui. Per Spinoza, non si tratterà per nulla di «non farsi toccare»: «gli Stoici operano attraverso una sospensione del rapporto difettivo con il mondo, Spinoza attraverso un’immersione totalmente affettiva in esso» (p. 116). L’individuo, lo sottolineerà efficacemente Deleuze, non ha rapporti, ma è esso stesso un avviluppo di rapporti; la gioia individuale, come spiega Fabbrichesi, va intesa allo stesso tempo come una forma di «autoerotismo» dell’unica sostanza, come il mondo che guarda se stesso compiaciuto (p. 121). La ragione non può lavorare in assenza di un supporto emotivo – meglio ancora, come vedrà Nietzsche, la ragione non ha valore che quello che le deriva dall’essere «l’affetto più potente» (p. 54). È questa con-fatalità a rendere il paradigma dell’imperturbabilità ancora in qualche modo un fraintendimento rispetto a quello della gioia; conclude Fabrichesi, mostrando quanto indistricabilmente vadano concepiti agente e mondo: «Vi è un intreccio avviluppante di decisioni che vengono consapevolmente operate e di esseri che strenuamente decisi ad agire. Ma l’essere decisi affonda le radici in una serie di concatenamenti che non si possono conoscere, se non cogliendo l’invito della filosofia a divenire saggi» (p. 48).
Ricomposta l’estraneità di facciata tra ragione e affetto, la potenza acquisisce il ruolo di autentico sostrato, se di sostrato si può ancora parlare, del diventa ciò che sei: l’indagine di Fabbrichesi potrebbe intendersi anche come una grande riflessione attorno a questo precetto dal carattere storicamente problematico, caratterizzato da una ricchezza semantica che appare inesauribile da ogni trattazione unilaterale. Tra i grandi meriti di Fabbrichesi v’è anche quello di lasciar emergere a turno, attraverso i tre capitoli del libro, le accezioni che esso può assumere, e che serve sempre tenere presenti con uno sguardo sinottico, per riequilibrare le problematiche di un uso del linguaggio ricalcato su un’esistenza diacronica, che non può che tradire un pensiero che cerca di cogliere il punto di vista dell’eterno (la scienza intuitiva, l’eterno ritorno). Prolungando le linee tracciate da Fabbrichesi, potremmo analizzare questa concettualità inviluppata scomponendola in quattro fattori problematici, quattro fonti classiche di equivocità che non sono in realtà che i diversi aspetti di quest’unica natura solo apparentemente antinomica del precetto.
Primo: l’autrice richiama spesso alla necessità, scoperta dagli stoici, di «imparare a vivere secondo natura» (pp. 24, 173), di scoprire nella fondamentale consonanza col cosmo la nostra potenza più propria. Quello che, così formulato, potrebbe apparire come un grido quasi reazionario è in realtà il più radicale e materialista dei punti di vista, il più lontano da un appello meramente normativo a una supposta natura cui adeguarsi coattamente. Seguire la natura è anche seguire la propria natura, è affermare la superiore originalità della physis immanente rispetto a un nomos spesso imposto, l’anteriorità della potenza sulla forma; è affermare il diritto dell’esistente, anche di quello singolare, in rapporto a ogni ideale estrinseco, poiché non c’è ideale che quello immanente al singolo esistente. Il nietzschiano «diventa ciò che sei» significa proprio, al di là di ogni «dover essere», elevare a potenza questa physis che troviamo come data.
Secondo: può essere una preoccupazione legittima che questa prospettiva appaia come una giustificazione dell’irresponsabilità. In un libro recente (Sulla viltà, Einaudi 2021), Peppino Ortoleva si domanda ad esempio se davvero si possano mettere sullo stesso piano Don Abbondio, che non fa che realizzare la propria natura di pavido, e personaggi come Fra Cristoforo e l’Innominato, la cui grandezza starebbe proprio nell’andare contro se stessi, dominando il proprio temperamento quasi criminale. A sua volta, il precetto di ripetere potenziata la propria essenza prima non deve trasformarsi in un nuovo asserto normativo che impedisca il lavoro su di sé e la trasformazione, e anzi l’intero percorso filosofico tracciato da Fabbrichesi tende nella direzione inversa. Ciò che sentiamo come più autenticamente nostro può spesso non coincidere con la nostra potenza, ciò che possiamo non è sempre identico ai nostri abiti immediati. Il «cammino del consentimento», come lo chiama Paul Ricoeur nella sua Filosofia della volontà, a condizioni che non abbiamo scelto, come il nostro carattere, l’inconscio, le condizioni biologiche, è un cammino che può essere completato, persino deviato, accogliendo influenze esterne e metabolizzandole affettivamente. L’amor fati è inseparabile da una «trasvalutazione degli affetti» (p. 171), e il «ciò che sei», lungi dall’essere dato dall’inizio e una volta per tutte, comprende anche tutte quelle cose che abbiamo reso nostre.
Terzo: anche così, sembra impossibile appianare del tutto la tensione tra il punto di vista dell’accettazione piena – la prospettiva stoica, l’amor fati nietzschiano – e quella del divenire gioioso – la gioia di Spinoza, la volontà di potenza, che sembra in qualche modo incitare alla lotta per il miglioramento delle condizioni vitali. Amor fati non significa solo acconsentire a tutto quanto ci accade; significa altresì, e forse soprattutto, dare forma a un destino che possiamo amare. Come recita un meraviglioso aforisma postumo di Nietzsche citato dall’autrice, l’eterno ritorno non insegna che a «vivere in modo tale che tu debba desiderare di rivivere» (p. 174). Gli stoici certo insegnano a non «digrignare i denti» contro quanto il destino ci riserva, ma altrettanto «contro natura» sarebbe forzare noi stessi all’accettazione di tutto quanto viene da fuori. Il consentimento è sempre trasformazione del consentito; il suo vero significato è ben reso da Fabbrichesi: «Rassegnarsi, nel senso etimologico di ri-assegnarsi: fare sì che il destino divenga una destinazione desiderata, assunta, guadagnata come un proprio movimento libero […] Libertà diviene allora sinonimo di potenza: capacità di conoscere e ri-conoscere ciò che accade» (p. 46).
Quarto: l’intero lavoro di Fabbrichesi si lascia consapevolmente attraversare da un grido lanciato da Spinoza ed esaltato dalla lettura deleuziana: non sappiamo cosa può un corpo. Ogni singolo affetto è determinato da una rete relazionale così complessa che nessuna mente finita potrebbe prevederne con esattezza l’esito. Da qui l’imperativo di non dire in anticipo – in termini deleuziani, non giudicare, ma lasciar esistere, vale a dire sperimentare. È questo corredo a privare il «diventa ciò che sei»di ogni contenuto normativo determinato, convertendolo piuttosto in una disposizione alla creazione di un essere nella cui realizzazione il nostro carattere possa scoprire la gioia. Non c’è modo di sapere ciò che siamo se non attraverso una lunga e rischiosa sperimentazione. Cos’era la follia di Nietzsche se non l’estremo amor fati applicato a questa sperimentazione? Cosa sono i richiami di Deleuze alla necessaria prudenza richiesta dalla sperimentazione, se non un orrore ammirato al pensiero di una vita piena che, come quella di Nietzsche, è stata dilaniata dal coraggio di un’assenza di misura? Il concetto di limite invocato da Fabbrichesi attraverso Deleuze serve proprio a questo scopo: la potenza è un tendere che deve contenersi un passo prima del proprio disfacimento, è sprigionamento di forze ma anche mantenimento di un’organizzazione minimale che ne assicuri il funzionamento coordinato. Non un rigido «limite-cornice», ma un «limite-tensione» (pp. 113-4) che col giusto lavoro può sempre essere spostato un passo più in là. L’esercizio spirituale è sempre un bilanciamento di forze centrifughe o espansive, espressive di potenza, e di forze centripete e contenitive che danno forma a un nucleo che fa da aggancio sempre metamorfico agli accidenti del mondo e del carattere.
Tutte queste difficoltà vengono insomma dalla necessità di cogliere il precetto sinotticamente, sia dal punto di vista temporale e umano, che da quello dell’eternità, dal punto di vista dell’esercizio che si dispiega e di quello dell’essere. La stessa essenziale duplicità si ritrova nel concetto di vita, altro polo della diade che fa da protagonista al libro. Esso si identifica da una parte come il flusso, impersonale e in questo senso atemporale, che definisce la potenza. Ma vita è anche la vita vissuta, ad un livello non riducibile a quello meramente personale o impersonale – una vita, diceva Deleuze –, e che acquisisce definitezza attraverso le pagine di una scrittura ancorata allo stesso svolgimento narrativo del vissuto. L’ultimo capitolo del libro è fondamentale alla comprensione complessiva del lavoro non solo in quanto ai contenuti, ma per la sua stessa forma: proprio l’approccio biografico a Nietzsche – o meglio, a «Friedrich» – eleva a potenza l’identificazione della filosofia con la sua pratica. Di Nietzsche, Fabbrichesi non presenta la dottrina o la teoria, ma «la potenza pratica di lavoro su di sé» (p. 127) con cui egli annullò la differenza tra la sua vita attuale, perlopiù derelitta e impotente, e la realizzazione della sua potenza più propria. Un divenire-Friedrich (avrebbe detto Deleuze), dell’autrice quanto del lettore, viene messo in atto attraverso le vicende e le lettere, in particolare quelle relative al tormentato rapporto con Lou Salomé. Pochi pensatori esemplificano quanto Nietzsche la solidarietà tra vita e pensiero evidenziata da una tradizione che da Diogene Laerzio va fino a Sini; se questa solidarietà si integra tanto bene al tono più ermeneutico-testuale dei primi due capitoli, è soprattutto perché Nietzsche mostra quanto la scrittura della propria vita possa configurarsi anch’essa come un esercizio volto all’aumento della potenza. Fabbrichesi suggerisce anzi che solo tramite tale esercizio Nietzsche fu capace di vedere la grandezza insita nella propria esistenza. L’auto-bio-grafia come askesis consiste, si potrebbe dire, nel saper cogliere gli eventi marchiati dal proprio nome, finanche gli eventi più tragici e sciagurati, da quel punto di vista che permette di vederli come tasselli del compimento di un destino. La «grande salute» non è uno stato, ma quel punto di vista dal quale la malattia si può narrare come identica alla salute, la sventura come identica alla realizzazione di sé, la disperazione più profonda alla gioia più alta. Potremmo parlare, facendo confluire Nietzsche, Peirce e Sini nella lente di Fabbrichesi, di un interpretante auto-bio-grafico finale, della scoperta di quel punto vitale che permetta una risignificazione integrale degli eventi come passi sul cammino della potenza di una vita.
Vita e potenza è anzitutto – lo prospetta la stessa autrice rifacendosi nelle prime pagine a Rachel Bespaloff – un incontro in forma di libro. Il suo pensare-con gli stoici, con Spinoza e Nietzsche è un generatore di ulteriori compulsioni a con-pensare – e ciò significa, seguendo l’equazione tra pensiero e vita, che il percorso tracciato da Fabbrichesi attraverso il suo canone di autori diventa anche un’esperienza vitale trasformativa. La contagiosità dell’urgenza personale espressa dal libro fa sì che lettura ed esercizio vengano a coincidere. Si tratta già di un aumento di potenza.
di Christian Frigerio
-
Dalla pulsione al desiderio, e ritorno
Recensioni / Ottobre 2022Sembra che la psicoanalisi non sappia molto della soddisfazione della pulsione, e che anzi si limiti a fare qualcosa con la sua insoddisfazione strutturale. Cosa ne fa? Un percorso di cura, attraverso costruzioni più o meno artificiose di godimenti sostitutivi, spostamenti del godimento dal suo luogo mancato alla stanza del terapeuta. Quel che in Vivere la pulsione. Saggio sulla soddisfazione in psicoanalisi (Orthotes, Napoli-Salerno 2022) lo psicoanalista lacaniano Franco Lolli intende disarticolare è proprio l’ovvietà del ragionamento che ho appena esposto, col quale attestiamo, implicitamente, cosa sia godimento, cosa sia pulsione e cosa voglia dire essere soddisfatti o insoddisfatti.
Per scrivere cosa ne sappia la psicoanalisi della pulsione, dovremmo prima sapere cos’è la pulsione, il che, metodologicamente, è inarrivabile: la psicoanalisi non cerca il ti estì ed è avversa tanto a una risposta che vada nella direzione dell’appiattimento ontologico di siffatta domanda quanto a una ricerca di cause che si presenti come ultima e fondante la disciplina. Pertanto, la prima domanda che dobbiamo lasciar cadere, nel leggere il saggio di Lolli, è proprio “cos’è la pulsione?”.
Se volessimo azzardare una risposta, diremmo “un indefinibile, un indecidibile”, annullando così retroattivamente la domanda. L’indefinibilità della pulsione non è un escamotage teoretico per sottrarsi a un’indagine scientifica degli eventi e della loro etiologia, ma anzi il preciso esito di tale indagine. Esito che attesta un Reale restìo da secoli a una generalizzazione definitoria possibile. Si tratta di un Reale filogenetico, trans-storico, che affonda nelle strutture comuni del sentire e al contempo le travalica e le precede, provocando atteggiamenti pulsionali non sussumibili e di cui il soggetto non sa niente, può solo limitarsi a constatarne la ripetizione e l’assurdità: una convinta femminista gode solo immaginando di essere stuprata da una camionata di nazisti, una donna colta è incredula perché attratta solo da uomini rozzi e grossolani, un’altra ha atteggiamenti di maternage e dolcezza nei rapporti, mentre per venire deve immaginare di possedere una donna «come farebbe un uomo» e sbatterla contro il muro (cfr. pp. 19-20).
In un’affascinante ricognizione di frammenti clinici, Lolli mostra come la pulsione faccia il paio con nient’altro che la singolarità, da cui «l’impossibilità di pensare […] la sua precisione» (cfr. p. 59). È possibile un’ontologia che renda conto dell’evento singolare della clinica? E ancora, possiamo permetterci di ontologizzare uno dei quattro concetti fondamentali della psicoanalisi (inconscio, ripetizione, transfert, pulsione) senza conseguenze? Col dire che la pulsione è un concetto che resiste all’appiattimento o riduzione ontologica, non intendiamo, ovviamente, che essa eluda il corpo o che in qualche modo non parta da esso: è ricorsivo e presente carsicamente come sfondo, nella produzione di Lolli, l’interesse per il corpo come “inizio” – dalla prima esperienza come psicoterapeuta in un istituto di riabilitazione per soggetti con disabilità motorie e psichiche a opere quali Prima di essere io e L' ingorgo del corpo – inizio che è al contempo uno slittamento: dal fisiologico al pulsionale, da cui si traccia la loro co-implicazione.

Francis Bacon: Ritratto di Henrietta Morales, 1909-1992, Ireland (WikiArt) Nel lambire, con difficoltà e incertezza, qualcosa di simile a un significato di pulsione, consci del punto di impossibilità che essa rappresenta in virtù delle ragioni esposte, potremmo accostarla a un concetto di natura trascendentale che si dispiega al crinale tra il somatico e lo psichico, permettendo un richiamo incessante dell’uno nell’altro. Ben diversamente da un “debordare”, la pulsione è garante di una forma di omeostasi e equilibrio, un punto tanto impreciso quanto necessario che non sacrifica alcuna polarità, e che anzi le ricomprende in un’economia soggettiva più ampia. Soddisfare il corpo, sembra dirci Lolli, implica anche una certa postura epistemologica e simbolica dello stesso; in tal senso l’oggetto non è mai senza concetto – e senza fantasma – e viceversa il concetto si modula su un corpo pulsionale che è dotato del suo realistico correlato oggettivo e neurofisiologico.
Pertanto, il saggio di Lolli ha il pregio di una radicale lucidità, con implicazioni dirette su un neo-lacanismo che, in sede sia teoretica che clinica, alle volte, sacrifica un registro per preferirne un altro, o si appiattisce su una polarità rinunciando all’altra: la pulsione così come letta da Lolli è tratto dirimente per ripensare tout court il rapporto tra Reale e Simbolico. Lasciare indietro il coté simbolico e epistemologico del sintomo può avere effetti nella direzione della cura dei sintomi contemporanei e, più decisamente, nell’intendere il desiderio, tema cruciale in psicoanalisi lacaniana: il movimento che il saggio sembra compiere consiste in un emergere progressivo del desiderio, in un delinearsi della pulsione anche come desiderio, dunque come struttura di domanda simbolica, lettura affatto scontata qualora la pulsione sia “incollata” al godimento reale.
Articolando le parentele della pulsione con l’oggetto a – che non è mai oggetto ontologicamente inteso, ma investito e impregnato dalla fenomenologia del fantasma –, poi con il desiderio e con il fantasma, Lolli può instaurare un movimento che vada dalla pulsione al desiderio, e ritorno: ritorno alla pulsione non prima di esser passati dal Simbolico. Se, su un versante, il nucleo di originaria e perduta indistinguibilità di desiderio e godimento si riverbera in un desiderio che mantiene del godimento il carattere antidialettico di bisogno, refrattario all’alterità dialogante e domandante, insomma una «condizione assoluta» (p. 159), per un altro verso, nonostante il proprio voler fare a meno dell’altro, se ne implora il diventarne oggetto, si supplica un riconoscimento della propria domanda muta. Piuttosto che allarmarsi per contraddizioni insolute, che sono all’ordine del giorno in psicoanalisi, conviene dunque compiere un movimento, che è la cifra stilistica e teoretica del saggio: un’“oscillazione” che ha la stessa preziosa scansione dell’andirivieni nevrotico, un percorso ondulatorio di indifferenza e dipendenza con cui ci si difende e si tenta di maneggiare «l’enigma del desiderio dell’altro» (p. 159).
Lolli rivitalizza la pulsione con una mancanza, la reinserisce nel circuito del desiderio, e in esso la incornicia: quest’operazione permette di aprire spiragli decisivi di soggettivazione in seno alla prigionia dell’immanenza piatta e stagnante del solo godimento. In un saggio della sua Metapsicologia del 1915, Pulsioni e i loro destini, Freud suggerisce una destinalità quasi senza scampo sancita dalla pulsione che ci agisce. Questo tratto ritorna nei casi clinici di Lolli i quali, più che ripetere, sono ripetuti da una passività che li esercita: Mario è schiacciato dal peso di un «vizio inconfessabile», si autoattribuisce una perversione, consistente proprio nel piacere di farsi schiacciare, come una farfalla sotto stivali di gomma (cfr. pp. 182-184). Se Mario non lo vuole e lo rigetta, cosa ha tracciato per lui il destino di doversi eccitare così e non altrimenti? Ripenso all’avvertenza editoriale dell’edizione italiana del sovracitato saggio freudiano, dove la traduzione interpretativa di Schicksale con destini, piuttosto che con vicissitudini, è giustificata dal fatto che le traversie della pulsione sono per lo più «soluzioni specifiche a cui le pulsioni sono necessariamente costrette» (S. Freud, Introduzione alla psicoanalisi e altri scritti 1915-1917, p. 6).
Tuttavia nell’evoluzione della spinta pulsionale, che è costitutivamente non lineare, bisogna tener conto di un embricarsi reciproco di forme attivo-passive che aprono uno spazio di smarcamento dalla necessità destinale: la complessità della pulsione è dovuta alla plasticità libidica, in quanto sovrapposizione e coesistenza di forme attive e passive, fasi che «si comportano le une rispetto alle altre all’incirca come successive eruzioni di lava» (p. 26). Sembrava dirci Freud che c’è un’imponderabile attività nella passività: trasponendolo in Lolli, serve forse percorrere quel che di desiderio vi è nella pulsione. Lo psicoanalista riprende questo luogo di respiro della pulsione, innestandovi il «bemolle della perdita […] che si sovrascrive al diesis del recupero di godimento» (p. 69). Molto si gioca in questo spazio: la variazione, il guadagno soggettivo, gli atti di scrittura di una memoria inconscia.
Lolli si è cimentato in un progetto audace e a tutti gli effetti riuscito: ri-problematizzare pressoché tutti i concetti chiave della psicoanalisi, senza cadere in ortodossie di Scuola, allontanandosi dalla ripetizione pedissequa dell’idioletto lacaniano, per aderire a una direzione teorica che è il riflesso della clinica. Nell’uscita dal piuttosto abusato binarismo desiderio/godimento, un pensiero della pulsione si configura come atto di shifting tra i due suddetti, fino al punto da non riconoscere cosa, di desiderio, vi sia nella pulsione, e cosa invece di godimento. Ammetto che alla vista del titolo ho temuto che Vivere la pulsione. Saggio sulla soddisfazione in psicoanalisi fosse l’ennesimo saggio di psicoanalisi su una possibilità più o meno raggiungibile di accedere al godimento: che l’insistenza sul “vivere” e sulla “soddisfazione” richiamassero una nota dimensione acefala di pulsione che, appunto, non si pensa ma si vive. Vivere, soddisfarsi, godere sono significanti collocabili in un’area semantica che taglia la mancanza del manque-à-être inteso come prototipo del soggetto lacaniano. Ho temuto dunque un invito a far coincidere, come in certo senso parte della lezione lacaniana vorrebbe, il fantasma (di fine analisi) con la pulsione, e dunque una progressiva sparizione dei tratti del desiderio, del simbolico, della mancanza, e del fantasma – quest’ultimo nel suo ruolo di velo e di struttura narrativa piuttosto che di affaccio dirompente sul Reale – fino al delinearsi di un Reale fuori-legge, talmente fuori che persino il soggetto ne è escluso, un impersonale di nessuno, che in certo neo-lacanismo teoretico la fa da padrone. Il movimento presunto che si assocerebbe a pulsione e soddisfazione non è invece inscrivibile in una teleologia naturale “verso il Reale” bensì è avvolto e complicato in se stesso: il “verso” la pulsione è già ritorto sul desiderio, e la mancanza desiderante in quanto inerente a un corpo che gode è già più di quanto manchi. La pulsione è quasi raffigurabile come un Giano bifronte che guarda indietro-avanti al desiderio-godimento, e ne media la conversione reciproca e l’inestricabilità.
Rispetto al movimento da me immaginato, a giudicare da certo stato dell’arte del neo-lacanismo, movimento che si sarebbe servito della pulsione come operatore di de-soggettivazione progressiva, ritrovo invece un ritmo scandito da complicazioni teoretiche che conducono direttamente alla messa a tema del soggetto in psicoanalisi: gli oggetti a – oggetti fantasmatici che fungono da resto e obliterazione di un godimento originario istituitosi già come perduto – sono molti per ciascun soggetto, dunque deve esservi soggetto a percepire molteplicità e differenza fra gli oggetti; la pulsione, in quanto, «tesoro dei significanti» sorprendentemente circola nel simbolico più di quanto saremmo portati a credere, sganciandosi così da un certo vitalismo biologicistico (cfr. p. 113) e da un riduzionismo di scariche meccaniche e spurganti, facendosi veicolo di un’elaborazione rappresentativa che si correla al fantasma e non prescinde dalla sua cornice, ricomprendendo così il sessuale come anche, necessariamente, immaginario e simbolico.
Se il saggio di Lolli dovesse essere rappresentato graficamente, sarebbe un nodo borromeo a quattro, in cui i tre registri lacaniani – Reale, Simbolico e Immaginario – procedono contestualmente e si istituiscono, di volta in volta, in maniera relazionale, di modo che alcun registro sia fagocitato (sorte che è spettata al Simbolico nel cosiddetto ultimo Lacan) o lasciato indietro: la pulsione è vettore di circolazione significante nel Reale, funzione operativo-trascendentale istitutrice di nessi tra la materialità dell’antefatto libidico e la complessità sintattica della traccia mnestica. Un paradosso dagli effetti di equilibrio sistemico: la pulsione si significantizza nella formulazione della domanda, ammettendo qualcosa del Reale alla trasmissione, eppure ha una natura di “bisogno” che in modo lavico smobilita dal basso il significante, e lo fa eruttare frammentandolo con un più-di irricomprensibile nella struttura. Mediante la precisa illustrazione teorica e clinica di tale meccanismo, a sua volta garante di una struttura, Lolli mostra la via emancipatoria di una ripetizione biologica che solo in virtù della sua natura trascendentale ci salva dalla fissazione d’oggetto. La pulsione, in quanto predelineata secondo una strutturalità intima dotata di leggi proprie, traina una liberazione: che la domanda possa procedere senza oggetto. Ciò in cui Lolli si allontana con decisione da una “psicoanalisi dell’impersonale” è precisamente la dimostrazione di questo meccanismo. Solo passando dal desiderio si rilancia la posta in gioco della soggettività, e la pulsione, ritornando alla propria natura di domanda simbolica, produce un effetto-soggetto.
di Sara Fontanelli
-
Sulla disperazione d’amore di Stefano Bonaga
Recensioni / Aprile 2022«Usare un quintale di tritolo per far saltare un portaombrelli»
Quando si soffre, è difficile non lamentarsi. Di fronte al tribunale della ragione, quando finisce un amore, è arduo non compilare una confessione, facendo del proprio dolore la testimonianza del torto subito dall’altro. Ma nel fare di sé stessi un personaggio tragico, non si può sfuggire più alla propria narrazione, poiché prima di confessare, si giura sempre di dire tutta la verità. Questo libro non è una confessione e in esso non opera sotterraneamente alcuna teodicea.
A sentire Stefano Bonaga, l’amore è una virtù della forza (Sulla disperazione d’amore, Aliberti compagnia editoriale 2019, n. 28; d’ora in poi, tra parentesi, sarà indicato solo il numero dell’aforisma). Ed è proprio la forza che al disperato d’amore manca: quel che gli tocca, che è anche tutto quel che può fare, è cercare di dormire e così di dimenticare. Se la cura non funziona, almeno si otterrà una «amorevole perdita del sé» (84). Restituire la complessa sintomatologia che cataloga l’autore non pertiene a questa sede, anche perché si tratterebbe di spiegare ciò che nel testo viene raccontato, mancando a quel tono che, come si dirà più tardi, è fondamentale all’effetto del testo stesso. Per ora basterà considerare che, a parere di chi scrive, il trattato prende una posizione chiara sulla determinazione del desiderio del disperato: se è la forza che gli manca, è perché la sua disperazione è, spinozianamente, legata alla sua impotenza. La tragedia del disperato d’amore sta tutta in questo annichilimento, che è un assoggettamento dell’oggetto, ma anche e soprattutto del soggetto, in una fossa che rasenta il «nulla della potenza» (83). A esser onesti, però, il disperato può ancora agire, ma solo in maniera coatta (118), e questo fa di lui una macchina che scava nella carne, che produce concatenamenti e che funziona a un regime metaforico (21). A monte, l’autore parte da una considerazione produttiva del desiderio, piuttosto che costruire il suo ragionamento su un desiderio-assenza. La definizione della disperazione risente, di rimando, della stessa matrice filosofica, anche se, nella disperazione, l’unica concatenazione che rimane possibile è quella che opera attraverso una progressiva sottrazione del sé a sé stessi, che ha come scopo quello di lasciare indietro solo la carne, a torturarsi (14). Necessariamente, allora, la ragione si rivela più come un accidente che come una facoltà, la cui potenza è determinata dal caso (71).
La disperazione d’amore, inoltre, come omogeneo effetto di questo posizionamento, guadagna in crudeltà, poiché non si tratterà più di una sofferenza psicologizzata: l’unico suffisso di “psico-” che interessa al disperato è “-pompo” (77). Piuttosto si patisce un dolore del corpo, che impedisce qualsiasi azione, poiché a essere inibita è la potenza. Di più, la doppia articolazione che lega il disperato a chi ama, sta tutta nella costatazione che, sebbene il legame con l’amato sia reciso, non è finito l’effetto fantasmatico della sua presenza. È una legge di proporzionalità inversa quella che lega la forza dell’amato a quella del disperato (38) e più l’altro sembra felice, più il disperato perde la capacità di farci qualcosa.
Sì, però prima o poi la disperazione d’amore finisce, ed è ragionevole immaginare che così accada. Che sia la ragione a legittimare l’immaginario (35) non diminuisce però la sofferenza, poiché l’attesa è vissuta come stagnazione, nell’ordine temporale dell’aion, dell’astrazione cui non si dà rimedio se non eventuale. Di più, anche le parole del suo vocabolario stanno nello stesso tempo astratto, “nulla, essere, sempre, mai” (23). Chiaramente esse soffocano solo chi le pronuncia. Come effetto, inoltre, dell’impotenza di agire ora, il disperato si strugge nel suo desiderio declinato al «congiuntivo passato» (81). E se il tempo del disperato d’amore è astratto, il suo spazio gli è indifferente: risponde così con euforia o depressione motoria, ma in entrambi i casi la «pace logistica» (36) è negata, poiché il disperato è, in fin dei conti, «homeless» (56).
Se però è vero che si può scrivere solo di ciò che non si vuole più nel cuore (18), la scrittura è amica del disperato d’amore. Ed è lo stile particolare che utilizza l’autore che ci piacerebbe qui tematizzare, dato che è proprio questo che permette un certo effetto terapeutico sul lettore. Sebbene infatti l’autore consigli ai disperati di stare alla larga dai poeti, e anzi ci indichi di frequentare le farmacie piuttosto che le biblioteche (73), questo è un libro per i disperati d’amore, scritto da un disperato d’amore. E come si diceva, è facile scadere nel tragico. Ma il tono che regge il trattatello è piuttosto tragicomico, a ben rappresentare la situazione del disperato: paradossale figura per cui è comico considerare la sua una tragedia, rispetto a quella del mondo, ma tragico pensarla comica rispetto al suo sentire (13). La forma del trattato, poi, mimica lo stile di una scienza esatta, di una accumulazione fenomenologica dei sintomi del malato. E, avendo la presunzione di credere che l’autore abbia patito di prima mano di quel che scrive, forse proprio per quell’Alba Parietti con cui si ricorda sempre la relazione, il tono che tende all’oggettivazione prende un gusto differente. Il testo sarà così anche un po’ autoironico, e l’autore addirittura si muove per questo una accusa di mediocrità (102). Al contrario, però, il trattatello suona piuttosto come una esternalizzazione, procedimento deleuzo-guattariano che strappa i sentimenti dalle profonde interiora di un “soggetto”, proiettandoli in un campo di pura esteriorità, facendone così degli affetti (Gilles Deleuze, Félix Guattari, Mille Piani. Capitalismo e schizofrenia, Cooper&Castelvecchi, 2003, p. 500).
A ciò sembra seguire un’altra operazione essenziale perché emerga questo stile così crudelmente divertente, ovvero una oggettivazione dell’esperienza secondo una logica tutta distorta dalla materia che organizza. Come ci ricorda Enzo Melandri, ogni oggettivazione presuppone una irrazionalizzazione uguale e però contraria, cioè di segno opposto: una soggettivazione (La linea e il circolo, Il Mulino, 1968, p. 772). Si capisce perché il disperato abbia bisogno di questo procedimento per espiare il proprio dolore, cioè la propria affezione triste, che lo lascia privo di forza, ha bisogno di oggettivare la propria impossibilità di agire, in modo da permettersi una azione. Che poi le parole di un disperato vengano pubblicate sarà anche osceno, ma sta nell’ordine delle cose umane (19).
Sia chiaro, d’altro canto, che non si trova nel testo di Bonaga alcuna epistemologia “masochista”, se per quest’ultima intendiamo l’attribuzione alla disperazione di un ruolo conoscitivo o di testimonianza, in breve, di un significato. Il dolore non serve, qui come in Pavese, a niente (Il mestiere di vivere, Einaudi, 1973, p. 59). Chi non ci crede, «si merita un boia e un piccolo patibolo, senza tanto clamore, in una esecuzione minore, modesta e sottotono» (50). Nemmeno il “giusto” fa parte di questo «vocabolario della sofferenza» (27), nessuna teodicea, come si diceva, serpeggia tra le parole a far la morale al disperato. Non solo il lettore, così, non si troverà davanti ad un giudice del proprio dolore dal quale difendersi, ma si vedrà piuttosto in uno specchio distorto nel quale non può riconoscersi, seppure vi distingua le proprie forme. Si sopravvive allora, come disperati, un po’ storditi a questa lettura, poiché ridendo di sé stessi, abituati ad essere divisi da sé, ci si trova a ridere della propria disgrazia, invece che continuare a disperarsi. Spaesati dall’immagine che questo specchio ci rimanda indietro, qualcosa accade. Proprio allora si capisce perché «una risata comica seppellirà i disperati d’amore» (94).
di Irene Sottile
-
La stella ascetica. Nietzsche e la soggettivazione
Recensioni / Febbraio 2022Per chi conosce Nietzsche il titolo del libro di Antonio Lucci, La stella ascetica. Soggettivazione e ascesi in Friedrich Nietzsche (Inschibboleth 2020), potrebbe risultare di primo acchito impressionante. Si tratta di uno studio sull’ascesi, ma, prima ancora di questa parola, compare in effigie il termine “soggettivazione”. Non è forse Nietzsche il promotore di un pensiero distruttivo del soggetto? A che scopo dunque trattare della soggettivazione laddove ogni baluardo soggettivo, ogni hypokeimenon, garanzia epistemologica o sostanza che sia, viene disciolto in una nuance, in una costellazione fumosa di impulsi e necessità? Del resto, lo stesso concetto di volontà di potenza mette fuori gioco una certa fiducia nell’arbitrario, e ciò rende complesso anche il tema di una possibilità volontaria lato sensu dell’ascesi, soprattutto quando questa è espressione di una dinamica soggettuale. Per rischiarare al meglio i dubbi qui sollevati, bisogna innanzitutto comprendere che il focus della ricerca presentata da Lucci è non un soggetto, individuale e universale, bensì la soggettivazione, come processo del farsi di un soggetto. Si tratta, in fondo, di un approccio che non si discosta per niente da quanto lo stesso Nietzsche applica mediante la sua genealogia: la conoscenza di un’idea non si cristallizza in un punto finale, da assumere come assodato, ma nel percorso e nel divenire della stessa, con i retroscena e gli usi pratici che entro sé cela. Allora diventa maggiormente interessante la proposta di uno studio sul soggetto soggettivato, poiché questo, lungi dall’essere riassemblato dopo la già avvenuta distruzione nietzscheana, viene piuttosto ulteriormente frantumato, così da poterne intravedere una delle anime, svelata, in queste pagine, come ascesi.
A conferma di quanto è stato ad ora spiegato occorrono le parole di Lucci: «ciò che la filosofia ha chiamato “soggetto” non è altro che il risultato di una serie di pratiche, di atti, di esercizi di soggettivazione di carattere fìsio-psichico – in una parola di un’askesis – e non un punto di partenza, un fondamento inconcusso» (p. 14). Pertanto, “soggetto” non significa né stadio definitivo né iniziale, non è un sostrato immutabile, non è assolutezza. Non è neanche mera apertura all’alterità, perché ciò che soggettivizza non può essere designato alla stregua di una passiva ricezione di input endogeni provenienti da condizioni esterne. C’è un’interiorità che muove dal (non)soggetto stesso, e che tenta di metterlo a fuoco, di plasmarlo secondo un’immagine precostituita, che tende a incrinarsi per raggiungere un risultato. In quest’ottica l’ascesi è fondamentale chiave di lettura non solo di pensatori quali Foucault, Hadot, Schopenhauer, Sloterdijk, Gehlen, Weber; il pensiero nietzscheano merita parimenti un posto in una possibile “storia dell’ascesi”, in particolare per la policromia con cui esso tinge questo concetto, la quale a sua volta proviene da influssi e contesti culturali differenti, primo tra tutti quello della Grecia antica.
Su questo primo aspetto, è mirabile la capacità di Lucci di andare a fondo del problema, con un’apertura filologica sia nei confronti del termine askeo a partire dagli utilizzi omerici e poi greci in generale, sia dell’uso che ne fa Nietzsche nei primi scritti di ascendenza greca, fino a giungere all’ascetica soluzione di una tragedia come «rimedio anti-ascetico della grecità» (p. 19). Con la ripresa dell’asse Orfeo-Pitagora, inoltre, l’ascesi, in quanto fenomeno storico-religioso, si configura anche come scelta politica, opposizione alle pratiche comuni della polis rivolte a divinità olimpiche, adottante un altro tipo di bios, un regime alimentare e un tenore di vita ben differenti. L’ascesi avrebbe dunque in Grecia un significato profondamente sociale, che implica una ribellione a un ordine preconfigurato. Nietzsche assorbe certo il significato “contrastivo” dell’ascesi, soprattutto allorquando questo è complice della rivalsa di divinità notturne su una certa serenità della tarda grecità. In La visione dionisiaca del mondo confluiscono questo, come altri motivi: l’ascesi come volontà o disposizione d’animo (Stimmung) è, ulteriormente, di chiara influenza schopenhaueriana.
Diventa perciò ancora più evidente perché dovrebbe essere utile ai fini dello studio di Nietzsche comprendere il suo rapporto con tale fenomeno: in esso è tratteggiata la nota connessione con Schopenhauer e la relativa rottura, se si pensa al significato filorientale che quest’ultimo vi attribuisce; ancor prima vi è il nesso con la grecità e il concepimento di un “rimedio” greco, come ascesi vitalistica, contrario alla pratica ascetica cristiana, indebolimento della volontà, che sarà oggetto degli scritti maturi. Certo, non bisogna escludere in principio il rapporto ascesi-santità, soprattutto laddove la prima designa «un campo semantico comune, che troverebbe poi una sintesi, come sua espressione compiuta, nell’idea tarda di ascesi come “esercizio”», ovvero una tensione plasmatrice e trasformativa verso un miglioramento, «un lavoro mirato al perfezionamento, che si applichi al dato naturale costituito dal corpo, per renderlo inattaccabile, non-rovinato, […] perfetto, privo di difetti» (p. 31). Come potrebbe questa definizione distanziarsi del tutto da quel medesimo lavoro che invece viene preteso per lo spirito? Non deve stupire se verrà attribuito un significato non del tutto corporale all’ascesi nietzscheana, la quale «ha innanzitutto un valore psico-energetico» (p. 59), vale come “incanalamento” di impulsi, direzionamento di una volontà superindividuale e non soggettiva, per quanto soggettivante. Ecco che «a loro volta questi stessi soggetti non sono che espressione di convoluti storici sovraindividuali anch’essi portatori di quanta psico-energetici: le culture […], atte a potenziare, incanalare o disinnescare i propri flussi energetici» (p. 64). È chiaro, pertanto, che non è l’aspetto psichico a distrarre da quello corporeo, elementi che per Nietzsche convivrebbero in armonia, quanto piuttosto quello culturale, che denota talvolta una passiva accettazione di carismi morali. In questo senso, dunque, anche l’ascesi come santità si propone a seguito di una degenerazione della civilizzazione attuata per mezzo del cristianesimo, è il pharmakon dolceamaro delle Stimmungen o energie psichiche cristiane.
L’ascesi è dunque strumento utile o dannoso per Nietzsche? Se stimata «in quanto modalità di gestione della propria potenza» essa sembra avere un ruolo positivo nella comprensione di una sofferenza che insegna, è benefica; in tal caso essa è fenomeno atemporale, cioè estrapolato dalle dinamiche storiche di civilizzazione che sottendono culture e religioni diverse. Nei frammenti postumi si legge di un’ascesi come preservazione dalla barbarie della civiltà: qui si fa pratica oppositiva, di segno greco, contro un regime infiacchito e manipolatorio. «Preparazione ascetica» diventa lo stigma di un’autoconservazione rude, ma quanto mai raffinata in una cura di sé rivolta a esasperare il tono arrendevole delle ascesi religiose, che segnano non altro che il travasamento dell’individuo in un’assuefazione a un possibile dettame oltremondano. Il cristianesimo si presenta, infatti, a sua volta, come una forma di preservazione, un’immunizzazione dalle passioni che fa dell’esercizio e dell’autocontrollo una tattica di depotenziamento. La definizione di ascesi in Nietzsche sembra quindi palesarsi come una corda tesa tra due pilastri, tra il l’infrollimento e il depauperamento delle energie di tipo religioso e l’auto-affermazione di una volontà di potenza estrorsa, esuberante, che tenta il raffinamento della propria energia in tracimazione. Si tratta in fondo di un fenomeno unitario, ma stirato tra due poli, i quali, agli antipodi, non possono che decifrare questa medesimezza in modo diverso, generando dunque, nello stesso Nietzsche, l’esplosione della miriade di significati che di volta in volta la pratica ascetica assume. Entrambi i versanti approcciano verso una esternalizzazione dell’individualità, ovvero verso la perdita dei tratti sintomatici della parzialità delle visioni singolari, riversate piuttosto in un’aspettativa “alle spalle” del mondo e della vita, nei casi di una certa ascesi religiosa, e “al di là” di principi morali e dettami metafisici, al di qua del corpo e della volontà, in Nietzsche. Per quest’ultimo, essa vale come l’applicazione di una forma di soggettivazione de-soggettivante, in cui non un io singolo e individuale è sostrato, ma un cosmo di relazioni e rimandi, di ritorni e re-individualizzazioni. Anche la solitudine, ulteriore tematica ascetica, si rispecchia in questo parametro: essa non rappresenta una chiusura idiotistica, ma la comprensione di un senso comune che non è né sociale né religioso, ma che, intersoggettivamente e de-soggettivamente, è cristallizzazione della volontà.
La questione del soggetto, con cui si era aperta questa disamina, sembra dunque ripresentarsi in chiusura, con quanto ne spiega le implicazioni e le genealogie che lo precedono: «per Nietzsche sono gli istinti a essere i soggetti e non quello che noi riteniamo essere normalmente “il” soggetto, vale a dire il nostro Io razionale» (p. 70). Il soggetto della potenza, nel senso bidirezionale del genitivo, è il frutto del gioco di maschere tra ascesi, istinti e soggetto: questa una delle più pregnanti cognizioni di un esercizio ludico e mai definitivo in Nietzsche, che Lucci offre tra molte intuizioni acute di questo libro, le quali meritano un’attenzione sia per l’originale – e complicata – espressione del tema a partire da questo autore, sia per un’analisi che scandagli in sé il già plurivoco fenomeno ascetico.
di Annamaria Pacilio
-
Psicoanalisi Queer Manifesto
Recensioni / Dicembre 2021Nella convinzione che non sia sostenibile una scrittura impersonale e non situata, chi scrive in questa sede lo fa da una posizione di soggettività queer e di adesione a un certo quadro epistemologico, quello di una psicoanalisi queer fin dai suoi quattro concetti fondamentali: l'inconscio, la ripetizione, il transfert e la pulsione.
Che si possa fare una psicoanalisi rigorosa, sia in sede teoretica che clinica, aderendo alla filologia lacaniana (se ce n’è una!) e al contempo attestandone il fondamento queer, lo mostra il saggio Queer Psychanalyse: clinique mineure et déconstructions du genre di Fabrice Bourlez (Éditions Hermann, Paris 2018), in traduzione italiana ad aprile per i tipi di Mimesis. Nella ricezione italiana dell’intersezione tra psicoanalisi e studi di genere, che si approssima al deserto concettuale, la scrittura di Bourlez colma una lacuna che non può persistere oltre. Una lacuna che ha prodotto effetti reali, attestati sia dal silenzio delle Scuole di Psicoanalisi impegnate in querelles lontane dalla causa analitica intesa come causa del desiderio, sia dai disagi soggettivi degli analizzanti che nei cabinets dei propri analisti non trovano risposta alle urgenze della contemporaneità e dei propri corpi.
Aspettando di leggere l’edizione italiana, diamo un occhio allo stato del terreno su cui andrà a installarsi. Da una parte, troviamo la proposta teologica del nostro pastore lacaniano Massimo Recalcati, fondata sul binomio Bibbia-Psicoanalisi, su una solida retorica del sacrificio? e su una speranza di guarigione dal sintomo che si approssima alla grazia divina; il tutto affiancato da una lettura delle tavole della sessuazione (Seminario XX) marcatamente binaria ed etero-patriarcale, poiché la sua intera opera risulta pervasa di dicotomie manichee e attestazione di differenze uomo-donna strutturanti, presuntamente fondate nella logica dell’inconscio: il queer non è chiaramente passato di qui. La carica di potere e autorità di cui gode il controtransfert dell’analista è – non esageriamo – quella di un dio, possibilmente maschio e paternalista, incarnato, e qualsiasi tentativo di rivendicare una psicoanalisi costitutivamente laica nei suoi fondamenti viene “punito” con scomuniche.
Differentemente, lo psicoanalista presentato da Bourlez è una figura etica, nel senso di un essere di desiderio, la cui consistenza non è l’autorità ma l’erratica, fallimentare e sempre eccentrica movenza del desiderio. Un analista che porta dei tacchi, coi quali gioca, cade, gode, performando la propria instabilità. Il tallone d’Achille, ossia la debolezza, il difetto, della psicoanalisi, diventa les talons hautes: i tacchi alti su cui essa svetta, solo a condizione di traballare e di poter cadere da un momento all’altro (pp. 142-44). La clinica di Bourlez ci permette di opporre al pugno duro del soggetto che è supposto sapere perché sa, o perché ha la presunzione di sapere, il tatto di chi abdica alla propria funzione e la decostruisce, limitandosi – eticamente – a occupare una posizione, che è quella del desiderio. Ecco dunque un primo punto per cui Queer Psychanalyse può portare buone notizie al neo-lacanismo italiano, arroccato in una condizione di neo-lacanismo classico, rigidamente milleriano e consacrato all’Uno: l’Uno dell’Unico Lettore (Miller fu così nominato da Lacan), l’Uno de La (Signora) Psicoanalisi, l’Uno del godimento masturbatorio di una pratica che, volendosi una, si vuole sola. Il caposaldo del neo-lacanismo L’Uno-tutto-solo di Jacques-Alain Miller conteneva a sua insaputa una profezia: la solitudine. Ma più che versare lacrime su un neo-lacanismo classico solo e moribondo, dobbiamo condannarne la violenza sistemica, che ha adoperato nella precisa scelta di escludere le psicoanalisi. Le psicoanalisi critiche, cliniche, decostruttive, che lo hanno minacciato con la loro alterità, costitutiva peraltro della sua materia-principe: l’inconscio che è discorso dell’Altro.
Queer Psychanalyse propone dunque non solo una clinica minore, ma minorizzata (minorisée), perché costretta dalla violenza padronale di un’esclusione a esprimersi dal margine. Ricorrendo a una metafora derridiana, possiamo dunque parlare della psicoanalisi diffusa – quasi con atteggiamento coloniale – da Miller come di un neo-lacanismo bianco, laddove “bianco” non (solo) indica il parlante in questione come maschio bianco cisgender eterosessuale ma soprattutto il tentativo di occultare dietro una supposta neutralità del discorso psicoanalitico (che non è mai neutrale, ma immediatamentepolitico) la messa a tacere, colpevole, violenta e intrinsecamente escludente, delle minoranze queer e trans. Bourlez ripristina un uso politico della psicoanalisi sottraendo l’uno-per-uno, l’esercito degli uni-tutti-soli, alla masturbazione paranoica del lettino, e riconsegnandoli alla specificità delle rivendicazioni del loro desiderio, che è passata attraverso il sangue di Stonewall e il “martirio” dei sieropositivi (cfr. pp. 37-38). Altra frontiera che Bourlez apre è il confronto con le teorie femministe, in particolare un urgente Butler con Lacan “Qu’y a-t il entre nous”? La linea che la nostra recensione persegue, riguardo l’imminente ricezione italiana di una psicoanalisi queer, non può che sostare su un fenomeno perlomeno bizzarro che ha colpito il neo-lacanismo: esso consiste nel dare centralità al godimento de la donna millantando un femminismo che non ha rapporto con alcuna delle quattro ondate femministe e che è avulso da rivendicazioni storiche e militanti. Insomma, un “puro” femminismo psicoanalitico, condotto – di nuovo – in solitudine sul lettino, una-per-una, combattendo coi propri fantasmi e accedendo a un godimento tanto singolare quanto innominabile, al di là del fallo: una vera deriva mistica.
La razionalità, il rigore, la logica radicale dell’inconscio – ben illustrata da Matte Blanco nel suo Saggio sulla bi-logica – sembrano rigettare questi accostamenti teologici e mistici, che non solo ridicolizzano l’impresa freudo-lacaniana ma occultano nuovamente la posizione del “chi parla” (né dio, né un al di là di…, ad esempio del fallo). Fortunatamente per noi, Bourlez corregge il tiro ricordandoci che tale godimento singolare (jouissance) può essere pronunciato perché l’esistenza di una comunità militante lgbtqia+ l’ha consentito, e decenni di lotte gay hanno fatto sì che l’innominabile assuma nomi, posizioni e colori di un arcobaleno, attraverso atti di nominazione del suddetto godimento, come il coming out: “sono psicoanalista e gay. L’ho detto, lo ripeto e ci ritornerò. Sarà meglio che vi abituiate” (cfr. p.19, trad. mia). In questo senso, anche l’ascolto (l’Ouïr) dell’analista deve essere un queer-ouïr. Bourlez gioca sulla medesimezza dei due fonemi, a cui aggiungerei jouir, per cui queer ouïr c’est jouir, l’ascolto queer è una forma di godimento: un ascolto in modo sempre già deviante, non coincidente con sé stesso, che diventa-altro e apre da dentro il fuori che rende i quadri clinici non chiudibili, infinitamente eccentrici, per far evolvere in maniera autenticamente critica i concetti fondamentali dell’inconscio. È quel che si intende con psicoanalisi open to revision, aperta alla revisione costante della sua prassi, e in questo senso inclusiva delle minoranze e spazio safe. In Francia i nomi per definirla proliferano: psychanalystes homosexuel.le.s, psylesbiennes, psy gay.e.s, homoanalystes, psy safe inclusif, analystes mineur.e.s, psy queer.
In questi spazi non aleggia il fantasma eteronormativo dell’analista uomo la cui analizzante è donna, con la presunzione maschile da parte del primo che vi sia tra i due un potenziale o un rischio di seduzione.
L’urgenza di far circolare in Italia Queer Psychanalyse di Bourlez deriva anche dall’errato confronto che è stato instaurato tra psicoanalisi lacaniana, femminismi e queer studies allo stato attuale del dibattito: pensiamo a testi come L’essere e il genere. Essere uomo/donna dopo Lacan della filosofa e psicoanalista lacaniana Clotilde Leguil, che ha messo per iscritto qualcosa che non esito a definire come una catastrofe del queer. Il modello di “essere donna” che Leguil propone consiste nel “godere della propria esclusione”, atto che dalla prospettiva di Bourlez sarebbe insostenibile. Per Leguil essere donna, oltre che essere esclusa e, paradossalmente, goderne, significa “confrontarsi con la follia”, e “godere di un’inesistenza per arginare la propria mancanza a essere”. Questi brevi estratti si affiancano a una ricostruzione storica semplicistica e a un’opera permeata, fin dal titolo, di una logica identitaria e binaria. Il binarismo è affermato fin dalla contrapposizione delle due opposte letture del concetto di “gender”, da parte degli studi di genere e della psicoanalisi: per i primi il gender sarebbe un’“artiglieria pesante”, una “gabbia che paralizza l’essere”, da abolire; per la seconda sarebbe il “soffio vitale dell’essere”, la possibilità più propria del soggetto, il quale “rincorre il genere per cogliere e raggiungere qualcosa del suo essere”. Correggere il tiro rispetto a questi quadri teorici fallaci sull’intersezione tra psicoanalisi e gender studies sembra essere per Bourlez un preciso dovere morale: nel suo saggio mostra che attestare l’esistenza di un punto di impossibilità tra La Psicoanalisi e il Queer è un gesto deliberato di occultamento, quello di un pensiero straight, per dirlo à la Wittig, di una precisa matrice eterosessuale che si dà come discorso maggioritario e maggiore: un discorso che silenzia i punti di espressione delle letterature minori, quelle che spingono la lingua al limite facendo tremare la grammatica maggioritaria. Maggiore e minore sono due modi possibili di leggere il testo lacaniano. Bourlez lo mostra anche con le dibattute tavole della sessuazione del Seminario XX, Ancora: uno schema bipartito che distingue il modo di godere fallico da quello femminile, col rischio di creare due universali che governano due logiche differenti, e dunque di riprodurre la differenza dei sessi. Il due è l’unico a priori della sessuazione o possiamo porre, già trascendentalmente, n-sessi, n eccezioni singolari a una legge piena di buchi, che fa acqua da tutte le parti? Attenersi alla binarietà dello schema non ci rende complici di una costruzione culturale ancora intrinsecamente dualista? Leggere le tavole in modo minore significa, invece, sessuare in modo queer, non prima di esser passati da Butler e Fausto-Sterling, intersecando la psicoanalisi con la storia del femminismo e della biologia. Significa intendere i sessi come un continuum e come i colori di un prisma (p. 281), a partire da nient’altro che i corpi (chiaramente significanti e sessuati), dalla loro innata biologia della complessità e della diversità, fino a includerne quel punto tanto imprendibile quanto matematico che è il Reale di ciascuno.
Il saggio di Bourlez ha un andamento decostruttivo: in cinque capitoli, vengono ripensati, in-fondati e reintegrati i fondamenti della pratica analitica. Nel primo, Bourlez sostiene di dover dé-faire l’analyse: e così ri-farla. Per disfare un’analisi, serve scrivere, resistere, fare in un certo senso e a proprio modo coming out (pp. 9-15). Nel secondo, manda in rovina l’Edipo: lo mantiene come osso fondamentale dell’analisi e come contenuto dell’inconscio, ma aprendolo a delle possibilità; ossia che ci siano n-sessi coinvolti nel teatrino edipico e che ci sia un necessario al di là dell’Edipo (pp. 94-98). La sorpresa è che la decostruzione dei generi non viene da un’integrazione, ma da una lettura radicale del testo freudiano stesso.
Bourlez prosegue tematizzando un atto nuovo, quello di performare l’omo-analista: nel terzo capitolo si chiede se i cabinets di Freud e Lacan fossero degli spazi che col lessico di oggi definiremmo safe, o ancora gay-friendly. Perché Dora fugge dopo sole tre settimane di analisi? (pp. 148-153) Perché le diagnosi di isteria spesso celano l’omosessualità femminile dietro la seduzione dell’analizzante per l’analista uomo, investito libidicamente come padre? (p. 147). La migliore sovversione che le isteriche abbiano potuto attuare nel discorso analitico è consistita nell’averlo fatto cessare. Dopo averlo inconsciamente istituito coi propri sintomi, se ne sono sbarazzate. Come? Andandosene. Rispettivamente nel Frammento di un’analisi di isteria (caso Dora) e in Psicogenesi di un caso di omosessualità femminile (caso della giovane omosessuale) “le due donne hanno buttato via il trattamento e le interpretazioni freudiane che lo accompagnano. Le sue manie d'interpretazione del sesso da parte del Padre le hanno fatte inorridire. Sono scappate. Lo hanno lasciato da solo con le sue pipe, le sue statuette e il suo divano” (p. 149).
I successivi capitoli sono dedicati a due precise operazioni politiche: l’inversione dell’etero-sessimo e l’apertura di un al di là della differenza dei sessi (ben diverso dall’al di là del fallo), per smontare le mosse che governano, in ogni nostra terapia individuale, quella che Bourlez definisce la micropolitica dell’atto analitico.
Perché leggere Queer Psychanalyse in Italia e farne, al contempo, il point de départ e il point de capiton del dibattito psicoanalitico contemporaneo? Per farla finita col verbo lacaniano come “sacra scrittura” da riconsegnare alla corretta filologia definitoria, e dunque con le derive teologiche e paranoiche che esso incarna, reiterando il discorso del padrone. Per de-feticizzare la Grande Psicoanalisi intesa come sola e unica soluzione al sintomo, sostituendola con la proliferazione di psicoanalisi queer, transfemministe e decostruttive. Il senso delle psicoanalisi, inteso qui come il loro desiderio, alla luce del saggio di Bourlez, non è l’indagine su un presunto “solo” godimento, ma il re-inquadramento dei modi di godere in un’analisi politica affiancata a un’epistemologia critica della sessuazione. Solo così potremo interrogare preliminarmente la scena eterosessuale, smascherarla nei suoi statuti oppressori e violenti, individuare i modi di vivere maggioritari e incarnare le nostre resistenze soggettive nelle grammatiche che non scegliamo di abitare, aprendo nuove possibilità di sessuazioni queer.
di Sara Fontanelli
Bibliografia
F. Bourlez, Queer Psychanalyse. Clinique mineure et déconstructions du genre, Éditions Hermann, Paris 2018.
J. Derrida, La mitologia bianca (pp. 275-349), in Id., Margini della filosofia (1972), Einaudi, Torino 1997.
J. Lacan, Il Seminario. Libro XX. Ancora (1972-1973), Einaudi, Torino 1983.
C. Leguil, L’essere e il genere. Essere uomo/donna dopo Lacan, Rosenberg & Sellier, Torino 2019.
J.-A. Miller, A. Di Ciaccia, L’Uno-tutto-solo. L’orientamento lacaniano, Astrolabio, Roma 2018.
-
Lacan con Kant
Recensioni / Ottobre 2020Se si vuol comprendere la posta in gioco del pensiero di Gilles Deleuze, ci sono due luoghi da frequentare, strettamente connessi e corrispondenti in buona sostanza alle sue due grandi opere teoriche degli anni ’60 (Differenza e ripetizione e Logica del senso): nel primo troviamo il progetto di un “empirismo trascendentale” o “superiore”, che non ricalchi più, come nel criticismo kantiano, le condizioni di possibilità della conoscenza sugli atti empirici della coscienza, ma che ci permetta di cogliere in se stessa la genesi trascendentale della differenza, ossia di “ciò per cui il dato è dato” (Deleuze 1997, p. 287). Nel secondo possiamo apprezzare il modo in cui Deleuze cerca di mettere in atto questo progetto, tramite la nozione-chiave di evento: dalla correlazione soggetto-oggetto – vera e propria impasse su cui si è incagliata buona parte del pensiero moderno – si può uscire, sembra dirci Deleuze, mostrando come la ragione trascendentale di entrambi si trovi proprio in una dimensione evenemenziale, ossia in quel vettore che dà conto da un lato di ciò che accade concretamente nella realtà, dall’altro dell’atto processuale che ha portato alla sua stessa realizzazione. L’evento possiede infatti per Deleuze una “struttura doppia”: è tanto “incorporeo” (trascendentale), slegato dalle sue concrete effettuazioni spazio-temporali quanto “incorporato” (empirico), incistato nella singolarità di ogni sua reale occorrenza (Deleuze 1975, p. 135).
Alessandra Campo, in Fantasma e sensazione. Lacan con Kant (Aesthetica Preprint, 2020) si inserisce nel progetto disegnato da Deleuze, percorrendo però una via che potremmo definire laterale. Pur appoggiandosi all’opera deleuziana, Campo tenta di mostrare come l’esigenza di un empirismo trascendentale – di una scienza compiutamente trascendentale del sensibile – abiti alcuni luoghi decisivi della filosofia kantiana e della psicanalisi lacaniana. Si tratta di una prospettiva originale, per almeno due motivi: in primo luogo perché ci costringe a ritornare analiticamente al criticismo kantiano, con cui l’autrice ingaggia un vero e proprio corpo a corpo, mostrandone la straordinaria attualità; in secondo luogo – e soprattutto – perché, ben al di là di un semplice confronto (ormai fin troppo percorso) tra filosofia e psicanalisi, tenta di avvicinare il progetto kantiano – a prima vista così saldo nella sua ricerca della certezza epistemica – alla prospettiva lacaniana, forse troppo frettolosamente autocertificatasi come anti-filosofica. In altri termini, come sembra emergere tra le righe del testo, se è vero che nella domanda kantiana intorno alla conoscenza si può intravedere in controluce un percorso in direzione dell’inconscio, nel reale lacaniano assistiamo altresì a un profondo sforzo speculativo volto a ghermire la genesi della realtà.
Al centro del saggio troviamo l’analisi della sensazione secondo Kant; appoggiandosi in particolare alle letture di Luigi Scaravelli (Scritti Kantiani) e Tommaso Tuppini (Kant. Sensazione, realtà, intensità), Campo mostra come per analizzare a fondo il senso dell’estetica kantiana non ci si debba affatto confrontare, come ci si dovrebbe aspettare, con l’omonima sezione della Critica della ragion pura, quanto piuttosto con quella dedicata alle Anticipazioni della percezione (p. 19), pagine non a caso definite da Deleuze “straordinarie” (Deleuze 2004, p. 81). Qui Kant analizza infatti la sensazione ben prima della sua trasformazione – mediante il decisivo ruolo delle intuizioni – in percezione spazio-temporalmente localizzata, mostrando innanzitutto la sostanziale passività del soggetto, affetto e modificato da un fuori a-dimensionale. Nelle Anticipazioni Kant ci mostra così il modo del tutto peculiare in cui i sensi pensano (p. 57), un modo intensivo che costituisce una sorta di tertium nella distinzione tra fenomeno e noumeno. Per Kant “il reale che è oggetto di sensazione, ha una quantità intensiva, cioè un grado”: prima della realtà estesa, quantificata spazio-temporalmente e in seguito sintetizzata dalle categorie, vi è insomma un reale intenso, graduato e qualitativo, condizione trascendentale di ogni successiva operazione di sintesi.
Parente prossimo – se non omonimo – della sensazione è, secondo Campo, il fantasma freudo-lacaniano. Come la sensazione per Kant, anche il fantasma assurge a condizione trascendentale dell’esperienza. Formatosi come consolazione contro l’angoscia per l’interruzione di un primordiale stato di godimento, il fantasma, secondo il Lacan del Seminario VI, è un’istanza in grado di costituire il soggetto al tempo stesso proteggendolo dall’irruenza del reale. Compito del fantasma è allora quello – come la sensazione kantiana – di rendere la conoscenza possibile, eseguendo una traduzione o un transito tra il reale (intenso) che non è lingua e la realtà (estesa) che lo è (p. 45). Il fantasma, paradossale figura al contempo genetica e di frontiera, è allora, in senso heideggeriano, ciò che a un tempo maschera e rivela la natura dirompente del reale (p. 84). Così come ogni sensazione possiede un grado che permetterà la sintesi operata prima dalle intuizioni e poi dalle categorie, allo stesso modo il fantasma trova la propria condizione trascendentale nell’oggetto a piccolo, argine che impedisce al soggetto di svanire di fronte al reale (p. 86) e che innesca l’impresa conoscitiva.
Nella complessa analogia a quattro termini (sensazione e grado da un lato, fantasma e oggetto a piccolo dall’altro) è la relazione di transizione a fare da protagonista dell’analisi di Campo: tanto per la sensazione quanto per il fantasma si tratta – si è visto – di figure che permettono il transito da una dimensione condizionante intensa che esiste atemporalmente, ma che colpisce e dunque è sentita, a una dimensione estesa che accade, ma risulta inevitabilmente condizionata, derivata. È un passaggio che Campo descrive in vari modi: come “mediatizzazione” tra un “nulla d’origine” a partire da cui sorge il grado/a piccolo e un “nulla di destino” verso cui inderogabilmente si consuma (p. 80); come barra/frazione che genera i poli (esteso e intenso) di un campo (p. 98); come skia-grafie (scrittura d’ombra) che fa transitare la luce verso il buio (p. 51); come abbassamento del profilo cosale dallo choc alla rappresentazione (p. 100). Ciò che emerge è l’idea che esista “un altro modo di ricevere” (p. 19), ossia un modo differente di intendere la passività e l’aisthesis: non più come percezione spazio-temporalmente localizzata e rappresentabile, ma come choc o trauma tale per cui il soggetto viene modificato/toccato proprio là dove non sente e non vede (p. 51), sul crinale tra l’insensibile/impercettibile (a priori) e il sensibile (a posteriori). La sensazione e il fantasma si sviluppano insomma per caduta e annullamento del proprio grado di intensità nell’esteso: l’andare a 0 dell’intenso diventa così paradossale legge di sviluppo (p. 78). Nei più classici termini della metafisica occidentale, si può intendere tale passaggio come transito dall’essere effetto (modificato, colpito) all’essere causa (ossia percipiente).
A questo proposito, il testo di Campo risulta permeato da una polemica nei confronti delle pretese di oggettività proprie di ogni regime epistemico: se tutta la realtà oggettivamente conoscibile va ricondotta in ultima battuta alla sensazione, ecco riemergere l’inquietante quesito che aveva tormentato la filosofia moderna: ciò che garantisce l’esistenza empirica della realtà è la stessa istanza che ne sancisce la dimensione inevitabilmente soggettiva, in quanto modificazione della sensibilità (p. 47). Ciò significa che l’approdo ultimo della sensazione kantiana e del fantasma lacaniano va derubricato nella cornice di un solipsismo senza alcuna via d’uscita? Al contrario: il riconoscimento di un’embricazione costitutiva tra soggettività e oggettività nella conoscenza – discorso che riguarda tanto la psicanalisi quanto la filosofia – rilancia l’opportunità di un empirismo trascendentale, superiore e radicale, capace di ritrovare in una dimensione estetico-cosmologica la ragione stessa della correlazione soggetto-oggetto.
Fantasma e sensazione. Lacan con Kant è un testo che indaga questioni filosofiche profonde e fondamentali con un focus interpretativo efficace. Ha il pregio dell’ambizione e dell’assoluto rigore dell’analisi – specialmente per quanto riguarda la filosofia kantiana – e, forse, il difetto di un’eccessiva densità: l’importanza dei quesiti mobilitati e delle loro implicazioni risulta a volte implicita, a svantaggio in particolare di chi non avesse immediata dimestichezza con molte delle questioni affrontate. Si sarebbe altresì apprezzato qualche approfondimento ulteriore rispetto all’originale tema estetologico che emerge dalle analisi – ossia quello di un’estetica dell’aniconico o di una figuratività non-figurativa (p. 51) – che, tra Francis Bacon e Paul Klee, si sforza incessantemente di rendere visibile l’invisibile. Ciononostante, il saggio di Campo è un riuscito tentativo di afferrare con le armi della speculazione filosofica e in un modo decisamente poco battuto il problema della sensazione e del fantasma. Al di là della doppia neutralizzazione, secondo cui essi sono, nella migliore delle ipotesi, una sorta di trasparente pharmakon propedeutico a più alte e “libere” forme di cognizione oppure, nella peggiore, mera illusione da correggere con i metodi quantitativi della scienza (psichiatrica o fisica), Campo ci mostra in che modo i sensi e l’inconscio “pensano”, cioè – in senso whiteheadiano – esibiscano una qualità (e una logica) che precede la loro “prima quantificazione” (p. 15); soglie atopiche e atemporali capaci di realizzare il campo della conoscenza, essi, proprio nei termini dell’evento secondo Deleuze, non smettono di insistervi.
di Giulio Piatti
-
Micoland: l’ordine nascosto dei funghi
Recensioni / Settembre 2020Secondo la filosofa e storica della scienza Donna Haraway, la lotta per un mondo più vivibile si combatte anche sul terreno della natura e dei suoi significati. Se tradizionalmente il pensiero femminista si è impegnato attivamente nel condannare i resoconti scientifici del mondo come sostanzialmente ideologici, impegnandosi in un lavoro di decostruzione che ne smascherasse i presupposti storico-culturali impliciti ad essi inestricabilmente connessi, per Haraway il campo della scienza è tuttavia soprattutto un campo di significati contestati e contestabili, aperti e dinamici. In esso alcune storie e metafore, lungi dal legittimare sistemi di oppressione, di sfruttamento e ordinamenti gerarchici del mondo, possono invece ampliare il nostro modo di pensare e immaginare, fungendo così da alleate nella lotta per la costruzione di un mondo più vivibile e giusto. L’ordine nascosto. La vita segreta dei funghi (Marsilio, 2020) di Merlin Sheldrake è un serbatoio di storie e metafore potenti, da questo punto di vista.
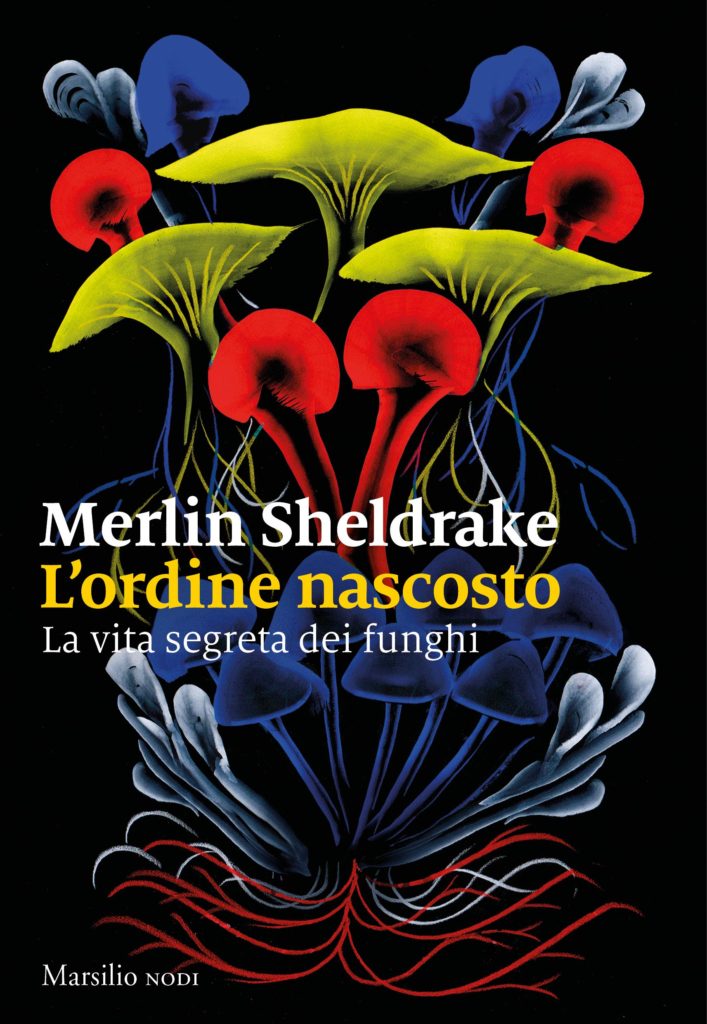
I funghi di cui ci parla Sheldrake sono, dal punto di vista concettuale, importanti strumenti in grado di mettere in crisi alcune categorie normalmente considerate auto evidenti. In particolare l’importanza teoretica e filosofica di questo saggio sta nel rimettere radicalmente in discussione la nozione classica di individuo-soggetto-uno prendendo le mosse direttamente dall’analisi delle caratteristiche costitutive di una particolare gamma di viventi. Un’operazione già sviluppata nell’ambito della microbiologia dove la nozione di individuo è stata, in vari contesti, potentemente trasfigurata fino a espandersi e trasformarsi a tal punto da divenire irriconoscibile: con essa alla biologia degli organismi viventi si è sostituita l’ecologia delle loro relazioni e interdipendenze. «Siamo ecosistemi composti – e decomposti da un’ecologia di microbi il cui significato solo da poco tempo ha cominciato a venire alla luce» (p. 28) scrive l’autore a proposito. In tal senso i funghi di Sheldrake emergono come esseri intrinsecamente relazionali, portando alla ribalta il concetto di simbiosicome categoria biologica centrale. Un ruolo importante, nel portare al centro del discorso biologico questa categoria, va attribuito alla biologa americana Lynn Margulis e alla sua teoria endosimbiotica, secondo cui la simbiosi avrebbe avuto un ruolo cruciale nell’evoluzione delle prime forme di vita: in particolare, le cellule eucariote sarebbero il risultato di un’unione poi stabilizzatasi tra organismi diversi. Se i funghi emergono dal testo di Sheldrake come organismi in grado di confondere confini netti, proprio per la natura del suo oggetto, il testo di Sheldrake deve uscire dallo specialismo e tracciare un “discorso più ampio”, che porta necessariamente l’autore a costruire relazioni di mutuo scambio accademico, a interfacciarsi con studiosi appartenenti ad altri campi disciplinari, a praticare incursioni in altri ambiti dando vita a un «movimento bidirezionale di informazioni e risorse» (p. 269) che traccia una rete complessa.
Al centro di testo di Sheldrake non ci sono soltanto i funghi in quanto specie: ma anche e soprattutto le simbiosi, le connessioni imprevedibili, gli intrecci e le reti complesse che questi possono generare. Vengono prese in considerazione le articolate reti di relazioni che il tartufo instaura con la sua comunità di microbi, con il terreno e con il clima in cui vive, da cui emerge il suo aroma caratteristico, risultato inoltre di un processo evolutivo che l’ha portato a rispecchiare i gusti animali, a farsi ritratto odoroso delle loro passioni perché questi potessero essere veicolo alla dispersione delle spore (p. 38). Un altro esempio è costituito dai licheni, secondo alcune ipotesi scientifiche risultato della simbiosi tra un’alga e un fungo, relazione frutto di un processo evolutivo che ha consentito a entrambi di adattarsi e popolare ambienti altrimenti inospitali e proibitivi. In tutti questi casi i funghi emergono soprattutto come organismi in grado di destrutturare categorie prestabilite e confini netti, come reti dinamiche di relazioni trasformative.
Ciò che viene messo fortemente in evidenza, infatti, è la complessità irriducibile delle relazioni e degli intrecci che i funghi instaurano e nei quali sono coinvolti. La stessa “dual hypotesis”, secondo cui i licheni sarebbero il risultato di una simbiosi tra un fungo e un’alga, è già stata ampiamente problematizzata da alcuni studi che hanno mostrato come gli attori coinvolti siano di più, le relazioni contestuali e fondamentalmente irriducibili a uno schema fisso (p. 114): da questo punto di vista l’identità dei licheni emerge più come una domanda che una risposta già nota, e questi si configurano come «sistemi dinamici più che un elenco di componenti che interagiscono tra loro» (p. 115). I licheni sono relazioni aperte in quanto il reticolo miceliare, ossia ciò che costituisce il “corpo” del fungo, si configura come processo più che cosa. I funghi emergono quindi come organismi viventi e dinamici, al punto che per Sheldrake si potrebbe parlare del reticolo miceliare, il corpo metamorfico e sempre provvisorio del fungo, come traccia della sua storia, del suo sviluppo continuo, sempre imprevedibile e contestuale. L’“indeterminismo comportamentale” che caratterizza il reticolo miceliare fa si che non si possano dare due reticoli identici e porta ad adottare metafore per descrivere i funghi che ci consentono di evitarne la reificazione, preservandone l’identità aperta e provvisoria. A questo proposito Sheldrake parla del micelio come di una “melodia” polifonica, irriducibilmente molteplice e plurale e delle ife, le cellule che lo costituiscono, come di flussid’incarnazione, processi in divenire senza pianificazione centralizzata da cui però emergono forme.

La stessa nozione di simbiosi viene ulteriormente trasfigurata e ampliata nel testo di Sheldrake, connessa al concetto di trasmutazione e metamorfosi. La capacità dei funghi di rendere ambigui i confini tra individui emerge in questo caso come potere di confondere i confini tra specie: Sheldrake riporta l’esempio del fungo Ophiocordyceps, capace di prendere “possesso” del corpo e della mente di una specie di formica, al fine di riprodursi diffondendo le spore. Quest’esempio particolare di simbiosi assomiglia per Sheldrake a un vero e proprio caso di possessione, in cui la formica diventa fungo, uscendo dai binari della propria storia evolutiva e cominciando a percorrere quelli dell’Ophiocordiceps (p. 134). Facendo riferimento al concetto di fenotipo esteso, coniato dal biologo Richard Dawakins, è possibile dare conto scientificamente di questa trasformazione e di questo mescolamento: con esso si fa riferimento al fatto che il genotipo non fornisce soltanto le istruzioni per costruire un organismo biologico, ma regola anche il comportamento. Attraverso quest’ultimo, proprio come un uccello costruendo il proprio nido esprime “esteriormente” i propri geni, il fungo si “travasa” nel mondo esterno, rendendo ambigui e confondendo profondamente il confine tra sé e altro. Richiedendo senza dubbio un certo sforzo immaginativo al lettore, Sheldrake propone un’analogia coraggiosa: così come la formica è manipolata dal fungo al punto da diventare fungo, da deviare dalla propria storia evolutiva per incrociare quella di quest’ultimo, è possibile considerare le esperienze stranianti e di ampliamento della coscienza prodotte sulla nostra mente dalla psilocibina, principio attivo dei funghi psichedelici, come incursioni del fungo nell’umano. È possibile pensare, con le parole dell’autore, che i funghi psilocibinici «indossino la nostra mente come l’Ophiocordiceps e la Massospora indossano il corpo degli insetti» (p. 141). Il punto di vista che ci offre l’autore pone l’accento sulla lunga storia delle relazioni tra esseri umani e funghi psilocibinici: più che considerare le loro storie evolutive come nettamente separate, l’operazione del testo consiste nell’invitarci a considerare l’intrecciarsi della storia evolutiva dei funghi con la storia culturale umana e il loro reciproco influenzarsi. Considerando la storia e la cultura legata alla psichedelia, e il modo in cui questa ha influito sulla storia evolutiva dei funghi, sul modo in cui si sono diffusi e sono stati coltivati, su come certe specie sono state preferite ad altre, siamo invitati a leggere questa come un rapporto di reciproco addomesticamento, piuttosto che una relazione a senso unico. Il ribaltamento di prospettiva che offre il testo è potente: non solo gli esseri umani hanno interferito con la storia dei funghi, coltivandoli, ma questi ultimi hanno “preso in prestito”, indossato e modificato la coscienza e la storia umana.
Non soltanto sulla storia umana i funghi hanno lasciato un’impronta e hanno interferito di più di quanto siamo soliti considerare, ma hanno avuto un ruolo importante anche nella storia evolutiva delle piante e dell’ambiente terrestre in generale. Se le piante sono riuscite a popolare la terraferma, dandole la configurazione che oggi conosciamo, ciò è avvenuto perché le loro antenate acquatiche, prive di radici, hanno stretto un’alleanza poi stabilizzatasi con i funghi. Questi ultimi hanno quindi funto da “radici” primitive, consentendo alle antenate delle piante terrestri di procurarsi acqua e nutrienti dal terreno, instaurando con queste relazioni di reciproco scambio. Una traccia di queste antiche associazioni è offerta dalle relazioni micorriziche, che ancora oggi i funghi stabiliscono con diverse specie di piante. L’importanza di queste relazioni è tutt’altro che secondaria: oggi più del novanta per cento delle specie di piante dipende dai funghi micorrizici. Le relazioni micorriziche hanno stimolato fortemente l’immaginazione di biologi e botanici, dando luogo a una vera e propria fioritura di metafore. Per descriverle, si parla di «mutualismo», ma anche di «relazione conflittuale e parassitaria mascherata» (p. 162). Altri biologi parlano di un equilibrio di potere che mantengono il fungo e la pianta all’interno della relazione, sottolineando come questa possa essere considerata alla stregua di un commercio, in cui nessuno degli attori coinvolti ha il controllo totale della relazione, ma ciascuno deve stringere compromessi e accordi. Secondo quest’ultima prospettiva, ci troviamo di nuovo di fronte a una relazione aperta: funghi e piante ereditano la capacità e la tendenza ad associarsi, ma la mettono in pratica in forme sempre nuove e rinegoziate, strategiche, imprevedibili e irriducibili a uno schema fisso. A questo proposito può essere trasferito ai funghi il termine inglese entangle, utilizzato per descrivere il nostro coinvolgimento in situazioni sociali mutevoli e complesse. Al di là delle diverse metafore con cui si è cercato di cogliere le relazioni micorriziche, risulta indubbia la centralità che i funghi hanno avuto nell’influenzare la storia passata e nel fare quella presente e futura del nostro ambiente. Secondo una logica che potremmo definire ecologica, le relazioni micorriziche hanno avuto un ruolo fondamentale nell’evoluzione di gran parte delle forme di vita terrestri (p. 166). Per descrivere queste forme di coinvolgimento profondo, alcuni biologi hanno proposto di utilizzare, al posto del termine evoluzione, che letteralmente significa “svolgere”, l’uso di involution, nel senso di coinvolgimento e partecipazione: con questa parola si riesce forse a rendere meglio il complesso intreccio di attrazione e repulsione che caratterizza le varie forme di convivenza che costruiscono gli organismi.
Se le relazioni micorriziche hanno dato un forte impulso alla produzione di metafore in biologia, ancora più potente da questo punto di vista è stata la scoperta del wood wide web: la rete sotterranea che attraverso i reticoli micorrizici crea un sistema di scambi, relazioni e condivisione tra gli alberi di una foresta. Le reti e i reticoli micorrizici condivisi hanno tutt’altro che una funzione accessoria: si possono invece paragonare a «sistemi circolatori condivisi» (p. 191) da un certo gruppo di alberi, secondo una prospettiva che invita a ripensare radicalmente gli ecosistemi forestali. Al paradigma del conflitto e della competizione come meccanismi chiave dell’evoluzione, la scoperta dei reticoli sotterranei condivisi ha consentito di sostituire metafore che enfatizzano la collaborazione e la distribuzione delle risorse all’interno di una comunità. Se l’immaginazione è stata stimolata al punto da portare a parlare, per quanto riguarda queste reti, della scoperta di “luoghi di cura”, di altruismo e cooperazione disinteressata in natura, Sheldrake ci invita a considerare invece le ambiguità che la nozione di rete porta con sé: così come internet ai suoi esordi è stata potentemente investita di fantasie romantiche e libertarie, come luogo a-gerarchico e orizzontale, per poi mostrarsi invece veicolo di relazioni di potere e di controllo, così le wood wide webs andrebbero considerate nella loro complessità e ambivalenza, come «amplificatori di interazioni»(p. 203). Ancora una volta il concetto su cui si insiste è quello di complessità: le reti di alberi costituiscono sistemi complessi adattativi, dinamici, caratterizzati da un ricambio costante e cangiante.

Se i funghi hanno avuto un ruolo centrale nel determinare il passato e il presente di numerosi ecosistemi, il loro protagonismo potrebbe addirittura crescere in futuro, soprattutto in relazione alla minaccia che i cambiamenti climatici rappresentano per la sopravvivenza di numerosi ecosistemi. Già in passato, i funghi hanno dimostrato grande capacità di sopravvivere e anzi di prosperare di fronte a mutamenti ambientali di grande portata: i funghi che decompongono il legno ebbero un ruolo importante nella transizione da un’epoca chiamata Carbonifero, in cui a causa dell’assenza di decompositori di lignina, il grande accumulo dei resti di alberi nel sottosuolo era stato causa di un importante cambiamento climatico. Proprio grazie alla loro capacità “decostruttiva” questi organismi hanno dimostrato capacità di sopravvivere alle devastazioni ambientali. Non soltanto la lignina, ma numerosi altri inquinanti possono essere digeriti e usati come fonte di sostentamento dai funghi: dai mozziconi di sigaretta ai pesticidi, a vari tipi di rifiuti agricoli, i funghi sanno trasformare vari inquinanti pericolosi per la vita umana e ripristinare ecosistemi gravemente danneggiati. Come sottolinea Sheldrake, i limiti relativi a queste pratiche di micorisanamento dipendono in larga parte dalla complessità di questi organismi: i funghi proliferano in modo irriducibilmente imprevedibile, così come il loro comportamento rispetto agli inquinanti rimane complesso. Il micorisanamento si configura come una forma di “digestione esterna”, o un’esternalizzazione di processi digestivi: un’associazione in cui organismi diversi intonano insieme una canzone metabolica che da soli non saprebbero cantare. In questa relazione, i funghi si configurano sia come tecnologie, che come partner degli esseri umani (p. 246).
Citando Donna Haraway, è importante capire «quali storie raccontano altre storie, quali pensieri pensano altri pensieri, quali sistemi sistemizzano sistemi» (fonte). Ciò che Haraway ci aiuta a mettere in evidenza, è come sia possibile rintracciare al di sotto delle diverse storie gli intrecci che le costituiscono. L’operazione al centro del testo di Sheldrake è soprattutto questa: mostrare, utilizzando resoconti scientifici del mondo, come storie che sembrano percorrere binari paralleli, come la storia evolutiva dei funghi, degli esseri umani e delle piante, siano invece un intreccio. Scavare nelle storie per disseppellire gli intrecci e le associazioni stravaganti che le hanno prodotte, fare emergere con forza, al di sotto della patina universalizzante e antropocentrica che predilige l’attore unico (l’essere umano, unico soggetto propriamente detto, e quindi unico attore e costruttore della propria storia, in un mondo di cose fondamentalmente inanimato e a sua disposizione) la pluralità degli attori coinvolti: queste sono le operazioni principali al centro del testo di Sheldrake. Molte importanti storie umane sono in realtà storie di associazioni e relazioni con i funghi, storie che portano alla ribalta attori non umani, attivi e coinvolti in una relazione bidirezionale quanto i loro partner umani. L’invenzione dell’agricoltura e i connessi processi di sedentarizzazione, potrebbero essere il frutto di una delle relazioni più intime che l’umano ha stretto con i suoi partner fungini: quella con i lieviti. È stato per i processi di fermentazione, per la produzione del pane e della birra che gli esseri umani hanno abbandonato il nomadismo: la svolta neolitica, e le trasformazioni legate all’agricoltura, possono essere considerate da questo punto di vista una risposta culturale ai lieviti, al punto che, secondo Sheldrake, in un certo senso, «siano stati i lieviti ad addomesticare noi» (p. 255). Così, come le storie umane rimandano necessariamente ad altro, le storie sui funghi ci portano altrove, a sconfinare in altri campi disciplinari per incontrare piante, alghe, ecosistemi forestali. L’effetto della narrazione del L’ordine nascosto è proprio questo: quello di farci deviare, mostrando come ogni storia rimandi in fondo a un’altra.
di Ambra Lulli
-
Lacan: una scienza di fantasmi
Recensioni / Maggio 2020In questo breve ma densissimo volume, Jacques Lacan, una scienza di fantasmi, (Orthotes 2019) Federico Leoni continua il suo lavoro di originale rilettura delle riflessioni di Jacques Lacan, facendo funzionare il complesso, monumentale e oscuro svolgersi del pensiero dello psicoanalista parigino come pungolo per costruire nuove possibilità di traiettorie teoriche. Infatti, questo libro non vuole essere tanto un testo d’introduzione a Lacan quanto la continua interrogazione e scavatura di alcune delle sue più importanti riflessioni. Un’indicazione sulla lettura del testo ci viene direttamente dall’autore alla fine del libro: “Questo è un libro insistente. Ogni capitolo mostra una stessa cosa, che si presenta ora come Uno, ora come tratto, ora come voce, ora come mana, ora come fantasma, ora come oggetto, ora come gesto, ora come miniatura, ora come ideogramma.” (Leoni 2019, p. 173). Questa “stessa cosa” che Leoni ci mostra in Una Scienza di Fantasmi è l’evento – sempre attivo – dell’insorgenza e dell’inscrizione che produce il continuo processo di soggettivazione. Il libro è, allora, una sorta di indagine sul “supporto” di questo processo, non ritrovato in un fondamento certo e stabile quanto definito e perciò perduto, ma in una materia fluida e inafferrabile che anima la soggettivazione sempre in atto. Cercheremo di riattraversare l’insistenza di questa “stessa cosa” attraverso due vettori in particolare: l’Uno e la perversione.
La struttura di questo libro è permeata da una modalità particolare, che viene in qualche modo rivelato verso la fine del libro: l’obliquità. L’obliquità, o inclinazione, è proprio quella del diwan, del lettino freudiano, residuo della regressione ipnotica (anticamera della psicoanalisi). Questa strana angolatura, caposaldo del metodo clinico psicoanalitico, viene applicata costantemente nel testo sul continuo torcersi del pensiero dei filosofi interpellati. Questo non significa che i filosofi (fra i più presenti troviamo Leibniz, Kant, Cartesio, Bergson e Deleuze) vengano interrogati sui loro fatti privati, ma che le loro teorie, in qualche modo, vengano rese “spurie”, inclinate e condotte verso nuove possibilità.
E non è un caso che nell’obliquità e nell’inclinazione ci stia anche la deviazione: infatti ciò che per eccellenza de-via in psicoanalisi è la per-versione, la negativa freudiana della nevrosi, ciò che modifica la rotta e batte strade nuove.L’Uno, rintracciato e moltiplicato in varie figure (come il mana, il gesto, la voce, l’oggetto), è il protagonista indiscusso di questo libro e ne è anche il ritmo, la scia continua che permette ai molti percorsi anche eterogenei dipanati dall’autore di scandirsi in maniera sempre più coordinata. E, in qualche modo, da un punto di vista letterario, si potrebbe ascrivere questo libro di filosofia al genere del picaresco: assistiamo infatti a un continuo peregrinare avventuroso di questo Uno, dalla psicoanalisi lacaniana ai vari pensieri filosofici indagati, fino all’arte e alla letteratura. Un’altra maniera di mettere a fuoco la centralità di questo Uno ce la suggerisce Leoni stesso attraverso l’altro protagonista di questo libro, il fantasma, paradossalmente più nascosto rispetto alla onnipresenza dell’Uno. L’Uno è il fantasma di questo saggio filosofico, nel senso che è la cornice che anima la sua struttura e attraverso la quale si determina un continuo assemblaggio fra psicoanalisi e filosofia.
L’Uno non è, però, una nozione priva di ambiguità e addirittura strane sorte di pregiudizi sia nell’ambito filosofico che in quello della psicoanalisi lacaniana, come nota Leoni stesso. Sul lato filosofico, nel testo si insiste su come l’Uno sia uno dei marchi dell’elaborazione filosofica sin da Platone e dal platonismo (in Plotino l’Uno trova il suo apice) e non a caso Leoni riprende il Parmenide di Platone che si interroga sull’Uno e il Moltepice (Leoni 2019, p. 103). D’altronde lo stesso Lacan a suo modo notava nel seminario XVI (La logique du fantasme, ancora inedito in italiano) che Platone e Plotino sono fra i pochi filosofi che non cadono nell’errore di sovrapporre Essere e Uno e che riescono a fornire una riflessione specifica su questa dimensione dell’Uno (Leoni 2019, p. 21). Nonostante ciò, secondo Leoni, “dell’Uno non ne è più nulla, nella filosofia, da un certo punto in poi, e salvo diramazioni preziose quanto isolate” (p. 6).
Sul lato psicoanalitico si può dire che il tema dell’Uno emerge in punti diversi dello svolgimento dei seminari lacaniani. All’inizio più che essere un Uno filosofico, l’uno lacaniano è l’eredità dell’einziger Zug (tratto unico o unario) del Progetto di una psicologia freudiano del 1895. Da qui Lacan inizia a elaborare la nozione di tratto unario, che definisce una visione dell’incidenza del significante a partire da un tratto traumatico originario e di “partenza” per l’identificazione e perciò soggettivazione (Seminario IX). Più tardi questo tratto unario assumerà forme differenti nel Seminario XVII subendo una torsione e divenendo S1, il significante padrone cui ci si identifica e da cui origina la catena significante. Solo a partire dal Seminario XIX Lacan (2011) inizia a porre la questione di un Uno filosofico-psicoanalitico, e lo fa confrontandosi soprattutto con Platone e la teoria degli insiemi di Cantor e Frege. Insomma, sembra che si passi da un uno dalla lettera minuscola all’Uno con la maiuscola. Quando Miller (2013) ripercorre le riflessioni di Lacan sull’Essere e l’Uno mette in luce come Lacan passi da una “ontologia” (o ancor meglio una para-ontologia) a una “henologia”, un discorso sull’Uno. Nella lettura milleriana l’Uno di questo Lacan è esemplificabile nella messa a fuoco della dimensione del “corpo che si gode”, narcisisticamente e autisticamente, che diviene sempre più centrale nella costruzione teorica lacaniana. L’immagine dell’Uno che si è andata a definire sempre di più nella psicoanalisi lacaniana è quella concentrata dalla formula milleriana dell’Uno-tutto-solo o Uno-senza-Altro, che rifugge dalla dialettica che si istituisce fra un soggetto e l’Altro, per richiudersi su sé stesso in un godimento sterile e “perverso”. Ma è proprio a partire da un’altra lettura della perversione che Leoni vuole riconsiderare filosoficamente la nozione di Uno psicoanalitico, con l’obiettivo di mostrarne una dimensione nascosta e ricavata proprio dalla elaborazione lacaniana.
La perversione, nell’ambito clinico lacaniano, viene spesso indicata come quella struttura per la quale il soggetto si colloca nella posizione di oggetto inscalfibile, scaricando sull’Altro l’angoscia generata in lui dalla divisione inferta nel soggetto dal linguaggio. Il perverso vuole dividere l’Altro, proiettare su di lui l’angoscia della castrazione che non intende sostenere su sé stesso addirittura arrivare ad angosciare Dio, l’Altro per eccellenza (Recalcati, 2016; Lacan, 2004).
Un altro modo di dire la questione della perversione (ed è a partire da questa altra angolazione che parte la riflessione di Leoni), non contraddicendo necessariamente le altre letture ma facendo emergere un lato “positivo-creativo”, è che il soggetto della perversione “comprende” la struttura e il funzionamento del linguaggio e che in qualche modo usi questa “competenza” riversandola sull’Altro. È in questo senso che, nella prospettiva della teologia psicopatologica paolino-lacaniana suggerita da Leoni nel primo capitolo, se il nevrotico vive nel dramma innescato dalla Legge e lo psicotico non riconosce, forclude questa dimensione della Legge, non accedendo completamente al Simbolico, il perverso conosce questa Legge per negarla e superarla, per andare aldilà di essa e collocarsi al posto di Dio (pp. 8-11). Il soggetto perverso si sistemerebbe nella posizione di colui che scrive, letteralmente crea la Legge, addirittura identificandosi con essa. In questa direzione, si può suggerire, a ulteriore chiarimento, l’immagine prototipica data dall’inserto filosofico-politico di Sade (autore caro a Lacan) all’interno della sua Filosofia nel boudoir. Qui viene messo in luce come il perverso conosca lo strumento della Legge e del suo istituirsi e come utilizzi questo sapere per creare e immaginare un nuovo tipo di società iperbolica, sebbene basata su principi razionali, macabramente illuministici e “formalizzati” su un piano giuridico-filosofico.
A partire da questo lato creativo della posizione soggettiva della perversione, Leoni ci interroga sulla possibilità di concettualizzare la filosofia non come un processo paranoico (la diagnosi che Freud aveva, a suo tempo, affibbiato, e con una certa logica, alla filosofia) di iperuniversalizzazione e astrazione, purificazione dei pensieri e dei concetti. Piuttosto l’autore ci spinge a immaginare la filosofia come un processo perverso, la messa in atto di una possibilità di continua scrittura e riscrittura creativa del pensiero e del mondo a partire dall’invenzione filosofica.
C’è qualcosa come un’altra perversione, qualcosa come un altro scatenamento del possibile, che quella costellazione di pensatori cerca di mettere a fuoco. Misurarsi con la morte di Dio significa misurarsi con quest’altra perversione, con quest’altro scatenamento del possibile. Nuovi possibili si rendono possibili, nuovi impossibili si disegnano a margine di quei possibili. […] [Il perverso] Si mette al posto di Dio, e crea i possibili, o dice che al posto di Dio non c’è nient’altro che questa incessante creazione dei possibili. (Leoni 2019 p. 79)
Infatti, si può dire che la scrittura leoniana di questo testo sia in un certo qual modo perversa, producendo deviazioni, scatenamenti e misurandosi con un’esplorazioni dei possibili. Nel quinto capitolo, Leoni si riallaccia, e non a caso, proprio alla figura di Bafometto (p. 85), principe infernale delle metamorfosi e idolo templare protagonista del romanzo del filosofo “perverso” Klossowski. Nel testo klossowskiano, infatti, si esplicherebbe una condizione di continua trasformazione e implicazione di “tratti dentro altri tratti”:
Ogni tratto di divenire sposta ogni altro tratto implicandolo nel proprio percorso, facendo di ogni altro tratto un proprio segno e facendo di sé stesso un segno di ogni altro tratto. Qui leggere è fare, interpretare è fabbricare. Per questo il lettore dei segni di quel cosmo non va immaginato come davanti a un libro, immune ai segni che sta decifrando, ma come un segno esso stesso, e come un fabbricatore esso stesso. (Leoni, 2019 p. 89-90)
Dunque, in questa direzione obliqua e deviata, l’Uno inizia ad apparire non tanto come un Uno che accade, uno spazio definito nello spazio-tempo o nel soggetto, quanto il supporto continuo, la piega nel soggetto che permette che una soggettivazione, continuamente in genesi e in divenire, accada (Leoni 2019 p. 51). Dunque, se questo Uno non è l’Uno-tutto-solo della perversione, che Uno perverso della creazione sarebbe? L’Uno, che qui viene ripreso a partire dal Seminario XIX di Lacan (2011), non è semplicemente un momento atavico, uno stadio larvale della soggettività che precede cronologicamente l’incontro del soggetto con l’Altro. Viene, invece, indicato come quell’evento, o ancora meglio come quel rimasuglio dell’evento (eco de l’Y a d’l’Un lacaniano) che permette strutturalmente l’emergere di una dialettica fra il soggetto dell’Altro. L’Uno non sarebbe, dunque, un soggetto che può mettersi in dialettica con un Altro (e che eventualmente sceglie di non farlo) ma sarebbe l’evento stesso della possibilità di un’emergenza del rapporto fra un soggetto e l’Altro, in altre parole il suo supporto. È come dire che nell’Uno sta già il Due e il molteplice, nel senso che l’Uno permette, ponendosi come fondamento, l’articolarsi fra più elementi, fra più Uni:
Ovvero, che c’è dell’Uno, c’è l’operazione di un Uno molto più profondo o molto più superficiale di così, un Uno che non sta né dalla parte dell’uno né dalla parte dell’altro, ma che distribuisce le parti e opera la divisione, non cessando un istante di non-dividersi al fondo della divisione stessa. Questo Uno è nella stessa posizione dell’Altro, anzi è l’Altro stesso, ma come il suo accadere. L’Uno è l’Altro che accade, o l’Altro è l’Uno ormai accaduto. L’Altro è il regime dei rapporti istituiti, l’Uno è l’istituirsi di quei rapporti. (Leoni 2019 p. 35)
Uno, dunque, che nel suo continuo mettere in atto la divisione senza esserne compromesso (una sorta di fondo psicotico a ogni nevrosi), mostra la natura continuamente metamorfica della soggettivazione, del suo incessante divenire all’interno di una logica sostenuta dallo scandire di questo Uno fondamentale. Dunque, nella lettura di Leoni, se l’Altro è il “regime” dove si sono dati dei legami e delle leggi secondo un ordine simbolico (istituito), l’Uno sarebbe il supporto che permette che questi rapporti si istituiscano senza esso si istituisca mai.
Ancora, per rimanere nel solco del complesso svilupparsi della riflessione lacaniana attraverso i suoi seminari, il tratto unario, l’elemento di identificazione a un tratto dal soggetto che fa partire la sua soggettivazione, è sostenuto dalla dimensione dell’uniano, appunto da quel yadlun (“c’è dell’uno”) inassimilabile e allo stesso tempo motore e supporto della possibilità di far partire la soggettivazione dall’identificazione del tratto unario. Certo, seguendo Lacan non troviamo un Uno tutto-pieno, monolitico e compatto, le sue fondamenta sono instabili. L’Uno lacaniano del Seminario XIX è rappresentabile, infatti, da una sacca vuota con un buco: «Si vous en voulez une figure, je représenterais le fondement du Yad’lun comme un sac. Il ne peut avoir l’Un que dans la figure d’un sac, qui est un sac troué» (Lacan, 2011 p. 147) [1]. Insomma, di questo Uno non si sa mai quanto ce n’è davvero dentro al sacco.
[1] Se volete una figura, io rappresenterei il fondamento di Yadl’un come un sacco. Non si può avere l’Uno se non dentro la figura di un sacco, che è un sacco bucato. (traduzione mia)
Non è un caso che l’Uno di Lacan sia inavvicinabile dal linguaggio ordinato dell’istituirsi del simbolico e che lo psicoanalista francese idei proprio per questo Uno il neologismo yadlun. Questo ci porta nella dimensione della lalangue (che Leoni incrocia nell’indagine su grido e voce nel capitolo otto) di una lingua primitiva rispetto all’intervento regolativo e differenziante del simbolico, capace dunque di mostrare, più che significantizzare, l’ambigua e inafferrabile consistenza di questo Uno.
E se Leoni ci indica un modo per immaginare come un soggetto venga fuori da questo Uno è attraverso l’immagine di un piano che si piega su se stesso, producendo una singolarità in continua trasformazione, la soggettivazione sempre in divenire. È così che il soggetto appare come una monade, piega e unità singolare in cui tutto il mondo si inclina attraverso quel particolarissimo vertice che è il fantasma, meccanismo di cornice-interfaccia della realtà e allo stesso tempo suo assemblaggio. Il fantasma è, infatti, già nella riflessione lacaniana, la dimensione che permette al soggetto di aprire una vasta gamma di possibili incontri con l’oggetto piccolo a.
S◊a, il matema del fantasma che Lacan (2013) indica nel Seminario VI, va a significare proprio questo: il punzone ◊ che contiene in sé più simboli (maggiore, minore, et, vel) rappresenta la plurimità delle possibilità di rapporto fra il soggetto diviso (S) del desiderio e l’oggetto causativo del desiderio, l’oggetto piccolo (a), resto di una delle forme dell’Uno lacaniano, Das Ding, la Cosa perduta per sempre dal soggetto nella rimozione originaria.
Jacques Lacan (Roma, 1974) Certo, ogni singolarità, ogni soggetto non può solo creare a partire dal suo fantasma ed è inevitabilmente posto sotto il giogo della legge della coazione a ripetere. Eppure, partendo da una sorta di teoria della registrazione, Leoni nell’ottavo capitolo mette in luce come anche la più fedele registrazione sia in qualche modo una deformazione, un cambiare strada, un de-viare dall’originale (Leoni 2019 p.129). In questo senso ci viene da suggerire l’associazione a un pensatore a suo modo decisamente perverso, William S. Burroughs, che insisteva sul ruolo dello scrittore come registratore, come supporto apparentemente passivo degli avvenimenti della realtà: “Uno scrittore può scrivere soltanto di una cosa: di quello che c’è davanti ai suoi sensi al momento di scrivere… Sono uno strumento di registrazione… Non presumo di imporre una “storia”, una “trama”, una “continuità”…” (Burroughs 1959 p. 199). Nonostante ciò, la vera operazione di Burroughs non si risolveva qui: lo scrittore per lui non si può limitare a ripetere a pappagallo ciò che della realtà si imprime su di lui ma ricostruisce e trasforma il testo della realtà attraverso tagli, sovrapposizioni e giustapposizioni attraverso cui inserisce nella ripetizione un brulicante continuo differenziarsi dentro al testo stesso attraverso la tecnica del cut-up, in cui il testo viene tagliato e poi ricomposto, e la tecnica del fold-in, dove, ancor più significativamente, il testo viene piegato su se stesso.
Pieghe e monadi, dunque, sono le forme filosofiche attraverso le quali Leoni ci vuole restituire una visione della soggettivazione vista dalla prospettiva di una scienza dei fantasmi, delle singolarità. Quello che si configura in questa scienza dei fantasmi è una posizione etica (Leoni p. 105) per indagare il soggetto nella sua prospettiva singolare a partire da una presa in carico del fantasma da cui lo si guarda, indicazione questa preziosa anche per la clinica. Scienza assolutamente soggettiva da una parte e dall’altra, invece, “unica scienza rigorosa”, con le parole di Husserl, perché consapevole di indagare il fantasma a partire da una cornice che è già a sua volta un fantasma:
Che cosa sa, infatti, la scienza del fantasma? Che il fantasma è tanto il fantasma “verso cui” essa guarda per scrivere e descrivere, come suo oggetto di studio; tanto il fantasma “da cui” essa scrive e grazie a cui essa descrive ciò che descrive; quanto il fantasma “in cui” essa scrive, cioè lo spazio e l’esigenza e lo strumentario e la ragnatela di strade resesi possibili, entro cui la sua scrittura, la sua descrizione si muove.” (Leoni 2019 p. 105)
Dunque, la scienza del fantasma auspicata da Leoni sarebbe una scienza capace di mettere in luce la cornice verso cui si tende nella scrittura, la cornice “oggetto di studio”, ma anche la cornice da cui si scrive (in qualche modo, un riconoscimento del fantasma dell’autore) ma soprattutto “ragnatela di strade resesi possibili”, l’esplicazione effettiva “in cui” questa scienza scrive e si dipana. È in questo senso che il testo propone non solo una questione “epistemologica” ma soprattutto una dimensione etica, di riconoscimento e di accoglimento del fantasma singolare all’interno dell’elaborazione del pensiero, che ne è la cornice stessa ma che costituisce anche il metodo di assemblaggio degli oggetti di studio, modificandoli.
A partire dalla definizione di questa scienza, Leoni negli ultimi capitoli del libro ci permette di vedere almeno due vertici a partire dai quali si può fare una scienza di fantasmi. Da una parte troviamo il filosofo “perverso”, che dopo Nietzsche è costretto a confrontarsi con la morte di Dio e alle nuove possibilità che gli sono date da scriversi. In qualche modo il filosofo perverso è un filosofo della contingenza lacaniana, colui che fa passare “ciò che non cessa di non scriversi” al “ciò che cessa di non scriversi”. Dall’altra, invece, in una posizione differente da quella del filosofo troviamo lo psicoanalista, che può manifestarsi attraverso più forme di singolarità: cadavere, santo (saint homme) e addirittura idiota. A differenza del filosofo, che fa emergere nuovi possibili attraverso assemblaggi fantasmatici, nella posizione di colui che “crea”, lo psicoanalista si pone in una posizione di annullamento, di “cadaverizzazione”, per permettere all’analizzante di incontrare e attraversare il suo proprio fantasma singolare.Una scienza di fantasmi, per concludere, è un libro che, fedele alla scena carrolliana descritta da Deleuze in Logica del senso, ci mostra uno scorrere obliquo e continuo di Uni, oggetti, figure, disegnando una ragnatela di associazioni attraverso le quali si inizia a vedere un fantasma emergente, una cornice ritmica. Questo testo vuole già essere, dunque, una messa alla prova di una possibile scienza dei fantasmi che animano il soggetto, lasciando libero di emergere, unico e singolare, un fantasma che anima la complessa struttura del testo:
Ciò che essa sa, e insieme ciò che essa fa, è conoscere e perciò spostare l’oggetto. Non si può conoscere il fantasma senza spostarlo. In parte perché lui stesso è mobile, metamorfico, consegnato a una perenne fibrillazione dei disparati che lo compongono. In parte perché noi stessi siamo mobili, noi che lo studiamo, noi con la nostra scienza del fantasma, la scienza stessa del fantasma che non è mai di fronte al fantasma ma è sempre spinta dal fantasma e immersa nel fantasma, dunque che è fantasma a tutti gli effetti. Se così è, la scienza del fantasma è un’arte che accompagna. (Leoni 2019 p. 105)
di Lorenzo Curti
Bibliografia:
Burroughs, W. S. (1959), Pasto nudo, tr. it. F. Cavagnoli, Adelphi, Milano 2012
Lacan, J. (2004) Seminario X. L’angoscia, tr. it. A Di Ciaccia e Adele Succetti, Einaudi, Torino 2007
Lacan, J. Séminaire XIX …ou Pire, Seuil, Paris, 2011
Lacan, J. (2013) Seminario VI. Il desiderio e la sua interpretazione, tr. it. A. Di Ciaccia e Lieselotte Longato, Einaudi, Torino 2016
Miller, J. A. L’Essere e l’Uno. La Psicoanalisi, 53/54, Astrolabio, 2013, pp. 177-227
Leoni, F., Jacques Lacan, una scienza di fantasmi, Orthotes, Napoli-Salerno, 2013
Recalcati, M., Jacques Lacan. La clinica psicoanalitica: struttura e soggetto. Raffaello Cortina, Milano, 2016
-
Andrea Cavalletti – Vertigine. La tentazione dell’identità
Recensioni / Settembre 2019 In quel distanziamento della prospettiva che si fa disorientante si coglie la vertigine, lo sguardo scavalca lo spazio reale ed effettivo per assurgere a vette basse, collocate in una profondità che si potrà toccare soltanto dopo lo schianto. Vicinanza e lontananza si deformano, creando un doppio sguardo che nella sua dualità bipolare alterna rischio, tentazione, paura e slancio; sintomi di un capogiro che vorticando su se stesso si autoalimenta senza arrestarsi mai. La vertigine, però, non è soltanto l’effetto di una distorsione visuale provocata dal timore dell’altezza, non va quindi ristretta al solo campo ottico, essa incarna anche la tendenza dell’essere a superarsi e a ritrovarsi - o a smarrirsi - in quello sguardo duplicato che, per forza di cose, interroga l’altro, e nella presenza dell’alterità si risolve. Vertigine è dunque quello stato che permette all’identità di rappresentarsi in una forma che richiede incertezza e la continua messa in discussione. Tale concezione della vertigine che si manifesta sia come sintomo psico-fisico che psicologico/ filosofico è ben rappresentata nel film del 1958 di Alfred Hitchcock, Vertigo (o La Donna che visse due volte) e che Andrea Cavalletti ha preso come punto di riferimento per sviluppare le proprie riflessioni inerenti la vertigine e raccolte nel suo ultimissimo libro edito da Bollati Boringhieri: Vertigine. La tentazione dell’identità. Questo libro difatti tratta il fenomeno della vertigine rendendolo strumento necessario per realizzare una vera e propria lettura dell’identità, in cui la perdita e il ritrovo di se stessi giocano ruoli fondamentali. È tale vertigine, dunque, il fulcro essenziale del testo che per l’autore, proprio per la sua natura malferma, incerta e cinetica, serve come supporto per intercettare e spiegare i nodi di un’identità che non trova (e non troverà) mai compimento in una forma definitiva. Tale “tentazione e ricerca” dell’identità è affrontato nel testo da punti di vista che fino ad ora erano stati esplorati in maniera separata e parziale e mai interconnessi tra di loro, cosa che Cavalletti fa, attuando un vero e proprio dialogo tra teorie scientifiche, psicologiche, filosofiche e artistiche; realizzando una mappatura intertestuale in cui il tema della vertigine resuscita in una nuova luce.
In quel distanziamento della prospettiva che si fa disorientante si coglie la vertigine, lo sguardo scavalca lo spazio reale ed effettivo per assurgere a vette basse, collocate in una profondità che si potrà toccare soltanto dopo lo schianto. Vicinanza e lontananza si deformano, creando un doppio sguardo che nella sua dualità bipolare alterna rischio, tentazione, paura e slancio; sintomi di un capogiro che vorticando su se stesso si autoalimenta senza arrestarsi mai. La vertigine, però, non è soltanto l’effetto di una distorsione visuale provocata dal timore dell’altezza, non va quindi ristretta al solo campo ottico, essa incarna anche la tendenza dell’essere a superarsi e a ritrovarsi - o a smarrirsi - in quello sguardo duplicato che, per forza di cose, interroga l’altro, e nella presenza dell’alterità si risolve. Vertigine è dunque quello stato che permette all’identità di rappresentarsi in una forma che richiede incertezza e la continua messa in discussione. Tale concezione della vertigine che si manifesta sia come sintomo psico-fisico che psicologico/ filosofico è ben rappresentata nel film del 1958 di Alfred Hitchcock, Vertigo (o La Donna che visse due volte) e che Andrea Cavalletti ha preso come punto di riferimento per sviluppare le proprie riflessioni inerenti la vertigine e raccolte nel suo ultimissimo libro edito da Bollati Boringhieri: Vertigine. La tentazione dell’identità. Questo libro difatti tratta il fenomeno della vertigine rendendolo strumento necessario per realizzare una vera e propria lettura dell’identità, in cui la perdita e il ritrovo di se stessi giocano ruoli fondamentali. È tale vertigine, dunque, il fulcro essenziale del testo che per l’autore, proprio per la sua natura malferma, incerta e cinetica, serve come supporto per intercettare e spiegare i nodi di un’identità che non trova (e non troverà) mai compimento in una forma definitiva. Tale “tentazione e ricerca” dell’identità è affrontato nel testo da punti di vista che fino ad ora erano stati esplorati in maniera separata e parziale e mai interconnessi tra di loro, cosa che Cavalletti fa, attuando un vero e proprio dialogo tra teorie scientifiche, psicologiche, filosofiche e artistiche; realizzando una mappatura intertestuale in cui il tema della vertigine resuscita in una nuova luce.Il volume è diviso rispettivamente in sei capitoli, ognuno dei quali affronta l’argomento sotto profili tematici diversi, ma tenuti assieme da un fil rouge che permette una lettura unitaria e quantomai interessante e innovativa. Nel primo capitolo intitolato effetto–vertigo, come già anticipato, Cavalletti per introdurre il fenomeno della vertigine si rifà al film, mettendolo a confronto con i due libri a cui esso è ispirato: ossia D’entre les morts di Boileau e Narcejac del 1954 e Bruges la morte del 1892 a firma di Georges Rodenbach. L’autore non si limita a una semplice comparazione delle opere, ma radica la propria riflessione rintracciando nelle trame intime della storia elementi che superano il piano narrativo, per approdare a campi concettuali di natura prevalentemente filosofica, essenziali per iniziare un’analisi sull’identità e le sue strutture. Vertigo è per eccellenza il racconto in cui l’inganno è espresso da ogni angolatura, e non è un caso, dunque, se nel primo capitolo Cavalletti rimanda al termine Schwindel a cui si associano contemporaneamente sia i significati di inganno e tentazione, sia di malattia e trucco, o di raggiro stando al saggio del 1948 Das Manifest der Kommunistischen partei di Marx ed Engels. Vocaboli che, specialmente nel film, si manifestano sia sotto forma registica attraverso espedienti tecnici, che in forma contenutistica ad esempio tramite l’impersonificazione della defunta Madeleine da parte di Judy.

A proposito Cavalletti ricorda come il famoso effetto vertigo (dolly zoom) sia stato risolto da Hitchcock grazie alla combinazione di uno zoom in avanti e di una carrellata indietro, o di uno zoom all’indietro e una carrellata in avanti, mantenendo invariata la dimensione del soggetto, permettendo così al pubblico di assumere la prospettiva di Scottie, interpretato da James Stewart, e immedesimandosi in lui. Tale meccanismo cinematografico è un trucco inteso per svelare un altro trucco sostanziale: ossia smascherare Judy attraverso un atto di dis-velamento che fa letteralmente “morire” Madeleine. L’artificio insito nella settima arte, sottolinea Cavalletti citando Walter Benjamin, di conseguenza si sporge aldilà dei propri espedienti artigianali per raggiungere il senso intrinseco della storia e la sua trama controversa.
Sempre in questo capitolo, riprendendo gli studi psichiatrici, ad esempio di Max Simon e del neurologo Charcot, Cavalletti descrive come la vertigine, specie nel’800, sia stata vista come una nevrosi, un’anomalia del sistema nervoso o un sintomo di isteria. Un’isteria che secondo La Mettrie, Esquirol e Simone Weil (tutti autori presenti nel testo) è destinata a diventare collettiva, in quanto l’intera società è affetta da un senso di vertigine stimolata da un sentimento di paura e sopraffazione psicologica e, proprio come asseriva la Weil in Réflexions sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale: l’avvento della “macchina” cinema servirà alla macchina sociale come strumento di massa per divulgare ideologie politiche propagandistiche e aizzare le folle. Il panico/vertigine di Scottie, dunque, può anche essere letto come la paura, ma al contempo necessaria volontà, di ribellarsi dei popoli soggiogati contro gli inganni dei loro governanti che in questo caso hanno il volto di Judy. Tale rapporto intersoggettivo rimanda al secondo e terzo capitolo del libro, intitolati Non siamo qui e Abito, maschera.
In questi capitoli entra in scena un concetto filosofico fondamentale per la disquisizione di Cavalletti: l’idea di habitus. Chiamando in causa i contributi, in particolar modo, di Husserl e del teorico dell’arte Robert Klein, all’interno del libro l’autore tessa un’indagine sulla vertigine che si posiziona ad un livello intersoggettivo. Se secondo Husserl l’habitus è ciò che è proprio del soggetto, ossia ciò che si possiede in quanto entità pensante e individuale. È interessante notare come Klein colga nella vertigine la possibilità di riscattare “l’abitudine” attraverso l’instaurazione di una relazione con un’entità esterna che si frappone, facendogli così raggiungere la dimensione dell’inappropriabile. La vertigine, perciò, secondo Klein provoca una dislocazione dell’io, in quanto lo sguardo altrui ci conquista, sottraendoci alla nostra coscienza riflessiva.
Cavalletti molto intuitivamente e sempre in riferimento a ciò, cita anche il carattere di reversibilità di Merleau-Ponty. Egli ricorda infatti come il filosofo francese in Phénoménologie de la perception e in Le visible et l’invisible precisa come le azioni dell’altro si riflettano in noi, in quanto quando l’essere si manifesta, esso esprime la presenza dell’altro - o dell’altro in me, urtando così la componente soggettiva. E la prospettiva del mondo, intrecciandosi inesorabilmente con quella dell’altro, viene attirata in un vortice in cui il mondo non è più pensato come proprio, perché appunto si viene influenzati da ciò che si verifica esternamente. E tale concezione, volendo, richiama anche alle recenti teorie sui neuroni specchio, in cui il gioco della reversibilità si attua ad un livello neurale. Cavalletti tramite un’analisi che coinvolge i maggiori pensatori della filosofia moderna, pone la vertigine come strumento intersoggettivo, ribadendo come la spinta tentatrice a gettarsi nel vuoto consista in realtà in una doppia percezione che ci fa sentire contemporaneamente qui e là. Facendo intervenire ancora Klein, l’autore nomina l’Eigenheit, ossia il rimbalzo tra rimorso e ricordo che stimola il soggetto a concepire il laggiù come un qui, e il qui come un là. Ricordandoci come sul precipizio si diviene un altro, evocando, così, l’ambivalenza data della presenza di Judy e Madeline che nel momento prima della caduta dalla torre coesistono entrambe.
Sempre attenendosi al contributo dei pensatori moderni, Cavalletti negli ultimi tre capitoli (Un singolare trasporto, Baratro, e Superficie) fa emergere questioni che, come in precedenza, amalgamano l’ambito cinematografico con quello filosofico. Compaiono quindi i concetti di: análogon, lapsus e Sterben (il morire). Seguendo le orme tracciate da Aristotele e successivamente da Hobbes, il lapsus non viene definito come un inganno dell’inconscio – lapsus che in questo particolare caso si esprime nell’atto volontario di Judy di indossare il collier appartenuto alla defunta Madeline – ma come un’azione compiuta in stato di veglia. Una volontà, potremmo dire sintetizzando, che permette alla maschera di cadere, richiamando ancora in causa il fenomeno della vertigine, quale esperienza stessa della messa in causa dell’identità. “L’ego è essenzialmente afflitto dalla vertigine, se questa consiste – nel compiere il passo che non si vorrebbe compiere, in un solecismo, in una contraddizione o in un lapsus dell’intentio (se potessimo non presupporre con questa parola il centro i l’identità che è forse la vertigine stessa a produrre)” (p. 97). Cavalletti in merito fa un ulteriore passo in avanti, portando come esempio l’esperienza attoriale di travestimento e smascheramento citando il famoso caso di Mary Pickford e il suo disorientamento vertiginoso nel guardarsi con gli occhi di un’altra senza essere la stessa, e riconoscendo nell’altro un análogon senza vita.
“Nella vertigine cinematografica la vertigine dell’identità viene annullata, e l’attrice potrebbe finalmente guardarsi con gli occhi di un’altra senza dover essere la stessa, senza dover aderire alla propria maschera colmandola di vita”(p. 148). Un senza vita che ci rimanda inesorabilmente al tema della morte (Sterben) e del baratro che, stando alla filosofia di Heidegger (autore che domina il capitolo quinto), è inclusa nella questione dell’Essere; in quanto l’essere esiste proprio a partire dalla sua possibilità di morte che non può per nessuna ragione venir rimandata. L’essere, di conseguenza, si determina anche grazie ad un’anticipazione di un non esserci più, perché in tale potenzialità l'esserci sovrasta se stesso, rimandando così al proprio poter-essere più proprio. E proprio in questo anticipo di poter essere che l’esserci, sempre secondo Heidegger, si apre alla sua condizione più estrema: la morte.
Ed è in base ai principi fino ad ora esposti, che Cavalletti ribadisce più spesso, anche durante il suo intervento del 22 Maggio presso la libreria Libre di Verona, quanto sia fondamentale il concetto di fissare la vertigine; fissarla appunto in quanto essa permetterebbe all’essere di rivelarsi nelle sue espressioni più autentiche, concedendo all’identità di formarsi e definirsi proprio in base a tale sbilanciamento vertiginoso. Da questo excursus si intuisce come Vertigine sia un’opera che apra un dialogo in cui le tematiche filosofiche e cinematografiche, congiungendosi tra loro, formano idee e principi che inquadrano il fenomeno della vertigine all’interno di una prospettiva nuova, in cui la spinta alla discussione e all’interrogazione dei vari quesiti non è mai data per scontata, ma sempre stimolata a superarsi e a oltrepassare i propri limiti; esattamente come l’uomo che dall’alto rivolgendo in basso il proprio sguardo si reincontra e si perde nel medesimo istante.
Silvia Cegalin
-
Alenka Zupančič – Che cosa è il sesso?
Recensioni / Maggio 2019 Che cosa è il Sesso? (trad. di P. Bianchi, Ponte alle Grazie, Genova 2018), ultima opera della filosofa slovena Alenka Zupančič, già autrice di lavori su Kant, Nietzche e Lacan, è un testo che raccoglie anni di riflessione sulla psicoanalisi freudo-lacaniana e che si pone la sfida di affrontare la sessualità come una questione intimamente ontologica. Lo scopo di Zupančič non è però quello di “recuperare” la psicoanalisi di Freud e Lacan e dare a essa uno statuto ontologico che nobiliti la disciplina psicoanalitica (che sicuramente ha sempre subito accuse di pseudoscientificità e determinismo sessuale). Quello di Zupančič non è neanche (o non solo) un tentativo di rispondere alle domande della filosofia con la psicoanalisi né una sua difesa acritica; anzi, la posizione della filosofa slovena è conflittuale anche internamente al discorso psicoanalitico, portando al centro una delle questioni che sono state problematiche sin dagli esordi freudiani – appunto, la sessualità. Il sesso di cui ci parla Zupančič non è semplicemente l’insieme di pratiche sessuali, a cui fornire uno statuto ontologico maneggevole che ci risollevi immaginariamente dagli imbarazzi e angosce che questa dimensione ha scatenato nel tempo; piuttosto la filosofa vuole andare a svelare quanto il sesso sia proprio quella faglia o mancanza strutturale che permette al soggetto di diventare tale. Il sesso protagonista di questo libro non è una presunta naturalità che dovremmo accettare, ma è esattamente quella dimensione “disontologica” e “disorientante” che fa che sì che emerga un soggetto e, quindi, un inconscio.
Che cosa è il Sesso? (trad. di P. Bianchi, Ponte alle Grazie, Genova 2018), ultima opera della filosofa slovena Alenka Zupančič, già autrice di lavori su Kant, Nietzche e Lacan, è un testo che raccoglie anni di riflessione sulla psicoanalisi freudo-lacaniana e che si pone la sfida di affrontare la sessualità come una questione intimamente ontologica. Lo scopo di Zupančič non è però quello di “recuperare” la psicoanalisi di Freud e Lacan e dare a essa uno statuto ontologico che nobiliti la disciplina psicoanalitica (che sicuramente ha sempre subito accuse di pseudoscientificità e determinismo sessuale). Quello di Zupančič non è neanche (o non solo) un tentativo di rispondere alle domande della filosofia con la psicoanalisi né una sua difesa acritica; anzi, la posizione della filosofa slovena è conflittuale anche internamente al discorso psicoanalitico, portando al centro una delle questioni che sono state problematiche sin dagli esordi freudiani – appunto, la sessualità. Il sesso di cui ci parla Zupančič non è semplicemente l’insieme di pratiche sessuali, a cui fornire uno statuto ontologico maneggevole che ci risollevi immaginariamente dagli imbarazzi e angosce che questa dimensione ha scatenato nel tempo; piuttosto la filosofa vuole andare a svelare quanto il sesso sia proprio quella faglia o mancanza strutturale che permette al soggetto di diventare tale. Il sesso protagonista di questo libro non è una presunta naturalità che dovremmo accettare, ma è esattamente quella dimensione “disontologica” e “disorientante” che fa che sì che emerga un soggetto e, quindi, un inconscio.
Santa Lucia di Domenico Beccafumi, utilizzato dall’autrice nel testo per mostrare la perversione della pulsione nel cristianesimo
Non è un caso, infatti – e Zupančič lo sottolinea continuamente nel testo – che Freud abbia sempre così insistito sulla centralità del Sesso nella psicoanalisi e che i suoi primi allievi, come Jung e Adler, abbiano sempre e sistematicamente reagito su questo punto. Ancora oggi la questione della sessualità rimane problematica e fa spesso da confine fra le varie correnti psicoanalitiche. André Green, nel 1995, pone una domanda apparentemente banale per la disciplina: “la sessualità ha ancora a che fare con la psicoanalisi?”. La questione, difatti, non è scontata: se in Europa (soprattutto in Francia) le nozioni di sessualità e pulsione avevano continuato a godere di un certo successo, oltreoceano invece la psicoanalisi aveva fatto vertere la propria pratica e la teoria verso concetti come quello di Sé e di Relazione. A dare ulteriore conferma del rapporto problematico della psicoanalisi con la sessualità, è una ricerca di Shalev e Yerushalmi (2009), ripresa anche da Zupančič, dove gli autori intervistano 10 psicoanalisti riguardo la tematica della sessualità in psicoterapia: ne emerge una generale e diffusa rimozione, e addirittura imbarazzo da buona parte dei clinici. La primigenia scoperta di Freud, la sessualità, piuttosto che essere l’elemento unificante delle varie divisioni e diaspore psicoanalitiche, è proprio il seme della discordia.
La domanda “Che cosa è il sesso?” – che, come abbiamo visto, è problematica anche per la stessa psicoanalisi – diventa il fil rouge per affrontare in maniera inedita e “rumorosa” domande classiche dell’ontologia. Non è senza peso che Freud, che aveva sempre cercato di tenersi distante dai riferimenti filosofici, in Endliche und Unendliche Analyse (1937) abbia riconosciuto proprio alla sessualità (come alla questione della pulsione di morte) un’origine filosofica nel dualismo empedocleo fra Eros e Neikos, che, sempre secondo Freud, avrebbe lavorato come criptomnesia inconscia. Ma in che misura il sesso (o meglio, l’interrogazione continua su quel punto di frattura e di inciampo che è il sesso) può funzionare come vettore nella lettura dei problemi dell’ontologia, del soggetto e della politica contemporanei? Non si tratta di ribadire, per Zupančič, semplicemente che il sesso c’è e che nasconderebbe in Sé quel senso e quella verità che tanto gli esseri umani si affannerebbero a cercare. Su questo la filosofa è chiara: il sesso non è “l’ultimo orizzonte del senso e della realtà”, qualcosa che semplicemente si può ritrovare dopo aver grattato la patina delle apparenze, eppure il Sesso è qualcosa di Reale. Ma questo Reale, ricavato dalle elaborazioni di Lacan, su cui tanto insiste Zupančič, non è la realtà dei filosofi, un orizzonte ontologico-epistemologico neutro e quasi rassicurante, piuttosto il Reale è, della realtà, quel nocciolo che resiste a ogni forma di simbolizzazione e ontologizzazione. Il Reale è esattamente ciò che viene tagliato fuori dall’Essere-in-quanto-essere perché sia possibile descriverlo e parlarne, e allo stesso tempo è quella dimensione che curva lo spazio ontologico dell’Essere. Non è un caso che sia Lacan sia Zupančič insistano tanto sulla sessualità di questo Reale, ed è l’inconscio il concetto che permette loro di giustificare questa insistenza. L’inconscio sessuale non è luogo di rimozione di un’istintività animale che “farebbe ritorno” in maniera disturbante, ma piuttosto un gap, un buco strutturale nel soggetto, che lo frattura dall’interno. Questo buco o negatività non è semplicemente un’assenza o uno zero, ma una quantità negativa (di eredità kantiana), inassimilabile e disgregante che funziona come luogo di emergenza del soggetto. Una crepa non è un niente, anzi conta spesso più dei muri, e il sesso è esattamente la crepa che divide i soggetti internamente. È in questo senso che la ripresa delle tavole della sessuazione lacaniana non serve a reiterare la formula della differenza sessuale, bensì a mostrare come essa lavori come operatore simbolico, tagliando il soggetto da dentro, piuttosto che dividendo i soggetti in due sessi o generi determinati fra di loro da un fantasmagorico rapporto sessuale (che non c’è). La sessualità, l’inconscio, il godimento e il Reale sono tutti nomi di ciò in cui il soggetto cartesiano inciampa svelando la frattura che lo domina dall’interno. Zupančič , riprendendo la questione lasciata aperta da Lacan (1973) nel Seminario XI su una sua possibile (para)-ontologia, in cui vi sarebbe una schisi fra l’Essere e il suo Reale, contribuisce a radicalizzare, anche in risposta ai progetti delle Object-Oriented Ontologies, nelle quali il soggetto tende a confondersi neutralmente con gli oggetti in una sorta di democrazia ontologica, l’immagine di un’ontologia dis-orientata agli oggetti, dove, invece, il soggetto continua a essere la frattura e l’alienazione scritta nel tessuto della realtà. Ed è proprio uno dei concetti fondamentali della psicoanalisi, la pulsione, a permettere la costruzione di una topologia del soggetto estimo, in cui i confini fra interiorità e esteriorità si deformano e l’oggetto (il famoso oggetto piccolo a lacaniano) si incista dentro il soggetto. Certo, parlare di pulsioni significa anche riportare all’attenzione antagonismi e conflitti rimossi o appiattiti in seno ai discorsi contemporanei.

Francis Bacon, Lying Figure
Si può dire che ciò che pone le basi del progetto (dis)ontologico di Zupančič sia proprio questa nozione di pulsione. Infatti, Zupančič riprende e rianalizza il Trieb freudiano, le cui vicissitudini di significante lo hanno portato ad essere tradotto e rinaturalizzato come istinto. Invece, ciò su cui insiste, a ragione, la filosofa slovena, è proprio l’innaturalità della pulsione, che poco ha a che fare con eventuali istinti biologico-riproduttivi: essa si produce piuttosto come scarto di godimento nel lavoro del corpo, eccedenza che ritorna sul soggetto, lavorando sui suoi bordi. E non è un caso che Zupančič riprenda quella sezione del Seminario XI dove Lacan parla della pulsione come “farsi vedere”, “farsi cacare”, “farsi masturbare”: pulsione è ritorno del godimento del soggetto, nelle parole di Freud “una bocca che si bacia da sola”. Nel bambino attaccarsi al seno non è semplicemente la soddisfazione di un istinto dell’ordine del nutrimento, ma si produce un resto di godimento, un’eccedenza “libera” nel neo-soggetto. Certo, come dice la filosofa, “con la soddisfazione in eccesso non si può ancora parlare di pulsione” (p. 156) ma è necessario che la soddisfazione inizi “a funzionare, allo stesso tempo, come incarnazione oggettiva […] del negativo e come gap implicito nell’edificio significante dell’essere” (p. 157). Allora la pulsione è proprio il rappresentante di questo negativo interno al soggetto, ne diviene la figura (dis)ontologica centrale. La pulsione è per definizione parziale e frammentaria: non ha un Eden perduto verso il quale tornare né una “teleologia” pulsionale. Non esiste, dunque, un carattere genitale maturo a cui il soggetto dovrebbe tendere. L’impasto pulsionale è sempre un azzardo, un incastro sregolato e polimorfo: “se c’è qualcosa cui la pulsione assomiglia, è a un montaggio” (Lacan, 1973 p. 172). Non c’è sessualità né desiderio normale (ma al massimo normalizzabile) proprio perché queste dimensioni non hanno una forma precisa alle quali le pulsioni si dovrebbero adattare. L’incastro è sempre necessariamente contingente, idiosincratico. E proprio a partire da questa ripresa della pulsione, Zupančič apre una possibilità (psicoanalitica) di ricucire la ferita aperta fra i queer studies e la psicoanalisi, mostrando il volto “anarchico” e “polimorfo” delle pulsioni e cercando di sollevare la psicoanalisi da quella posizione “normalizzatrice” di cui spesso è stata accusata (e di cui di fatto è stata responsabile in molti casi).
Altro merito della filosofa è quello che, seguendo il percorso della pulsione sessuale, fra Freud, Lacan e Deleuze, viene ritrovata la tanto temuta pulsione di morte. Come sostiene Lacan stesso: “Come stupirsi che il suo termine ultimo sia la morte? Poiché la presenza del sesso nel vivente è legata alla morte” (Lacan, 1973 p. 180). L’essere umano non è la lamella lacaniana, il mitico essere scissiparo e immortale: per noi la condizione della divisione sessuata implica la morte del soggetto individuale. L’equazione è questa: dove il soggetto è sessuato, significa che il soggetto deve morire. Allora, di nuovo con un gioco topologico, una condensazione si verifica: cercando il sesso sul nastro di Möbius, questo viene incontrato nel luogo della morte. Non solo, la pulsione di morte, primaria rispetto al brulichio delle pulsioni sessuali ci appare proprio come quell’incrinatura, quella contraddizione, “singolarità unificante” dalla quale le pulsioni emergono e alla quale ritornano: “Presa a questo livello, la sessualità è davvero sinonimo di pulsione di morte e non è un suo opposto come Eros con Thanatos.” (p. 176)
Se il lavoro di Zupančič è proprio quello di svelare filosoficamente le contraddizioni inerenti il soggetto (il sesso, la morte, l’inconscio, il Reale), allora proprio questo soggetto è “l’incarnazione oggettiva di questa contraddizione nella realtà” (p. 185). Per la filosofa incontrare la paradossalità della contraddizione non significa, però, doversi abbandonare a un atteggiamento scettico o cinico; si tratta, piuttosto, di accettare la contraddizione proprio come quel Reale accessibile al pensiero, di pensare la contraddizione, come gli stessi matemi lacaniani hanno fatto, portando la logica ai suoi punti di frattura e rendendo disponibile al pensiero, paradossalmente formalizzata, la contraddizione.

Francis Bacon, Three Studies for Figures at the Base of Crucifixion 2
What is Sex? è un libro originale, radicale e coraggioso per la forza con cui l’autrice invita a affrontare, pensare e concepire la contraddizione e il conflitto (e l’invito non è rivolto solo a filosofi e psicoanalisti, poiché la filosofa ha la capacità di sciogliere nodi intricati con battute immediatamente comprensibili). Chi volesse cercare qui una risposta alla domanda “cosa è il sesso” nel senso più rassicurante e definitivo di certo si troverebbe deluso, perché questo interrogativo diventa piuttosto l’intelaiatura di una riflessione filosofica che vuole prendere di petto tutte quelle contraddizioni, quei conflitti e quelle fratture che la psicoanalisi ha saputo riconoscere (e che, in molti casi, ha saputo anche dimenticare e rimuovere) nel soggetto, nella sessualità, nella morte, nell’inconscio e nell’ambiguità del legame sociale. In questo senso Che cosa è il Sesso? è anche un testo esplicitamente politico, che ci porta nuovamente di fronte quell’antagonismo strutturale che anima e agita la società dal suo interno, facendoci guardare con sospetto dove e quando il Rapporto (sessuale) e la Relazione sono state scritte con la R maiuscola, ponendo proporzioni “sacre” e determinate fra classi, sessi, popoli. Alenka Zupančič ci insegna a guardare con diffidenza chi istituisce questo rapporto in maniera ferrea (come i sistemi dittatoriali), ma anche chi tende a nascondere il conflitto insito nella relazione, neutralizzandolo nell’Etica. La filosofa, infatti, leggendo in chiave politica il famoso ed enigmatico detto di Lacan “non c’è rapporto sessuale”, ci restituisce l’immagine di un rapporto senza prototipo o modello ideale, ma che può sorgere, ogni volta nuovo e da ricostruire, sotto la “necessità” della contingenza, dell’idiosincrasia degli incontri fra i soggetti e nei conflitti che si generano dentro e fra i soggetti. Insomma, una prospettiva che ci fa assumere la responsabilità della contraddizione, piuttosto che negarla o rimuoverla, della frattura che ci domina da dentro e che noi incarniamo nel mondo anche in una dimensione autenticamente politica e trasformativa.
di Lorenzo Curti
Bibliografia:
Freud, S. (1937) Analisi terminabile e interminabile.Trad. it. R. Colorni. OSF Vol. XI. Torino: Bollati Boringhieri
Green, A. (1995) Has sexuality anything to do with psychoanalysis? International Journal of Psychoanalysis78: 871-883
Lacan, J (1973). Seminario: Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi. Trad. it. S. Loaldi e I. Molina. Torino: Einaudi, 1979
Shalev, O. & Yerushalmi, H. (2009) Status of sexuality in contemporary psychoanalytic psychotherapy as reported by therapists. Psychoanalytic Psychology, Vol. 26, No. 4, 343–361
Zupančič, A. (2018) Che cosa è il sesso?. Tr. it. P. Bianchi. Milano: Ponte alle Grazie.
-
 La constatazione della pervasività degli automatismi che intessono la nostra esistenza individuale e collettiva porta Pelgreffi a sviluppare un’interrogazione radicale intorno all’essenza di tale fenomeno. L’automatismo viene considerato a partire dall’ampiezza del suo senso, che trova applicazione in ambiti apparentemente eterogenei, come il biologico e il sociale, rivelando, fin dall’inizio, la sua costitutiva ambiguità, che porta, tra l’altro, a un’essenziale riconfigurazione della tradizionale opposizione tra naturale e culturale. Il comportamento automatico si rivela essere, da una parte, il modo di manifestarsi di ciò che è spontaneo, non programmato, emergente. In quest’ottica, afferisce all’ambito del biologico, delle procedure innate radicate nel profondo del bios, dell’inconscio corporeo e psichico. Dall’altra, richiama ciò che è stato appreso ed è diventato abitudine, nel senso di ciò che si impone come prassi automatica a seguito di ripetizioni esercitanti. Si tratta, in questo caso, dello spettro di significati che rimandano al contesto della “seconda natura”, ossia delle abitudini acquisite nel corso della vita, le quali si installano sugli automatismi innati, rimpiazzandoli e riconfigurandoli.
La constatazione della pervasività degli automatismi che intessono la nostra esistenza individuale e collettiva porta Pelgreffi a sviluppare un’interrogazione radicale intorno all’essenza di tale fenomeno. L’automatismo viene considerato a partire dall’ampiezza del suo senso, che trova applicazione in ambiti apparentemente eterogenei, come il biologico e il sociale, rivelando, fin dall’inizio, la sua costitutiva ambiguità, che porta, tra l’altro, a un’essenziale riconfigurazione della tradizionale opposizione tra naturale e culturale. Il comportamento automatico si rivela essere, da una parte, il modo di manifestarsi di ciò che è spontaneo, non programmato, emergente. In quest’ottica, afferisce all’ambito del biologico, delle procedure innate radicate nel profondo del bios, dell’inconscio corporeo e psichico. Dall’altra, richiama ciò che è stato appreso ed è diventato abitudine, nel senso di ciò che si impone come prassi automatica a seguito di ripetizioni esercitanti. Si tratta, in questo caso, dello spettro di significati che rimandano al contesto della “seconda natura”, ossia delle abitudini acquisite nel corso della vita, le quali si installano sugli automatismi innati, rimpiazzandoli e riconfigurandoli.L’intento di Pelgreffi è rendere tale ambiguità, consustanziale al concetto di automatismo, non già paradosso paralizzante, ma apertura di senso produttiva e meritevole di essere indagata nella sua doppiezza. Tale approccio permette di chiamare in causa un’altra ambiguità del concetto di automatismo, che concerne il suo riferirsi, al tempo stesso, alla vita individuale e collettiva. Gli automatismi sviluppati dai singoli individui si riflettono e dialogano costantemente con le dinamiche che regolano la convivenza, culturalmente codificata, all’interno di un collettivo. Tale prisma semantico viene messo in luce tramite un’attenta e avveduta rassegna delle teorie di coloro che si sono occupati, ciascuno a modo proprio ma anche in dialogo reciproco, del concetto di automatismo. Dalle analisi classiche intorno al concetto aristotelico di hexis si giunge alla filosofia francese novecentesca, passando per Hume, Nietzsche e Butler. Non viene tralasciato il dialogo, da una parte, con le scienze psicologiche (in particolare Pavlov e Janet) e, dall’altra, con la pratica artistica dell’attore, compresa attraverso le riflessioni di Diderot e di Stanislavskij. Tali incursioni ermeneutiche permettono a Pelgreffi di approdare a un dialogo serrato con i risultati teorici ottenuti da Merleau-Ponty, in particolare nella sua Fenomenologia della percezione, e mettere in evidenza il ruolo cruciale che la corporeità svolge all’interno di una teoria generale degli automatismi.

Il corpo, compreso come limite e soglia, si configura come il punto fondamentale di incrocio e trasformazione tra le diverse forme di automatismo evidenziate in precedenza. Tale approccio permette di delineare la funzione formante degli automatismi, ossia la circostanza, secondo la quale l’acquisizione di abitudini ripetute ha valore soggettivante, nella misura in cui plasma la modalità di esistenza di chi incarna tali abitudini. È una simile prospettiva che permette a Pelgreffi di introdurre la dinamica eminentemente etica aperta da una filosofia dell’automatismo, nella misura in cui la funzione formante di quest’ultimo rivela, come suo doppio costitutivo, la presenza di una resistenza basale, della possibilità di uno stacco produttore di divergenza, nel processo di acquisizione degli automatismi e nella loro riconfigurazione. In tale potenzialità trasformante si cela la possibilità etica e il focus gnoseologico che permettono di comprendere come si possa produrre differenza attraverso la ripetizione, ossia come sia possibile la de-automatizzazione dei propri automatismi, pur dimorando all’interno dell’orizzonte ampiamente automatizzato in cui la vita si esplica in quanto tale.
La peculiarità dell’approccio adottato da Pelgreffi consiste nel situare nel corpo e, pertanto, nell’insieme di pratiche che possono proporsi di istituire i criteri di un’etica della corporeità, la soglia di tale possibilità di de-automatizzazione, ossia di riconfigurazione critica dei propri automatismi attraverso gli automatismi stessi: «la corporeità è la zona intermediale in cui l’automatismo come senza precedenti e l’automatismo come risultato della ripetizione trovano una sintesi non neutralizzante, aperta anche alla diversione dalla forma sintetica operante» (p. 88). Una tale prospettiva viene conquistata considerando gli automatismi nella loro dimensione genetica e processuale, al fine di comprendere l’acquisizione di un’abitudine nel suo svolgersi e affermarsi e metterne in luce la struttura composta da esercizi ripetuti con effetti di ritorno plastici e in continuo dialogo con una resistenza produttiva installata nella corporeità. Particolare rilievo assume, in una tale ottica, l’attenzione al processo di apprendimento delle abitudini, nel quale si celano le codificazioni sociali (Bourdieu) e i presupposti manuali della tecnica (Sennett). L’intento è quello di ricondurre criticamente il potere della ripetizione automatizzantesi contro la ripetizione stessa, in quanto «all’interno dell’automatismo, esistono contro-movimenti di de-automatizzazione che si tratta di veicolare, di guidare e gestire dall’interno» (p. 220). A partire da questa prospettiva, è importante rilevare come un tale approccio permetta di aprire la strada a una radicale riconfigurazione del ruolo della soggettività, la quale non viene abbandonata, ma ridimensionata e ricondotta alle pratiche di vita, innervate nella corporeità e nel suo fondo inconscio, solo a partire dalle quali la figura del soggetto si può manifestare, dato che «non c’è soggetto senza automatismo, senza estroflessione originaria al dispositivo» (p. 179). È al livello di tali pratiche, delle quali il soggetto rappresenta il risultato epifenomenico parziale e posteriore, che un’etica della resistenza produttiva e della ripetizione differenziante può essere codificata.
di Marco Pavanini
-
Nello spazio di questa rubrica dal titolo Start Up desidero riflettere su un discorso oggi “nell’aria”, curiosamente tanto in un piccolo paesino della Sardegna quanto in una città mito come New York: il discorso è quello dell’innovazione, della pratica innovativa e del soggetto innovatore. Il discorso, come forse saprete, si dice rivoluzionario: cambierà, dice, letteralmente il mondo. Qui, intendo prendere sul serio il dispiegarsi di queste parole pericolose nello spazio - direbbe Foucault - per comprendere come un discorso, sintomo al contempo di desideri, istanze difensive e mancanze a essere, si faccia corpo. Per fare questo, la rubrica vuole occuparsi della molteplicità di spazi che la materialità di tale discorso richiede, richiama e evoca per e nel suo farsi materia. Una genealogia spaziale dell’innovazione attraverso lo spazio urbano, organizzativo, immaginario e infine, del soggetto che là dove è occupa sempre uno spazio.
Nel corso della rubrica si attingerà alle note del diario etnografico frutto dell’osservazione svolta presso un incubatore d’impresa e spazio co-working milanese nell’ambito del mio progetto di Dottorato in Urban and Regional Development, Politecnico di Torino e Università degli Studi di Torino, attualmente Visiting research student presso The New School, New York.
Contatto: annapaola.quaglia@polito.it
Su gentile concessione dell’artista Daniel Horowitz, alcune immagini di sue opere esposte a New York nelle esibizioni Totem e taboo e Civilization and its Discontents, accompagneranno le puntate della rubrica.
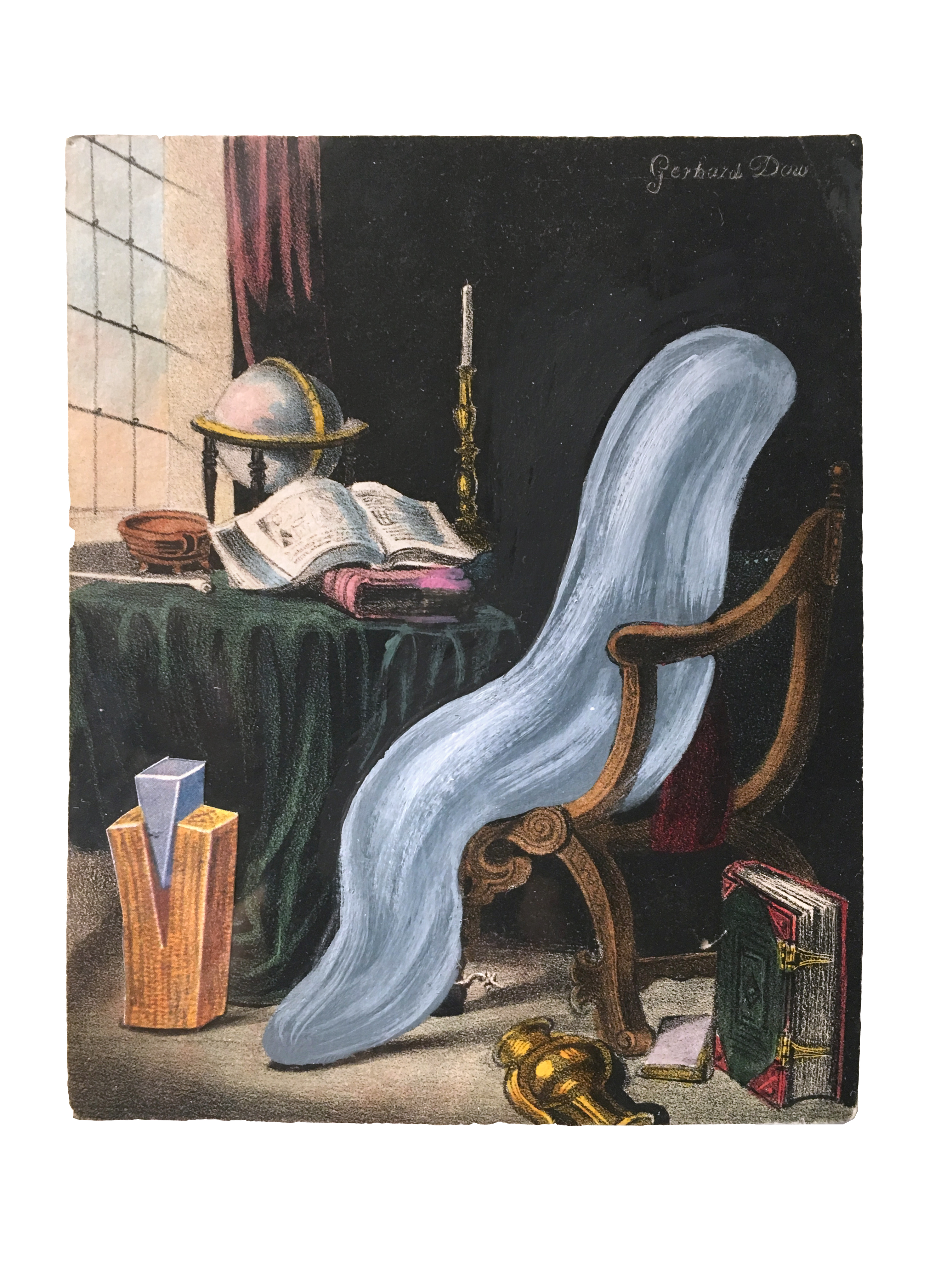
D. B. Horowitz, Lawless Boy, 2016, oil on antique hand-colored engraving
-
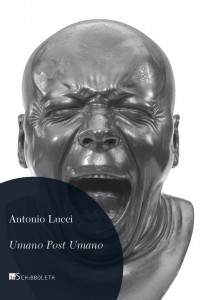 Alla voce “posthumanism” Wikipedia elenca sette possibili sfumature semantiche del termine, tutte riconducibili a diverso titolo a questa controversa nozione: si menzionano l’anti-umanismo, il postumanismo culturale, il postumanismo filosofico, la condizione postumana, fino ad arrivare ai massimalismi di transumanismo, Al Takeover ed estinzione volontaria dell’uomo. Ora, senza entrare nel merito di questa catalogazione – che come tale implica una certa arbitrarietà – cercheremo di presentare il saggio di Antonio Lucci Umano Post Umano (Inschibboleth, 2016), azzardandone una collocazione all’interno del cosiddetto postumanismo filosofico. Premessa: “postumano” indica un ambito delle scienze umane distante da una stabilizzazione disciplinare; i margini tematici a cui richiama sono sfrangiati ed estremamente porosi, continuamente soggetti a sconfinamenti e ampliamenti epistemici – di carattere sia inclusivo sia esclusivo. Dagli anni ’70 fino a oggi, infatti, l’idea di poter parlare di “postumano” nei termini di una questione culturalmente rilevante ha fatto sì che il sintagma “post” – su cui pesa tutta la portata della sua novità concettuale – divenisse l’oggetto di innumerevoli branche delle humanities. Con buona probabilità il motivo di questa fortuna è dipeso dal fatto che parlare di post-umano significhi, più o meno consapevolmente, testare la tenuta di un’idea di scienza – “umana” appunto – che mai come oggi pare minacciata da un preoccupante autosuperamento. L’espressione post-umano effettivamente, come ricorda anche Wikipedia, richiama tanto all’idea di crisi quanto alla categoria generale del “salto al di là”, sia storico (after Humanism) che locale (beyond Humanism). Posthumanism va dunque maneggiato come si maneggia un sintomo, concertando prudenza e perizia. Sarebbe eccessivamente sbrigativo liquidare l’emersione prepotente di questa nozione riducendola a un che di passeggero o magari, per additarne l’inconsistenza, a un evanescente fenomeno mediatico. E’ vero, la confusione non manca: l’oggetto su cui si dibatte rimane il più delle volte nascosto dietro un’impenetrabile cortina di nebbia concettuale; le metodologie di analisi talvolta si combinano seguendo giustapposizioni naïf, talaltra si arroccano su anguste posizioni protocollari figlie di specialismi nati l’altro ieri. Eppure, come vedremo, navigando a vista tra interdisciplinarità e tecnicismo, è ancora possibile mantenere un certo equilibrio, tale da consentirci di formulare una risposta plausibile alla domanda “cosa significa postumano?”.
Alla voce “posthumanism” Wikipedia elenca sette possibili sfumature semantiche del termine, tutte riconducibili a diverso titolo a questa controversa nozione: si menzionano l’anti-umanismo, il postumanismo culturale, il postumanismo filosofico, la condizione postumana, fino ad arrivare ai massimalismi di transumanismo, Al Takeover ed estinzione volontaria dell’uomo. Ora, senza entrare nel merito di questa catalogazione – che come tale implica una certa arbitrarietà – cercheremo di presentare il saggio di Antonio Lucci Umano Post Umano (Inschibboleth, 2016), azzardandone una collocazione all’interno del cosiddetto postumanismo filosofico. Premessa: “postumano” indica un ambito delle scienze umane distante da una stabilizzazione disciplinare; i margini tematici a cui richiama sono sfrangiati ed estremamente porosi, continuamente soggetti a sconfinamenti e ampliamenti epistemici – di carattere sia inclusivo sia esclusivo. Dagli anni ’70 fino a oggi, infatti, l’idea di poter parlare di “postumano” nei termini di una questione culturalmente rilevante ha fatto sì che il sintagma “post” – su cui pesa tutta la portata della sua novità concettuale – divenisse l’oggetto di innumerevoli branche delle humanities. Con buona probabilità il motivo di questa fortuna è dipeso dal fatto che parlare di post-umano significhi, più o meno consapevolmente, testare la tenuta di un’idea di scienza – “umana” appunto – che mai come oggi pare minacciata da un preoccupante autosuperamento. L’espressione post-umano effettivamente, come ricorda anche Wikipedia, richiama tanto all’idea di crisi quanto alla categoria generale del “salto al di là”, sia storico (after Humanism) che locale (beyond Humanism). Posthumanism va dunque maneggiato come si maneggia un sintomo, concertando prudenza e perizia. Sarebbe eccessivamente sbrigativo liquidare l’emersione prepotente di questa nozione riducendola a un che di passeggero o magari, per additarne l’inconsistenza, a un evanescente fenomeno mediatico. E’ vero, la confusione non manca: l’oggetto su cui si dibatte rimane il più delle volte nascosto dietro un’impenetrabile cortina di nebbia concettuale; le metodologie di analisi talvolta si combinano seguendo giustapposizioni naïf, talaltra si arroccano su anguste posizioni protocollari figlie di specialismi nati l’altro ieri. Eppure, come vedremo, navigando a vista tra interdisciplinarità e tecnicismo, è ancora possibile mantenere un certo equilibrio, tale da consentirci di formulare una risposta plausibile alla domanda “cosa significa postumano?”. -
Una questione di scarpe. Derrida e Van Gogh
Sconfinamenti, Serial / Maggio 2016 Il capitolo finale del volume di Jacques Derrida La vérité en peinture reca l’etichetta Restitutions – de la vérité en pointure. Essa ovviamente implica un calembour sul titolo del libro: infatti i due termini peinture e pointure sono quasi omofoni, anche se si differenziano sul piano del significato, dato che il secondo indica in francese la misura di un paio di scarpe. Questo testo derridiano è costruito in maniera inusuale, ossia come un dialogo a più voci, in cui i parlanti restano indeterminati. Si inizia con qualcuno che osserva: «Non ricordo più chi diceva “non ci sono fantasmi nei quadri di Van Gogh”? Invece qui c’è proprio una storia di fantasmi». Per dimostrare ciò, Derrida mette a confronto due autorevoli interpretazioni di un dipinto dell’artista olandese che raffigura un paio di scarpe slacciate. Gli interpreti in questione, Heidegger da un lato e lo storico dell’arte americano Meyer Schapiro dall’altro, sono accomunati dal fatto di chiedersi a chi appartengano tali scarpe, quasi fosse necessario restituirle al legittimo proprietario. Per il filosofo tedesco, che evoca il dipinto nel saggio L’origine dell’opera d’arte, a essere in causa è senz’altro «un paio di scarpe da contadino». Ma poiché egli non ha indicato con precisione nel suo testo a quale fra i vari quadri di Van Gogh raffiguranti scarpe si riferisse, Schapiro glielo ha chiesto per via epistolare, appurando che si trattava dell’opera (databile alla seconda metà del 1886) che reca il numero 255 nel catalogo compilato da Jacob Baart de la Faille. Basta questo a Schapiro per dedurre che le calzature raffigurate nel quadro non appartenevano a un qualche contadino bensì al pittore stesso, che in quel periodo risiedeva in città, a Parigi...Scarica il PDF
Il capitolo finale del volume di Jacques Derrida La vérité en peinture reca l’etichetta Restitutions – de la vérité en pointure. Essa ovviamente implica un calembour sul titolo del libro: infatti i due termini peinture e pointure sono quasi omofoni, anche se si differenziano sul piano del significato, dato che il secondo indica in francese la misura di un paio di scarpe. Questo testo derridiano è costruito in maniera inusuale, ossia come un dialogo a più voci, in cui i parlanti restano indeterminati. Si inizia con qualcuno che osserva: «Non ricordo più chi diceva “non ci sono fantasmi nei quadri di Van Gogh”? Invece qui c’è proprio una storia di fantasmi». Per dimostrare ciò, Derrida mette a confronto due autorevoli interpretazioni di un dipinto dell’artista olandese che raffigura un paio di scarpe slacciate. Gli interpreti in questione, Heidegger da un lato e lo storico dell’arte americano Meyer Schapiro dall’altro, sono accomunati dal fatto di chiedersi a chi appartengano tali scarpe, quasi fosse necessario restituirle al legittimo proprietario. Per il filosofo tedesco, che evoca il dipinto nel saggio L’origine dell’opera d’arte, a essere in causa è senz’altro «un paio di scarpe da contadino». Ma poiché egli non ha indicato con precisione nel suo testo a quale fra i vari quadri di Van Gogh raffiguranti scarpe si riferisse, Schapiro glielo ha chiesto per via epistolare, appurando che si trattava dell’opera (databile alla seconda metà del 1886) che reca il numero 255 nel catalogo compilato da Jacob Baart de la Faille. Basta questo a Schapiro per dedurre che le calzature raffigurate nel quadro non appartenevano a un qualche contadino bensì al pittore stesso, che in quel periodo risiedeva in città, a Parigi...Scarica il PDFA cura di:
Giuseppe Zuccarino è critico e traduttore. Ha pubblicato vari saggi: La scrittura impossibile, Genova, Graphos, 1995; L’immagine e l’enigma, ivi, 1998; Critica e commento. Benjamin, Foucault, Derrida, ivi, 2000; Percorsi anomali, Udine, Campanotto, 2002; Il desiderio, la follia, la morte, ivi, 2005; Il dialogo e il silenzio, ivi, 2008; Da un’arte all’altra, Novi Ligure, Joker, 2009; Note al palinsesto, ivi, 2012; Il farsi della scrittura, Milano-Udine, Mimesis, 2012. Tra i libri da lui tradotti figurano opere di Mallarmé, Bataille, Klossowski, Blanchot, Caillois e Barthes.
-
Che cosa può motivare la scelta di dedicare un libro al problema del «precategoriale» in
 Husserl? Il libro di Federica Buongiorno, Logica delle forme sensibili. Sul precategoriale nel primo Husserl, è motivato dalla convinzione che il problema del precategoriale sia un tema inaggirabile della fenomenologia di Husserl, un problema del quale la fenomenologia husserliana può e deve rispondere. In un passo molto chiaro Buongiorno afferma che il «compito della fenomenologia […] è appunto quello di condurre l’anonimo (l’implicito) al categoriale e ricondurre poi quest’ultimo […] alle radici pre-categoriali» (p. 184). La difficoltà – a ragione valorizzata in questo libro – risiede nel fatto che la precedenza del precategoriale non rappresenta il momento iniziale di un processo conoscitivo, bensì quel tratto costitutivamente «anonimo» e «non tematico» dell’«esperienza fondante» (p. XVII). L’Autrice, dunque, evidenzia sin dall’inizio come la differenza tra «categoriale» e «precategoriale» non vada intesa, per così dire, in maniera lineare, cioè come una differenza tra due momenti di un medesimo processo conoscitivo, ma come il problematico opporsi di due livelli irriducibilmente distinti: il «tematico» e il «non tematico». Il precategoriale è un fenomeno rilevante proprio in quanto costituisce quella «esperienza fondante» che si sottrae alla tematizzazione e alla conoscenza tradizionale, e che impegna la fenomenologia nella sua specificità.
Husserl? Il libro di Federica Buongiorno, Logica delle forme sensibili. Sul precategoriale nel primo Husserl, è motivato dalla convinzione che il problema del precategoriale sia un tema inaggirabile della fenomenologia di Husserl, un problema del quale la fenomenologia husserliana può e deve rispondere. In un passo molto chiaro Buongiorno afferma che il «compito della fenomenologia […] è appunto quello di condurre l’anonimo (l’implicito) al categoriale e ricondurre poi quest’ultimo […] alle radici pre-categoriali» (p. 184). La difficoltà – a ragione valorizzata in questo libro – risiede nel fatto che la precedenza del precategoriale non rappresenta il momento iniziale di un processo conoscitivo, bensì quel tratto costitutivamente «anonimo» e «non tematico» dell’«esperienza fondante» (p. XVII). L’Autrice, dunque, evidenzia sin dall’inizio come la differenza tra «categoriale» e «precategoriale» non vada intesa, per così dire, in maniera lineare, cioè come una differenza tra due momenti di un medesimo processo conoscitivo, ma come il problematico opporsi di due livelli irriducibilmente distinti: il «tematico» e il «non tematico». Il precategoriale è un fenomeno rilevante proprio in quanto costituisce quella «esperienza fondante» che si sottrae alla tematizzazione e alla conoscenza tradizionale, e che impegna la fenomenologia nella sua specificità.Ma non è questo il tema specifico del libro, che tratta, come esplicita il sottotitolo, del precategoriale «nel primo Husserl». Questa restrizione tematica rende ancor più ambiziosa la sfida di questo testo. Mettere a tema il precategoriale nel primo Husserl significa infatti individuare e discutere tale questione al livello metodologico e problematico delle Ricerche Logiche, quindi, prima della «riduzione fenomenologica» delle Idee, prima delle analisi genetiche e prima che Husserl, nella Crisi delle scienze europee, affronti esplicitamente il problema del «mondo della vita». Ma è proprio questa la sfida del libro di Federica Buongiorno, che – sempre consapevole di queste difficoltà – cerca di pensare il precategoriale con Husserl (nello specifico, con il primo Husserl) ma anche oltre Husserl. Per ragioni di spazio, in questa recensione mi concentro su questi due aspetti principali del libro, sebbene esso affronti con precisione filologica moltissime altre questioni; mi limito a ricordare il rapporto con Brentano (cap. I), l’influenza di Bolzano (cap. II) e il confronto con Kant, che l’Autrice valorizza costantemente.
Innanzitutto, vorrei richiamare l’attenzione sul titolo del testo. Che il problema del precategoriale abbia a che fare con qualcosa come una «logica delle forme sensibili» può sembrare, soprattutto per lo studioso di fenomenologia, una cosa ovvia. In realtà questo legame, tutt’altro che pacifico, tra il precategoriale e la logica delle forme sensibili sintetizza la tesi centrale di questo libro. Si tratta dell’idea – lo dico con parole mie – che il problema del precategoriale conduca all’elaborazione di una radicale “logica del sensibile”, a una “logica” che, in quanto “dedotta” dalla sensibilità stessa, di “logico” in senso tradizionale conserva ben poco. Ci si deve innanzitutto chiedere in che misura il primo Husserl ci offra la possibilità di pensare questa “logica del sensibile”, e in che misura questa “logica” sia capace di restituire, nella sua ricchezza e originarietà, il fenomeno del precategoriale.
Nell’“Introduzione”, in un passo molto significativo sul quale tornerò in chiusura, si dice che il carattere «costitutivamente problematico» del precategoriale introduce una «tensione di carattere fondazionale all’interno della teoria husserliana». Il punto è che questa tensione non può «essere risolta richiamandosi alla predelineazione del categoriale nel suo fondamento ante-predicativo, sebbene sia questo il ragionevole orizzonte interpretativo nel quale disporre il problema» (p. XII, corsivo mio). Il problema del precategoriale comporta infatti una strutturale eccedenza rispetto a una certa idea di precategoriale, una idea già attiva a livello delle Ricerche Logiche e definibile come una «predelineazione del categoriale» nella sensibilità. Questa “eccedenza” rappresenta a mio avviso qualcosa di decisivo per questo libro, nel quale l’analisi filologica del testo husserliano, volta a individuare la presenza del precategoriale nel primo Husserl, è costantemente ravvivata dalla consapevolezza della portata filosofica e teoretica del problema. La discussione del problema del precategoriale nel primo Husserl trova il proprio centro nel concetto di «intuizione categoriale», di cui Federica Buongiorno rintraccia le origini (cap. III. 1,2) e di cui ricostruisce – inquadrando la nozione all’interno delle Ricerche Logiche – il contesto problematico (cap. III. 3), per offrirne poi una analisi mirata nella parte finale del libro (cap. IV).
A un primo livello si può dire che la rilevanza dell’intuizione categoriale per il problema del precategoriale risiede nel fatto che, come è noto, attraverso questa nozione diventa possibile pensare il categoriale come dato. Questa nozione – ecco la sfida lanciata a Kant – implica una «profonda riconsiderazione dei rapporti tra sensibilità e intelletto, tra base estetica (precategoriale) e operazioni logico-discorsive» (p. 148). Ma, a mio avviso, Buongiorno coglie un punto fondamentale quando parla di una «duplice vettorialità» dell’intuizione categoriale (p. 136). Questa espressione dà voce al duplice aspetto dell’intuizione categoriale, come atto fondato sull’intuizione sensibile e come atto che offre al tempo stesso un nuovo tipo di oggettualità, una oggettualità eccedente rispetto all’intuizione sensibile. È forse proprio questa duplice vettorialità dell’intuizione categoriale ciò che permette di preservare il carattere originario, sensibile e intuitivo del precategoriale, senza tuttavia ridurre la sensibilità (per dirla con Kant) a una “intuizione cieca”, o (con le parole dell’Autrice) a una “mera sensibilità”, con cui il precategoriale, come giustamente viene precisato, non deve essere mai confuso (p. XVII). È sempre in quest’ottica che nel testo ci si confronta con il concetto fenomenologico di intuizione «in senso ampio». L’intuizione categoriale – l’esempio della copula è emblematico – presuppone proprio la possibilità di intuire (in senso ampio) qualcosa di radicalmente non intuibile (in senso stretto). Come rileva Buongiorno, l’allargamento fenomenologico del concetto di intuizione va di pari passo con l’«ampliamento dell’esistenza alla sfera logico-ideale» (p. 115).
L’insistenza su questa duplice vettorialità dell’intuizione categoriale è inoltre coerente con una prima importante scelta metodologica del testo. Buongiorno individua infatti nella rielaborazione husserliana della teoria brentaniana delle «rappresentazioni improprie» una chiave di lettura per comprendere la specificità della concezione fenomenologica del rapporto tra «intuizione (riempimento)» e «intelletto (intenzione
 significante)». Se per Brentano «le rappresentazioni improprie e i giudizi su di esse fondati avevano carattere “pseudo-conoscitivo”, […] per Husserl è possibile cogliere intuitivamente gli oggetti ideali» (p. 52). L’Autrice mette in luce il fatto che le rappresentazioni simboliche (intese come rappresentazioni improprie) contengono in sé un rinvio al «pre-logico». È proprio in virtù di questo «presupposto pre-logico» che il rappresentare simbolico, sebbene improprio, non si vede precluso un orizzonte di possibile datità. L’intuizione categoriale viene poi tematizzata in maniera analitica nell’ultimo capitolo del libro, di cui posso ricordare solo alcune pagine. L’Autrice, richiamandosi a Lohmar, distingue tre diversi livelli dell’intuizione categoriale (p. 173). In primis, la percezione semplice o «percezione complessiva» (Gesamtwahrnehmung), che offre un oggetto sensibile «unitario» (per esempio una porta rossa). Successivamente, la «percezione specifica» o «intenzione esplicitante», che è «ancora percezione, dunque un atto semplice», anche se «non ha più un carattere complessivo»; a questo livello «l’atto non è ancora mutato: ci limitiamo a concentrare il nostro interesse percettivo su un momento dell’intero» (nell’esempio, il rosso della porta). Infine, l’intuizione categoriale, dove «le parti esplicitate della Sonderwahrnehmung vengono ricombinate e connesse da un atto categoriale e sintetico» (l’esser-rossa-della-porta, il giudizio ‘la porta è rossa’). Secondo l’Autrice – e qui veniamo a uno snodo fondamentale del testo – il «fenomeno decisivo, sul piano categoriale, avviene già nel passaggio dalla Gesamtwahrnehmung alla Sonderwahrnhemung, le quali rientrano ancora nella modalità intuitiva semplice, sensibile». In questo livello intermedio si mostrerebbe dunque una strutturale e positiva ambiguità dell’intuizione: il momento esplicitante si configura come una «sintesi della coincidenza» che «non è ancora una formazione categoriale, ma non è neppure più o soltanto un contenuto sensibile. […] È proprio in questo discrimine interno alla sensibilità ma già aperto sul categoriale, in questo tratto di scivolosa commistione tra intuizione primaria e secondaria che il precategoriale fa valere il proprio impatto problematico all’interno della Sesta Ricerca» (pp. 175-176, corsivo mio).
significante)». Se per Brentano «le rappresentazioni improprie e i giudizi su di esse fondati avevano carattere “pseudo-conoscitivo”, […] per Husserl è possibile cogliere intuitivamente gli oggetti ideali» (p. 52). L’Autrice mette in luce il fatto che le rappresentazioni simboliche (intese come rappresentazioni improprie) contengono in sé un rinvio al «pre-logico». È proprio in virtù di questo «presupposto pre-logico» che il rappresentare simbolico, sebbene improprio, non si vede precluso un orizzonte di possibile datità. L’intuizione categoriale viene poi tematizzata in maniera analitica nell’ultimo capitolo del libro, di cui posso ricordare solo alcune pagine. L’Autrice, richiamandosi a Lohmar, distingue tre diversi livelli dell’intuizione categoriale (p. 173). In primis, la percezione semplice o «percezione complessiva» (Gesamtwahrnehmung), che offre un oggetto sensibile «unitario» (per esempio una porta rossa). Successivamente, la «percezione specifica» o «intenzione esplicitante», che è «ancora percezione, dunque un atto semplice», anche se «non ha più un carattere complessivo»; a questo livello «l’atto non è ancora mutato: ci limitiamo a concentrare il nostro interesse percettivo su un momento dell’intero» (nell’esempio, il rosso della porta). Infine, l’intuizione categoriale, dove «le parti esplicitate della Sonderwahrnehmung vengono ricombinate e connesse da un atto categoriale e sintetico» (l’esser-rossa-della-porta, il giudizio ‘la porta è rossa’). Secondo l’Autrice – e qui veniamo a uno snodo fondamentale del testo – il «fenomeno decisivo, sul piano categoriale, avviene già nel passaggio dalla Gesamtwahrnehmung alla Sonderwahrnhemung, le quali rientrano ancora nella modalità intuitiva semplice, sensibile». In questo livello intermedio si mostrerebbe dunque una strutturale e positiva ambiguità dell’intuizione: il momento esplicitante si configura come una «sintesi della coincidenza» che «non è ancora una formazione categoriale, ma non è neppure più o soltanto un contenuto sensibile. […] È proprio in questo discrimine interno alla sensibilità ma già aperto sul categoriale, in questo tratto di scivolosa commistione tra intuizione primaria e secondaria che il precategoriale fa valere il proprio impatto problematico all’interno della Sesta Ricerca» (pp. 175-176, corsivo mio).Federica Buongiorno può dunque affermare che il precategoriale, costituendo la “radice sensibile” dell’intuizione categoriale, è implicitamente presente nella Sesta Ricerca. Questa tesi non è affatto ovvia. L’Autrice, infatti, riconosce con Lohmar che a livello di quest’opera (nelle quale le analisi genetiche sono lasciate da parte) la percezione è assunta «a-problematicamente». Del resto, già nell’“Introduzione” si legge che il tentativo di tematizzare il precategoriale nel primo Husserl si scontra con un dato innegabile: il carattere statico e non genetico delle analisi delle Ricerche Logiche. Eppure il problema può e deve essere posto, perché tanto il carattere «complessivo» della percezione quanto la «sintesi della coincidenza» risulterebbero difficilmente spiegabili senza presupporre questo riferimento al precategoriale. Ci si può infatti chiedere: «come fa la percezione ad afferrare A come un intero?» (p. 206). È per rispondere a domande come questa che l’Autrice richiama, come «supplemento concettuale indispensabile» (p. 180), la nozione di Typus, che Husserl guadagnerà successivamente, nella quale è possibile individuare quella forma di «schematismo fenomenologico» che costituisce un presupposto implicito dell’intuizione categoriale. Proprio a partire da questo schematismo fenomenologico si rende inoltre apprezzabile la differenza tra Husserl e Kant, sulla quale l’Autrice insiste in vari luoghi ma che emerge molto incisivamente dalla considerazione della Terza ricerca. La «riconsiderazione dei rapporti tra sfera analitica e sintetica» – rendendo pensabile un rapporto che ha carattere essenziale e analitico, pur implicando una sintesi (è il caso del legame essenziale tra qualità e intensità) – permette ad Husserl di «fondare esteticamente l’apriori» (p. 120). Attraverso l’apriori materiale Husserl riferisce la forma «“alle cose stesse”» (p. 125), «sono gli oggetti a fornire il Leitfaden della conoscenza» (p. 127).
Il radicamento dell’intuizione categoriale in una sensibilità “ibrida” e “già aperta al categoriale”, e così l’idea secondo la quale la sensibilità racchiude una “logica degli oggetti”, sono aspetti particolarmente emblematici del modo in cui il primo Husserl pensa il precategoriale. Ma è forse proprio in questa logica degli oggetti che il tentativo husserliano sembra essere attraversato da quella problematicità che rappresenta un aspetto essenziale del fenomeno del precategoriale, il contrassegno della sua “eccedenza” rispetto al categoriale. Si può infatti dire che se da un lato l’intuizione categoriale, esibendo il necessario radicamento del categoriale nella sensibilità, è una condizione per porre il problema del precategoriale, dall’altro si ha l’impressione che in Husserl l’“anteriorità originaria” del precategoriale rimanga limitata a questa predelineazione delle categorie nella sensibilità. Ciò è del resto riconosciuto dall’Autrice in un passo dell’“Introduzione” che ho già citato, ma che voglio richiamare di nuovo. Vi si dice, per l’appunto, che la «tensione» provocata dal precategoriale non può «essere risolta richiamandosi alla predelineazione del categoriale nel suo fondamento ante-predicativo, sebbene sia questo il ragionevole orizzonte interpretativo nel quale disporre il problema» (corsivo mio). Per questo motivo il libro di Federica Buongiorno suggerisce la necessità di pensare il precategoriale non solo «con» Husserl, ma anche «oltre» Husserl.
A mio avviso, le ultime pagine di questo testo possono essere lette come una ripresa e una radicalizzazione della situazione problematica presentata nell’“Introduzione”, dove il precategoriale è indicato come un fenomeno situato «nello scivoloso discrimine tra originarietà e descrittività» (p. XII). Questa radicalizzazione è operata facendo riferimento alla «paradossalità» fenomenologica del soggetto (come soggetto e come oggetto, come costituente e costituito), che rappresenta secondo l’Autrice «la cifra stessa della fenomenologia». In effetti, lo statuto paradossale del soggetto comporta una difficoltà teoretica analoga alla più volte segnalata “problematica anteriorità” del precategoriale. Ma in che senso si può dire che la domanda sul soggetto costituisce una radicalizzazione della domanda sul precategoriale? Leggendo queste ultime pagine la risposta sembra essere la seguente: la commistione tra «passività» e «attività» oppure tra «intuizione» e «pensiero», fin qui affrontata in stretto rapporto all’intuizione categoriale, viene ora pensata come essenzialmente appartenente alla struttura del soggetto. Da questo punto di vista, a essere ambigua non è innanzitutto la sensibilità, come mostra l’analisi dell’intuizione categoriale, ma la stessa soggettività umana. La questione del precategoriale, dunque, comporta non soltanto un abbandono del presupposto antropologico kantiano (la divisione della capacità conoscitiva in sensibilità e intelletto) ma mette la fenomenologia di fronte alla domanda «come è l’uomo?», domanda che secondo l’Autrice è presente nel pensiero di Husserl, pur restando «difficilmente dipanabile» al suo interno.
Per concludere, questo libro, nel suo lato più strettamente husserliano, mostra in maniera filologicamente dettagliata come il problema del precategoriale conduca all’elaborazione di una logica delle forme sensibili che trova – diversamente che in Kant – negli oggetti stessi il proprio filo guida. D’altro canto, le ultime pagine di questo testo, rivendicando una aspirazione teoretica che va oltre il testo husserliano, indicano nella domanda antropologica «come è l’uomo?» una via più radicale per pensare il precategoriale.
di Fabio Pellizzer
-
Femminile in un uomo
Lacaniana, Serial / Aprile 2015«Che ne è del femminile nell'analisi di un uomo?» Domanda tutt’altro che semplice e ingenua quella postami da una collega psicoanalista e che dava il là a queste note. Tale domanda infatti presuppone non solo che il femminile riguardi un uomo, non meno di
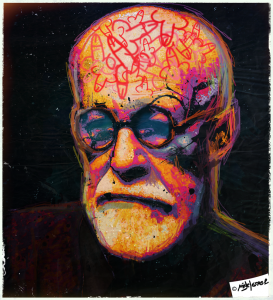 una donna, ma anche che l'esperienza analitica possa incidere sul modo in cui un uomo può fare posto e trattare il femminile che lo abita piuttosto che espellerlo sulla via di quelle che, con Freud, possiamo chiamare le “insegne falliche”. Lungi dall'essere riducibile all'organo sessuale maschile, il fallo è piuttosto quel simbolo che, nel linguaggio, viene a rappresentare ciò che l'essere parlante incontra come mancanza fondamentale che specifica del suo essere al mondo. In un certo senso la scoperta freudiana dell'inconscio va di pari passo alla constatazione che, a livello dell'inconscio, esiste una certa “democrazia” tra i sessi per ciò che concerne il fallo. Proprio in quanto il fallo non coincide con l'organo, il pene, esso riguarda entrambe i sessi, pertanto, almeno per il discorso analitico, non è su questo piano che si può operare la differenziazione sessuale tra maschile e femminile. Il fallo è una risposta in termini di avere/non avere a una questione che concerne l'essere nel suo rapporto con il reale del sesso e, al contempo, con il linguaggio in cui esso viene al mondo. Il fallo, dunque, apre e struttura il campo della significazione dell'esperienza umana, introducendo il soggetto a una dialettica fondata sul dono, dialettica che, per quanto illusoria, renderebbe possibile lo scambio tra l'uno e l'altro.
una donna, ma anche che l'esperienza analitica possa incidere sul modo in cui un uomo può fare posto e trattare il femminile che lo abita piuttosto che espellerlo sulla via di quelle che, con Freud, possiamo chiamare le “insegne falliche”. Lungi dall'essere riducibile all'organo sessuale maschile, il fallo è piuttosto quel simbolo che, nel linguaggio, viene a rappresentare ciò che l'essere parlante incontra come mancanza fondamentale che specifica del suo essere al mondo. In un certo senso la scoperta freudiana dell'inconscio va di pari passo alla constatazione che, a livello dell'inconscio, esiste una certa “democrazia” tra i sessi per ciò che concerne il fallo. Proprio in quanto il fallo non coincide con l'organo, il pene, esso riguarda entrambe i sessi, pertanto, almeno per il discorso analitico, non è su questo piano che si può operare la differenziazione sessuale tra maschile e femminile. Il fallo è una risposta in termini di avere/non avere a una questione che concerne l'essere nel suo rapporto con il reale del sesso e, al contempo, con il linguaggio in cui esso viene al mondo. Il fallo, dunque, apre e struttura il campo della significazione dell'esperienza umana, introducendo il soggetto a una dialettica fondata sul dono, dialettica che, per quanto illusoria, renderebbe possibile lo scambio tra l'uno e l'altro.Concepire la differenza tra maschile e femminile a partire dalla logica fallica, logica binaria, fondata sull'opposizione di un più a un meno, lascia aperta l'idea o quanto meno l'illusione che tale differenza sia “eliminabile” in base a un principio di parità tra i sessi del tipo: “Ciò che non ho oggi potrò averlo un domani o, al rovescio, ciò che ho posso prodigarmi a donarlo all'altro, riconosciuto come sprovvisto di tale bene”. Si tratta della dialettica dello scambio che, lungi dall'essere istintivamente predeterminata o “naturale”, tenta di organizzare il rapporto tra gli umani delimitandone il campo della più parte delle manifestazioni cosiddette affettive che presiedono alle condotte dell'individuo nel rapporto coi suoi simili: gelosia, invidia, aggressività, oblatività, amore narcisistico... In questo senso la logica fallica tenderebbe a situare la differenza sessuale lungo una scala graduata che va dal più al meno, in una sorta di gerarchia che determina anche tutte le sfumature immaginarie del potere. Come detto poco fa non è tuttavia su questo piano che, già a detta di Freud, si iscrive la differenza tra maschile e femminile, non meno che sul piano dei caratteri primari che ci si ritrova tra le gambe o, ancora, a partire della prevalenza di una lettera X o Y scritta geneticamente su un'elica alla quale oggi l'essere parlante cerca sempre più di ancorare il suo destino.

Lacan, riprendendo la lettera freudiana, esplora inizialmente la differenza tra i sessi passando anch'egli attraverso la dialettica del fallo, ma operando al contempo uno spostamento e una nuova condensazione rispetto al Freud che troviamo nel testo La significazione del fallo. In relazione al fallo l'uomo si situerebbe dal lato dell'averlo, a differenza della donna che viceversa tenderebbe a collocarsi dal lato dell'esserlo. Queste due differenti posizioni in relazione al fallo specificherebbero la commedia dei sessi e tutta la parata amorosa, soprattutto per ciò che concerne la dimensione del desiderio che interviene tra il maschile e il femminile, qui presi come posizioni sessuate al di là del sesso “biologico”. Biologico è qui tra virgolette in quanto, per ciò che concerne l'essere parlante, il ritrovarsi dal lato uomo o donna non può prescindere dal linguaggio, dalla dimensione simbolica e da come ciascuno, letteralmente, la incarna. Per tale ragione, almeno per il discorso analitico, è improprio parlare di identità sessuale, per il semplice fatto che rispetto all'assunzione del sesso entra in gioco un impossibile, l'impossibile di fare Uno. Il sesso non solo non fa identità ma, al rovescio, è proprio ciò su cui ciascun soggetto incontra la sua disparità assoluta, l'alterità sia nel rapporto con l'altro da sé che in se stesso.
Ebbene, sia in Freud che in Lacan, il femminile, proprio perché non prendibile nella logica regolata dal fallo, a cui può essere invece ricondotto il maschile, si presenta come l'alterità per eccellenza, come quel “continente nero” che sfugge alla presa da parte del simbolico, del linguaggio e che piuttosto rinvia al reale del corpo godente. Lacan non indietreggerà di fronte a questo “continente nero” e negli ultimi anni del suo insegnamento riprenderà la questione del femminile proprio a partire dall'elaborazione di un godimento Altro non regolato e sottomesso alla logica fallica, godimento caratterizzato da una certa infinitezza a cui una donna, non meno di un uomo, può accedere senza tuttavia poterne dire niente poiché strutturalmente imprendibile dal linguaggio. Lacan esplorerà il godimento propriamente femminile non solo a partire dall'elaborazione dell'esperienza analitica, ma anche attraverso lo studio delle testimonianze di alcuni mistici, quali San Giovanni della Croce e Santa Teresa D'Avila.
 Torno ora alla domanda di partenza postami dalla collega: «Che ne è del femminile nell'analisi di un uomo?». Non saprei! Ciò che tuttavia da questo non sapere posso dire è che l'analisi si è per me caratterizzata come una sorta di percorso a ostacoli, dove ogni ostacolo rappresentava l'identificazione inconscia prelevata nel campo dell'Altro a cui il mio essere si era come abbarbicato nell'impossibile tentativo di darsi un'identità, un Io con cui rispondere alla meno peggio al proprio essere nel mondo. Ebbene l'analisi, con mia grande sorpresa e non senza orrore, conduceva alla caduta di queste identificazioni che, in ultimo, scoprivo ruotare attorno a un unico perno, a un'identificazione primaria agita rispetto al padre, inteso qui come funzione più ancora che come individuo. La caduta di queste identificazioni “falliche”, su cui tanto il sintomo quanto l'Io si sostenevano, lasciava ora il posto al confronto con un altro “substrato identificatorio” che, con Freud, potremmo chiamare identificazioni per “appoggio” o anaclitiche, radicate in misura maggiore al legame col materno, legame tanto oscuro quanto difficile da sbrogliare, per il carattere tenace di un attaccamento ancorato più alla parzialità di alcuni oggetti afferenti al corpo (bocca, ano, sguardo, voce) che al linguaggio, ovvero all'Altro simbolico. Allora se qualcosa del femminile ha potuto trovare posto nella mia analisi è stato non solo nell'andare appunto al di là delle identificazioni falliche inconsce su cui l'Io si sosteneva, ma anche operando il distacco da quegli oggetti parziali su cui il soggetto basava la sua singolare e ripetitiva modalità di godimento. In questo litorale ritagliato tra il linguaggio ridotto alla sua dimensione di catena significante insensata e il corpo preso non tanto nella sua forma o immagine quanto nella sua esperienza pulsionale, il femminile poteva tratteggiarsi quale effetto “leggero” di un atto che apriva al nuovo, all'impensato, all'inedito, all'intima alterità.
Torno ora alla domanda di partenza postami dalla collega: «Che ne è del femminile nell'analisi di un uomo?». Non saprei! Ciò che tuttavia da questo non sapere posso dire è che l'analisi si è per me caratterizzata come una sorta di percorso a ostacoli, dove ogni ostacolo rappresentava l'identificazione inconscia prelevata nel campo dell'Altro a cui il mio essere si era come abbarbicato nell'impossibile tentativo di darsi un'identità, un Io con cui rispondere alla meno peggio al proprio essere nel mondo. Ebbene l'analisi, con mia grande sorpresa e non senza orrore, conduceva alla caduta di queste identificazioni che, in ultimo, scoprivo ruotare attorno a un unico perno, a un'identificazione primaria agita rispetto al padre, inteso qui come funzione più ancora che come individuo. La caduta di queste identificazioni “falliche”, su cui tanto il sintomo quanto l'Io si sostenevano, lasciava ora il posto al confronto con un altro “substrato identificatorio” che, con Freud, potremmo chiamare identificazioni per “appoggio” o anaclitiche, radicate in misura maggiore al legame col materno, legame tanto oscuro quanto difficile da sbrogliare, per il carattere tenace di un attaccamento ancorato più alla parzialità di alcuni oggetti afferenti al corpo (bocca, ano, sguardo, voce) che al linguaggio, ovvero all'Altro simbolico. Allora se qualcosa del femminile ha potuto trovare posto nella mia analisi è stato non solo nell'andare appunto al di là delle identificazioni falliche inconsce su cui l'Io si sosteneva, ma anche operando il distacco da quegli oggetti parziali su cui il soggetto basava la sua singolare e ripetitiva modalità di godimento. In questo litorale ritagliato tra il linguaggio ridotto alla sua dimensione di catena significante insensata e il corpo preso non tanto nella sua forma o immagine quanto nella sua esperienza pulsionale, il femminile poteva tratteggiarsi quale effetto “leggero” di un atto che apriva al nuovo, all'impensato, all'inedito, all'intima alterità.Il fatto che il femminile non si possa dire non toglie tuttavia che, a posteriori, ogni soggetto, uno per uno, non possa rintracciare le contingenze in cui tale incontro avrà potuto effettuarsi. Almeno questo è quanto Freud, prima, e Lacan, dopo, invitano gli analisti a fare. Forse le colleghe analiste potranno, ancora una volta e un domani, tornare a dirne ulteriormente qualcosa e a interrogare i colleghi analisti proprio su questo enigma.
di Sergio Caretto
-
La psicoanalisi e le donne
Lacaniana, Serial / Febbraio 2015La psicoanalisi e le donne hanno sempre camminato insieme sin dalla nascita della prima. Diverse donne, nel tempo inaugurale della psicoanalisi, hanno aperto a Freud la via del transfert e gli hanno mostrato l’essenziale circa il nesso tra i sintomi di origine psichica e la sessualità. Cosa possiamo cogliere circa la specificità del rapporto tra la psicoanalisi e il femminile?
All’origine della psicoanalisi c’è l’incontro tra Freud e alcune isteriche. Isteria e femminile non coincidono in modo totale, ma vi è qualcosa nella logica dell’isteria che consente di connettersi col femminile. Freud constata che, nell’esperienza clinica, certi sintomi resistevano sia a trattamenti che avevano una presa diretta sul corpo (idroterapia, pranoterapia, ecc.), sia al trattamento che avrebbe avuto una presa diretta sullo psichismo: l’ipnosi. Così facendo, egli prende atto e nota del fatto che vi sia una discontinuità, qualcosa che esiste nella sua materialità e che, però, non si lascia trattare allo stesso modo delle altre sostanze materiali con cui la scienza medica è abituata ad aver a che fare. Freud incontra molto presto quel punto limite d’intrattabilità e ciò lo spinge a inventare la psicoanalisi e a proseguire, lungo tutta la vita, nella sua elaborazione, rilanciandola ogni volta che trova che quel punto insiste e chiama a una riformulazione della teoria. Nel testo sull’Interpretazione dei sogni lo chiama “l’ombelico del sogno”, mentre in Analisi terminabile e interminabile, scritto al termine della sua carriera, “la roccia della castrazione”. Per Lacan sarà il reale, l’impossibile.
È a partire da ciò che egli ipotizza l’esistenza dell’inconscio in quanto sessuale; giacché è con l’inconscio e con le sue elucubrazioni di lalingua, che il soggetto cerca di trattare questo impossibile strutturale. La sessualità umana, per la psicoanalisi, è una sessualità che non corrisponde a una sessuologia, poiché essa non è associata a una sorta di “manuale d’uso” che potrebbe spiegare al soggetto come utilizzarla. La sessualità non è nemmeno legata all’istinto. L’istinto e la biologia dettano agli animali quando, come e con quale simile soddisfare l’appetito legato alla necessità della specie di riprodursi. Per l’essere vivente che è preso dal e nel linguaggio, il parlessere, il modo in cui si situerà nella propria sessualità, come uomo o come donna, non è qualcosa di già dato sin dalla nascita. Ciascuno, a partire da certe condizioni– condizioni che non ha scelto, ma con le quali dovrà giocarsi la sua partita –, transitando attraverso un percorso fatto di identificazioni e di godimenti, arriverà a scegliere inconsciamente di posizionarsi dal lato maschile o dal lato femminile, in relazione alla propria sessualità.
Dal lato uomo troviamo una modalità di godimento legata alla logica fallica, logica del tutto, dell’universale. Grazie al significante fallico il soggetto può trovare un orientamento simbolico universalizzante che lo aiuta a raccapezzarsi con quella sessualità che nulla e nessuno gli può spiegare. L’organo sessuale maschile e il tipo di godimento che da esso il soggetto può trarre, rappresenta bene, sul piano del godimento, questa logica universale del tutto. La posizione maschile di godimento è identificata con la parvenza di avere il fallo e questo produce, nel soggetto così situato, una condizione tale per cui il proprio modo di godere è modulato secondo la logica del o tutto o niente, in concordanza con l’alternanza tumescenza-detumescenza propria dell’organo che viene identificato con il fallo (anche se non lo è). Da questo lato, l’immagine anatomica contribuisce a fissare in modo più assoluto il soggetto maschile al godimento fallico. Godimento che, nel
 Seminario Ancora, Lacan nomina come “godimento dell’idiota”. Dal lato donna, la logica fallica e il godimento che le è proprio è anche presente. In questa logica, il soggetto donna è nella posizione che l’identifica a essere il fallo, per sé e per l’altro. L’anatomia, che le rivela che non ce l’ha, non le impedisce di poter godere anche lei in modo fallico, a livello del corpo ma anche fuori dal corpo. Nulla vieta a una donna, per esempio, di godere del potere – sostituto fallico per eccellenza – allo stesso modo di un suo collega uomo, né di ottenere della soddisfazione sessuale attraverso un godimento fallico. Freud non ha mai smesso di interrogarsi sulla specificità delle donne, arrivando a concludere che la donna fosse caratterizzata dall’assumersi la castrazione, superando l’invidia del pene. Ciò però non basta per spiegare la specificità femminile, poiché l’assunzione della castrazione pertiene anche al mondo maschile, dal momento che il fallo simbolico – che manca all’uno e all’altra – non coincide con l’organo maschile. Jacques Lacan non è indietreggiato rispetto a questo impossibile nel quale l’opera freudiana si era arenata, interrogandosi ed elaborando qualcosa di più incisivo sulla specificità del godimento femminile. È questa specificità che fa dire a Lacan che La donna (come universale) non esiste, dal momento che non esiste Il godimento femminile unico e universale. Ciascuna donna può avere, se vi acconsente, un suo rapporto con un godimento al di là del fallo, al di là della castrazione e dell’Edipo, a condizione però di servirsi anche della logica fallica. Diversamente, si aprirebbe il campo al discorso sulla follia, ma questa è un’altra faccenda. Non si tratta, come possiamo vedere, di far coincidere il femminile con l’isteria. Vi è, però, qualcosa che le raccorda, senza sovrapporsi. A partire dei soggetti isterici, Freud scopre un al di là. L’inconscio, che cela un trauma in relazione alla sessualità, è un al di là. Un al di là degli enunciati, del sintomo, del lamento, i quali rivelano di essere dei messaggi da decifrare, solo a partire dal fatto che ci sia qualcuno che si metta nella posizione di volerlo cogliere e accogliere. L’isteria si difende dal sessuale insito nell’inconscio e perciò produce dei sintomi. L’isterica si difende dal godimento Altro, ma proprio perché si difende può trovarsi nella posizione opportuna per accedervi.
Seminario Ancora, Lacan nomina come “godimento dell’idiota”. Dal lato donna, la logica fallica e il godimento che le è proprio è anche presente. In questa logica, il soggetto donna è nella posizione che l’identifica a essere il fallo, per sé e per l’altro. L’anatomia, che le rivela che non ce l’ha, non le impedisce di poter godere anche lei in modo fallico, a livello del corpo ma anche fuori dal corpo. Nulla vieta a una donna, per esempio, di godere del potere – sostituto fallico per eccellenza – allo stesso modo di un suo collega uomo, né di ottenere della soddisfazione sessuale attraverso un godimento fallico. Freud non ha mai smesso di interrogarsi sulla specificità delle donne, arrivando a concludere che la donna fosse caratterizzata dall’assumersi la castrazione, superando l’invidia del pene. Ciò però non basta per spiegare la specificità femminile, poiché l’assunzione della castrazione pertiene anche al mondo maschile, dal momento che il fallo simbolico – che manca all’uno e all’altra – non coincide con l’organo maschile. Jacques Lacan non è indietreggiato rispetto a questo impossibile nel quale l’opera freudiana si era arenata, interrogandosi ed elaborando qualcosa di più incisivo sulla specificità del godimento femminile. È questa specificità che fa dire a Lacan che La donna (come universale) non esiste, dal momento che non esiste Il godimento femminile unico e universale. Ciascuna donna può avere, se vi acconsente, un suo rapporto con un godimento al di là del fallo, al di là della castrazione e dell’Edipo, a condizione però di servirsi anche della logica fallica. Diversamente, si aprirebbe il campo al discorso sulla follia, ma questa è un’altra faccenda. Non si tratta, come possiamo vedere, di far coincidere il femminile con l’isteria. Vi è, però, qualcosa che le raccorda, senza sovrapporsi. A partire dei soggetti isterici, Freud scopre un al di là. L’inconscio, che cela un trauma in relazione alla sessualità, è un al di là. Un al di là degli enunciati, del sintomo, del lamento, i quali rivelano di essere dei messaggi da decifrare, solo a partire dal fatto che ci sia qualcuno che si metta nella posizione di volerlo cogliere e accogliere. L’isteria si difende dal sessuale insito nell’inconscio e perciò produce dei sintomi. L’isterica si difende dal godimento Altro, ma proprio perché si difende può trovarsi nella posizione opportuna per accedervi.Il soggetto isterico è un soggetto diviso, che testimonia che vi è in lui un qualcosa da svelare, un al di là, appunto, anche quando spesso lui stesso oppone resistenza a questo svelamento. Le donne, a partire da una condizione che le caratterizza e rispetto alla quale sono in un certo modo privilegiate, oltre a essere iscritte nel godimento fallico, possono avere – se lo vogliono – accesso a un godimento Altro. L’inconscio non coincide con questo godimento Altro, il godimento femminile, come lo chiama Lacan; ma un modo per accedervi è quello di passare attraverso l’esperienza dell’inconscio, così come accade durante un’analisi. Quando un soggetto – uomo o donna – entra in analisi, ciò di cui fa esperienza è che i suoi sintomi, i suoi comportamenti, i suoi enunciati rivelano Altro da ciò che credeva; non solo un altro senso, ma addirittura un altro godimento. Cogliere questo, man mano, nell’analisi, conduce il soggetto ad acconsentire e accettare quell’altra logica, innanzitutto rispetto a sé, e di conseguenza anche rispetto agli altri. Accettare che vi sia un Altro godimento, forme di godere altre e diverse da quella sostenuta dall’Io, dal discorso cosiddetto comune, che è quello del padrone.
Passare attraverso l’esperienza di un’analisi e portarla a termine, può essere il modo, per una donna, di accedere al godimento specificamente femminile, il quale non si può afferrare, né dire, né localizzare da nessuna parte, ma, talvolta, lo si può provare.
di Maria Laura Tkach
-
Jean-Luc Nancy – Dov’è successo?
Recensioni / Febbraio 2015 Il tema dell'archivio, oggetto dell'intervista di Nathalie Léger a Jean-Luc Nancy qui proposta in traduzione italiana a cura di Igor Pelgreffi, acquista nel corso del Novecento una sempre maggiore autonomia dalle discipline che se ne sono occupate tradizionalmente, in primo luogo la storia e la filologia. Dal punto di vista filosofico, emerge così progressivamente la domanda sul senso dell'archivio e sugli effetti che esso può determinare sulle opere e sull'immagine stessa di un autore. In altre parole, come ricorda il curatore in apertura del saggio introduttivo, «come esaminare il passato del proprio lavoro? Qual è la sua materia, quali sono i suoi oggetti? Qual è la parte della cancellazione e della distruzione? Come iniziare con ciò che resta?» Innanzitutto, ogni archivio è un luogo. Non solo nel senso dello spazio fisico in cui sono raccolte le opere di uno o più autori, ma uno spazio entro cui sono possibili certe operazioni intellettuali: infatti, se da un lato l'archivio rappresenta una risorsa insostituibile nel processo di analisi del pensiero di un filosofo, nella conservazione delle sue opere e nella costruzione della sua immagine futura, dall'altro lato esso apre una serie di interrogativi filosofici inediti, relativi al funzionamento dell'archiviazione, al suo duplice carattere di mantenimento e perdita, al momento a partire dal quale si può dire di aver davvero archiviato qualcosa. In sintesi, dove e a chi (o a cosa) accade l'archiviazione? È questo l'interrogativo di fondo attorno a cui si snoda tutto il discorso di Nancy, d'ispirazione decostruttiva, qui presentato. Come osserva acutamente Pelgreffi, «non possiamo comprendere l'archivio se non immaginiamo un intreccio fra spazio dell'archivio e tempo dell'archivio così come fra spazio dell'archiviazione e tempo dell'archiviazione, cioè quello che, in termini derridiani, potremmo pensare come una différance spazio-temporale, nel senso di una spazializzazione del tempo e di una temporalizzazione dello spazio.» Ed è senza dubbio in consonanza col pensiero di Derrida che Nancy costruisce il proprio discorso sull'arché e sull'istituzione dell'archivio, col risultato - paradossale, come quasi sempre accade seguendo un approccio derridiano o,
Il tema dell'archivio, oggetto dell'intervista di Nathalie Léger a Jean-Luc Nancy qui proposta in traduzione italiana a cura di Igor Pelgreffi, acquista nel corso del Novecento una sempre maggiore autonomia dalle discipline che se ne sono occupate tradizionalmente, in primo luogo la storia e la filologia. Dal punto di vista filosofico, emerge così progressivamente la domanda sul senso dell'archivio e sugli effetti che esso può determinare sulle opere e sull'immagine stessa di un autore. In altre parole, come ricorda il curatore in apertura del saggio introduttivo, «come esaminare il passato del proprio lavoro? Qual è la sua materia, quali sono i suoi oggetti? Qual è la parte della cancellazione e della distruzione? Come iniziare con ciò che resta?» Innanzitutto, ogni archivio è un luogo. Non solo nel senso dello spazio fisico in cui sono raccolte le opere di uno o più autori, ma uno spazio entro cui sono possibili certe operazioni intellettuali: infatti, se da un lato l'archivio rappresenta una risorsa insostituibile nel processo di analisi del pensiero di un filosofo, nella conservazione delle sue opere e nella costruzione della sua immagine futura, dall'altro lato esso apre una serie di interrogativi filosofici inediti, relativi al funzionamento dell'archiviazione, al suo duplice carattere di mantenimento e perdita, al momento a partire dal quale si può dire di aver davvero archiviato qualcosa. In sintesi, dove e a chi (o a cosa) accade l'archiviazione? È questo l'interrogativo di fondo attorno a cui si snoda tutto il discorso di Nancy, d'ispirazione decostruttiva, qui presentato. Come osserva acutamente Pelgreffi, «non possiamo comprendere l'archivio se non immaginiamo un intreccio fra spazio dell'archivio e tempo dell'archivio così come fra spazio dell'archiviazione e tempo dell'archiviazione, cioè quello che, in termini derridiani, potremmo pensare come una différance spazio-temporale, nel senso di una spazializzazione del tempo e di una temporalizzazione dello spazio.» Ed è senza dubbio in consonanza col pensiero di Derrida che Nancy costruisce il proprio discorso sull'arché e sull'istituzione dell'archivio, col risultato - paradossale, come quasi sempre accade seguendo un approccio derridiano o,come in questo caso, post-derridiano - che proprio l'“oggetto archivio”, la cui istituzione è segnata da un luogo e una data, finisce per essere l'elemento meno stabile per determinare la nostra relazione col passato. Piena continuità, dunque, col testo di Derrida Mal d'archive, di cui questo discorso di Nancy rappresenta idealmente la prosecuzione. Infatti, Nancy condivide la preoccupazione derridiana di una possibile riduzione dell'archivio al mito del “ritorno all'origine”, in altre parole l'istituzione di un luogo a cui consegnare il passato dell'autore, il suo tempo perduto. Al contrario, osservano Derrida e Nancy, non esiste alcuna origine piena da poter rendere presente e disponibile, ma soltanto l'archiviazione che permette di rinvenire la traccia dell'origine. Come osserva
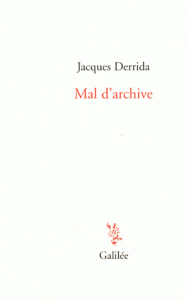 Pelgreffi, da tale confronto con Derrida emerge che il soggetto non è diviso tra due mondi, quello interno e quello sociale, ma è preso nel processo di riassorbimento e rigenerazione delle forme soggettive che dà luogo all'archivio, precedendo dunque ogni dualismo tra interiorità ed esteriorità. Ne consegue che il datum documentale non è un atomo, ma un'unità differenziata, ibrida, divisa originariamente nei suoi elementi giuridici, etici, politici ed esistenziali. Ma se Nancy richiama esplicitamente Derrida, intreccia altresì un dialogo “silenzioso” con Foucault, per il cui pensiero, com'è noto, la nozione di archeologia è di primaria importanza. Dal suo punto di vista, l'archivio permette di chiarire il nesso tra sapere e potere che si manifesta in ogni discorso: in questo senso, l'archivio non è soltanto il luogo fisico dove rinvenire tutte le informazioni su uno o più autori, ma «il sistema generale della formazione e della trasformazione degli enunciati.» In altre parole, secondo Foucault l'archivio si pone a metà strada tra il trascendentale e l'empirico, dà luogo a un ordine terzo rispetto al puramente ideale - la ragione come archetipo perfetto dell'archivio - e all'assolutamente empirico, sciolto da ogni regola discorsiva.
Pelgreffi, da tale confronto con Derrida emerge che il soggetto non è diviso tra due mondi, quello interno e quello sociale, ma è preso nel processo di riassorbimento e rigenerazione delle forme soggettive che dà luogo all'archivio, precedendo dunque ogni dualismo tra interiorità ed esteriorità. Ne consegue che il datum documentale non è un atomo, ma un'unità differenziata, ibrida, divisa originariamente nei suoi elementi giuridici, etici, politici ed esistenziali. Ma se Nancy richiama esplicitamente Derrida, intreccia altresì un dialogo “silenzioso” con Foucault, per il cui pensiero, com'è noto, la nozione di archeologia è di primaria importanza. Dal suo punto di vista, l'archivio permette di chiarire il nesso tra sapere e potere che si manifesta in ogni discorso: in questo senso, l'archivio non è soltanto il luogo fisico dove rinvenire tutte le informazioni su uno o più autori, ma «il sistema generale della formazione e della trasformazione degli enunciati.» In altre parole, secondo Foucault l'archivio si pone a metà strada tra il trascendentale e l'empirico, dà luogo a un ordine terzo rispetto al puramente ideale - la ragione come archetipo perfetto dell'archivio - e all'assolutamente empirico, sciolto da ogni regola discorsiva.Questo duplice dialogo con Derrida e Foucault induce a evidenziare anche un altro fil rouge del testo di Nancy: la questione dell'alterità. Infatti, nell'istituzione dell'archivio è già sempre coinvolto l'altro, in modo tale che la domanda sull'archivio implica anche sempre la questione del rapporto tra archiviazione, estraneità e istituzione. Come ha osservato molte volte Derrida, qualunque processo di istituzione conserva una traccia di ciò che esclude, cioè di quell'estraneità che sceglie originariamente di estromettere dall'istituzione o dall'archiviazione. In sintesi, per dotarsi di una qualche identità, l'archivio, nell'atto della sua istituzione, è costretto a relazionarsi con ciò che sceglie di non archiviare. Deve nominarlo, assumerne le sembianze, in modo tale che può accadere che sia proprio l'escluso dall'archiviazione ad assumersi il compito di conservarne la memoria. Ora, tale intreccio irrisolto tra identità e alterità è continuamente rilanciato da Nancy in questo testo, ad esempio attraverso la questione “che cos'è un'opera?” - come nota il curatore, vero e proprio contrappunto alla domanda di Foucault “che cos'è un autore?”, oggetto di una conferenza al Collège de France del 1969.
Volendo individuare la tesi portante del discorso di Nancy, attorno a cui si annodano tutti i vari temi che egli affronta in questo breve testo, si potrebbe azzardare la seguente affermazione: l'archivio sottrae l'autore stesso a qualunque forma di sapere oggettivo. Il che significa che non si potrà mai raggiungere una qualche conoscenza definitiva e cogente di «chi è diventato questa firma che offre il suo nome, i suoi tratti, il suo carattere»all'archiviazione: quest'ultima resterà sempre un processo che non consente di afferrare concettualmente la natura del proprio rapporto con un certo autore, benché lo riguardi direttamente. In altre parole, chi è diventato l’autore, una volta che transita dal proprio archivio? Nancy risponde: «Nessuno che noi possiamo nominare o circoscrivere in alcun modo. “Gli archivi di X” sono un modo di far indietreggiare X più lontano, più in profondità nei suoi archivi. Noi vediamo i suoi tentativi, le sue note, le sue esitazioni, le sue vergogne forse, le sue dissimulazioni, i suoi oblii: ma lui, “lui”, dov’è?».
di Claudio Tarditi
-
Corpo e linguaggio
Lacaniana, Serial / Gennaio 2015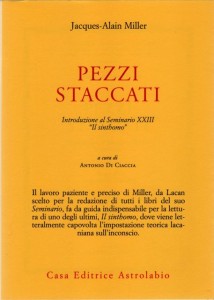 Jacques-Alain Miller (2006a), nel commento al Seminario XXIII – Il sinthomo di Lacan (2006a), sottolinea che, da un punto di vista psicoanalitico, «il corpo è paragonabile a un ammasso di pezzi staccati. Non ce ne rendiamo conto tanto che restiamo catturati dalla sua forma, tanto che la pregnanza della sua forma impone l’ideale della sua unità» (p. 13). Lo statuto primitivo del corpo, contrariamente all’evidenza del visibile, è infatti di essere in pezzi staccati e, affinché il bambino possa percepire il proprio corpo come una unità, occorre che sia passato attraverso quello che Lacan (2002a) considera un vero e proprio «crocevia strutturale» (p. 107) nello sviluppo. Nel 1936, riprendendo le ricerche sperimentali sulla percezione compiute da Henri Wallon, Lacan indica con il nome di stadio dello specchio quella fase in cui il lattante, tra i sei e i diciotto mesi, ancora immerso in uno stato di frammentazione, impotenza e di prematurazione fisiologica, risponde in modo giubilatorio alla vista della propria immagine riflessa nello specchio. L’immagine speculare permette al bambino un primo riconoscimento, una prima identificazione e, contemporaneamente, segna uno iato incolmabile poiché egli non potrà mai ricongiungersi all’immagine che lo specchio gli rimanda. Scrive Lacan (2002b): «questa Gestalt […] simbolizza la permanenza mentale dell’io e al tempo stesso ne prefigura la destinazione alienante» (p. 89). In questo passo, possiamo già trovare l’idea del soggetto lacaniano come strutturalmente diviso ed è per questa via che Lacan (2002a) sottolinea la dimensione tragica dello stadio dello specchio, la cui essenza è quella di essere una «lacerazione originale» (p. 110) in cui l’essere del soggetto è per sempre separato dalla sua proiezione ideale.
Jacques-Alain Miller (2006a), nel commento al Seminario XXIII – Il sinthomo di Lacan (2006a), sottolinea che, da un punto di vista psicoanalitico, «il corpo è paragonabile a un ammasso di pezzi staccati. Non ce ne rendiamo conto tanto che restiamo catturati dalla sua forma, tanto che la pregnanza della sua forma impone l’ideale della sua unità» (p. 13). Lo statuto primitivo del corpo, contrariamente all’evidenza del visibile, è infatti di essere in pezzi staccati e, affinché il bambino possa percepire il proprio corpo come una unità, occorre che sia passato attraverso quello che Lacan (2002a) considera un vero e proprio «crocevia strutturale» (p. 107) nello sviluppo. Nel 1936, riprendendo le ricerche sperimentali sulla percezione compiute da Henri Wallon, Lacan indica con il nome di stadio dello specchio quella fase in cui il lattante, tra i sei e i diciotto mesi, ancora immerso in uno stato di frammentazione, impotenza e di prematurazione fisiologica, risponde in modo giubilatorio alla vista della propria immagine riflessa nello specchio. L’immagine speculare permette al bambino un primo riconoscimento, una prima identificazione e, contemporaneamente, segna uno iato incolmabile poiché egli non potrà mai ricongiungersi all’immagine che lo specchio gli rimanda. Scrive Lacan (2002b): «questa Gestalt […] simbolizza la permanenza mentale dell’io e al tempo stesso ne prefigura la destinazione alienante» (p. 89). In questo passo, possiamo già trovare l’idea del soggetto lacaniano come strutturalmente diviso ed è per questa via che Lacan (2002a) sottolinea la dimensione tragica dello stadio dello specchio, la cui essenza è quella di essere una «lacerazione originale» (p. 110) in cui l’essere del soggetto è per sempre separato dalla sua proiezione ideale.Da una parte, dunque, lo stadio dello specchio permette quell’operazione simbolica che offre al soggetto la possibilità di individuarsi come un “io” mentre, dall’altra, è ciò che lo divide irrimediabilmente dalla sua immagine. È a questo livello che si pone la «Spaltung tra il moi che viene a costituirsi e il soggetto dell’inconscio je, che non si lascia reperire nell’immagine speculare, e che troverà modo di presentarsi nei punti di vacillamento dell’io» (Cosenza, 2003, p. 23-24). Nell’analisi di questo momento così importante nella costituzione dell’immagine del corpo Lacan evidenzia il ruolo fondamentale e preliminare svolto dalla madre: ella è colei che tenendo in braccio l’infans gli indica che l’immagine che lo specchio rimanda è la sua. È quindi attraverso l’azione operata da un elemento terzo – in questo caso la madre – eterogeneo alla dimensione della similarità, che «il soggetto si pone come operante, come umano, come io (je), a partire dal momento in cui appare il sistema del simbolico» (Lacan, 2006b, p. 66).
Quanto detto mette in rilievo come il corpo si strutturi a partire dall’apporto dell’immagine e l’esperienza del corpo in frammenti, di cui testimoniano i soggetti schizofrenici, si pone come caso paradigmatico degli effetti provocati dal non accesso alla funzione unificante dell’immagine speculare. Per Eva, una ragazza schizofrenica, per esempio il corpo è piuttosto il luogo di un ritorno nel reale della libido: Eva in certi momenti di vacillazione deve cingere la testa con una fascia perché possa avere la tranquillità «che tutto ciò che è all’interno della testa resti dentro». Quando il bambino viene al mondo, viene già al mondo nel campo dell’Altro simbolico ed è il simbolico che per Lacan costituisce uno dei tre registri, oltre all’immaginario e al reale, che presiede alla nascita e alla formazione del soggetto. Il simbolico, in particolare, è ciò che umanizza il soggetto sottraendolo alla condizione di puro vivente per immetterlo nel legame sociale.
 Nelle Due note sul bambino, Lacan (1987) ci dice che il bambino diventa soggetto solo tramite il desiderio dell’Altro, cioè a partire dal modo in cui la madre, il suo Altro primordiale, ne ha fatto causa del proprio desiderio. Da ciò si coglie che il corpo per l’essere parlante non è più solo un organismo, prodotto di puri bisogni biologici, ma è la risultante della relazione che intercorre tra l’organismo di un vivente e l’Altro del linguaggio. È quindi il simbolico a trasformare l’organismo in corpo e il parlare di corpo implica una trilogia che comporta, oltre al corpo, la parola e l’essere. Per un verso, l’entrata nel campo del linguaggio fa pertanto perdere all’umano lo statuto di essere naturale ma, contemporaneamente, fa guadagnare al corpo uno statuto inedito perché diviene tempio della pulsione: «Come tempio della pulsione il corpo è libidicamente erotizzato, sublimato, sessualmente portatore di una differenza che fa problema, sede di un desiderio che ha fonte in quella perdita di godimento che è correlativa alla iscrizione stessa del simbolico. Ma il corpo è anche ciò che patisce di “quello che non va” e che Lacan chiama “il reale”. È questo reale che si manifesta nel sintomo e che insiste rendendo sofferente il corpo come un impossibile da sopportare ma di cui però non si riesce a fare a meno: “godimento”, lo chiama Lacan» (Miller, 2006b, p. 8).
Nelle Due note sul bambino, Lacan (1987) ci dice che il bambino diventa soggetto solo tramite il desiderio dell’Altro, cioè a partire dal modo in cui la madre, il suo Altro primordiale, ne ha fatto causa del proprio desiderio. Da ciò si coglie che il corpo per l’essere parlante non è più solo un organismo, prodotto di puri bisogni biologici, ma è la risultante della relazione che intercorre tra l’organismo di un vivente e l’Altro del linguaggio. È quindi il simbolico a trasformare l’organismo in corpo e il parlare di corpo implica una trilogia che comporta, oltre al corpo, la parola e l’essere. Per un verso, l’entrata nel campo del linguaggio fa pertanto perdere all’umano lo statuto di essere naturale ma, contemporaneamente, fa guadagnare al corpo uno statuto inedito perché diviene tempio della pulsione: «Come tempio della pulsione il corpo è libidicamente erotizzato, sublimato, sessualmente portatore di una differenza che fa problema, sede di un desiderio che ha fonte in quella perdita di godimento che è correlativa alla iscrizione stessa del simbolico. Ma il corpo è anche ciò che patisce di “quello che non va” e che Lacan chiama “il reale”. È questo reale che si manifesta nel sintomo e che insiste rendendo sofferente il corpo come un impossibile da sopportare ma di cui però non si riesce a fare a meno: “godimento”, lo chiama Lacan» (Miller, 2006b, p. 8).Bibliografia:
Cosenza, D. (2003). Jacques Lacan e il problema della tecnica. Roma: Astrolabio.
Lacan, J. (1987). Due note sul bambino. La Psicoanalisi, 1, 22-23.
Id. (2006a). Il seminario. Libro XXIII. Il sinthomo (1975-1976). Roma: Astrolabio.
Id. (2006b). Il seminario. Libro II. L’io nella teoria di Freud e nella tecnica della psicoanalisi (1954-1955). Torino: Einaudi.
Id. (2002a). Aggressività in psicoanalisi (1948). In Id., Scritti. Vol. 1. Torino: Einaudi.
Id. (2002a). Lo stadio dello specchio come formatore della funzione dell’io In Id., Scritti. Vol. 1. Torino: Einaudi.
Miller, J.-A (2006a). Pezzi staccati. Introduzione al seminario XXIII “Il sintomo”. Roma: Astrolabio.
Id. (Ed.) (2006b). Gli imbrogli del corpo. Roma: Borla.
di Monica Buemi
-
PK#1 \ Il prisma trascendentale. I colori del reale
Rivista / Settembre 2014Non occorre un grande impegno teorico per mostrare come si possa fare filosofia senza ricorrere alla nozione di “trascendentale” ‒ oppure, in maniera più profonda, senza assumere la posizione trascendentale. Lo mostra, banalmente, la storia del pensiero filosofico novecentesco. Dalla filosofia analitica alla filosofia ermeneutica, non si contano le tradizioni filosofiche che hanno reso persuasiva l’idea secondo cui l’interrogazione filosofica potesse ‒ e, anzi, dovesse ‒ articolarsi senza ripetere il gesto fondativo, ovvero senza declinare la domanda sulla fondazione in modo tale da dover passare attraverso la questione trascendentale.
Si fa prima se si interrogano i saperi che descrivono ‒ o spiegano ‒ l’esperienza. Si fa prima se si imposta il discorso filosofico immettendolo nell’alveo del discorso scientifico, il quale parla direttamente dell’esperienza. Un po’ come quando si deve insegnare a qualcuno come si nuota. Gli si mostrano i gesti del nuoto stando sulla riva? No, lo si butta in acqua, magari in acque poco profonde, e gli si insegna, dentro l’acqua, a nuotare. Così, appunto, si fa prima. Assumere la posizione trascendentale, in tale prospettiva, non risulta essere altro che un’inutile perdita di tempo.
Tuttavia, è lecito almeno sollevare un dubbio: si può davvero accordare alla filosofia il ruolo di sapere critico, che interroga i propri fondamenti, quelli degli altri saperi e, più in generale, il fondamento del rapporto tra sapere ed esperienza, senza passare attraverso la nozione di trascendentale? Si può davvero fare a meno di chiedersi sia come è fatto, in generale, il soggetto che fa esperienza del mondo, sia come sono fatti quei mondi ai quali si rapporta ogni esperienza possibile?
Se tale domanda, tale dubbio, risulta anche solo vagamente plausibile, allora si vede bene che perseguire l’obiettivo di praticare una filosofia in qualche modo definibile come “trascendentale” non si configura più come una semplice perdita di tempo.
Tutta la difficoltà sta, ora, nel mettersi d’accordo su ciò che l’espressione “in qualche modo” indica. Lo scopo di questo primo numero consiste nel mettere alla prova alcune possibili letture e declinazioni di tale espressione
A cura di Philosophy Kitchen
Scarica in PDF
English version
DOI: https://doi.org/10.13135/2385-1945/1.2014
Pubblicato: settembre 2014
Indice
Lato I
Giovanni Leghissa - Il trascendentale, ovvero il rimosso della filosofia. Proposte per una terapia [PDF It]
Rocco Ronchi - Puro apparire [PDF It]
Jean-Christophe Goddard - La Wissenschaftslehre. Une contribution décisive à l'anthropologie de la modernité [PDF Fr]
Lato II
Claudio Tarditi - Oltre il trascendentale, il trascendentale. In dialogo con Husserl [PDF It]
Paolo Vignola - La stupida genesi del pensiero. Trascendentale e sintomatologia in G. Deleuze [PDF It]
Lato III
Alberto Andronico - Custodire il vuoto. Uno studio sul fondamento del sistema giuridico [PDF It]
Emanuela Magno - Dal pensiero alla vacuità. La critica nāgārjuniana e il trascendentale [PDF It]
Carlo Molinar Min - Il ritmo della decostruzione. Un'esperienza quasi-trascendentale [PDF It]
Lato IV
Alessandro Salice, Genki Uemura - Naturalizzare la fenomenologia senza naturalismo [PDF It]
Traduzioni
Bernard Stiegler - Tempo e individuazione tecnica, psichica e collettiva nell’opera di Simondon [PDF It]
Claude Romano - Il problema del mondo e l'olismo dell'esperienza [PDF It]
-
 È con il titolo Mal fare, dir vero, lo stesso delle conferenze che lo hanno generato, che viene edito in Italia il volume contenente il corso tenuto nel 1981 da Michel Foucault all’Università Cattolica di Lovanio. Oltre al testo delle lezioni del corso – tenutesi dal 2 aprile al 20 maggio di quell’anno – il volume ospita anche due interviste a Foucault (la prima a firma di A. Berten, la seconda condotta da J. François e J. De Wit) e una lunga e interessante Situazione del corso a opera dei curatori dell’edizione francese, F. Brion e B. E. Harcourt. Il testo del corso vero e proprio è stato ricostruito grazie a tre diversi tipi di fonte: 1) cassette U-Matic contenenti la registrazione audio-visiva di gran parte del corso (esclusa la conferenza inaugurale); 2) un manoscritto foucaultiano originale della conferenza e della prima lezione; 3) un dattiloscritto, stabilito da audiocassette mai ritrovate, depositato all’Institut Mémoires de l’édition contemporaine (Imec) contenente la trascrizione delle prime cinque lezioni e della conferenza. Il volume è inoltre corredato di un ricco apparato critico, particolarmente utile allo studioso e al ricercatore.
È con il titolo Mal fare, dir vero, lo stesso delle conferenze che lo hanno generato, che viene edito in Italia il volume contenente il corso tenuto nel 1981 da Michel Foucault all’Università Cattolica di Lovanio. Oltre al testo delle lezioni del corso – tenutesi dal 2 aprile al 20 maggio di quell’anno – il volume ospita anche due interviste a Foucault (la prima a firma di A. Berten, la seconda condotta da J. François e J. De Wit) e una lunga e interessante Situazione del corso a opera dei curatori dell’edizione francese, F. Brion e B. E. Harcourt. Il testo del corso vero e proprio è stato ricostruito grazie a tre diversi tipi di fonte: 1) cassette U-Matic contenenti la registrazione audio-visiva di gran parte del corso (esclusa la conferenza inaugurale); 2) un manoscritto foucaultiano originale della conferenza e della prima lezione; 3) un dattiloscritto, stabilito da audiocassette mai ritrovate, depositato all’Institut Mémoires de l’édition contemporaine (Imec) contenente la trascrizione delle prime cinque lezioni e della conferenza. Il volume è inoltre corredato di un ricco apparato critico, particolarmente utile allo studioso e al ricercatore.Le lezioni vere e proprie seguono l’ordine cronologico: 1/ una conferenza inaugurale (2 aprile); 2/ due lezioni (22 e 28 aprile) sulla confessione nell’età antica (mondo omerico – Iliade – e tragico – Edipo re); 3/ due lezioni (29 aprile e 6 maggio) sulla confessione nel cristianesimo dei primi secoli e nel monachesimo cristiano; 4/ due lezioni finali (13 e 20 maggio) sulla modernità, concluse con una breccia finale nel sistema penale contemporaneo.
Questa edizione va ad aggiungere un nuovo tassello al mosaico dei corsi foucaultiani, e lo fa collocandosi proprio in un punto delicatissimo della pensée Foucault. Il problema della confessione, infatti, emerge all’incrocio di alcune coppie problematiche che caratterizzano il percorso foucaultiano e, proprio in virtù di questa collocazione privilegiata, si presenta come punto di osservazione particolarmente interessante dell’intero orizzonte di lavoro di Foucault.
Innanzitutto la coppia follia/prigione. Dopo la storia della follia e dopo le ricerche sulla storia dell’incarcerazione punitiva, la produzione foucaultiana sembra imboccare una terza via, una pista di ricerca interessata al problema della sessualità. È proprio nel delineare i contorni di una storia della sessualità che Foucault incappa nel problema della confessione, che rappresenta la chiave d’accesso a un’operazione di livello superiore: il progetto di una storia della verità. Su di un piano metodologico più generale il corso del 1981 ha una posizione particolare anche rispetto alla coppia sapere/potere, rapporto che appare specificarsi soprattutto a partire dall’introduzione della nozione di aleturgia: pratica che, se da un lato fa apparire «ciò che è vero», dall’altro compie tale apparizione a sua volta all’interno di una pratica, quella della giustizia. In tal modo la storia della verità si concretizza, come da programma, come storia delle pratiche del far-vero.
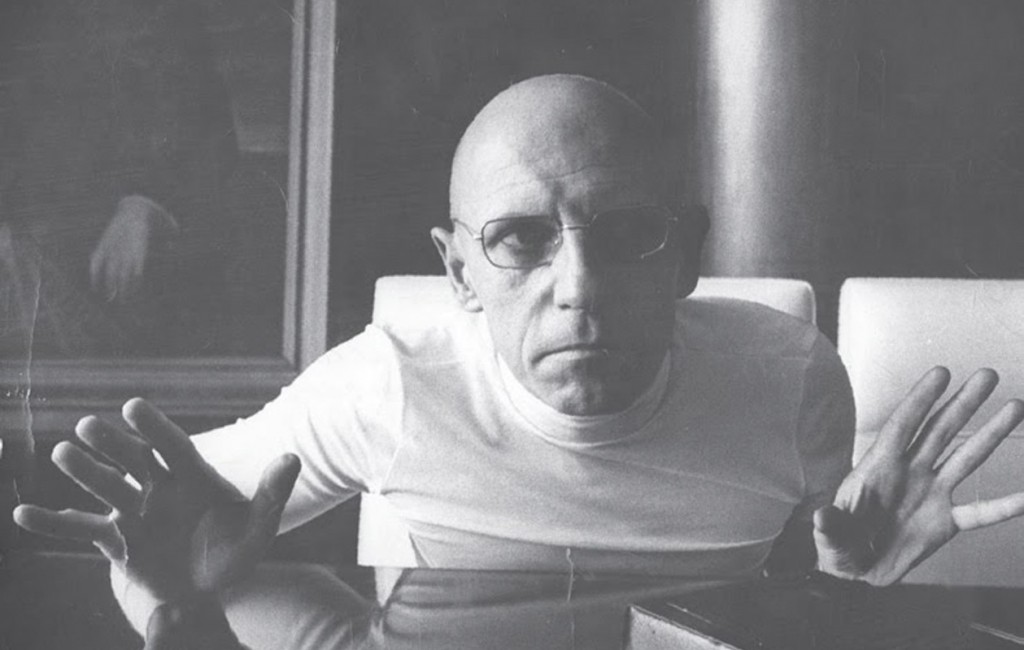
Mal fare, dir vero entra perciò di diritto in quella fase di definitivo chiarimento della dialettica che intercorre tra archeologia/genealogia come rapporto tra analisi delle forme e analisi della formazione delle forme stesse. Il corso in questione infatti, pur mantenendo il proprio valore in quanto studio tematico, risulta particolarmente interessante dal punto di vista metodologico: da un lato la ricostruzione precisa del procedere in fieri di Foucault, ormai pienamente maturo, mette a disposizione dello studioso foucaultiano un nuovo terreno di analisi; d’altro lato in questo corso forse più che in altri Foucault dedica spazio – per esempio nella conferenza inaugurale, ma non solo – a riflessioni di carattere metodologico generale. All’interno di queste riflessioni un posto privilegiato sembra essere occupato dal rapporto storia/filosofia, come se Foucault volesse in qualche modo rispondere alla domanda che tutti gli rivolgevano: «è questa impresa un lavoro di storia o di filosofia?». Ecco che Foucault, quasi sottovoce, in un corso quasi dimenticato, traccia la linea di una risposta: il suo lavoro è un lavoro storico-filosofico, anche se in un’accezione del tutto nuova; non è una storia della filosofia, né una filosofia della storia, bensì qualcosa come una pratica storico-filosofica.
Il volume non rappresenta un punto di approdo definitivo nell’elaborazione delle problematiche che si delineano intorno a questi diversi assi di articolazione anzi, come spesso si rivela esser vero per i corsi di Foucault, esso contribuisce ad aprire il ventaglio dei problemi e ad ampliare il terreno di gioco. Il corso foucaultiano assume davvero la struttura dell’«anello di Möbius» che gli riconoscono i curatori dell’edizione francese nel saggio introduttivo (p. VIII). Su di un unico lato o, meglio, su di un unico bordo collassano il problema politico e quello filosofico: da un lato la questione di come l’individuo accetti di legarsi al potere che si esercita su di esso e dall’altro la questione circa il modo in cui i soggetti si leghino alle forme di veridizione in cui sono implicati. Il pensiero di Foucault sembra subire una curvatura che, attraverso la pratica della confessione, fa svoltare l’interesse foucaultiano dalla politica all’etica.
Alcuni interpreti hanno voluto vedere in questo movimento una cesura; in realtà il corso, lungi dal confermare l’ipotesi di una frattura, evidenzia definitivamente il punto di saldatura del decorso filosofico foucaultiano: la confessione, infatti, rappresenta uno di quei ethoi che costituiscono il contorno del soggetto morale e attraverso i quali si esercita il governo della vita e della condotta dei corpi. La pratica della confessione e la sua analisi contribuiscono, secondo i curatori, a smentire l’idea di una cesura tra etica e politica, evidenziando invece come il passaggio assuma l’aspetto di una torsione quasi necessaria al discorso di Foucault, come se essa si prefigurasse – inattesa – sin dalla Storia della follia. È infatti in questo punto di curvatura che, secondo i curatori, il soggetto si inserisce tra potere e sapere «come un cuneo: se il governo passa attraverso la formazione degli ethoi nei quali gli individui si costituiscono come soggetti della loro condotta, allora il distacco da sé – rendersi in permanenza capaci di distaccarsi da se stessi – è la condizione di possibilità etica delle forme di resistenza politica a cui la sua filosofia invita».
di Gabriele Vissio