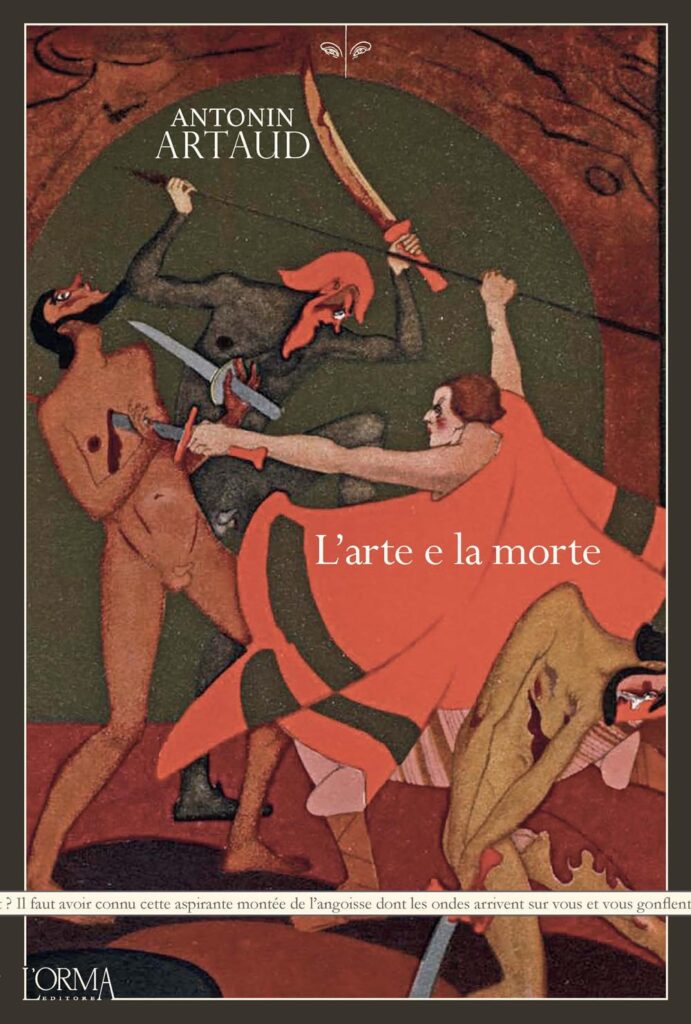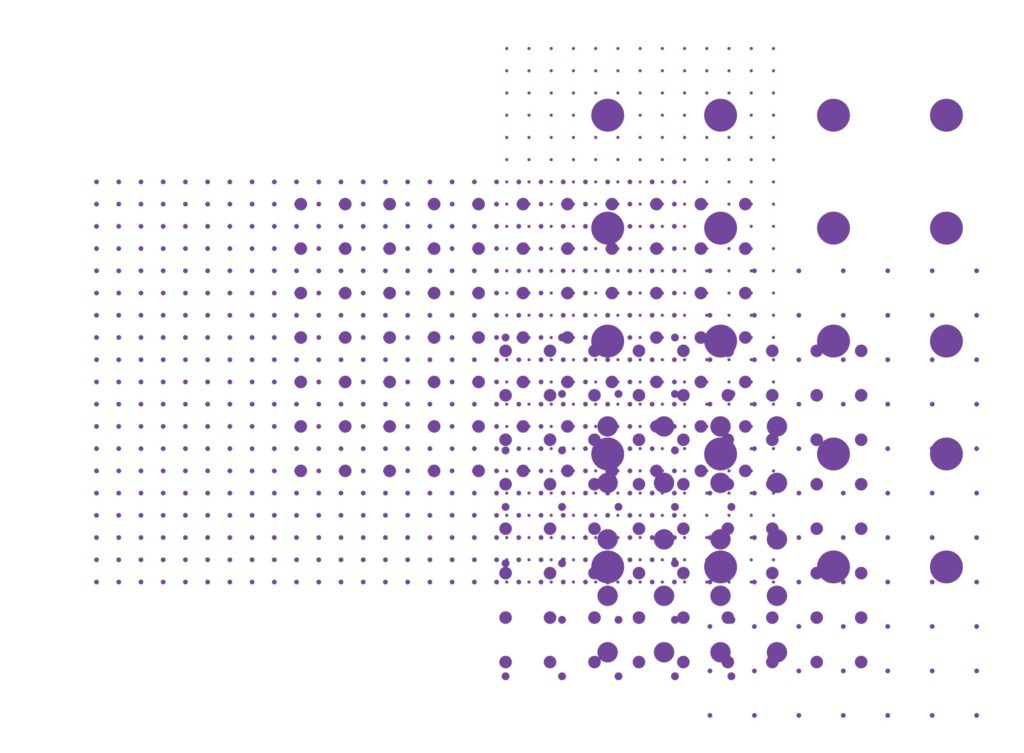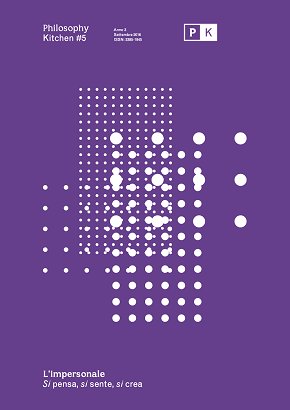-
-
Alenka Zupančič – Che cosa è il sesso?
Recensioni / Maggio 2019 Che cosa è il Sesso? (trad. di P. Bianchi, Ponte alle Grazie, Genova 2018), ultima opera della filosofa slovena Alenka Zupančič, già autrice di lavori su Kant, Nietzche e Lacan, è un testo che raccoglie anni di riflessione sulla psicoanalisi freudo-lacaniana e che si pone la sfida di affrontare la sessualità come una questione intimamente ontologica. Lo scopo di Zupančič non è però quello di “recuperare” la psicoanalisi di Freud e Lacan e dare a essa uno statuto ontologico che nobiliti la disciplina psicoanalitica (che sicuramente ha sempre subito accuse di pseudoscientificità e determinismo sessuale). Quello di Zupančič non è neanche (o non solo) un tentativo di rispondere alle domande della filosofia con la psicoanalisi né una sua difesa acritica; anzi, la posizione della filosofa slovena è conflittuale anche internamente al discorso psicoanalitico, portando al centro una delle questioni che sono state problematiche sin dagli esordi freudiani – appunto, la sessualità. Il sesso di cui ci parla Zupančič non è semplicemente l’insieme di pratiche sessuali, a cui fornire uno statuto ontologico maneggevole che ci risollevi immaginariamente dagli imbarazzi e angosce che questa dimensione ha scatenato nel tempo; piuttosto la filosofa vuole andare a svelare quanto il sesso sia proprio quella faglia o mancanza strutturale che permette al soggetto di diventare tale. Il sesso protagonista di questo libro non è una presunta naturalità che dovremmo accettare, ma è esattamente quella dimensione “disontologica” e “disorientante” che fa che sì che emerga un soggetto e, quindi, un inconscio.
Che cosa è il Sesso? (trad. di P. Bianchi, Ponte alle Grazie, Genova 2018), ultima opera della filosofa slovena Alenka Zupančič, già autrice di lavori su Kant, Nietzche e Lacan, è un testo che raccoglie anni di riflessione sulla psicoanalisi freudo-lacaniana e che si pone la sfida di affrontare la sessualità come una questione intimamente ontologica. Lo scopo di Zupančič non è però quello di “recuperare” la psicoanalisi di Freud e Lacan e dare a essa uno statuto ontologico che nobiliti la disciplina psicoanalitica (che sicuramente ha sempre subito accuse di pseudoscientificità e determinismo sessuale). Quello di Zupančič non è neanche (o non solo) un tentativo di rispondere alle domande della filosofia con la psicoanalisi né una sua difesa acritica; anzi, la posizione della filosofa slovena è conflittuale anche internamente al discorso psicoanalitico, portando al centro una delle questioni che sono state problematiche sin dagli esordi freudiani – appunto, la sessualità. Il sesso di cui ci parla Zupančič non è semplicemente l’insieme di pratiche sessuali, a cui fornire uno statuto ontologico maneggevole che ci risollevi immaginariamente dagli imbarazzi e angosce che questa dimensione ha scatenato nel tempo; piuttosto la filosofa vuole andare a svelare quanto il sesso sia proprio quella faglia o mancanza strutturale che permette al soggetto di diventare tale. Il sesso protagonista di questo libro non è una presunta naturalità che dovremmo accettare, ma è esattamente quella dimensione “disontologica” e “disorientante” che fa che sì che emerga un soggetto e, quindi, un inconscio.
Santa Lucia di Domenico Beccafumi, utilizzato dall’autrice nel testo per mostrare la perversione della pulsione nel cristianesimo
Non è un caso, infatti – e Zupančič lo sottolinea continuamente nel testo – che Freud abbia sempre così insistito sulla centralità del Sesso nella psicoanalisi e che i suoi primi allievi, come Jung e Adler, abbiano sempre e sistematicamente reagito su questo punto. Ancora oggi la questione della sessualità rimane problematica e fa spesso da confine fra le varie correnti psicoanalitiche. André Green, nel 1995, pone una domanda apparentemente banale per la disciplina: “la sessualità ha ancora a che fare con la psicoanalisi?”. La questione, difatti, non è scontata: se in Europa (soprattutto in Francia) le nozioni di sessualità e pulsione avevano continuato a godere di un certo successo, oltreoceano invece la psicoanalisi aveva fatto vertere la propria pratica e la teoria verso concetti come quello di Sé e di Relazione. A dare ulteriore conferma del rapporto problematico della psicoanalisi con la sessualità, è una ricerca di Shalev e Yerushalmi (2009), ripresa anche da Zupančič, dove gli autori intervistano 10 psicoanalisti riguardo la tematica della sessualità in psicoterapia: ne emerge una generale e diffusa rimozione, e addirittura imbarazzo da buona parte dei clinici. La primigenia scoperta di Freud, la sessualità, piuttosto che essere l’elemento unificante delle varie divisioni e diaspore psicoanalitiche, è proprio il seme della discordia.
La domanda “Che cosa è il sesso?” – che, come abbiamo visto, è problematica anche per la stessa psicoanalisi – diventa il fil rouge per affrontare in maniera inedita e “rumorosa” domande classiche dell’ontologia. Non è senza peso che Freud, che aveva sempre cercato di tenersi distante dai riferimenti filosofici, in Endliche und Unendliche Analyse (1937) abbia riconosciuto proprio alla sessualità (come alla questione della pulsione di morte) un’origine filosofica nel dualismo empedocleo fra Eros e Neikos, che, sempre secondo Freud, avrebbe lavorato come criptomnesia inconscia. Ma in che misura il sesso (o meglio, l’interrogazione continua su quel punto di frattura e di inciampo che è il sesso) può funzionare come vettore nella lettura dei problemi dell’ontologia, del soggetto e della politica contemporanei? Non si tratta di ribadire, per Zupančič, semplicemente che il sesso c’è e che nasconderebbe in Sé quel senso e quella verità che tanto gli esseri umani si affannerebbero a cercare. Su questo la filosofa è chiara: il sesso non è “l’ultimo orizzonte del senso e della realtà”, qualcosa che semplicemente si può ritrovare dopo aver grattato la patina delle apparenze, eppure il Sesso è qualcosa di Reale. Ma questo Reale, ricavato dalle elaborazioni di Lacan, su cui tanto insiste Zupančič, non è la realtà dei filosofi, un orizzonte ontologico-epistemologico neutro e quasi rassicurante, piuttosto il Reale è, della realtà, quel nocciolo che resiste a ogni forma di simbolizzazione e ontologizzazione. Il Reale è esattamente ciò che viene tagliato fuori dall’Essere-in-quanto-essere perché sia possibile descriverlo e parlarne, e allo stesso tempo è quella dimensione che curva lo spazio ontologico dell’Essere. Non è un caso che sia Lacan sia Zupančič insistano tanto sulla sessualità di questo Reale, ed è l’inconscio il concetto che permette loro di giustificare questa insistenza. L’inconscio sessuale non è luogo di rimozione di un’istintività animale che “farebbe ritorno” in maniera disturbante, ma piuttosto un gap, un buco strutturale nel soggetto, che lo frattura dall’interno. Questo buco o negatività non è semplicemente un’assenza o uno zero, ma una quantità negativa (di eredità kantiana), inassimilabile e disgregante che funziona come luogo di emergenza del soggetto. Una crepa non è un niente, anzi conta spesso più dei muri, e il sesso è esattamente la crepa che divide i soggetti internamente. È in questo senso che la ripresa delle tavole della sessuazione lacaniana non serve a reiterare la formula della differenza sessuale, bensì a mostrare come essa lavori come operatore simbolico, tagliando il soggetto da dentro, piuttosto che dividendo i soggetti in due sessi o generi determinati fra di loro da un fantasmagorico rapporto sessuale (che non c’è). La sessualità, l’inconscio, il godimento e il Reale sono tutti nomi di ciò in cui il soggetto cartesiano inciampa svelando la frattura che lo domina dall’interno. Zupančič , riprendendo la questione lasciata aperta da Lacan (1973) nel Seminario XI su una sua possibile (para)-ontologia, in cui vi sarebbe una schisi fra l’Essere e il suo Reale, contribuisce a radicalizzare, anche in risposta ai progetti delle Object-Oriented Ontologies, nelle quali il soggetto tende a confondersi neutralmente con gli oggetti in una sorta di democrazia ontologica, l’immagine di un’ontologia dis-orientata agli oggetti, dove, invece, il soggetto continua a essere la frattura e l’alienazione scritta nel tessuto della realtà. Ed è proprio uno dei concetti fondamentali della psicoanalisi, la pulsione, a permettere la costruzione di una topologia del soggetto estimo, in cui i confini fra interiorità e esteriorità si deformano e l’oggetto (il famoso oggetto piccolo a lacaniano) si incista dentro il soggetto. Certo, parlare di pulsioni significa anche riportare all’attenzione antagonismi e conflitti rimossi o appiattiti in seno ai discorsi contemporanei.

Francis Bacon, Lying Figure
Si può dire che ciò che pone le basi del progetto (dis)ontologico di Zupančič sia proprio questa nozione di pulsione. Infatti, Zupančič riprende e rianalizza il Trieb freudiano, le cui vicissitudini di significante lo hanno portato ad essere tradotto e rinaturalizzato come istinto. Invece, ciò su cui insiste, a ragione, la filosofa slovena, è proprio l’innaturalità della pulsione, che poco ha a che fare con eventuali istinti biologico-riproduttivi: essa si produce piuttosto come scarto di godimento nel lavoro del corpo, eccedenza che ritorna sul soggetto, lavorando sui suoi bordi. E non è un caso che Zupančič riprenda quella sezione del Seminario XI dove Lacan parla della pulsione come “farsi vedere”, “farsi cacare”, “farsi masturbare”: pulsione è ritorno del godimento del soggetto, nelle parole di Freud “una bocca che si bacia da sola”. Nel bambino attaccarsi al seno non è semplicemente la soddisfazione di un istinto dell’ordine del nutrimento, ma si produce un resto di godimento, un’eccedenza “libera” nel neo-soggetto. Certo, come dice la filosofa, “con la soddisfazione in eccesso non si può ancora parlare di pulsione” (p. 156) ma è necessario che la soddisfazione inizi “a funzionare, allo stesso tempo, come incarnazione oggettiva […] del negativo e come gap implicito nell’edificio significante dell’essere” (p. 157). Allora la pulsione è proprio il rappresentante di questo negativo interno al soggetto, ne diviene la figura (dis)ontologica centrale. La pulsione è per definizione parziale e frammentaria: non ha un Eden perduto verso il quale tornare né una “teleologia” pulsionale. Non esiste, dunque, un carattere genitale maturo a cui il soggetto dovrebbe tendere. L’impasto pulsionale è sempre un azzardo, un incastro sregolato e polimorfo: “se c’è qualcosa cui la pulsione assomiglia, è a un montaggio” (Lacan, 1973 p. 172). Non c’è sessualità né desiderio normale (ma al massimo normalizzabile) proprio perché queste dimensioni non hanno una forma precisa alle quali le pulsioni si dovrebbero adattare. L’incastro è sempre necessariamente contingente, idiosincratico. E proprio a partire da questa ripresa della pulsione, Zupančič apre una possibilità (psicoanalitica) di ricucire la ferita aperta fra i queer studies e la psicoanalisi, mostrando il volto “anarchico” e “polimorfo” delle pulsioni e cercando di sollevare la psicoanalisi da quella posizione “normalizzatrice” di cui spesso è stata accusata (e di cui di fatto è stata responsabile in molti casi).
Altro merito della filosofa è quello che, seguendo il percorso della pulsione sessuale, fra Freud, Lacan e Deleuze, viene ritrovata la tanto temuta pulsione di morte. Come sostiene Lacan stesso: “Come stupirsi che il suo termine ultimo sia la morte? Poiché la presenza del sesso nel vivente è legata alla morte” (Lacan, 1973 p. 180). L’essere umano non è la lamella lacaniana, il mitico essere scissiparo e immortale: per noi la condizione della divisione sessuata implica la morte del soggetto individuale. L’equazione è questa: dove il soggetto è sessuato, significa che il soggetto deve morire. Allora, di nuovo con un gioco topologico, una condensazione si verifica: cercando il sesso sul nastro di Möbius, questo viene incontrato nel luogo della morte. Non solo, la pulsione di morte, primaria rispetto al brulichio delle pulsioni sessuali ci appare proprio come quell’incrinatura, quella contraddizione, “singolarità unificante” dalla quale le pulsioni emergono e alla quale ritornano: “Presa a questo livello, la sessualità è davvero sinonimo di pulsione di morte e non è un suo opposto come Eros con Thanatos.” (p. 176)
Se il lavoro di Zupančič è proprio quello di svelare filosoficamente le contraddizioni inerenti il soggetto (il sesso, la morte, l’inconscio, il Reale), allora proprio questo soggetto è “l’incarnazione oggettiva di questa contraddizione nella realtà” (p. 185). Per la filosofa incontrare la paradossalità della contraddizione non significa, però, doversi abbandonare a un atteggiamento scettico o cinico; si tratta, piuttosto, di accettare la contraddizione proprio come quel Reale accessibile al pensiero, di pensare la contraddizione, come gli stessi matemi lacaniani hanno fatto, portando la logica ai suoi punti di frattura e rendendo disponibile al pensiero, paradossalmente formalizzata, la contraddizione.

Francis Bacon, Three Studies for Figures at the Base of Crucifixion 2
What is Sex? è un libro originale, radicale e coraggioso per la forza con cui l’autrice invita a affrontare, pensare e concepire la contraddizione e il conflitto (e l’invito non è rivolto solo a filosofi e psicoanalisti, poiché la filosofa ha la capacità di sciogliere nodi intricati con battute immediatamente comprensibili). Chi volesse cercare qui una risposta alla domanda “cosa è il sesso” nel senso più rassicurante e definitivo di certo si troverebbe deluso, perché questo interrogativo diventa piuttosto l’intelaiatura di una riflessione filosofica che vuole prendere di petto tutte quelle contraddizioni, quei conflitti e quelle fratture che la psicoanalisi ha saputo riconoscere (e che, in molti casi, ha saputo anche dimenticare e rimuovere) nel soggetto, nella sessualità, nella morte, nell’inconscio e nell’ambiguità del legame sociale. In questo senso Che cosa è il Sesso? è anche un testo esplicitamente politico, che ci porta nuovamente di fronte quell’antagonismo strutturale che anima e agita la società dal suo interno, facendoci guardare con sospetto dove e quando il Rapporto (sessuale) e la Relazione sono state scritte con la R maiuscola, ponendo proporzioni “sacre” e determinate fra classi, sessi, popoli. Alenka Zupančič ci insegna a guardare con diffidenza chi istituisce questo rapporto in maniera ferrea (come i sistemi dittatoriali), ma anche chi tende a nascondere il conflitto insito nella relazione, neutralizzandolo nell’Etica. La filosofa, infatti, leggendo in chiave politica il famoso ed enigmatico detto di Lacan “non c’è rapporto sessuale”, ci restituisce l’immagine di un rapporto senza prototipo o modello ideale, ma che può sorgere, ogni volta nuovo e da ricostruire, sotto la “necessità” della contingenza, dell’idiosincrasia degli incontri fra i soggetti e nei conflitti che si generano dentro e fra i soggetti. Insomma, una prospettiva che ci fa assumere la responsabilità della contraddizione, piuttosto che negarla o rimuoverla, della frattura che ci domina da dentro e che noi incarniamo nel mondo anche in una dimensione autenticamente politica e trasformativa.
di Lorenzo Curti
Bibliografia:
Freud, S. (1937) Analisi terminabile e interminabile.Trad. it. R. Colorni. OSF Vol. XI. Torino: Bollati Boringhieri
Green, A. (1995) Has sexuality anything to do with psychoanalysis? International Journal of Psychoanalysis78: 871-883
Lacan, J (1973). Seminario: Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi. Trad. it. S. Loaldi e I. Molina. Torino: Einaudi, 1979
Shalev, O. & Yerushalmi, H. (2009) Status of sexuality in contemporary psychoanalytic psychotherapy as reported by therapists. Psychoanalytic Psychology, Vol. 26, No. 4, 343–361
Zupančič, A. (2018) Che cosa è il sesso?. Tr. it. P. Bianchi. Milano: Ponte alle Grazie.
-
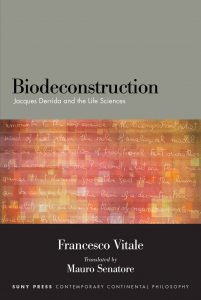 Tra le scuole di pensiero marcatamente connotate dalla presenza di un capostipite fondatore – si pensi alla fenomenologia di Husserl, all’ermeneutica di Heidegger, e alla biopolitica di Foucault – oggi è forse la decostruzione a godere della più vasta pervasività; e non tanto per intensità e clamore mediatico, quanto piuttosto in termini di tacita assunzione e di capillarità. A nostro modo di vedere, ciò è potuto accadere poiché, situandosi a cavallo di istanze epistemologico-metodologiche e di ipotesi ontologiche forti, il pensiero di Derrida ha raggiunto lo statuto di referente teorico ineludibile, sia dal punto di vista dei detrattori sia da quello dei più strenui fautori. Equipaggiando la filosofia di un metodo critico di lettura e riscrittura, così come, al contempo, drenando dai bacini delle filosofie decostruite operatori concettuali dormienti, la decostruzione ha fornito strumenti e spazi di disputa. È divenuta cioè il teatro ideale di animate discussioni, tanto interne, volte ad affinare la lettura degli stessi testi derridiani, quanto esterne, ossia vertenti sulla possibilità o meno di applicare le procedure e le nozioni decostruttive in relazione a prospettive di diverso lignaggio. Ora, è esattamente in direzione di questo doppio binario che si inserisce il recente lavoro di Francesco Vitale, Biodeconstruction. Jacques Derrida and Life Sciences (Suny Press, 2018). Frutto di un’attenta ricerca filologica, capace di coordinare l’approccio storico-ricostruttivo con quello più spiccatamente propositivo, il testo di Vitale si situa a pieno titolo tra i lavori della “scuola” decostruttiva progressista, intendendo con questa espressione quel filone di studi derridiani – di cui Rodolphe Gasché è probabilmente il nume tutelare – impegnati a manifestare fedeltà metodologica alla decostruzione, tramite un’espansione della sua area di operatività. Dopotutto il volume di Vitale, come si vedrà, cerca di assecondare quello che fu l’auspicio stesso di Derrida: preservare la singolarità del gesto decostruttivo tradendone però, di volta in volta, i limiti epistemici.
Tra le scuole di pensiero marcatamente connotate dalla presenza di un capostipite fondatore – si pensi alla fenomenologia di Husserl, all’ermeneutica di Heidegger, e alla biopolitica di Foucault – oggi è forse la decostruzione a godere della più vasta pervasività; e non tanto per intensità e clamore mediatico, quanto piuttosto in termini di tacita assunzione e di capillarità. A nostro modo di vedere, ciò è potuto accadere poiché, situandosi a cavallo di istanze epistemologico-metodologiche e di ipotesi ontologiche forti, il pensiero di Derrida ha raggiunto lo statuto di referente teorico ineludibile, sia dal punto di vista dei detrattori sia da quello dei più strenui fautori. Equipaggiando la filosofia di un metodo critico di lettura e riscrittura, così come, al contempo, drenando dai bacini delle filosofie decostruite operatori concettuali dormienti, la decostruzione ha fornito strumenti e spazi di disputa. È divenuta cioè il teatro ideale di animate discussioni, tanto interne, volte ad affinare la lettura degli stessi testi derridiani, quanto esterne, ossia vertenti sulla possibilità o meno di applicare le procedure e le nozioni decostruttive in relazione a prospettive di diverso lignaggio. Ora, è esattamente in direzione di questo doppio binario che si inserisce il recente lavoro di Francesco Vitale, Biodeconstruction. Jacques Derrida and Life Sciences (Suny Press, 2018). Frutto di un’attenta ricerca filologica, capace di coordinare l’approccio storico-ricostruttivo con quello più spiccatamente propositivo, il testo di Vitale si situa a pieno titolo tra i lavori della “scuola” decostruttiva progressista, intendendo con questa espressione quel filone di studi derridiani – di cui Rodolphe Gasché è probabilmente il nume tutelare – impegnati a manifestare fedeltà metodologica alla decostruzione, tramite un’espansione della sua area di operatività. Dopotutto il volume di Vitale, come si vedrà, cerca di assecondare quello che fu l’auspicio stesso di Derrida: preservare la singolarità del gesto decostruttivo tradendone però, di volta in volta, i limiti epistemici. -
Jean-Luc Nancy – La comunità sconfessata
Recensioni / Marzo 2016 Con La comunità sconfessata (ed. orig. La communauté désavouée, Galilée, Paris 2014) Jean-Luc Nancy compie un passo avanti nel tentativo di dipanare e allargare le maglie di un gioco di rimandi reciproci che lo connette a Maurice Blanchot a partire da L’absolu littéraire, apparso nel 1978: un rapporto di prossimità che lega Nancy a Blanchot nonostante i differenti percorsi teorici. La risposta di Nancy a La communauté inavouable di Blanchot, uscito nel 1983, si fa attendere trent’anni, anni che sono stati non solo testimoni della morte dello stesso Blanchot, ma anche della reale difficoltà di comprensione del suo testo e, in particolare, di quel segreto inconfessabile che, secondo l’autore, caratterizza propriamente la comunità. Nancy ammette di essere rimasto inizialmente paralizzato nel constatare che un autore del calibro di Blanchot decidesse di rispondere a un “giovane filosofo senza autorità” (p. 32) e con una tale sollecitudine (La communauté inavouable esce infatti lo stesso anno dell’articolo di Nancy intitolato La communauté désoeuvrée, “Aléa”, n. 4/1983). Solo recentemente l’imbarazzo e lo stupore, oltre che una certa prudenza teorica, hanno ceduto il passo all’urgenza etica che il tema della comunità prospetta e all’importanza di un’interrogazione su quel carattere comune delle nostre esistenze che ci consente di essere in rapporto, nell’insieme e nella condivisione (partage) ancora prima che individui o entità discrete.
Con La comunità sconfessata (ed. orig. La communauté désavouée, Galilée, Paris 2014) Jean-Luc Nancy compie un passo avanti nel tentativo di dipanare e allargare le maglie di un gioco di rimandi reciproci che lo connette a Maurice Blanchot a partire da L’absolu littéraire, apparso nel 1978: un rapporto di prossimità che lega Nancy a Blanchot nonostante i differenti percorsi teorici. La risposta di Nancy a La communauté inavouable di Blanchot, uscito nel 1983, si fa attendere trent’anni, anni che sono stati non solo testimoni della morte dello stesso Blanchot, ma anche della reale difficoltà di comprensione del suo testo e, in particolare, di quel segreto inconfessabile che, secondo l’autore, caratterizza propriamente la comunità. Nancy ammette di essere rimasto inizialmente paralizzato nel constatare che un autore del calibro di Blanchot decidesse di rispondere a un “giovane filosofo senza autorità” (p. 32) e con una tale sollecitudine (La communauté inavouable esce infatti lo stesso anno dell’articolo di Nancy intitolato La communauté désoeuvrée, “Aléa”, n. 4/1983). Solo recentemente l’imbarazzo e lo stupore, oltre che una certa prudenza teorica, hanno ceduto il passo all’urgenza etica che il tema della comunità prospetta e all’importanza di un’interrogazione su quel carattere comune delle nostre esistenze che ci consente di essere in rapporto, nell’insieme e nella condivisione (partage) ancora prima che individui o entità discrete.In questo dialogo “a distanza” compare immediatamente un ulteriore referente, Georges Bataille, le cui opere del dopoguerra, rilette in un’ottica politica comunitaria, diventano oggetto d’interesse tanto per Nancy quanto per Blanchot. Anche in nome dell’amicizia e della fraternità che lo legano a Bataille, Blanchot si convince della possibilità di integrare la nozione di comunità alla luce delle analisi contenute in questi testi, in riferimento ai quali è sviluppata la nozione di “comunità negativa”. Nel corso del terzo capitolo – “Il cuore o la legge” – i rimandi ai testi di Bataille e di Blanchot, echi che ricordano i riferimenti silenziosi ricercati dalla poesia neoterica, si fanno serrati come se tre figure si riflettessero infinitamente su due specchi posti l’uno di fronte all’altro: il rifiuto di consacrare la comunità alla sua propria esistenza è punto di partenza comune tanto a Blanchot quanto a Nancy – che fonda infatti su questo rifiuto la scelta del termine ‘inoperosa’ – ma, se Nancy e Bataille relegano la sovranità a “nulla”, negandone l’essenza primaria (p. 48), Blanchot la consacra invece alla realtà dello Stato moderno, confinandola a un’altezza che nulla può eccedere e collocandola dalla parte degli dèi e degli eroi. Se per Bataille la scrittura resta lacerata nella sua tensione verso un’inaccessibile trasmissione, Blanchot vede nella scrittura stessa la possibilità di trasmettere l’intrasmissibile, offrendo dunque il suo testo come lavoro “dell’inoperosità”. La comunicazione sconveniente di Bataille – chiaro riferimento alla sua attività letteraria notturna di carattere erotico –, occupandosi di diffondere un segreto senza segreto, da un lato delinea una comunità di amici che sembra esprimersi nella forma stessa della “comunità inoperosa” e dall’altro dà voce all’abbandono dell’autore dovuto al movimento della sua stessa comunicazione, al suo comunicare qualcosa di incomunicabile. La produzione notturna di Bataille diventa anche occasione affinché si manifesti l’accortezza di Blanchot nei suoi riguardi che, in quanto amico e membro della comunità, si propone come custode del “cuore o della legge” e si fa portavoce dell’abbandono e dell’isolamento di Bataille tramite l’elaborazione di un’altra scrittura o, meglio, di una scrittura altra. Blanchot realizza infatti La communauté inavouable come tentativo di pensare la comunità lontano dalle semplificazioni operate dalle cause da sostenere, dalle leggi da rispettare e dalla dicotomia comunicativa che relega la scrittura dettata dalla passione “scatenata” o “abbandonata” alla sola sfera privata, allontanandola dalla legge o dalla politica. Scrive Nancy a tale proposito: «Il cuore o la legge: se la legge non può mai decidere del cuore, il cuore in compenso può dettare legge al di là di ogni legge. È forse l’inconfessabile» (p. 55).

La legge dell’abbandono, che per unicità ed eccezionalità può essere paragonata alla legge del cuore o dell’amore, condanna il soggetto a essere “senza ritorno e senza ricorso”. È Bataille dunque a essere in “estasi” (usando un termine caro allo stesso autore), a essere abbandonato e a venir meno come soggetto, rapportandosi in questo modo con l’esperienza della comunicazione e con la sua impossibilità. Blanchot, in quanto amico e membro della comunità, comprende meglio di tutti la solitudine di Bataille: tale aspetto è magistralmente assunto da Nancy nel cogliere a sua volta entrambi nel loro abbandono ancora prima che essi si comprendano reciprocamente. In ultima istanza, sembra che Blanchot, ancora prima di affrontare la questione della comunità, ci tenga a farla primariamente vivere e ad affermarla, rimarcando un certo legame continuo, uno slittamento di testi, rapporti e identità, un’immediatezza creativa e segnando, in altri termini, un abbandono stesso della comunità “senza ritorno e senza ricorso”, nonostante la forma d’insieme si mantenga sotto il suo nome. La comunità sconfessata si presenta quindi come un testo che, più che affrontare il tema della comunità, si pone esso stesso come il soggetto di una comunità invocata, tanto da aprire la riflessione a partire da un “Io” e a concluderla terminando con un “Noi”, e in quanto tale strizza l’occhio in modo tacito, ma perentorio, alla “comunità degli amanti” di Bataille.
Nel quarto capitolo – “La comunità consumata” – Nancy legge nella considerazione sul movimento del ‘68 l’occasione tramite cui Blanchot indaga il popolo che, in quanto istanza o soggetto, mantiene il proprio essere a partire dall’oscillazione continua tra assemblaggio e disassemblaggio; scartando ogni fondazione della comunità di carattere propriamente politico e privilegiandone una di tipo ontologico-sociale – che potremmo definire della Gemeinschaft, più che della Gesellschaft – Nancy vede la comunità, che si sottrae a ogni determinazione, legarsi tramite il proprio slegamento e realizzare il “mondo vero degli amanti”, la cui verità costituisce il cuore o la legge del popolo, «la legge di un popolo che va concepito più come un cuore che batte che come un’associazione» (p. 70). Si noti bene come l’amore, racchiuso nella sfera ristretta della soggettività, sia – nella sua impossibilità – estraneo alla comunità degli amanti, contrariamente alla passione, al conatus, che, simile all’obbligo etico, costituisce uno slancio che istituisce la relazione con l’alterità tramite l’abbandono che porta con sé.
L’ultimo capitolo – “Ciò che essenzialmente sfugge” – attribuisce l’elusività e i toni più marcatamente mistico-cristiani di Blanchot – che affida al suo libro il compito di “parlare” anziché tacere e che lo vede destinatario di un messaggio importante – al suo progressivo avvicinamento al tema, mai svelato, dell’inconfessabile, presenza di colpa politica non-confessabile, forma di indicibile. L’inconfessabile, riscontrabile nell’esperienza della morte, che si comunica senza che si possa decidere della sua comunicazione, consiste nell’impossibilità di determinare sia l’effettività sia la dissoluzione della comunità. In altri termini, l’inconfessabile va ricercato nell’impossibilità di attribuire senso ultimo ai rapporti interni alla comunità e nella necessità che la comunità stessa si mantenga incerta nella propria essenza, al riparo da ogni confessione come da ogni dominio e da ogni solidità, “insubordinata”, non-comune e dunque “sconfessata”.
di Evelina Praino
-
Six Feet Under e la narrazione del lutto
Longform / Gennaio 2016Siamo a Los Angeles, nella funeral home della famiglia Fisher: la serie tv[1] si apre con la morte del patriarca e prosegue con il cordoglio dei familiari e con le loro diverse reazioni al lutto.
Pur essendo girato per un pubblico di massa, Six Feet Under tratta in modo esplicito oltre che ironico argomenti che oggi sembrano essere diventati tabù, come la morte e il cordoglio ma anche e soprattutto il dolore che ne consegue. Infatti, le caratteristiche psicologiche e sociali dei personaggi sono l’occasione per trattare il tema della morte in modo pedagogico e per offrire allo spettatore un’interpretazione circa il modo di reagire al lutto.
-
Corpi che non contano. Judith Butler e gli animali
Recensioni / Dicembre 2015 Vengono smembrati, disossati, cucinati e infine divorati. Vengono sfruttati, vivisezionati, modificati e poi sacrificati. Sono i corpi animali, i corpi che (ancora) non contano – o meglio: contano in termini nutritivi, economici e scientifici; contano, insomma, da un punto di vista antropocentrico. Sono materia prima, corpi senza vita che l’uomo plasma come vuole e di cui non piange le uccisioni. Sono piccoli blocchi, mattoncini di carne sui quali l’uomo ha fondato il suo impero, edificato e arroccato su principi di naturalità che soltanto oggi, con immensa lentezza e fatica, iniziano a essere minimamente scalfiti. La messa in discussione dei ruoli assegnati sulla base del naturalismo è un processo complicato ma necessario, in quanto mina la binarizzazione gerarchizzante di base: natura da una parte, cultura dall’altra. Compiere questo primo ma fondamentale passo porta alla ridefinizione dei ruoli svolti dagli esseri, abolendo l’assegnazione degli stessi “per natura” e sviluppando al contempo nuove concezioni e definizioni: ruolo come dimensione in cui muoversi e agire, ruolo come spazio in cui si fa e si disfa, ruolo come luogo libero che accoglie la performance dell’animale, umano e non. Il volume collettaneo Corpi che non contano. Judith Butler e gli animali (Mimesis, 2015) si pone l’obiettivo di testare, come annuncia provocatoriamente il curatore Massimo Filippi nell’introduzione, il pensiero di Judith Butler sugli animali. Se la domanda cardine del pensiero butleriano è «A chi spetta una buona vita?», quale lavoro filosofico meglio del suo può essere utile da incorporare negli Animal Studies? Nonostante la pensatrice americana non abbia mai esteso il suo ragionamento agli animali non umani, all’interno dei suoi studi sono molteplici gli strumenti e i concetti potenzialmente utili (vita precaria, performatività, lutto…) alla demolizione delle binarizzazioni oppositive e al riconoscimento dell’altro non umano. Nella breve intervista presentata all’interno del volume, è la stessa Butler a elogiare i movimenti antispecisti per lo sforzo che stanno compiendo in questa direzione: «Sono convinta che questi movimenti si stiano sforzando di mettere in rilievo le reti di interdipendenza che normalmente non vengono riconosciute». Non resta dunque che limare le derive antropocentriche del pensiero butleriano e inaugurare nuove strade che ci portino lontano dalla norma vigente, mettendola in discussione come i movimenti femministi e queer hanno fatto nei decenni passati nei confronti del pensiero eteronormato, riscuotendo successi e raggiungimenti filosofici, sociali e mediatici allora insperati.
Vengono smembrati, disossati, cucinati e infine divorati. Vengono sfruttati, vivisezionati, modificati e poi sacrificati. Sono i corpi animali, i corpi che (ancora) non contano – o meglio: contano in termini nutritivi, economici e scientifici; contano, insomma, da un punto di vista antropocentrico. Sono materia prima, corpi senza vita che l’uomo plasma come vuole e di cui non piange le uccisioni. Sono piccoli blocchi, mattoncini di carne sui quali l’uomo ha fondato il suo impero, edificato e arroccato su principi di naturalità che soltanto oggi, con immensa lentezza e fatica, iniziano a essere minimamente scalfiti. La messa in discussione dei ruoli assegnati sulla base del naturalismo è un processo complicato ma necessario, in quanto mina la binarizzazione gerarchizzante di base: natura da una parte, cultura dall’altra. Compiere questo primo ma fondamentale passo porta alla ridefinizione dei ruoli svolti dagli esseri, abolendo l’assegnazione degli stessi “per natura” e sviluppando al contempo nuove concezioni e definizioni: ruolo come dimensione in cui muoversi e agire, ruolo come spazio in cui si fa e si disfa, ruolo come luogo libero che accoglie la performance dell’animale, umano e non. Il volume collettaneo Corpi che non contano. Judith Butler e gli animali (Mimesis, 2015) si pone l’obiettivo di testare, come annuncia provocatoriamente il curatore Massimo Filippi nell’introduzione, il pensiero di Judith Butler sugli animali. Se la domanda cardine del pensiero butleriano è «A chi spetta una buona vita?», quale lavoro filosofico meglio del suo può essere utile da incorporare negli Animal Studies? Nonostante la pensatrice americana non abbia mai esteso il suo ragionamento agli animali non umani, all’interno dei suoi studi sono molteplici gli strumenti e i concetti potenzialmente utili (vita precaria, performatività, lutto…) alla demolizione delle binarizzazioni oppositive e al riconoscimento dell’altro non umano. Nella breve intervista presentata all’interno del volume, è la stessa Butler a elogiare i movimenti antispecisti per lo sforzo che stanno compiendo in questa direzione: «Sono convinta che questi movimenti si stiano sforzando di mettere in rilievo le reti di interdipendenza che normalmente non vengono riconosciute». Non resta dunque che limare le derive antropocentriche del pensiero butleriano e inaugurare nuove strade che ci portino lontano dalla norma vigente, mettendola in discussione come i movimenti femministi e queer hanno fatto nei decenni passati nei confronti del pensiero eteronormato, riscuotendo successi e raggiungimenti filosofici, sociali e mediatici allora insperati.Quando il 26 ottobre 2015 l’International Agency for Research on Cancer – agenzia facente parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità – diffonde un comunicato con cui informa che le carni rosse sono probabilmente cancerogene e le carni rosse lavorate (insaccati e salumi) sono sicuramente cancerogene, un brivido di inquietudine – nella maggioranza dei casi carico di inesattezze scientifiche e macchiato di qualunquismo e semplificazioni – getta nello scompiglio l’opinione pubblica. Il dibattito che ne consegue è, ancora una volta, unidirezionale, tecnoscientifico e antropocentrico, ma permette di mettere in luce alcuni aspetti discussi in Corpi che non contano. La reazione alla diffusione del rapporto dello IARC infatti mette in evidenzia ciò che nell’ultimo saggio Federico Zappino definisce “norma sacrificale”. Si tratta della norma che, ancora più di quella eterosessuale, è stata forclusa, resa non evidente, inintelligibile. È il sacrificio perpetuo di miliardi di animali non umani, un sacrificio dal quale è complicato liberarci se si tengono presenti i desideri che esso soddisfa (il consumo di carne a tavola, per esempio) e la soggettivazione di cui è parte integrante. Come liberare l’uomo da un desiderio senza doverlo castrare e reprimere, si chiede Zappino? Seguendo le orme di Foucault, è bene lasciare spazio a nuovi desideri, creativi e fluidi, che possano accompagnare in modo libero la critica alla norma vigente, dando vita a nuove dimensioni da sperimentare.
Quando la norma resiste agli scossoni – come ha dimostrato la reazione al comunicato dell’OMS, veicolata attraverso messaggi pregni di “orgoglio carneo” e talvolta venati da caustico umorismo – allora è necessario intaccarla alla radice; questo è l’obiettivo che si pongono James Stanescu e Richard Iveson, che firmano un saggio a testa nel volume. Entrambi pongono l’accento sull’errore di considerare l’animale quale pre-condizione dell’umano. Si tratta di uno scivolone che coinvolge anche Judith Butler in Frames of war, in cui ancora una volta viene promulgata un’idea profondamente umanista e fondata su quell’eccezionalismo umano che dovrebbe essere la prima barriera da abbattere per intavolare una discussione critica sul rapporto interspecifico. In quest’ottica, lo stesso concetto di umano diventa norma, escludendo tutto ciò che non rientra in questa categoria dalla considerazione e relegandolo a un “grado zero” (l’animalità) su cui fondare il dominio dell’uomo sul mondo. La carne degli animali è quindi soltanto meat [carne morta] e non flesh [carne viva], è altro da noi umani, è soltanto materia inerte potenzialmente cancerosa – salsicce, wurstel, salumi, braciole, costolette – e, soprattutto, non è meritevole di lutto. La morte dell’animale per mano umana non è, dunque, omicidio, cioè morte degna di essere compianta, ma mera uccisione, morte senza ricordo, perché dovuta, necessaria e, ovviamente, naturale.
Accanto al concetto di lutto, a lungo esplorato da Butler nel corso della sua carriera, si affianca quello di vita precaria, punto cardine nell’applicazione del pensiero butleriano agli Animal Studies secondo Stanescu. La precarietà – essendo prima di tutto una condizione collettiva e non individuale – pone l’accento sulle connessioni e sulla relazione ed è, secondo Butler, un luogo da cui partire per riorganizzarsi e non uno stadio da superare. Inoltre, la precarietà è sia un luogo che una questione ontologica; un concetto cruciale ma da cui non dobbiamo difenderci, perché la minaccia reale è l’immunità con cui schermiamo la precarietà stessa, operando processi di disconoscimento nei confronti dell’Altro. «Tramite un rifiuto di affrontare la nostra finitudine corpeizzata e condivisa», scrive Stanescu, operiamo la prima spaccatura che ci separa dal bios dell’animale non umano. Solo muovendo dalla nostra precarietà possiamo comprendere che la carne che consumiamo e sfruttiamo in molteplici modi prima di essere lavorata (e diventare cancerogena) si muove, si nutre e si riproduce: è viva, ed è animale tanto quanto la nostra.
Ogni anno su questo pianeta vengono uccisi circa centocinquanta miliardi di animali non umani. Dati simili sono spesso inintelligibili, nascosti agli occhi dei più e radicati profondamente nella norma sacrificale. Come ricorda Marco Reggio nel suo intervento in Corpi che non contano, il pensiero butleriano può essere fondamentale per portare alla luce i rapporti di interdipendenza fra uomo e animali non umani e per mettere in discussione il concetto stesso di umano e il suo eccezionalismo. Fra le maglie della rete che tenta di opprimere e nascondere la solidarietà interspecifica, si fanno strada studi – come questo – che portano a galla verità soggiacenti, da sempre presenti ma, speriamo, ancora per poco ignorate.
di Danilo Zagaria
-
Ancora troppo umani. Il postumano di Giovanni Leghissa
Recensioni / Ottobre 2015 Nel suo saggio Postumani per scelta. Verso un’ecosofia dei collettivi, ospite della collana “Spiritualità senza Dio?” diretta da Luigi Berzano, Giovanni Leghissa dà unitarietà a un tema che ormai lo vede occupato da alcuni anni (La fondazione, la fondazione dell’umano, il post-umano, 2013; Il postumano: un nuovo paradigma?, 2013; curatela di aut aut, La condizione postumana, 2014). Nonostante la brevità del saggio, l’autore si propone di soddisfare la duplice esigenza teorica di inquadrare da più vicino lo sfuggente dibattito sulla questione postumana e, insieme, di estrarne una possibile interpretazione critica. Così, alla messa in ordine di linee guida di una discussione spesso frammentaria, si affianca l’argomentazione di una tesi, frutto dell’incontro di assi di ricerca eterogenei ma convergenti. Le fonti e le questioni interpellate sono infatti numerose e provenienti dalle più disparate aree del sapere filosofico. Tra i “maestri” e le tradizioni di pensiero che vediamo avvicendarsi figurano l’illuminismo, l’evoluzionismo, la filosofia francese del dopoguerra, l’epistemologia, la fenomenologia husserliana, l’idea di un sapere enciclopedico alla Enzo Paci, la decostruzione e l’antropologia filosofica di Hans Blumenberg. Come dichiara l’autore, si tratterà allora di seguire questi molteplici stimoli nell’intento di definire la condizione postumana in termini filosofici, individuando e descrivendo schematicamente gli atteggiamenti caratteristici del suo approccio.
Nel suo saggio Postumani per scelta. Verso un’ecosofia dei collettivi, ospite della collana “Spiritualità senza Dio?” diretta da Luigi Berzano, Giovanni Leghissa dà unitarietà a un tema che ormai lo vede occupato da alcuni anni (La fondazione, la fondazione dell’umano, il post-umano, 2013; Il postumano: un nuovo paradigma?, 2013; curatela di aut aut, La condizione postumana, 2014). Nonostante la brevità del saggio, l’autore si propone di soddisfare la duplice esigenza teorica di inquadrare da più vicino lo sfuggente dibattito sulla questione postumana e, insieme, di estrarne una possibile interpretazione critica. Così, alla messa in ordine di linee guida di una discussione spesso frammentaria, si affianca l’argomentazione di una tesi, frutto dell’incontro di assi di ricerca eterogenei ma convergenti. Le fonti e le questioni interpellate sono infatti numerose e provenienti dalle più disparate aree del sapere filosofico. Tra i “maestri” e le tradizioni di pensiero che vediamo avvicendarsi figurano l’illuminismo, l’evoluzionismo, la filosofia francese del dopoguerra, l’epistemologia, la fenomenologia husserliana, l’idea di un sapere enciclopedico alla Enzo Paci, la decostruzione e l’antropologia filosofica di Hans Blumenberg. Come dichiara l’autore, si tratterà allora di seguire questi molteplici stimoli nell’intento di definire la condizione postumana in termini filosofici, individuando e descrivendo schematicamente gli atteggiamenti caratteristici del suo approccio. -
CRUDELTÀ, SOVRANITÀ, RESISTENZA NELLA PSICANALISI
Longform / Luglio 2015[…] gli Stati generali sono sempre convocati nei momenti critici, quando una crisi politica richiede una scelta, e prima una liberazione della parola in vista di una decisione d’eccezione che dovrà impegnare l’avvenire (Derrida, 2013, p. 56)
Stati d’animo della psicanalisi è il titolo della conferenza tenuta alla Sorbona da Jacques
 Derrida nel luglio 2000, in apertura degli Stati generali della psicoanalisi, occasione straordinaria di confronto tra psicoanalisti di tutto il mondo appartenenti alle diverse correnti del movimento psicoanalitico. La conferenza, uscita in Francia nel 2000 (Derrida 2000), è stata pubblicata in Italia alla fine del 2013 dalla casa editrice ETS, nella pregevole traduzione di Claudia Furlanetto, che ha curato il volume arricchendolo con un’agile e chiara introduzione e con un’ampia intervista a René Major, filosofo molto vicino alla psicanalisi di orientamento lacaniano e amico personale di Derrida. È proprio Major a ricostruire la lunga gestazione degli Stati generali, da lui stesso promossi e organizzati con tre anni di lavoro preparatorio, ma concepiti sin dalla fine degli anni Settanta, ai tempi delle dittature in Brasile e in Argentina. L’esigenza più urgente di Major era stata allora quella di denunciare le opacità dei rapporti tra la psicoanalisi e il potere, che andavano dalla complicità vera e propria di alcuni analisti nei crimini commessi dagli apparati di stato, alle azioni dissuasive messe in atto da una parte delle istituzioni psicanalitiche per insabbiare lo scandalo. In seguito lo spazio del confronto si sarebbe ampliato, fino a portare in primo piano la questione del senso politico della psicoanalisi. Alla caduta dei regimi sudamericani non fece infatti seguito un’epoca di pace e rispetto dei diritti umani nel mondo; d’altra parte i primi a violarli erano e restavano in molti casi i cosiddetti baluardi della democrazia, data la presenza della pena di morte in diversi stati americani. Anche in questo caso, le dichiarazioni di denuncia da parte delle istituzioni psicanalitiche rimanevano vaghe, come se, al di là dell’opportunismo, si volesse evitare di assumere una precisa posizione di condanna. Come se la psicanalisi, rispetto al potere – in particolare al potere di far soffrire – dovesse mantenersi a distanza.
Derrida nel luglio 2000, in apertura degli Stati generali della psicoanalisi, occasione straordinaria di confronto tra psicoanalisti di tutto il mondo appartenenti alle diverse correnti del movimento psicoanalitico. La conferenza, uscita in Francia nel 2000 (Derrida 2000), è stata pubblicata in Italia alla fine del 2013 dalla casa editrice ETS, nella pregevole traduzione di Claudia Furlanetto, che ha curato il volume arricchendolo con un’agile e chiara introduzione e con un’ampia intervista a René Major, filosofo molto vicino alla psicanalisi di orientamento lacaniano e amico personale di Derrida. È proprio Major a ricostruire la lunga gestazione degli Stati generali, da lui stesso promossi e organizzati con tre anni di lavoro preparatorio, ma concepiti sin dalla fine degli anni Settanta, ai tempi delle dittature in Brasile e in Argentina. L’esigenza più urgente di Major era stata allora quella di denunciare le opacità dei rapporti tra la psicoanalisi e il potere, che andavano dalla complicità vera e propria di alcuni analisti nei crimini commessi dagli apparati di stato, alle azioni dissuasive messe in atto da una parte delle istituzioni psicanalitiche per insabbiare lo scandalo. In seguito lo spazio del confronto si sarebbe ampliato, fino a portare in primo piano la questione del senso politico della psicoanalisi. Alla caduta dei regimi sudamericani non fece infatti seguito un’epoca di pace e rispetto dei diritti umani nel mondo; d’altra parte i primi a violarli erano e restavano in molti casi i cosiddetti baluardi della democrazia, data la presenza della pena di morte in diversi stati americani. Anche in questo caso, le dichiarazioni di denuncia da parte delle istituzioni psicanalitiche rimanevano vaghe, come se, al di là dell’opportunismo, si volesse evitare di assumere una precisa posizione di condanna. Come se la psicanalisi, rispetto al potere – in particolare al potere di far soffrire – dovesse mantenersi a distanza.