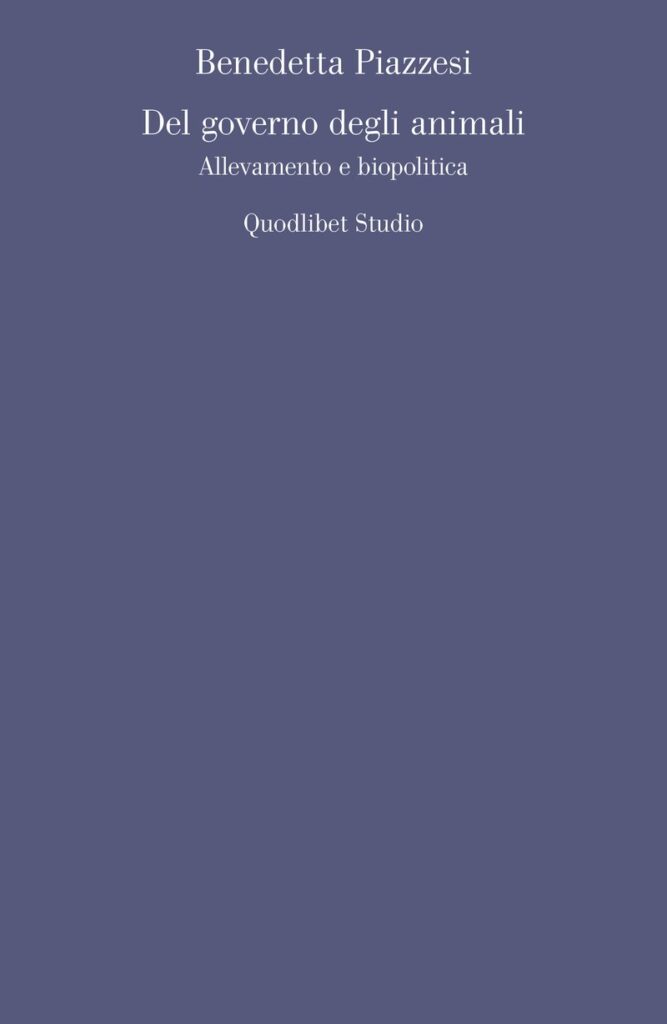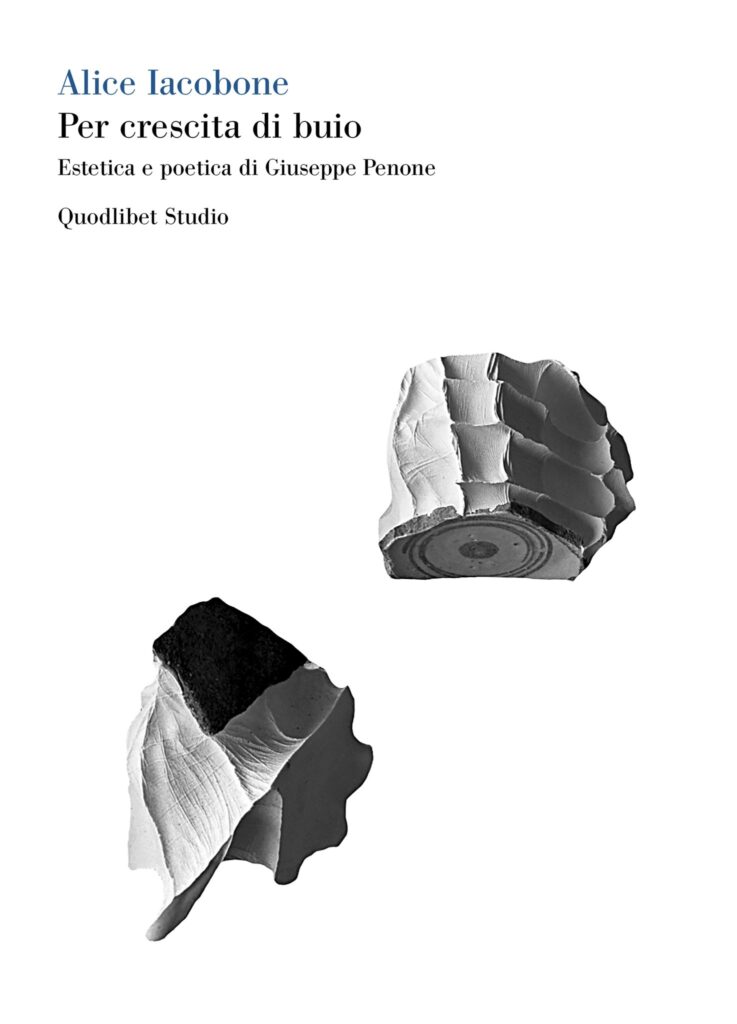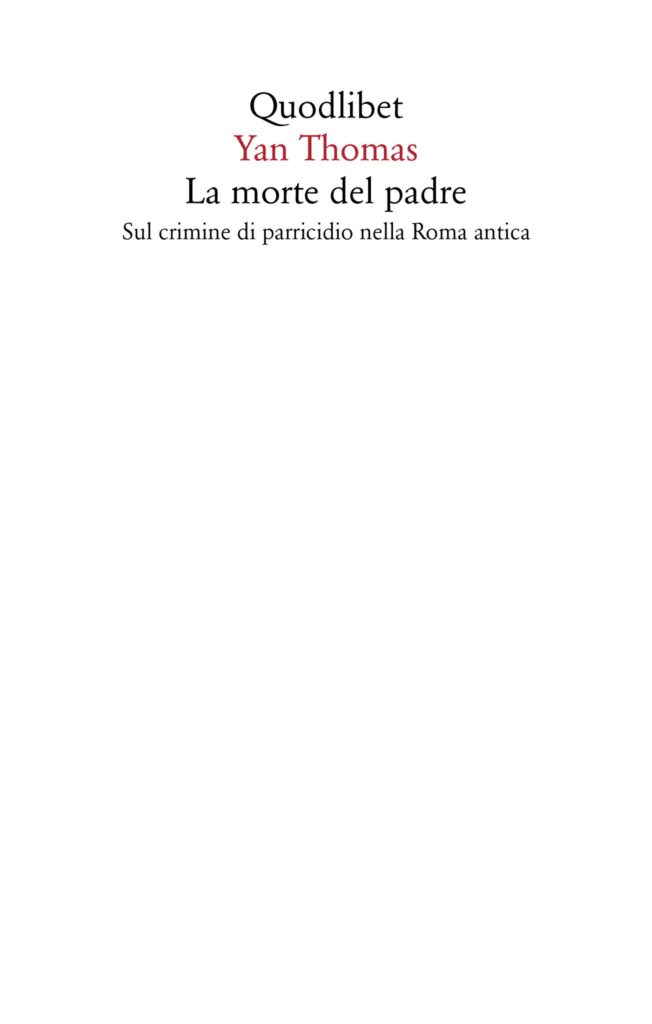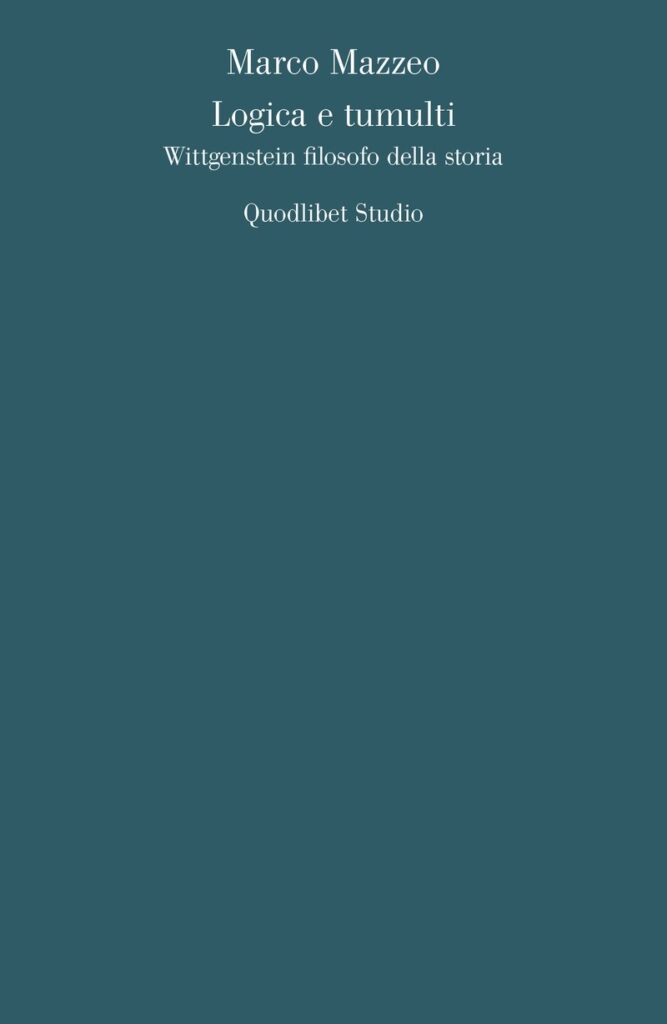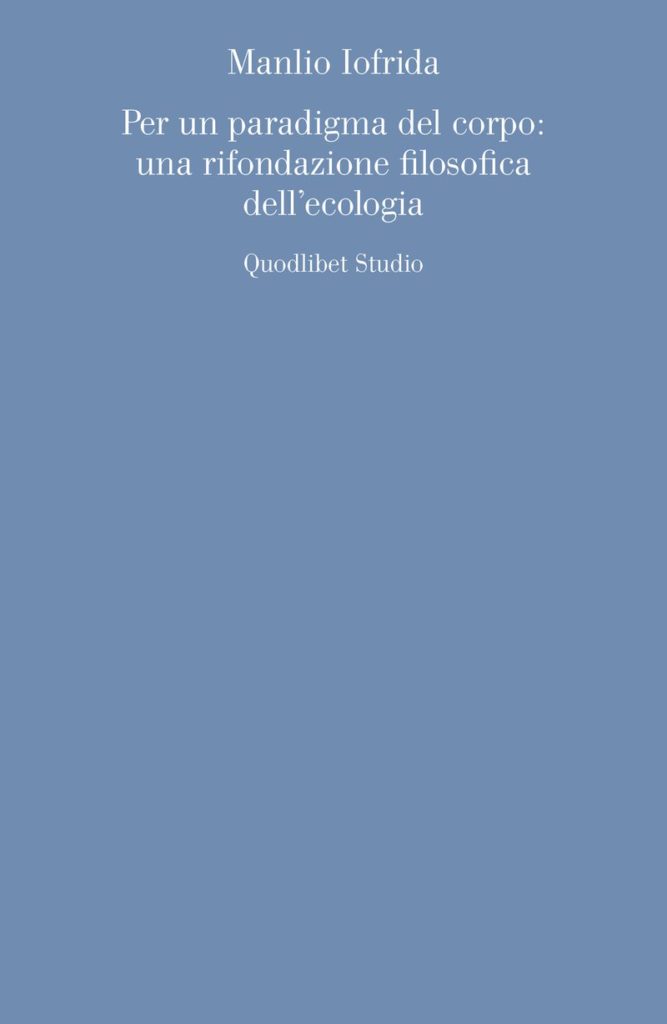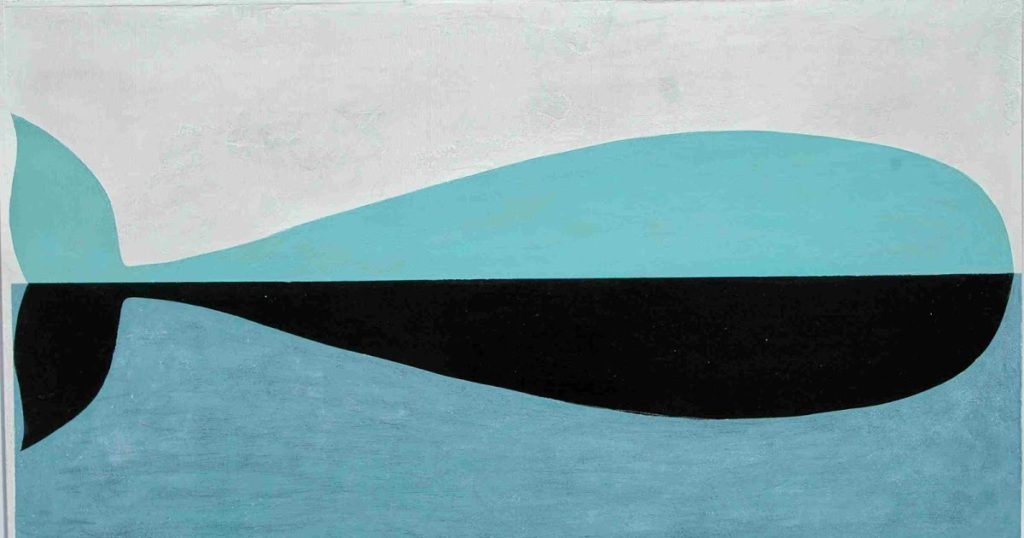«“L’uomo è nato libero ed ovunque è in catene” (Rousseau J.J. 2010, p.5). Se l’animale è ancora in catene, è perché continua a essere, intimamente, Libero» (Piazzesi 2023 p.8). Questa frase risuona con tutta la sua potenza nell’introduzione del testo di Benedetta Piazzesi Del governo degli animali. Allevamento e biopolitica edito da Quodlibet nel 2023. Piazzesi è ricercatrice filosofa che, situandosi nei Critical Animal Studies, si interessa in particolare alla congiunzione tra teorie filosofiche, epistemologiche, culturali e tecniche-politiche di governo moderno che performano il corpo animale al fine del suo sfruttamento: potremmo dire la sua “mise au travail” con tutto ciò che essa comporta. Del governo degli animali si inserisce in queste riflessioni come quarta opera dell’autrice a cui precedono Così perfetti e utili. Genealogie dello sfruttamento animale (2015), Dalla predazione al dominio. La guerra contro gli animali (con R. Colombo & G. Mormino 2017) e Un incontro mancato. Sul fotoreportage animalista (con il fotografo S. Belacchi 2017).
In questo studio Piazzesi ricostruisce una genealogia dell’intersezione tra produzione di saperi, tecniche di allevamento e/o domesticazione e le strategie di governo sui corpi degli animali prendendo in considerazione il periodo che intercorre tra la metà del XVII fino al XIX secolo in Francia. La scelta di questo periodo non è certa casuale. L’epoca moderna vede infatti la nascita degli Stati e un crescente interesse di questi ultimi alle produzioni teoriche filosofiche e scientifiche per i primi tentativi di programmi centralizzati di governo che, proporrà l’autrice, non investono solo gli umani ma anche gli animali. Inoltre, la modernità è una temporalità storica complessa e in piena trasformazione che spesso viene ridotta ad alcune concezioni che sembrano colorare tutta l’epoca. Tra queste, Piazzesi evidenzia come emerga il presupposto largamente accettato che l'animale è sfruttato in quanto ridotto ontologicamente, epistemologicamente e politicamente a materia non vivente, passiva e inerte facilmente riducibile a oggetto sfruttabile e/o analizzabile. Quello che sembra emergere da una lettura non erronea ma frettolosa del moderno è che in questa epoca si sarebbe prodotto quello che la filosofa definisce un oblio dell’animale dalla sfera politica nella produzione dei saperi e delle teorie. Questo argomento fa riferimento in particolare da un lato alla teorizzazione del sistema cartesiano che ha privato l’animale dello statuto ontologico e teorizzato il modello dell’animale-macchina largamente usato per gli studi di anatomia sviluppatosi nel seicento. Dall’altro, allude alle teorie politiche del contratto sociale e in particolare alla sua declinazione hobbesiana che nella postulazione del contratto vedrebbbe la recisione netta tra l’animale-bestia che continua la guerra di tutti contro tutti nello stato di Natura, e un umano improvvisamente politico che avrebbe lasciato alle spalle i suoi istinti naturali per divenire, finalmente, Uomo.
Analizzando questi discorsi Piazzesi propone al contrario che la preoccupazione della possibilità di governare gli animali non solo non è assente ma altresì è centrale nella costruzione dello stato moderno.
Per dimostrare questa proposta l’autrice ripercorre con un’analisi genealogica i dibattiti tra allevatori e teorici che hanno portato alla produzione sia di saperi teorico-scientifici sviluppatisi sul vivente non umano che di tecniche di assoggettamento animale mostrando l’interesse che questi studi hanno suscitato verso gli apparati di potere. Poteri e saperi si ripensano e ricompongono negli allevamenti, nella ricerca e nella costruzione degli spazi urbani divenendo quelli che l’autrice, riprendendo Foucault, chiama saperi-poteri.
Piazzesi evidenzia inoltre che nuove scienze del vivente e tecniche di allevamento si sviluppano e ripensano proprio criticando la riduzione cartesiana dell’animale a oggetto passivo. Quest’ultime, infatti, investono in una relazione proficua e produttiva con quella che non uniformemente possiamo definire soggettività animale e che a seconda dei dibattiti, delle discipline, delle tecniche e del periodo, è stata declinata come : morale, istinti, abitudine, carattere, forme di ragione o soggettività tronca, come la definisce Kant per sottolinearne la differenza tra soggettività animale e soggettività umana segnando quella che viene storicamente definita la differenza antropologica.
Se possiamo dire, quasi come un ritornello seguendo Donna Haraway, che scienze e tecniche non sono mai neutrali, le analisi di Piazzesi evidenziano come le riflessioni intorno alla soggettività animale siano state il fulcro su cui le tecniche di domesticazione e/o di allevamento si sono concentrate per ottimizzare la messa a lavoro produttiva e riproduttiva (quando le due non si accavallano) degli animali tutti, in particolare quelli “da reddito”.
È in questa direzione che la filosofa rilegge in maniera originale la storia dell’allevamento e del governo degli animali attraverso le lenti degli studi di Georges Canguilhem e di Michel Foucault. Del primo riprende l’analisi per cui nella modernità i saperi si riorganizzano intorno alla produzione epistemologica sui viventi tutti, e del secondo invece riprende la chiave di lettura biopolitica che vede nelle politiche di governo un investimento sul corpo biologico e sui suoi comportamenti. Se infatti Foucault scrive in Sorvegliare e punire che:
Questo investimento politico del corpo è legato, secondo relazioni complesse e reciproche, alla sua utilizzazione economica. È in gran parte come forza di produzione che il corpo viene investito da rapporti di potere e di dominio, ma, in cambio, il suo costituirsi come forza di lavoro è possibile solo se esso viene preso in un sistema di assoggettamento (in cui il bisogno è anche lo strumento politico accuratamente preordinato, calcolato e utilizzato): il corpo diviene forza utile solo quando è contemporaneamente corpo produttivo e corpo assoggettato. (Foucault 1923 p. 29),
Piazzesi ci propone che queste pratiche di assoggettamento sul corpo vibrante e desiderante siano elaborate anche in relazione agli animali non umani. Ed è qui che torniamo all’assunto con cui mi sono introdotta che è l’epicentro teorico su cui Piazzesi mi sembra sviluppi tutto il testo. Se la gabbia e la prigione, diremmo con Foucault, sono una tattica politica non di contenimento del corpo asservito e già passivo, ma di quello che non si è ancora riuscito a soggettivare (perché si imprigiona chi ruba e chi si oppone alle forme di potere e non chi passivamente le accetta e asseconda) allora l’animale è ancora in prigione perché attivamente e ostinatamente resistente a un sistema che investe sul suo corpo per metterlo a valore nel migliore dei modi possibili. Tutti i saperi sul vivente tra cui le scienze veterinarie, l’etologia, e le tecniche di domesticazione: «si pongono dunque il problema di come eludere la resistenza animale» (p.11).
La grande ricchezza di questo testo è quello di mostrare e ripercorrere la complessità e la non linearità della costruzione epistemologica moderna e poi contemporanea che ha fatto dell'animale lo sfruttabile, lo schiavizzabile, l’uccidibile e il mangiabile, e il suo indissociabile legame a una messa a valore produttivo-riproduttiva economico-politica.
La cartografia che emerge dalle pagine del testo ci permette di visualizzare, inoltre, i diversi modi in cui il corpo animale è stato domesticato e/o messo a lavoro forzato, se di lavoro si può parlare e qui rimando agli studi di Paul Guillibert (2023) e Lena Balaud e Antoine Chopot (2021). Questa operazione cartografica rende dignità e valore a delle storie diversificate che non toccano nessuna categoria dell’animale in generale (che non esiste) ma che devono essere calate tanto su corpi singolari che in discorsi particolari creati su corpi desideranti, resistenti (o non) per dei fini specifici.
.
Oltre il meccanicismo verso una moralizzazione dell’animale
Le scienze del vivente e le tecniche di allevamento hanno sperimentato secondo Piazzesi tecniche politiche volte a penetrare nei mœurs dell’individuo animale cercando di malleare e poi perfezionare il comportamento dello stesso. Ogni forma di sapere è stata ripensata attraverso tentativi e tensioni che avevano l’obiettivo di esercitare dei poteri su aspetti differenti della vita animale, dove il concetto di vita o di bios si concettualizza continuamente. In questa direzione se la scienza veterinaria o l’etologia mostrano un’attenzione alla relazione reciproca con l’animale, evidenziandone caratteristiche che prima non venivano considerate come le possibilità morali, istintuali e abitudinarie-comportamentali, questi valori acquisti sono stati rilevati per essere resi adattabili alle finalità umane. L’animale che collabora e con cui si instaura una relazione è più produttivo di un animale su cui si esercita una forza fisica. Investire sulla morale è inoltre un programma biopolitico volto a sbarazzarsi della bestialità che segue il processo di civilizzazione moderno e che va al di là del corpo animale non umano. Mettendo in relazione le agende politiche della nascita dello stato francese Piazzesi mette in luce come il programma di domesticazione della bestia è pensato tanto sull’animale che verso il contadino e il povero. Moralizzazione dell’animale e civilizzazione del popolo procedono di pari passo con l'urbanizzazione: l’umano e l’animale devono essere resi civili per entrare in città; questa è a tutti gli effetti una necessità di socializzazione che deve conformarsi con un una forma di organizzazione economico, politica e sociale urbana. È in questa prospettiva che iniziamo a percepire come le analisi foucaultiane siano estremamente fertili per questa proposta. Il corpo animale è considerato come superficie agente e sui cui agire. Non c’è nessuna appropriazione di corpi inermi, ma la volontà di assoggettare dei corpi capaci di sabotare, scappare, rifiutare il loro lavoro e sfruttamento.
Questo non significa che il paradigma cartesiano dell’animale corpo inerme e appropriabile non abbia avuto alcuna influenza sulla riflessione delle pratiche di governo sugli animali. Piazzesi non sembra avere intenzioni critiche, nel senso tecnico del termine, ma è interessata piuttosto a complicare e aggiungere dei piani alla storia dello sfruttamento animale. La nascita della scienza veterinaria, l’etologia e le altre le scienze del vivente non smantellano il paradigma meccanicista ma mettono in luce invece le differenti intenzioni delle strategie di potere di investimento sul corpo degli animali (che si moltiplicano e non si riducono l’un l’altra).
Ogni tentativo segue orientamenti epistemo-politici che vengono adottati da allevatori e/o dalle agende degli stati a seconda delle forme di produzione in cui si vuole investire e/o a seconda della “destinazione d’uso” verso cui si pensano gli animali. Riflettendo sulla categoria del nonumano in senso largo è importante riflettere su come le forme di sapere-potere producano e strutturino le differenze tra i corpi degli oppressi proiettandosi verso una forma di messa a valore piuttosto che un’altra. Piazzesi in questa direzione prosegue le riflessioni femministe sulla differenza biologica del lavoro, mostrando come queste proseguano sul corpo animale anche in una chiave specie-specista.
È altresì importante però sottolineare, come d’altronde l’autrice ripropone con attenzione, che un modo di pensare-praticare il governo non è mai assoluto e compatto, e che ogni specifica nuova forma di sapere-potere non ne spazza via un’altra con un movimento di rimozione.
L’investimento biopolitico del potere sul corpo non esclude la tecnica politica della privazione e dell’appropriazione della forza lavoro o forza vita dell’animale. È interessante in questa direzione fare un parallelo con Exploiter les Vivants di Paul Guillibert. Provando a ridefinire obiettivi, strategie e tecniche di governo di messa a lavoro dei nonumani Guillibert propone la differenza tra appropriazione gratuita del vivente e sfruttamento dell’animale da reddito di cui viene capitalizzato sia il lavoro produttivo che quello riproduttivo. Piazzesi e Guillibert ci invitano a problematizzare e a stratificare lo statuto dello sfruttamento animale e/o dell’appropriazione gratuita del vivente evidenziando come i bordi del lavoro produttivo e riproduttivo implicano strategie e tecniche di controllo specifiche e speciste specializzate e differenziate. Guilbert, ad esempio, ipotizza che la logica dell’appropriazione operata verso corpi ridotti a “non viventi” o oggetti passivi, continui ad essere il fulcro teorico nella pratica violenta dell’estrattivismo. Potremmo dire in questo senso che l’estrattivismo ricade ancora su un’immagine di mondo prettamente cartesiana. Appropriazione e sfruttamento dunque non si sostituiscono nettamente ma vengono utilizzati per praticare forme differenti di violenza.
.