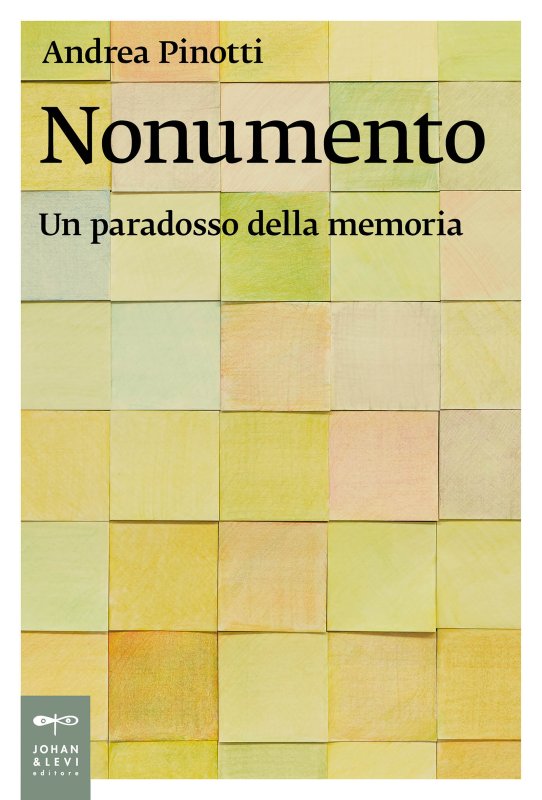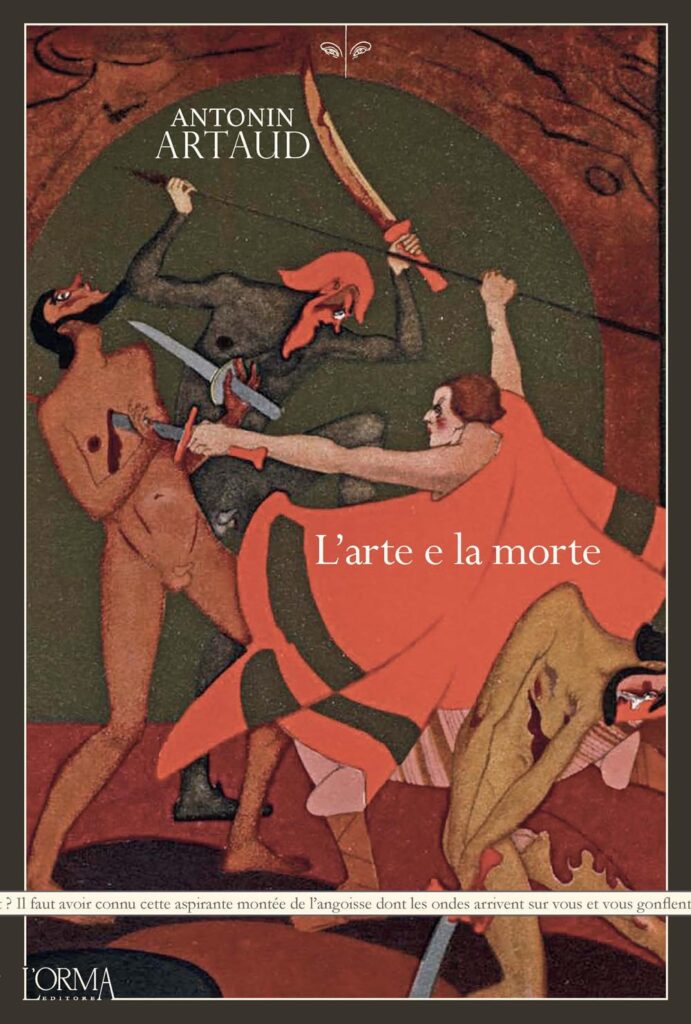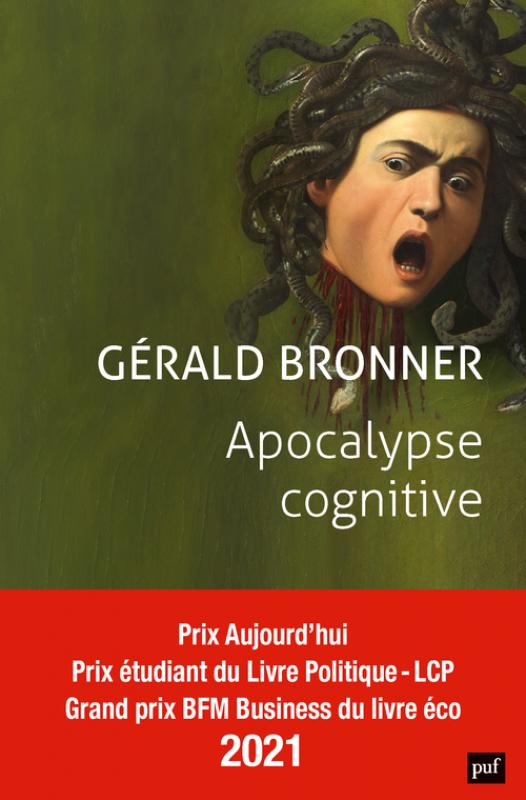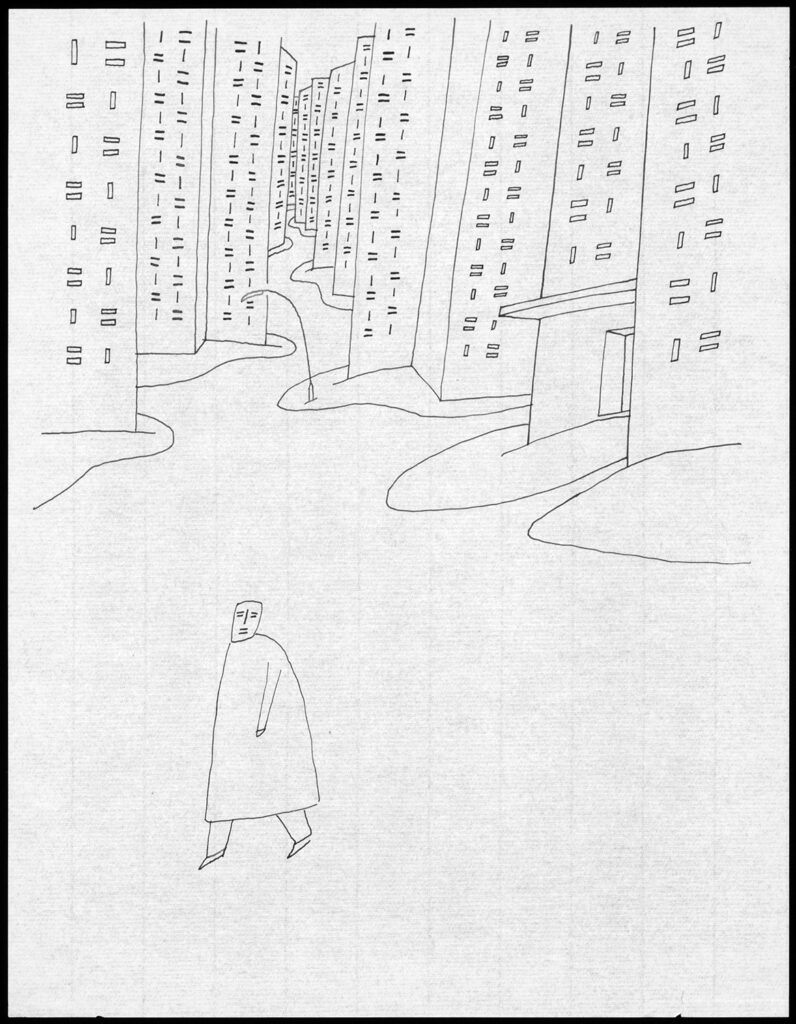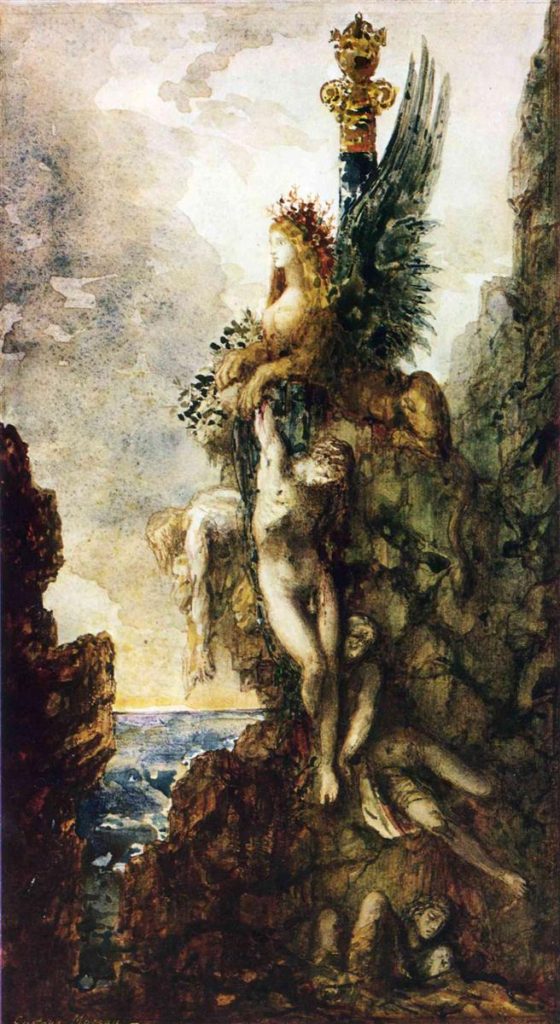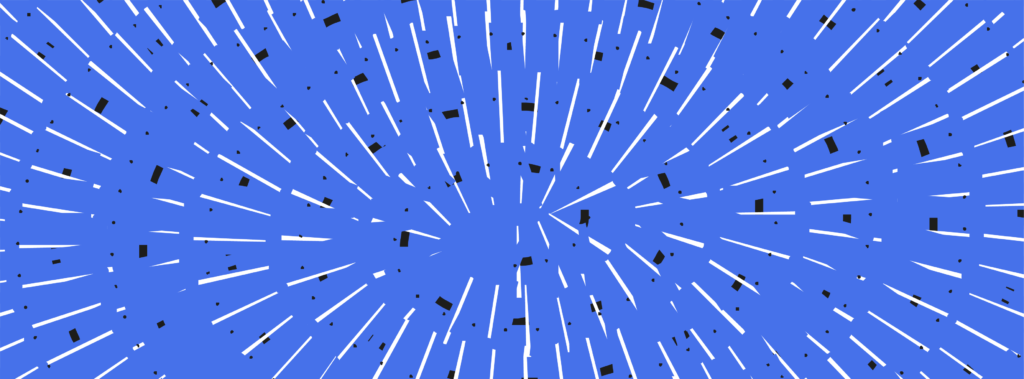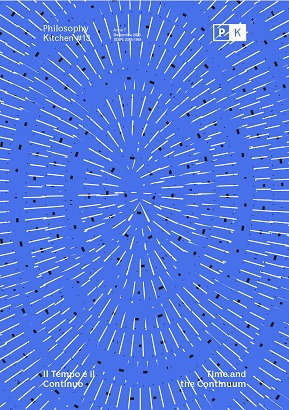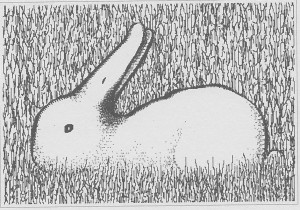-
-
«Che cos’è il digitale e come può essere definito? Cos’ha da dire la tradizione fenomenologica, sviluppatasi più di un secolo fa, su tale questione? Come percepiamo e come entriamo in relazione con oggetti, eventi e ambienti nell’era digitale? Come viviamo il nostro corpo e come questo si modifica in ambienti diversi da quello analogico, per esempio nella realtà virtuale o nella realtà aumentata?» (p. 11). Sono queste le domande alla base del testo "Fenomenologia del digitale. Corpi e dimensioni al tempo dell’intelligenza artificiale" (Mimesis, 2024) scritto da Floriana Ferro. L’autrice studia da anni la tradizione fenomenologica e, nell’opera, utilizza questo approccio per indagare il rapporto tra l’umano e le nuove tecnologie digitali, fino a giungere a una proposta originale su come dovremmo vivere tale rapporto.
L’autore che guida la trattazione di Ferro è Maurice Merleau-Ponty. Nel libro si fa costante riferimento al concetto di “carne”, che il filosofo francese elabora nella tarda fase del suo pensiero. Tale concetto nasce dall’esigenza di superare il dualismo ancora presente nella Fenomenologia della percezione (1945) in favore di un monismo che annulli la distinzione tra Leib e Körper. Ne Il visibile e l’invisibile (1964), Merleau-Ponty scrive:
Ciò che chiamiamo carne, questa massa interiormente travagliata, non ha nome in nessuna filosofia. Medium formatore dell’oggetto e del soggetto, essa non è l’atomo d’essere, l’in sé duro che risiede in un luogo e in un momento unici […]. Si deve pensare la carne non già a partire dalle sostanze, […] ma, dicevamo, come elemento, emblema concreto di un modo d’essere generale (Merleau-Ponty, 2003, p. 163).
Il concetto di “carne” mostra, dunque, una realtà viva e dinamica, in cui i vari elementi interagiscono tra loro grazie a un comune modo d’essere. La figura che rappresenta al meglio questa situazione è quella del chiasma, caratterizzata «da un intreccio dinamico tra polarità divergenti. Nella x e nella χ vengono raffigurate due linee che partono da due punti diversi, si incontrano in un punto e poi seguono direzioni opposte» (p. 36). In questo movimento dialettico – da intendere in senso schellinghiano e non hegeliano – si considera la realtà nella sua pluralità di rapporti, tutti essenziali per comprendere la complessità e la ricchezza del mondo in cui viviamo.
Partendo dalla prospettiva merleau-pontiana, Ferro esamina la relazione che si instaura tra noi e gli ambienti digitali. La realtà virtuale e la realtà aumentata, infatti, sono presenze sempre più familiari e la loro natura e funzione chiamano in causa anche la riflessione filosofica. Una delle tesi presenti nel libro è che gli ambienti analogici e digitali non siano in un rapporto antitetico, bensì esista un continuum tra loro. Per sostenere tale posizione, l’autrice fa riferimento all’idea di Umwelt, esposta da filosofi come Edmund Husserl e lo stesso Merleau-Ponty, ma anche da scienziati come Jakob von Uexküll. L’interconnessione tra il soggetto e l’ambiente circostante applicata alle nuove tecnologie digitali e lo sviluppo dialettico della realtà legato alla “carne” consentono a Ferro di proporre una nuova versione della realtà, che si differenzia sia da quella di Milgram, Kishino e altri del 1994, sia da quella più recente di Skarbez e altri, elaborata nel 2021. Se le prime due versioni individuano nel reale e nel virtuale i due poli della realtà, Ferro – richiamando le polarità ontologiche “possibile-reale” e “virtuale-attuale” formulate da Pierre Lévy nella sua rilettura della filosofia di Gilles Deleuze – esprime una convinzione diversa:
[…] il virtuale non è da considerarsi in contrapposizione al reale, ma come una caratteristica del suo movimento dialettico. I due elementi che costituiscono il reale sono, invece, l’analogico e il digitale, che consistono in due diversi poli della carne, l’elemento comune della realtà. Questi due poli si relazionano dinamicamente in maniera chiasmatica, incontrandosi senza mai sovrapporsi o rischiare di annichilire l’altro polo (p. 77).
Cosa rende possibile l’esperienza del continuum analogico-digitale? Per rispondere a questo quesito, Ferro usa il concetto di “analogia”, declinandolo in chiave fenomenologica. L’esperienza in ambienti diversi presenta comunque dei punti di continuità, poiché tutti partecipano a questo modo di essere che caratterizza la “carne”, consentendo di parlare di analogia transdimensionale. «[…] le relazioni percettive [s]i possono quindi considerare come soggette ad analogie applicabili a dimensioni differenti. L’oggetto è quindi ”analogo”: ciò significa che non rimane del tutto uguale, né cambia totalmente al mutare della dimensione» (p. 126).
Meritevole di particolare attenzione è il quarto capitolo, in cui si analizza il complesso rapporto tra i corpi umani e quelli artificiali. In questo contesto, Ferro dimostra le connessioni che sussistono tra la filosofia e l’ingegneria robotica: l’interazione tra gli umani e i robot è un campo di studio in grande crescita, guidato soprattutto dagli sviluppi dell’IA. La Human Robot Interaction (HRI) porta all’attenzione la questione dell’empatia, ampiamente discussa dalla filosofia e, in particolar modo, dalla fenomenologia. Per comprendere empaticamente l’altro dobbiamo porre uguale attenzione sui due termini dell’espressione alter ego: in primo luogo, devo riconoscerlo come ego in grado di esercitare un comportamento analogo al mio (come avviene nell’associazione appaiante di Husserl); in secondo luogo, devo anche essere consapevole delle differenze tra il mio vissuto e il suo (elemento base dell’empatia descritta da Edith Stein). Numerosi esperimenti dimostrano come gli umani, pur interagendo con degli umanoidi artificiali, esperiscano il doppio movimento appena delineato, riuscendo a provare empatia verso i robot. Secondo Ferro questo è possibile grazie a una comune esperienza del corpo e della “carne” che, come fatto in precedenza, permette di parlare di un’analogia transcorporea.
L’analogia transdimensionale e l’analogia transcorporea conducono alla proposta di un’ontologia piatta (flat ontology). Come sottolinea l’autrice, il termine “piatto” non deve essere interpretato come mancanza di stratificazione della realtà; infatti, «Il concetto di ontologia piatta, inteso in senso fenomenologico, non implica una realtà priva di profondità, bensì la mancanza di una struttura gerarchica degli enti» (p. 169). Quest’ottica, tipica del postumano, viene qui usata per reinterpretare il tardo pensiero merleau-pontiano, evidenziando le infinite interconnessioni tra entità umane e non umane, accumunate da un’unica modalità di esistenza che, però, non annulla mai le loro peculiarità. A conclusione del capitolo, Ferro amplia la prospettiva, includendo nella sua analisi tre esempi di ontologia piatta tratti da autori contemporanei: la Actor-Network Theory (ANT) di Bruno Latour, la Object-Oriented Ontology (OOO) di Graham Harman e l’onticologia di Levi Bryant. Queste proposte – pur nelle loro differenze, messe ben in luce dall’autrice – hanno il pregio di guardare la realtà in modo non antropocentrico, valorizzando lo statuto ontologico degli enti che spesso vengono esclusi dalla riflessione filosofica e scientifica.
Nella sua critica alla metafisica classica di stampo aristotelico-tomista, Deleuze si ispira all’ontologia dell’univocità promossa da Duns Scoto, secondo cui gli enti non differiscono in virtù di un maggior o minor grado di partecipazione all’essere; «Le differenze ci sono, ma l’essere si distribuisce in maniera equa: si predica allo stesso modo per tutte le modalità individuanti, malgrado queste siano diverse l’una rispetto all’altra» (p. 185). In Differenza e ripetizione (1968), il filosofo francese oppone all’immagine di un nómos sedentario, che non coglie la dinamicità del reale, quella di un nómos nomade, capace di comprendere la natura della differenza. La proposta di Ferro segue quest’ultimo (valorizzando, però, anche la verticalità dell’essere), offrendo un’ottima introduzione alla fenomenologia del digitale, ricca di riferimenti bibliografici e feconda di spunti da poter sviluppare: nel libro, infatti, si trovano rimandi (per citarne alcuni) anche alla postfenomenologia, alla teoria ecologica e alla Gestaltpsychologie.
Discutere il nostro rapporto con il digitale è un problema sempre più impellente, nonché un dovere per noi esseri umani: come affermava già Martin Heidegger nella conferenza La questione della tecnica (1953), l’umano è homo technicus, ovvero capace di disvelare l’essere tramite la sua attività produttiva; ma, contemporaneamente, egli è anche homo technologicus, in grado, cioè, di pensare e discutere il suo essere tecnico. Fenomenologia del digitale. Corpi e dimensioni al tempo dell’intelligenza artificiale è un prezioso strumento per iniziare questa discussione.
Efrem Trevisan
Bibliografia
Deleuze, G. (1997). Differenza e ripetizione, Raffaello Cortina, Milano.
Heidegger, M. (1991). La questione della tecnica, in Saggi e discorsi, Mursia, Milano.
Merleau-Ponty, M. (2003). Fenomenologia della percezione, Bompiani, Milano.
Merleau-Ponty, M. (2003). Il visibile e l’invisibile, Bompiani, Milano.
-
Alla luce dell’ombra di Gilbert Simondon
Recensioni / Novembre 2024Sostiene Merleau-Ponty nel suo importante saggio Le philosophe et son ombre che il compito del filosofo sia quello di penetrare l’ombra di coloro ci hanno preceduti e sui quali ci siamo formati. Con questa evocativa immagine, intende restituire vivacità ad una pratica filosofica che rischia di illanguidirsi nella riproposizione del già detto e del presunto acquisito. L’ombra è quel non-detto, quella non-cosa che eppure è presente, che prolunga l’immagine da cui proviene oltre il limite che la figura definisce: il compito del filosofo è allora prendersi carico di quell’ombra, penetrarla, attraversarla e, impregnandosi della sua sostanza, ripensarla, nella consapevolezza che «[p]enser n’est pas posséder des objets de pensée, c’est circonscrire par eux un domaine à penser, que nous ne pensons donc pas encore»[1]. Una ricerca, quindi, che ci vede coinvolti in prima persona, intimamente, e che ci spinge a ripensare quel non detto che noi stessi non abbiamo ancora pronunciato. Gilbert Simondon
E di intimità è a parlare proprio Giovanni Carrozzini, autore di Simondonian Rhapsody: «[a]l termine di uno dei miei due interventi al film-documentario di François Lagarde, Simondon du désert, Pascal Chabot, notando la mia tendenza a riferirmi a Gilbert Simondon con il solo nome di battesimo, mi chiese come mai scegliessi di farlo. Risposi, senza alcuna titubanza, che ciò si spiegava sulla scorta del fatto che avevo stabilito con il filosofo una tale “intimità” da caratterizzare la mia ricerca su di lui come un’autentica storia d’amore».[2] In questo libro, composto da dieci saggi che intrecciano la filosofia simondoniana con quella di grandi pensatori del passato e a lui contemporanei (da Nietzsche a Lacan, passando per i presocratici e Sartre, per giungere fino a Barthes, Ruyer e Jankélévitch), si concretizza quella penetrazione dell’ombra caldeggiata da Merleau-Ponty: ampliamento e prolungamento della filosofia nel dialogo tra filosofie differenti, ma ugualmente genuine. Proprio per la sua natura di ricerca inesausta, il volume si riflette caleidoscopicamente, in continui rimandi di fasci luminosi che gettano luce reciproca: alla luce del pensiero di Simondon si rileggono i vari filosofi cui l’autore si confronta, così come alla loro luce se ne indagano le ricadute, in ottica di una migliore comprensione del pensiero di Simondon. Da questo serrato confronto cosa possiamo imparare? Ecco allora il cuore pulsante del lavoro di Carrozzini: ripensare la filosofia alla luce dell’ombra di Simondon.
I vari contributi del saggio sono collegati da una tematica di fondo che trova condensazione nel capitolo dedicato al confronto tra la riflessione sulla morte in Jankélévitch e in Simondon. Per il filosofo della tecnica, difatti, la questione tanatologica è della massima importanza. Alla luce della sua tesi dottorale principale dal titolo estremamente significativo - L’individuazione alla luce delle nozioni di forma e di informazione[3] - appare evidente come l’interesse preminente della sua filosofia sia il processo di individuazione, di presa di forma, di in-formazione come dinamismo immanente all’essere stesso che si individua e individualizza senza esaurire la sua carica di potenzialità inespresse. Carrozzini afferma correttamente che «l’informazione è l’innesco, apportato da una singolarità di un processo che implica il mutamento degli equilibri e degli assetti del sistema in cui si propaga»[4], concentrando così l’attenzione alla propagazione interna agli assetti del sistema. In questo senso l’aspetto tanatologico assume un ruolo rilevante: come è possibile pensare un sistema che sia in sé aperto, in equilibrio non stabile ma dinamico dunque, con termine sinondoniano, metastabile? Ovvero un sistema che possa includere in sé la morte come momento, come fase che non impedisce il processo di presa di forma. In questo senso si possono leggere anche le critiche mosse dal filosofo francese alla Gestaltheorie, alla teoria della Forma in qualità di Buona Forma, di forma formata. L’equilibrio che si verrebbe a creare sarebbe esclusivo e adiabatico: verrebbe a mancare proprio quella dimensione di attraversamento trasversale, di trasformazione proprie di un sistema in-formativo. Dal punto di vista della Gestaltheorie l’obiettivo finale dell’informazione è il completamento della formazione, è la piena assunzione di una forma in sé completa, etimologicamente perfetta, cui nulla si può aggiungere. Esito di questa processualità spuria: la morte del sistema.
Di conseguenza, l’impostazione formulata da Simondon cerca di bypassare, nella sua elaborazione, le secche entro le quali rischia di incagliarsi alla fin fine ogni pensiero astrattamente ontologico. L’ipotesi che guida la sua ricerca – la formulazione di un sistema aperto e in formazione – richiede una riconcettualizzazione complessiva della terminologia filosofica che sappia dialettizzare la sterile dicotomia classica ilemorfismo vs sostanzialismo. Come che sia, l’aspetto però veramente rilevante di questo rinnovamento concettuale è la critica alla dialettica di stampo hegeliano. Interessante è però notare che Simondon stesso è un utilizzatore del metodo triadico hegeliano. Solamente, differente è lo spirito che lo anima. Difatti, Carrozzini individua alcune strutture che possono rimandare alla mente la dialettica tesi-antitesi-sintesi, ma che presentano una logica ben differente. La prima è formulata in Imagination et invention,[5] in occasione di un importante corso di Psicologia alla Sorbona. Analizzando il processo di formazione delle immagini, tre sono le tappe individuate: l’immagine a priori, la cui operazione principale è l’anticipazione; l’immagine a praesenti, che presenta contenuti cognitivi in quanto «ogni percezione è accompagnata da un’attività immaginativa che funge da selezione degli stimoli esterni»[6]; infine, l’immagine a posteriori che si concretizza nel simbolo, figura dalla forte carica affettivo-emotiva. Se è vero che il simbolo può essere inteso come una sintesi di anticipazione e cognitività, tra a priori e a praesenti, lo è altrettanto il fatto che quest’ultimo ha natura eminentemente metastabile, ovvero apre il sistema all’ontogenesi dell’invenzione.
È con il concetto di ontogenesi che la dinamicità dell’essere si svincola dalle catene dialettiche. Al momento speculativo dell’in sé e per sé dell’Idea, si sostituisce così il prolungarsi dell’individuazione, della presa di forma che riattiva, di volta in volta, quel bacino che resiste all’esaurimento. Al preindividuale – associato all’ápeiron anassinandreo – segue l’individuato, ciò che si è condensato nel processo di individuazione, che non rimane chiuso in sé, ma prosegue la sua espansione nel terreno del transindividuale, in quella individuazione collettiva indisgiungibile da quella psichica e individualizzata.[7] E il processo non si arresta: in gioco non è la struttura, ma la strutturazione, la continua relazionalità ontogenetica[8] che dinamicizza l’essere: l’ontogenesi è performatività, è operatività. Così Carrozzini: «[l]a forma diviene così una presa di forma, una processualità: la struttura corrisponde a una strutturazione, il divenire a una genesi, il principio di individuazione a un’operazione»[9].
Questione tanatologica, rinnovamento del concetto di informazione in qualità di in-formazione, ovvero di presa di forma, critica alla dialettica in ottica ontogenetica: sono queste le più importanti acquisizioni della filosofia di Gilbert Simondon e che l’autore di Simondonian Rhapsody bene illustra in questa raccolta di saggi. Ripensare alla luce di queste nozioni per penetrare l’ombra del non detto, per riattivare quella carica di potenziali sempre in procinto di essere espressi e di esprimersi è l’obiettivo di questo lavoro che ha il merito di introdurre il filosofo francese tra i grandi interlocutori del Novecento e della nostra contemporaneità.[10]
Un’ultima, breve nota, tratta dal capitolo conclusivo Sacralità e tecnicità. Breve storia di un intreccio[11], a testimonianza dell’ampiezza della sua filosofia, e che permette un ulteriore ampliamento delle prospettive ontogenetiche. Riconoscendo l’importanza del sacro per il pensiero tecnico e per la filosofia in senso lato,[12] è la sacralità stessa a essere rivalutata: non più l’inviolabilità della separazione, dell’intangibilità differenziante che isola domini in sé autosufficienti, ma la reticolarità di nodi e punti-chiave che emergono stagliandosi, figure che spiccano da uno sfondo che ne rende possibile l’ek-stasi. Evidente la fecondità di queste riflessioni solamente accennate in vista di futuri scandagli filosofici: come è possibile pensare l’essere in chiave trascendentale?
Simone Vaccaro
[1] M. Merleau-Ponty, Le philosophe et son ombre, in Signes, Gallimard, Paris 1960, p. 260.
[2] G. Carrozzini, Simondonian Rhapsody, Orthotes, Napoli-Salerno 2024, p. 5.
[3] G. Simondon, L’individuazione alla luce delle nozioni di forma e di informazione, Mimesis, Milano-Udine 2011.
[4] G. Carrozzini, op. cit., p. 18.
[5] G. Simondon, Imagination et invention 1965-1966, PUF, Paris 2014.
[6] G. Carrozzini, op. cit., p. 48.
[7] Cfr., ivi, p. 83.
[8] Cfr., ivi, pp. 93-97. Considerazioni che ricordano quelle avanzate più recentemente da Graham Priest in One: «[th]e matter is rather like that in classical gravitational theory. Every object exerts a gravitational influence on every other, however far apart. Thus, the net gravitational force on me is partly determined by a rock on a planet in another galaxy […]. So it is with the relations which constitute my quiddity». Cfr., G. Priest, One, Oxford University Press, Oxford 2014, p. 173.
[9] G. Carrozzini, op., cit., p. 62.
[10] Accogliendo la proposta di Frédéric Worms nella presentazione del volume Sur la philosophie di pensare «à la lumière de Simondon». Cfr, F. Worms, Présentation, in G. Simondon, Sur la philosophie 1950-1980, PUF, Paris 2016, pp. 5-14.
[11] G. Carrozzini, op. cit., pp. 131-134.
[12] Degne di nota sono le notevolissime considerazioni contenute nel corso Psicosociologia della tecnicità (1960-1961), sui rapporti tra tecnica e sacralità. Cfr., G. Simondon, Sulla tecnica, Orthotes, Napoli-Salerno 2017, pp. 13-99.
-
Nonumento: un paradosso della memoria
Recensioni / Ottobre 2024Andrea Pinotti ha pubblicato l’anno scorso, per Johan & Levi, l’esito di un ventennio di ricerche sul tema del monumento e del nonumento. La quantità di informazioni che si traggono dal libro, la precisione della tassonomia in esso proposta e la riflessione teoretica che l’accompagna susciterebbero nel lettore l’impressione di una certa monumentalità – se non fosse che il titolo sta lì a infastidire la pronuncia di chi vorrebbe dire «monumento», con la «m». Nonumento. Un paradosso della memoria, smonta la categoria di «monumento» (e le aspettative che più comunemente si associano a essa) e, allo stesso tempo, costruisce quella di «nonumento».
Pinotti ha abituato il pubblico ad analisi in cui fenomeni contemporanei vengono inquadrati in un contesto storico e teorico capace di illuminarli[1]. Dell’attualità del «nonumento» – in una prima caratterizzazione, un monumento che nega la monumentalità – può accorgersi facilmente chi rifletta sui corsi e ricorsi della cosiddetta cancel culture. Gli attivisti di Black Lives Matter che abbatterono la statua di Edward Colston (1636-1721) nel giugno 2020 a Bristol difficilmente avevano altro in mente che eliminare il monumento di un cittadino tanto illustre quanto compromesso dal passato schiavista. Alle inevitabili polemiche seguite al gesto iconoclasta[2] sarebbe seguita la proposta ironica di Banksy [fig. 1] per un monumento capace di soddisfare le esigenze sia degli attivisti sia di chi avrebbe voluto rimettere la statua al suo posto. Pinotti propone di leggere lo schizzo di Banksy come «pienamente nonumentale» (p. 218), prendendone sul serio la proposta. Laddove il monumento pretende di scrivere la storia – dal punto di vista, almeno, di chi pensa e dispone il monumento –, il nonumento di Bansky creerebbe «quella che con Walter Benjamin potremmo chiamare “immagine dialettica”: un’immagine capace di incorporare dinamicamente istanze differenti, persino confliggenti e contraddittorie» (p. 218). L’esempio mi sembra offrire un buon accesso alla ricerca di Pinotti, per varie ragioni. Innanzitutto ne evidenzia l’attualità e il potenziale critico – cioè, di discernimento – rispetto a un panorama in evoluzione; mostra, inoltre, quanto la relazione fra «monumento» e «nonumento» sia intima e costitutiva. Quest’aspetto, con le sue ragioni e le sue implicazioni, è centrale.
Il testo è quadripartito. L’introduzione fornisce lo schizzo del quadro storico e teorico all’interno del quale, nel Novecento, la categoria di monumento è entrata in crisi; allo stesso tempo, introduce l’emergere del nonumento – o delle strategie nonumentali – quale refuso di quella memoria divenuta inaccessibile al monumento. L’intersecarsi di monumento e nonumento è così introdotto fin dai primi passi. Seguono, poi, due parti analitiche. La prima parte, dedicata al monumento, articola i casi molteplici della messa in crisi del monumento, mostrando come la categoria stessa di monumento includa i principi del suo dissolvimento. La seconda parte, la più corposa, è dedicata al nonumento. Pinotti offre una tassonomia nonumentale, in cui all’analisi di casi singoli s’intreccia lo sviluppo della prospettiva teorica. Il libro incede con un ripetuto esercizio di avvicinamento a singoli nonumenti e allargamenti ai presupposti e alle implicazioni teoriche. Lo si potrebbe per questo cogliere come un caso di attenzione morfologica, in senso lato. La forma del nonumento non si dà, e non può che essere studiata, attraverso lo studio dei suoi sviluppi concreti – ma è l’emergere di quella forma, allo stesso tempo, a illuminare i casi concreti. Le Conclusioni con cui termina il volume ne ricapitolano le linee principali e affrontano il potenziale critico del nonumento, in cui il suo potenziale critico e la crisi del monumento si uniscono.
Il primo aspetto da sottolineare a proposito della crisi novecentesca del monumento è, pertanto, che essa ha una doppia valenza: sia storica che teorica. Il primo aspetto coincide con il diffondersi, nel secondo Dopoguerra, di casi di contro-monumenti e anti-monumenti. I primi, legati alla difficoltà di costruire memoriali per la Shoah; i secondi, definiti in base alla costruzione di un memoriale che si oppone a un altro memoriale. Ma l’aspetto storico si connette con lo sviluppo teorico. Nel corso del Novecento la riflessione sulla funzione memoriale si radicalizza: è il secolo in cui si consolida la comprensione del passato (e del rammemorato) come (ri-)costruzione del presente, in cui diventa evidente che dietro a ogni tradizione si cela un tradimento. E il monumento, scrive Pinotti, «è la materializzazione di questo gesto operativo» – ma, «insieme, il suo occultamento» (p. 9). Il dipanarsi della crisi storica del monumento coincide con l’emergere teorico delle contraddizioni interne al monumento, attraverso cui rammemorare diviene dimenticare. La Prima parte, quindi, mostra l’insidiarsi di queste contraddizioni in tutte le categorie («la verticalità, la visibilità, la permanenza, la materialità, la fissità, la magniloquenza, la transitività, ecc», p. 248) con cui cerchiamo, normalmente, di pensare il monumento: ognuno degli approcci tentati finisce in una impasse che Pinotti deduce quasi more geometrico. Più che di fronte a categorie in grado di definire e spiegare il monumento nelle sue forme ci troviamo di fronte a retoriche che girano attorno a un vuoto, il bisogno di monumento. È proprio lo scarto fra bisogno di monumento e bisogno di ricordare a spiegare il passaggio dal monumento al nonumento. Se il primo subisce quei paradossi, il secondo li assume. Ciò che accomuna i nonumenti, oltre le specifiche differenze, è «l’esperienza del commemorare come esercizio paradossale» (p. 100): essi, per dir così, esercitano attivamente il paradosso che è loro proprio.
L’aspetto più generale – nel rapporto fra storia e teoria – dell’incidere ancipite del libro, in cui dai casi si risale ai loro presupposti, e alle loro implicazioni, appare anche nel modo in cui è ricavata la stessa definizione di nonumento. Il refuso (della memoria) che trasforma il monumento in nonumento ricorda – e trasforma – un conio linguistico di Gordon Matta-Clark, uno dei primi artisti considerati nella Seconda parte del volume di Pinotti. Matta-Clark aveva introdotto le espressioni di Non.u.mental e Non-ument per riflettere su lavori quali Conical Intersect (1975, Parigi): da un lato, l’esclusione degli interessi del fruitore dall’architettura (not.u, cioè: not you), dall’altro, la negazione della grandeur monumentale (not-monumental, cioè: non-umental). Siamo, fin qui, nell’ambito dei rimandi intrinseci a un’opera, esplicitati attraverso l’analisi dell’opera e delle riflessioni dell’autore (e critiche, in particolare di Judith R. Kirshner). Ma Pinotti nota che vi è un’ulteriore paradosso iscritto nelle opere di Matta-Clark. Esse, infatti, «sono andate distrutte: ne restano solo le documentazioni fotografiche o i video» (p. 117). Si passa così da una dinamica interna alle sue opere a una dinamica che ha implicazioni più generali, nonumentali. L’operazione di Matta-Clark insiste sulla nozione di monumento invertendone di segno i valori storici relativi e involontari, trasformandoli in «una sorta di valore monumentale volontario e intenzionale» (p. 118). Potremmo dire, parafrasando Aby Warburg, che il nonumento funziona quasi come un’inversione energetica del monumento, in cui ciò che appare proprio del monumento, ma è invero inaccessibile, può realizzarsi in forme consapevolmente problematiche. Siamo così già passati al livello teorico: alla definizione del nonumento nella sua polarità costitutiva col monumento, che ha implicazioni ad ampio raggio e che sostiene la tassonomia delle strategie dei lavori nonumentali («immergenti, invisibili, effimeri, atmosferici, aumentati, performativi, interattivi, riappropriati, intransitivi», p. 248).
Il «paradosso della memoria» a cui fa riferimento il sottotitolo del volume sembra, attraverso l’analisi di Pinotti, insinuarsi nelle fibre di ogni «monumento» e «nonumento»: la polarità fra monumento e nonumento appare così come una caratteristica ineludibile per entrambi. L’obiezione più immediata che potrebbe venire in mente – i monumenti sono ben esistiti prima dei nonumenti! – è utile per approfondire un aspetto assai rilevante di questa polarità: la crisi interna della monumentalità non esaurisce infatti la definizione del nonumento, per quanto il nonumento abbia costitutivamente a che fare con quella crisi. Il paradosso attorno a cui si muove Pinotti non va quindi rintracciato nella crisi del monumento (che appare paradossale, ma manifesta consequenzialità logica), presa per sé; né nella definizione del nonumento. Il paradosso più proprio appare essere, piuttosto, quello del rapporto che viene così disegnato fra i due poli stessi: monumento e nonumento.
Il primo capitolo conclude dichiarando che l’esito della ricerca sul nonumento, in conformità al suo oggetto, non può che essere aporetico. Non solo per la problematicità intrinseca del nonumento, ma per la stessa forma polare della «dialettica immanente al problema del nonumento, che si può riassumere nella formula spinoziano-hegeliana omnis determinatio est negatio (e reciprocamente, omnis negatio est determinatio). Chi nega pone, insomma, e se è vero che il monumento, come abbiamo visto nella prima parte, è insieme dispositivo di rammemorazione e macchina di oblio, la sua negazione o decostruzione nel nonumento non sembra potersi sottrarre a questa fatale polarità» (p. 118). Che fare, allora, in questa situazione? Pinotti, sembrerebbe, cerca di assumere l’aporia, di attivarla.
Come il monumento esiste entrando in crisi, così il nonumento esiste manifestando la crisi del primo; e questa manifestazione rende paradossalmente possibile la rammemorazione che al monumento deve finire per sfuggire. È qui l’aporia. Il monumento presuppone un gesto rammemorativo che diventa reperibile solo attraverso la sua negazione, mentre il nonumento presuppone un oggetto – il monumento – che rende impossibile e che, allo stesso tempo, vivifica.
Nella prospettiva sviluppata da Pinotti l’ipotesi forse decisiva è allora che le immagini («per rimanere nell’ambito che più ci interessa qui, quello delle immagini …» (p. 195)), certo prese in senso lato, siano capaci di negazione. Ma quale negazione? È una domanda che questa ricerca permette di riformulare.
Attraverso il lapsus calami che insinua un «non» nel «monumento», la negazione articola l’oggetto stesso dell’indagine – il rapporto polare fra monumento e nonumento, in ultima analisi – e la sua aporia. Non si tratta però di una negazione il cui raggio d’azione possa essere limitato alla sfera del solo discorso. La forma dell’aporia individuata da Pinotti, infatti, sembra essere quella di una negazione di cui proprio l’immagine sarebbe eminentemente capace. (Si tratta qui, certo, della «immagine» nonumentale: ma sarebbe possibile un’estensione, se non all’immagine in generale, almeno ad altri casi? E che ne è del rapporto fra immagine e discorso?) Attraverso il rapporto fra nonumento e monumento sembra profilarsi, per l’immagine, la possibilità di una negazione in cui ciò che viene negato non è per ciò stesso escluso, ma nemmeno riassorbito dal negante. Una storia di fantasmi, forse – il paradosso della memoria.
Davide Mogetta
[1] Fra gli altri lavori recenti, cfr. A. Pinotti, Alla soglia dell’immagine. Da Narciso alla realtà virtuale, Einaudi, Torino 2021; e, inoltre, il progetto AN-ICON (https://an-icon.unimi.it/).
[2] Dopo una discussione su varie ipotesi di musealizzazione temporanea e permanente (https://www.artnews.com/art-news/news/toppled-slave-trader-edward-colston-statue-expected-to-be-permanently-installed-in-bristol-museum-1234696195/) la statua è oggi esposta allo M Shed Museum di Bristol (https://www.bbc.com/news/uk-england-bristol-68569148).
-
PK#23 \ ottobre 2025
a cura di Fabrizio Meroi e Paolo Vanini
Nel dibattito filosofico contemporaneo, l’utopia viene spesso presentata come un progetto politico che ha l’ambizione di fare tabula rasa del passato, per instaurare – in un futuro più o meno imminente – un modello di società radicalmente contrapposto allo status quo del presente storico. In questo senso l’utopia si configura come un’ipotesi rivoluzionaria, ma anche potenzialmente totalitaria, nella misura in cui prevede un capovolgimento totale della realtà che non ammette alcun compromesso o riforma parziale (Tower Sargent 2010; Altini 2013). Motivo per cui è opportuno mantenere uno sguardo critico verso l’utopia, nella consapevolezza che la strada verso un mondo ideale può talvolta condurre nel vicolo cieco di un mondo impossibile.
Alla base di questo approccio c’è la tendenza a sottovalutare il fatto che il termine utopia non nasce per indicare un progetto politico, ma un genere letterario nato in epoca rinascimentale (Fortunati 2001; Vieira 2010; Yoran 2010). In quanto tale, l’utopia sfrutta la dimensione della finzione narrativa non per fare tabula rasa del passato, bensì per praticare un gesto di epoché nei confronti della realtà attuale. Il Nuovo Mondo immaginato e raccontato dagli utopisti, prima ancora di essere un luogo ideale, rappresenta un modello alternativo al mondo esistente: un mondo fondato su principi logici, etici, politici e religiosi diversi da quelli che regolano i meccanismi della società a cui apparteniamo (Ruyer 1988). È precisamente in questo frangente che emerge la dimensione scettica del pensiero utopico: per immaginare una società che obbedisce a norme e valori diversi dai nostri, è innanzitutto necessario sospendere il giudizio sull’effettiva validità di questi valori e queste norme. L’utopia è al contempo una finzione e un’ipotesi teorica, che consente al lettore di osservare la realtà da una prospettiva inusuale e paradossale, perché l’utopia si configura come un mondo al contrario che gioca con le contraddizioni del mondo reale per suggerire che tali contraddizioni non costituiscono l’unica realtà possibile (Ginzburg 2002; Piaia 2018).
A partire da queste premesse, il presente numero di Philosophy Kitchen intende indagare il rapporto tra utopia e scetticismo attraverso un approccio interdisciplinare, con lo scopo di mostrare come l’immaginazione utopica abbia permesso di destabilizzare i confini che – all’interno di una determinata tradizione o disciplina – regolamentano e giustificano la distinzione tra possibile e impossibile, così come tra legittimo e illegittimo o giusto e sbagliato. Quando tali confini vengono superati, l’utopista-scettico (poco importa che sia uno scrittore, un intellettuale o un artista) non genera materialmente un “nuovo mondo”, ma crea le condizioni per agire, pensare e comporre in modi diversi rispetto a quelli cristallizzati dalla tradizione. L’abitudine a guardare e interpretare il mondo in ottemperanza a certi valori tradizionali innesca l’erronea e inconsapevole convinzione che questi criteri siano indiscutibili e immodificabili (Montaleone 2011). Al contrario, l’utopista-scettico rivendica il bisogno di dubitare di questi criteri, per emancipare il proprio sguardo dalla forza coercitiva dell’abitudine e rivelare la possibilità di nuovi orizzonti.
Al riguardo, questo numero di PK muove da tre domande tra loro complementari:
1) In che modo lo scetticismo utopico ha contribuito alla creazione di nuovi linguaggi e forme di espressione in ambito sia filosofico che artistico?
2) In che modo questi linguaggi e forme di espressione hanno rappresentato un momento di discontinuità rispetto alla tradizione precedente, attraverso un dialogo più o meno conflittuale con il passato?
3) In che senso, infine, questi momenti di discontinuità utopica possono essere interpretati come forme di “ingegneria concettuale”, capaci di accelerare quel processo che permette a una visione teorica di radicarsi nel mondo reale e nel senso comune?
Le proposte possono esplorare questi interrogativi focalizzandosi su diversi momenti o tematiche della tradizione utopica, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- l’utopia e il simbolismo carnevalesco tra Medioevo e Rinascimento;
- l’utopia come trompe-l'œil narrativo;
- l’utopia tra pensiero laico e simbolismo religioso;
- lo stato di natura e l’utopia come finzione giuridica;
- l’incontro con l’Altro: identità e alterità nei mondi utopici;
- natura e cultura nel pensiero utopico;
- il rapporto tra umorismo e scetticismo nelle utopie satiriche;
- utopie e distopie nell’immaginario moderno e contemporaneo;
- utopia e architettura;
- musica, tempo e utopia: la musica come forma di espressione utopica.
Bibliografia:
Altini, C. (2013). Utopia. Storia e teoria di un'esperienza filosofica e politica, Bologna: il Mulino.
Fortunati V. (2000). “Utopia as a Literary Genre”, in Dictionary of Literary Utopias, ed. by V. Fortunati and R. Trousson, Paris: Champion, p. 634-643.
Ginzburg, C. (2002). No Island Is an Island: Four Glances at English Literature in a World Perspective, Columbia: Columbia U.P.
Montaleone, C. (2011). Oro, cannibali, carrozze. Il Nuovo Mondo nei Saggi di Montaigne, Torino: Bollati Boringhieri.
Piaia, G. (2018). “L’Utopia di Thomas More tra iocus serio e messaggio universale”, Rinascimento, 58, p. 371-381.
Ruyer, R. (1988), L’Utopie et les Utopies, Brionne: Montfort.
Tower Sargent, L. (2019). Utopianism. A Very Short Introduction, Oxford: Oxford University Press.
Vieira, F. (2010). “The Concept of Utopia”, in The Cambridge Companion to Utopian Literature, ed. by G. Clayes, Cambridge: Cambridge University Press. Yoran, H. (2010). Between Utopia and Dystopia, New York: Lexington.
Procedura:
Per partecipare alla call, inviare all'indirizzo redazione@philosophykitchen.com e a quello del curatore in cc. paolo.vanini@unitn.it entro il 30 settembre 2024, un abstract di massimo 4.000 caratteri, indicando il titolo della proposta, illustrando la strutturazione del contributo e i suoi contributi significativi, e inserendo una bibliografia nonché una breve biografia dell’autore o dell’autrice.
L'abstract dovrà essere redatto secondo i criteri scaricabili qui [Template Abstract], pena esclusione.
Le proposte verranno valutate dai curatori e dalla redazione. I contributi selezionati, che saranno sottoposti a double-blind peer review.
Lingue accettate: italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo.
Calendario:
- 30 settembre 2024: consegna degli abstract
- 15 ottobre 2024: comunicazione degli esiti
- 30 aprile 2025: consegna dei contributi selezionati
- 30 giugno 2025: comunicazione degli esiti della selezione
- ottobre 2025: pubblicazione del volume
-
L’arte e la morte
Recensioni / Aprile 2024Alla vigilia del centenario del Manifesto di Breton (1924), è apparso in Italia, per i tipi de L’Orma, una nuova edizione dell’Arte e la morte di Antonin Artaud, curata da Giorgia Bongiorno e Maia Giacobbi Borelli. Già tradotto nel 2003 per Il Melangolo, il volume si compone di otto testi redatti tra il 1925 e il 1928, che furono originariamente pubblicati, a eccezione di Chi, nel cuore…, su riviste surrealiste, per poi venire raccolti per la prima volta nel 1929. Nel lasso di questi pochi anni Artaud aderisce entusiasticamente al movimento surrealista (dirige addirittura un intero numero della rivista La Révolution surréaliste), per poi venirne espulso nel 1926. Questa nuova pubblicazione rende conto della complessità del contesto in cui l’opera vede la luce, grazie ai due saggi delle curatrici, in apertura al volume, e alle note introduttive a ogni testo, che, seppur brevi, ne tracciano efficacemente la genesi.
L’adesione ambivalente e sofferta di Artaud al Surrealismo può d’altronde essere sintetizzata dallo stesso autore nella Lettre à Madame Toulouse nel 1924:
J’ai fait connaissance avec tous les dadas qui voudraient bien m’englober dans leur dernier bateau surréaliste, mais rien à faire. Je suis beaucoup trop surréaliste pour cela. Je l’ai d’ailleurs toujours été, et je sais, moi, ce que c’est que le surréalisme. C’est le système du monde et de la pensée que je me suis fait depuis toujours (Artaud 1993, 112).
Più surrealista dei surrealisti, colpevoli di confinare la rivoluzione nella sfera politica o artistica quando doveva investire ogni aspetto della vita, Artaud raccoglie e rielabora stimoli del gruppo fino a portarli all’estremo. La contestazione surrealista della ragione come unico strumento per indagare e interpretare il mondo si radicalizza in Artaud nella volontà di ritrarre un universo molteplice e contradditorio fino a erodere il rapporto biunivoco tra le parole e le cose. Dietro le apparenze si nascondono infinite dimensioni di significato che la razionalità non è in grado di cogliere; nel momento in cui si tenta di ritrarla, la realtà si rivela ineffabile. Sintomo di questa continua sovrapposizione di piani è, nei testi dell’Arte e la morte, l’osservazione della misura degli oggetti e della natura, che appaiono sempre sproporzionati, percepiti ora minuscoli ora giganteschi.
Nella vertigine di questo infinito, la sfida di Artaud è quella di riuscire a stare in bilico, senza cristallizzarsi mai in un significato definitivo; ed ecco che l’arte e la morte del titolo acquistano centralità in quanto stati di sospensione tra i vari aspetti del reale. Il primo di questi due poli, l’arte, intesa come visualizzazione del possibile, rappresenta in questo senso un eccellente campo d’indagine. La centralità che Artaud attribuisce all’arte figurativa come strumento di conoscenza e fonte d’ispirazione per la sua scrittura, tratto saliente dell’intera produzione artaudiana (basti pensare a Van Gogh ou le suicidé de la societé o a Le Théâtre et son double), risulta già qui ampiamente attestata. Paolo Uccello figura tra i protagonisti della raccolta, mentre i dipinti di Jean de Bosschère (di cui un’illustrazione è stata scelta per la copertina) e André Masson sono esplicitamente indicati come punti di riferimento per la redazione, rispettivamente, di L’automa personale e L’incudine delle forze.
E tuttavia l’arte figurativa non si limita a essere fonte di ispirazione in queste pagine; essa ne influenza potentemente la scrittura. Come sottolinea Bongiorno nel suo saggio introduttivo al volume, Un’oscura e intraducibile scienza, L’arte e la morte «richiede una lettura che della circolarità tra immagine e parola che rasenta a tratti l’intraducibilità» (2023, 7). Il pensiero di Artaud mal si adatta alla progressione ordinata di un testo articolato ma riesce a condensarsi in visioni capaci di suggerire connessioni inattese. In contrapposizione alla corrispondenza perfetta e forzata tra la parola e il suo referente e alla gerarchia sottesa nella sintassi, Artaud si affida alla potenza evocativa dell’immagine, che si dimostra un linguaggio più efficace per veicolare una realtà multiforme e in continua trasformazione. L’arte figurativa diviene dunque modello imprescindibile per la scrittura di Artaud, alla ricerca di una forma che possa veicolare l’autentica natura delle cose.
L’arte risulta dunque uno dei poli d’attrazione fondamentali della raccolta, in quanto momento che mette in crisi la distinzione di ciò che è reale e ciò che è immaginario, capace di esprimere istanze contraddittorie per il linguaggio analitico. Ma anche la morte costituisce, paradossalmente, un momento di sospensione. Artaud lo sottolinea esplicitamente fin dalla breve lirica posta a esergo della raccolta: «La morte giace / come l’ultimo sobbalzo / piena di trance / ma SOSPESA» (23). Come quello che abitualmente si immagina essere lo stato definitivo per eccellenza, la fine, possa essere percepito come una fase di transizione, viene argomentato già nell’apertura del primo saggio:
È il corpo stesso, giunto al massimo dell’espansione e delle forze, che deve comunque andare più lontano. Una specie di ventosa messa sopra l’anima, la cui asprezza corre come vetriolo fino agli ultimi limiti del sensibile. E l’anima non ha neanche la possibilità di spezzarsi. Perché questa stessa espansione è falsa. La morte non si accontenta così facilmente. L’espansione nell’ordine fisico è come l’immagine rovesciata di un restringimento che deve occupare lo spirito su tutta la superficie del corpo vivo (27-28).
La morte viene dunque descritta come la soglia che vanifica gli orizzonti di significato inevitabilmente parziali che attribuiamo alla realtà; è il passaggio per eccellenza, che secondo Artaud non conduce all’annientamento, ma costituisce il punto in cui questo flusso perenne, questo movimento di espansione-restringimento, diviene manifesto sul corpo.
Immediatamente evocati nel titolo, arte e morte non rappresentano tuttavia gli unici mezzi a disposizione per entrare in contatto con l’infinità del reale. La raccolta ne suggerisce molti altri: il sogno, le sostanze psicotrope, l’occulto, l’amore e il teatro. D’altronde, Artaud introduce il tema del sogno nella raccolta proprio mentre parla della morte, di cui sembra costituire una sorta di prova generale: il testo descrive l’agonia come qualcosa di simile alla sensazione di soffocamento e di angoscia che si prova negli incubi. Il sogno ha pertanto una valenza fondamentale in quanto consente di conoscere e di vivere determinate sensazioni senza doverne subire le conseguenze su un piano concreto. Il fatto che l’attività onirica non trovi riscontro nel mondo materiale ma rimanga virtuale non inficia il suo valore, non la rende meno vera.
Anche l’esperienza delle droghe, a cui Artaud fu esposto precocemente a causa della malattia psichica, contribuisce a raggiungere questo obiettivo: contro «l’ottenebramento della vita», ovvero contro l’idea che sia reale soltanto ciò che ha una manifestazione sensibile, le droghe permettono di raggiungere una «lucidità assolutamente anormale» (30), che consente di avere chiara percezione anche di altri aspetti della verità. Proprio come nei sogni, nei momenti di alterazione l’uomo può accedere a una dimensione altra che normalmente è preclusa all’esperienza. Dato che «il reale è solo uno degli aspetti più transitori e meno riconoscibili dell’infinita realtà» e che «il reale uguaglia la materia e imputridisce con lei, le sostanze tossiche recuperano la loro dignità superiore dal punto di vista dello spirito, cosa che ne fa le più prossime e utili collaboratrici della morte» (31).
Se di fatto le droghe sono secondo Artaud un mezzo per acuire i sensi e percepire ciò che della realtà normalmente sfugge, esistono tuttavia personaggi dotati di una sensibilità tale da non aver bisogno di ricorrere a ulteriori sovreccitazioni: è il caso di Madame Sacco, cartomante cara ai surrealisti, protagonista della Lettera alla veggente. Artaud siede davanti a lei «come un’ombra», pallido riflesso di ciò che è, ma sa che agli occhi di lei è finalmente «intero senza far nulla, integro senza sforzar[si]» (35). La veggente è presentata come depositaria di un sapere che trascende ogni sforzo razionale, ogni studio: percepisce la verità profonda delle cose senza i filtri normalmente imposti dal pensiero logico e dai limiti dei sensi. Madame Sacco vede l’integrità del reale con tutti gli strati che lo compongono; in questo senso, può vedere Artaud nella sua nuda interezza laddove lui stesso non riesce a cogliere che contraddizioni insanabili. La differenza dei due sguardi diventa manifesta nel momento in cui l’autore esplicita il suo sgomento davanti a una figura che gli appare così potente e contemporaneamente così ordinaria: «Mi sembra così graziosa, di una grazia talmente umana, talmente quotidiana. Graziosa come una qualsiasi delle donne dalle quali mi aspetto il pane e lo spasmo» (39).
E tuttavia, paradossalmente, scorgere la donna dietro la veggente allontana Artaud; la donna, in ogni manifestazione che assume all’interno di questa raccolta, veggente, madre o compagna che sia, è l’altro per eccellenza, colei che esplicita il dramma della separazione, l’oppressione dell’identità personale e la necessità di andare oltre. Sono esemplari, in questo senso, i due testi successivi alla lettera, Abelardo ed Eloisa e Abelardo il Chiaro, entrambi ispirati alla famosa vicenda dei due amanti. Al centro dei due brani c’è il tentativo di indagare l’amore e il desiderio sessuale attraverso l’accumulo di immagini brucianti. Abelardo è irresistibilmente spinto a unirsi a Eloisa, a perdersi in lei; eppure, questa pulsione irrefrenabile rimane iscritta in una «prospettiva tutta maschile» (48), come nota giustamente l’introduzione, in cui l’incontro reale non avviene. La passione tra i due innamorati non può essere vissuta a causa della castrazione del filosofo; ma l’impossibilità fisica di portare a compimento l’atto sessuale fortifica il legame tra i due, capaci di creare «un amore preso nella tensione fra sesso e cielo» (Bongiorno 2023, 11). L’uscita dal sé e l’unione con l’altro non si concretizzano attraverso l’atto sessuale ma diventano infatti la spinta verso l’incontro mistico, l’estasi: «Ma ecco che Santa Eloisa lo sente. […] Entra muggendo nelle cavità della sua testa. Lei solleva il coperchio del suo sepolcro con una mano di ossicini di formica» (51-2). La mutilazione di Abelardo diviene dunque simbolo di un bisogno di fondersi nell’altro che, incapace di scaricarsi sul piano fisico, rimane in uno stato di tensione e mantiene in purezza tutta la sua potenza.
Nel culmine di questo strano amplesso metafisico, dal fantasma di Abelardo emerge esplicitamente la figura dell’autore:
Pover’uomo! Povero Antonin Artaud! È proprio lui l’impotente che scala gli astri, che cerca di mettere in relazione la sua fragilità con i punti cardinali degli elementi, che si sforza di comporre un pensiero che tenga, un’immagine che stia insieme da ognuna delle superfici sottili o solidificate della natura (52).
Abelardo, come del resto tutti gli altri personaggi che popolano la raccolta, non rappresentano per Artaud un’immedesimazione posticcia, ma un vero e proprio riconoscimento, un’identificazione autentica e profonda che riesce a rivelarsi soltanto attraverso la libertà concessa all’espressione artistica: la scrittura permette di visualizzare un orizzonte immaginifico nella quale l’io e l’altro coincidono laddove nella dimensione del reale si creerebbe una contraddizione. È questo del resto il presupposto fondamentale alla base dell’arte per cui Artaud viene maggiormente ricordato, il teatro. Proprio perché consente di visualizzare una sovrapposizione di significati, la pratica teatrale costituisce, almeno a questa altezza, uno dei terreni di studio essenziali in cui portare avanti la sua ricerca intellettuale. Se Artaud ha già lavorato come attore nelle compagnie di Dullin e Pitoëff nei primi anni Venti, risale proprio al periodo di composizione di questi saggi l’esperienza del teatro Alfred Jarry; fondato con Vitrac e Aron, si delinea come il primo tentativo artaudiano di rifondare un’arte che gli stessi surrealisti percepivano come vecchia e sterile e costituisce il banco di prova in cui maturano molti degli stimoli alla base di Le Théatre et son Double. L’arte e la morte restituisce la vitalità di queste riflessioni riunendo dei saggi «altamente poetici e insieme già profondamente teatrali» (Giacobbe Borelli 2023, 13). Nell’ultimo, Il vetro dell’amore, quello che più si avvicina al teatro anche a livello formale, l’amore di uno studente per una «serva abietta e mal lavata» (75) è il pretesto per far rivivere una nutrita schiera di scrittori pronti a consigliare l’innamorato. Sotto un’apparenza di «vaudeville hoffmanniano» (74), il testo evoca lo spazio di una misera stanzetta che si allarga fino a comprendere la storia e la letteratura, in cui alla fine gli amanti possono abbracciarsi e confondersi: «Ci fu soltanto l’amore: Eloisa col mantello, Abelardo con la tiara, Cleopatra con l’aspide, tutte le lingue dell’ombra, tutte le stelle della follia» (79). Il brano è fitto di questi travestimenti che, più che nascondere, rivelano l’autentica identità molteplice dei personaggi. Amore, arte e sogno si rincorrono e si confondono con l’aspide mortifera: è forse l’unica via per conoscere tutte le lingue dell’ombra, tutte le stelle della follia.
Lorenza Valsania
-
I
Sono anni felici per chi si occupa di estetica in Italia. Nell’ultimo decennio abbiamo assistito alla pubblicazione di importanti studi volti al rinnovamento della disciplina. Esempi rappresentativi di questa tendenza sono i lavori di Desideri (2011, 2018), l’estetica relazionale di Diodato (2020), la modellizzazione epistemologica e la prospettiva antropologica di Bartalesi (2017, 2020; per quanto riguarda le questioni epistemologiche si vedano anche gli articoli del 2022 contenuti nel giornale Philosophies, 7(2)), nonché l’attenzione alla nozione di habitus estetico del pluralismo naturalista di Portera (2020). In questo panorama, la nuova edizione del libro di Garroni Estetica. Uno sguardo-attraverso (2020) è meno una riproposizione di un classico che un programma. Ci indica che è proprio lo statuto disciplinare dell’estetica a essere messo in questione. La descrizione dell’estetico è il terreno di gioco della partita. Il gioco filosofico di riconoscere somiglianze e differenze tra le diverse teorie si fa particolarmente acceso quando si considera un nuovo filone di ricerca che in anni recenti si sta proponendo come rinnovatore degli studi: il paradigma dell’esperienza-con (Matteucci, 2019; Iannilli, 2022).una nuova ecologia del percepire
È facile vedere come una certa aria di famiglia innervi tutto il dibattito appena menzionato. Non solo tutti gli autori condividono un’attenzione alla delimitazione dell’ambito dell’estetico (e quindi l’idea che l’estetico abbia un ambito peculiare da distinguere in qualche modo da quello conoscitivo, morale e dell’esperienza abituale) ma anche tracciano le conseguenze disciplinari e antropologiche della propria caratterizzazione. Così, per tutti questi autori, l’estetico diventa l’ambito privilegiato per uno studio integrato sull’esperienza umana e sulla mente, in altre parole sulla natura umana, se si intende «natura» non in termini essenzialistici, ma come un’ontogenesi e una filogenesi del panorama culturale tipicamente umano. Le questioni estetiche, così, costituiscono allo stesso tempo un banco di prova e una conferma per certi modelli di mente e di esperienza, come per esempio l’ipotesi della mente estesa. Tuttavia, è nei dettagli che si profilano modelli anche molto differenti di concepire l’estetico e la sua disciplina, la mente e l’esperienza. Una comunanza di intenti teorici fa da contrappunto a un dibattito che si svolge sui presupposti e sugli aspetti fondazionali dell’estetico.una nuova ecologia del percepire
Questa la temperie che ha accolto l’uscita di Estetica senza (s)oggetti (2022) di Nicola Perullo, un testo tanto programmatico quanto innovativo per i temi, gli autori e le prospettive che tratta. Il libro prosegue e amplia le ricerche del paradigma dell’esperienza-con, ma allo stesso tempo se ne smarca e le decentra. Il sottotitolo «Per una nuova ecologia del percepire» esemplifica bene la vocazione etica e ecologica della proposta di Perullo volta a trovare un nuovo quadro concettuale, o meglio: a presentare una sincretica narrazione teorica, in grado di sfidare l’antropocentrismo esplicito o residuale cristallizzato nella distinzione tra soggetto e oggetto. Questo movimento di decentramento, che nel libro si ripete a più livelli, va dunque compreso anche alla luce delle precedenti ricerche personali dell’autore, di cui il libro è una prosecuzione e una radicalizzazione: Estetica ecologica (2020) e Epistenologia (2021). In particolare, in Estetica ecologica erano già stati presentati elementi fondamentali che troviamo ampliati nell’ultimo libro. Il paradigma aptico, l’estetico come esplorazione di corrispondenze, così come il “compito” del gusto trovano nel nuovo libro una discussione più approfondita.
Gli argomenti affrontati in Estetica senza (s)oggetti sono vasti e di ampie prospettive. Riflessioni metafilosofiche e epistemologiche si stratificano su altre di ordine etico e ecologico, che vanno ad addensarsi ad altre ancora di carattere più spiccatamente teoretico e estetico. Non potrebbe essere altrimenti dato che l’autore esplicita l’esigenza teorica e sociale di praticare una filosofia che sia adeguata all’etichetta di «est-etic-onto-epistemo-logia» (p. 68). Estetica senza (s)oggetti (d’ora in avanti: esso, secondo l’abbreviazione dello stesso autore) delinea un progetto, indica strade da percorrere liberamente, non solo in quanto studiosi. «C’è bisogno di estetica» scrive Perullo all’inizio del libro (p. 14, corsivo rimosso). E di un’estetica ecologica in grado di trasfigurare la percezione verso un modo più comprensivo e collusivo di relazione con il mondo. Forse un modo per fare fede al progetto-esso è di ripercorrerlo nei passaggi, o «dislocamenti», che traccia.
II
Il primo e più basilare è il passaggio dall’oggetto alla relazione. I tortuosi e complessi capitoli II e III sono dedicati a questo scopo. Da qui inizia un percorso lungo tutto il libro che segue una doppia traiettoria. Una “a spirale” dove le questioni aperte sono da comprendere più che nella successione lineare delle pagine, nella loro distanza radiale dal centro del libro: il paradigma aptico. Un’altra “frattale” dove la critica e la decostruzione di schemi filosofici consolidati tendono a risolversi nello schema ricorrente della forma soggetto-oggetto.
Secondo Perullo, per pensare radicalmente la relazione occorre farlo «senza fondamento» (p. 41). Non basta pensare, serve anche sentire e immaginare, cogliere e rispondere alle possibilità e alle amplificazioni offerte dai diversi modi di immaginare il reale delle scienze (soprattutto la fisica quantistica), la filosofia (compresa quella orientale), le arti (intese comprensivamente come technai). Per queste ragioni la relazione e la sua portata ontologica non possono essere intese come un collegamento tra due poli, un soggetto e un oggetto, perché sarebbe in fondo come la pietra che piega la vanga di wittgensteiniana memoria, cioè la riproposizione di una sostanza (pp. 42, 97). «[L]a relazione – scrive Perullo – è la cresta dell’onda da cui sgorgano quelle posizioni, quelle funzioni oggettivamente incarnate che chiamiamo “soggetto” e “oggetto” ma che non la esauriscono affatto e non ne sono un presupposto» (p. 71). Oltre al già citato Wittgenstein, qui il riferimento principale è la process philosophy di Bergson, James e Whitehead, che ha «dimostrato da un lato che le relazioni accadono in quanto processi, dall’altro che i processi si manifestano come relazioni» (p. 42).
Le relazioni si manifestano come avvenimenti nella e con la coscienza, non nel rapporto di una coscienza con qualcos’altro. Così, il compito iniziale di liberare il campo da alcuni fraintendimenti sulla natura non categoriale della relazione passa attraverso la delineazione di una “strana” – così Perullo (p. 79) – eco-logica. Nella misura in cui è strana è anche straniante, come mostrano le descrizioni di una pietra di Rovelli e di Ingold in cui la tecnica dello straniamento si eleva vero e proprio organon della teoria (pp. 36-37). Assumere il punto di vista di una pietra, della sua storia nel tempo profondo e delle relazioni con cui è intrecciata è il primo passo verso una consapevolezza della posizione «in-between» (in-tra) dell’ambito estetico (p. 72). Collocandosi nell’azione della coscienza (in-) nel fluire di processi e relazioni (-tra), l’estetico non può essere considerato semplice interazione o immersione in un contesto, in quanto questi termini implicano o una separazione di enti o una vuota fusione. La percezione ecologica, in cui i processi attenzionali non si lasciano guidare dalle intenzioni del soggetto, ma dalle affordances dell’ambiente è piuttosto una ricerca e una creazione di corrispondenze. La corrispondenza, scrive Perullo, è «una risonanza lungo la potenzialità del percepire nella continuità del flusso esperienziale» (p.77). Corrispondere è percepire sub specie possibilitatis, e quindi attesta un modo possibile di percepire al di là della percezione abituale e degli schemi individuali. La consapevolezza che ne consegue è quella consapevolezza dell’essere in-tra, nel senso specificato sopra. Per questo Perullo descrive l’estetico come «consapevole richiamo della conoscenza» (p. 77). Nel dislocarsi della percezione è la coscienza (nel duplice senso mentale e morale) che si svincola dalle costruzioni dualistiche di cui è imbevuta. Ma nel richiamarsi a sé, la coscienza non si riconosce più come una coscienza individuale, di un certo organismo. L’ecologia mostra il carattere impersonale della coscienza, l’azione dei processi prima della formazione di un soggetto e di un oggetto (pp. 83, 95). «La corrispondenza – scrive Perullo – è apertura al potenziale in quanto la forma è sempre un divenire-forma, la materia è sempre un materializzar-si» (p. 79). In questo passaggio si può scorgere in estrema sintesi la proposta di esso di abbandonare l’ontologia, lo studio della realtà per oggetti, per un’ontogenesi che ne ripercorra i processi.
III
Nella proposta dello smarcamento ontogenetico si inserisce un secondo ordine di dislocamenti, quelli da ego (Estetica Governata dagli Oggetti) a esso. Per buona parte del III capitolo l’autore infatti si confronta con la Object Oriented Ontology, soprattutto nelle versioni di Meillassoux, Harman e Morton. Se ai primi due autori Perullo recrimina l’inadeguatezza di un pensiero ontologico e ontologizzante rispetto al comune obiettivo dell’anti-antropocentrismo, col terzo non mancano punti di contatto (cfr. pp. 106-107). Tuttavia è la mancata presa di coscienza dello statuto non soggettivistico della relazione che misura la distanza tra esso e ego. Per questo esso rifiuta la OOO e propone una OOP!, un’Ontogenesi Orientata ai Processi, dinamica e relazionale.
Il capitolo si conclude con quella che a ragione potrebbe essere considerata la teoria estetica di OOP!, la tematizzazione di esso delle nozioni di campo estetico, di qualità estetica, e le loro conseguenze per la caratterizzazione dell’esperienza estetica. In queste pagine si misura la vicinanza di Perullo al paradigma dell’esperienza-con, soprattutto nel richiamo alla nozione di campo estetico di Berleant. «Il campo estetico – scrive Perullo (p. 114) – è proprio ciò che opera trasversalmente, ortogonalmente, producendo quelle oscillazioni precedenti alla scissione tra «soggetto» e «oggetto» e dalle quali emerge l’estetico con le sue qualità e i suoi valori». Dal campo estetico, in quanto campo percettivo in cui soggetto e oggetto sono funzionalmente inseparabili, emergono le proprietà estetiche come processi e relazioni. Il modello che ne risulta è quello di un’esperienza estetica situata, immediata e ubiqua (p. 126). Un campo infatti opera sempre in un preciso contesto spaziale e temporale, nel qui e ora, è singolare e specifico, ma non è isolato. Infatti i campi si relazionano e si intrecciano tra loro, stratificandosi e sconfinando l’uno nell’altro, secondo intersezioni ortogonali, cioè senza gerarchie predefinite. Per questo secondo Perullo l’estetico è ubiquo: riguarda la relazione tra un «qui e ora» e un «sempre e ovunque». È una disposizione in cui la singolarità dell’evento risuona nell’universalità e ubiquità dei processi. Infine, in quanto evento nella coscienza, l’estetico è una modalità di percepire che si dà indipendentemente dalle istanze cognitive. Per questo l’esperienza estetica è anche immediata.
IV
Il dislocamento dal paradigma visivo al paradigma aptico è il più importante del libro e in un certo senso le riflessioni precedenti convergono verso questo passaggio. Se il paradigma visivo è quello della distanza dall’oggetto, della solidità delle cose, il percepire aptico non è altro che il percepire estetico consapevole della dimensione relazionale e processuale, operativa e performativa che le è propria (p. 143). Percepire in modo aptico è lasciarsi guidare dai processi attenzionali (p. 149) in una forma di percezione in cui la passività dell’azione si mostra primaria alla agency tipica del soggetto che agisce intenzionalmente. «Azione» qui è sinonimo di «processo» o «vettore» all’interno di un campo di esperienza. L’azione così intesa non è vincolata al soggetto che la produce e diventa espressione non di una vita individuale, ma del «vivere» o di «una vita» - concetti che l’autore recupera rispettivamente da Jullien e da Deleuze. Caratteristico dell’aptico è l’agire patendo, cioè la consapevolezza che nell’esperienza estetica sia la passività, piuttosto che l’attività del soggetto, a connotare il processo (pp. 93-95). Il percepire aptico si caratterizza così come una modalità percettiva della prossimità e del contatto, per questo, come abbiamo visto precedentemente, è un’esperienza immediata. Tuttavia questo non comporta un appiattimento dell’aptico alla sola dimensione tattile. L’immediatezza, per Perullo, non è sinonimo di istantaneità – un’assunzione della quale comporterebbe la negazione della dimensione processuale della percezione – ma corrisponde all’indipendenza della percezione aptica dall’ambito tematizzante e cognitivo (p. 157).
Nella percezione aptica gli oggetti si ritraggono a favore dei processi e la relazione tra il soggetto percipiente e l’oggetto percepito sfuma in relazioni collusive con l’ambiente. Nella misura in cui si collude con processi e relazioni, la percezione aptica è un’esperienza animante, nel senso che produce, secondo Perullo, una forma di animismo estetico. Ricorrono riferimenti agli elementi naturali, all’animarsi di possibilità percettive e alla dimensione “climatica” dell’esperienza estetica – a questo riguardo è particolarmente interessante e suggestivo il riferimento al concetto di «fûdo», clima, del filosofo giapponese Tetsurô Watsuji (p. 156). L’esperienza estetica come collusione equivale così a un abitare quella «terra di mezzo» che è l’estetica (p. 143), una percezione connotata “in-tra” (in-between) soggetto e oggetto, cielo e terra, visivo e aptico. Molti nodi della eco-logica e della teoria estetica di esso confluiscono e riaffiorano nel capitolo IV, dedicato al paradigma aptico. Se i capitoli precedenti si districavano tra smarcamenti complessi e a tratti tortuosi, in questo capitolo l’autore traccia più liberamente le proprie idee. Per questo il capitolo contiene le formulazioni più radicali e interessanti di esso, ma anche le più difficili da tradurre in una recensione senza correre il rischio di perderne il senso.
V
Se la OOO spicca come il bersaglio polemico esplicito di esso, nel capitolo IV, ma in generale in molti passi del libro, ricorre un obiettivo spesso alluso e obliquamente messo in corrispondenza. È il modello dell’estetico di derivazione kantiana o, come credo, il modo di intendere l’estetica come «disciplina non speciale» di cui Garroni è, per così dire, il caposcuola. Sotto questa luce si possono comprendere alcuni gesti teorici di Perullo volti a sancire una distanza da un certo “garronismo” dell’estetica italiana contemporanea. Per esempio la scelta dei riferimenti. Wittgenstein non è letto di concerto con Kant, ma con la process philosophy. Altri riferimenti come il buddhismo e lo shivaismo, Jullien, Deleuze e Guattari, fino anche a Berleant, Ingold, Rovelli, Bohm – per indicare i più importanti e citati – mostrano invece l’intenzione di proporre un cambio di canone per l’estetica. Non c’è dunque da stupirsi se in un libro in cui si presenta il problema del proprio tempo come un problema estetico non venga mai citato Schiller. Evidentemente, «disciplina non speciale» è un termine la cui storia ha cristallizzato una certa tradizione, certi schemi e abitudini di pensiero. Occorreva a Perullo un nuovo nome per il cambiamento che esso annuncia. La scelta di un termine come est-etic-onto-epistemo-logia esprime bene la volontà di distanziarsi, senza però tradire del tutto, la lezione di una ricerca del senso e del suo prodursi attraverso l’esperienza. L’«indisciplina rigorosa» (p. 29) della narrazione teorica di Perullo è forse l’indice, in forma di rivolgimento ironico, della maturazione di un distacco da una tradizione che sente vicina, o che sentiva tale almeno fino a Estetica ecologica (vedi Perullo, 2020: 24, soprattutto n. 5).
In filosofia un cambio di preposizione può produrre conseguenze inaspettate. È nel cambio dall’«attraverso» (che probabilmente per Perullo è un «di» camuffato) al «con» che si misurano due modelli distinti (e distanti) di comprendere l’estetico. Un confronto esplicito è quantomai urgente per gli studi di estetica, ma non è nelle mie capacità né nelle mie intenzioni. Mi limito a indicare ciò che, a seconda dei punti di vista, costituisce un possibile motore o freno del passaggio di paradigma proposto da esso: la questione del carattere di anticipazione dell’estetico.
Chi aderisce a una cornice di derivazione kantiana, infatti, riconosce all’estetico la funzione di anticipazione cognitiva e etica. Un’adesione forte al modello kantiano richiede un’interpretazione trascendentale dell’anticipazione (l’estetico è la condizione di possibilità della conoscenza e dell’etica). Una debole, invece, si può limitare a una lettura logico-operazionale. Negli atteggiamenti conoscitivi e etici sono contenuti elementi strutturali dell’estetico, così come l’estetico ha elementi strutturali affini al conoscere e alla vita etica. L’estetico è quasi-conoscenza e quasi-etica. Per il kantiano debole una esplicitazione del «quasi» sarà allora il suo obiettivo principale.
Sottolineo l’aspetto di derivazione perché è decisivo. Non è in questione se accettare o meno la metafisica e la gnoseologia kantiana in toto o solo in parte. Il problema riguarda piuttosto il modello e la descrizione di estetico che si intende proporre. A prescindere dalle proprie convinzioni filosofiche, il punto è come spiegare o come indicare un possibile senso (o non senso) alla questione dell’anticipazione. Insomma che l’estetico anticipi l’atteggiamento conoscitivo e etico non è di per sé una verità apodittica, ma un criterio. Anzi: un criterio per criteri che, di teoria in teoria, descrizione in descrizione, deve assumere una forma determinata e un contenuto adeguato. Dunque, non essendo un criterio, non è in questione se adottarlo, ma come declinarlo attraverso altri criteri e descrizioni, secondo i termini e le prospettive che si ritengono più adatti. Un rifiuto del carattere di anticipazione può essere una misura legittima, ma solo nella misura in cui ne viene svelato l’aspetto per così dire illusorio e mistificato. Non basta attaccare il paradigma criticista come paradigma dualista. Il paradigma dell’esperienza-con – di cui esso è una ramificazione – deve mettere a tema l’anticipazione. Pena: un atteggiamento eliminativista nei confronti di un discorso sull’estetico. Tale eliminativismo è in evidente contraddizione con gli intenti, gli scopi e la portata di questo nuovo paradigma e ancor di più con esso.
VI
Si possono riconoscere molti aspetti della narrazione teorica di Perullo che sono volti a rendere conto dell’anticipazione etica dell’estetico. Per esempio è indice di questa consapevolezza l’idea trasversale a tutto il libro che i problemi della contemporaneità abbiano la loro radice nella percezione. Infatti la dimensione aptica dell’agire patendo è espressione di una funzione trasformativa dell’estetico che non sfocia necessariamente in una coazione all’agire etico intenzionale. Insomma, la trasformazione che segue dai dislocamenti di esso è anzitutto una trasfigurazione – una «prospettiva rovesciata» (p. 201) – del reale come appare in quel misto di ontologia, ideologia e senso comune che è l’esperienza abituale. La questione ecologica è anzitutto una sfida a percepire ecologicamente, con una mente che si lascia intonare ai processi del campo percettivo e agli sconfinamenti tra campi differenti.
Un ultimo aspetto indicativo delle compenetrazioni tra etico e estetico si può trovare nella proposta di coltivare la compassione come guida dell’esperienza estetica (p. 132). L’immedesimazione partecipata con l’opera mette tra parentesi l’origine “alta” o “bassa”, l’artisticità o l’artigianalità dell’opera. In una battuta, la compassione è ciò che sposta l’attenzione dalla “storia degli effetti” alla “storia degli eventi” di cui l’opera è traccia. L’aptico quindi anticipa l’etico perché, in quanto rapporto non ontologizzante, prefigura una relazione libera da rapporti di dominio a favore di relazioni di collusione che, occorre ricordarlo, non vincolano sul piano dell’azione individuale. Dopo tutto la risposta “est-etica” alla crisi di realtà è la più cara all’autore e non a caso il libro si conclude con illuminanti riflessioni sulla saggezza.
Sulla questione dell’anticipazione conoscitiva, invece, ci sono alcune oscillazioni. Il paradigma dell’esperienza-con generalmente insiste sulla dimensione cooperativa e performativa, percettuale e non tematica dell’esperienza estetica, enfatizzando l’alterità con il modello dell’esperienza-di che è invece rappresentazionale, individuale e individualista, tematico e tematizzante, conoscitivo e eminentemente cognitivo. Insomma l’estetico non anticipa il cognitivo, vi si oppone.
Per esso il discorso è più complesso. Perullo insiste sull’esigenza di non opporre né sostituire i modelli (p. 24), ma di considerare esso come un paradigma, per così dire, “più sottile” che si insinua dentro al modello dualistico. Smarcare, per Perullo, non equivale a sostituire, ma a decentrare la sguardo, allargare il campo. Per insinuarsi davvero è però imprescindibile tematizzare il problema dell’anticipazione, cioè della relazione tra l’estetico e il cognitivo, tra l’estetico e il linguaggio.
Tracce di questa tematizzazione si possono trovare nelle pagine dedicate al giudizio estetico. Sebbene Perullo sia chiaro nel non ritenere il giudizio come necessario all’esperienza estetica, non è esclusa la possibilità di un recupero della nozione a seguito di possibili smarcamenti (p. 138). La questione della compassione estetica menzionata sopra va in effetti in questa direzione.
Alcuni passi sembrano tematizzare più direttamente, anche se in modo forse un po’ dimesso, la questione dell’anticipazione estetica. «[C]iò che, nel linguaggio, anticipa l’articolazione, coincide con il piano trasversale, longitudinale e in un certo senso antecedente (ma un «prima» che non è quello cronologico) alla scissione tra mente e corpo, soggetto e oggetto; quella scissione dalla quale fiorisce l’attitudine duplicante della mente rappresentazionale» (pp. 115-116, corsivo aggiunto). E ancora: «[L]’estetica […] costituisc[e] essa stessa proprio l’esempio paradigmatico del preambolare. In altri termini: prima che tu faccia esperienza dell’estetico, ti spiego in cosa consisterà, i suoi «principi», le sue condizioni di possibilità e le sue ragioni, avvertendoti al contempo che ciò ti servirà parzialmente, fino a un certo punto, forse poco, perché è nell’esperienza-con, nel suo specifico attraversamento, che percepirai davvero di cosa si tratta. Dopo che hai fatto esperienza, ti racconterò in cosa è consistita; ma a quel punto è probabile che tu non sia più così interessato ad ascoltarmi, avendone esperito direttamente il sapore: la spiegazione sarà come darti la fotografia di un viaggio che hai fatto già e in prima persona» (p. 142, corsivo originale). In questi passi la questione dell’anticipazione viene proposta a due differenti livelli, quello dell’estetico in quanto ambito e quello dell’estetica in quanto disciplina. Ma se come è scritto nel primo passo l’estetico anticipa il linguaggio, rimane da chiarire come i significati vengono effettivamente formati o, in altre parole, come avviene il passaggio dalle relazioni agli oggetti. E se l’estetica, cioè la nostra conoscenza dell’estetico, può spiegare soltanto o prima o dopo l’esperienza, senza avere un coinvolgimento attivo o decisivo durante (per dirla con Perullo: «in-tra»), rimane da comprendere perché in un quadro teorico in cui è dato giustamente ampio spazio all’orizzontalità dei contesti di esperienza, proprio a un tipo di esperienza, quella linguistica, è assegnata una gerarchia verticale – non importa se “al di sopra” o “al di sotto” dell’estetico. Talvolta un preambolo può soltanto premettere senza promettere alcunché. una nuova ecologia del percepire
Molti altri passi sembrano non lasciare dubbi su una frattura difficilmente conciliabile tra vita percettiva e vita cognitiva. Come abbiamo visto in precedenza, infatti, l’esperienza estetica per Perullo è immediata perché scevra da condizionamenti di ordine cognitivo («L’aptico e l’estetico sono l’immediatezza non cognitiva e spesso afasica nel suo manifestarsi qui e ora», p. 161). L’estetico apparterrebbe quindi all’ambito dell’ante-predicativo, sarebbe libero da determinazioni cognitive (p. 164). Una riprova si può trovare osservando l’infante. L’età dell’infanzia è quel momento in cui la dimensione operativa e processuale della percezione emerge senza condizionamenti teorizzanti e linguistici propri dello sviluppo cognitivo dell’età adulta (p. 180).
Su questo ultimo punto rimane almeno un dubbio. Anche se il bambino non è in grado di formulare linguisticamente le sue percezioni, non è detto che non sia in grado di percepire simbolicamente, in un’unità di immagine, le affordances che si offrono ai processi attenzionali e percettivi (cfr. Desideri, 2018: 57). Generalizzando, invece, la cosiddetta anticipazione cognitiva ha ovvie conseguenze per un discorso sulla percezione – non soltanto estetica. Affrontare il problema di una percezione che funziona iuxta propria principia e una percezione agita cognitivamente e simbolicamente ha a che fare direttamente con esso. Infatti, dato il primo caso si dovrà capire perché in una cornice teorica in cui l’eteronomia dei processi relazionali e le azioni non intenzionali agiscono e animano l’esperienza estetica (l’«agire-patire» dell’estetico), proprio alla percezione è dato lo statuto esclusivo di funzionare secondo principi propri. Non basta dire che la percezione è eteronima perché non sia autonoma. Infatti, se il suo funzionamento è eteronimo, la percezione senza cognizione sarà autonomamente eteronima. Nel secondo caso, invece, rimarrebbe da spiegare perché tanta enfasi nel descrivere il campo estetico come eminentemente operativo e performativo, quando le operazioni, i processi e le performance sono già in una certa misura (ancora tutta da stabilire) cognitivi.
L’estetico come «richiamo della coscienza» sembra alludere più a una coscienza ri-attivata e liberata da costruzioni simboliche, piuttosto che a una conoscenza anticipata, più a una dimensione extra-simbolica, che a una pre-simbolica, ma il modo in cui esso si rapporta al problema dell’anticipazione estetica rimane comunque una questione aperta. Ciò che ho esposto in conclusione, più che una critica, è una richiesta di chiarimento e di sviluppo di un progetto meritevole che annuncia un rinnovamento e un ampliamento degli studi di estetica. Per perseguirlo basterà tenere ferma la lezione che esso ci indica nelle ultime pagine del libro. Rimanere saggi nell’urgenza.
Giovanni Lenzi
Riferimenti
Bartalesi, L. (2017) Antropologia dell’estetico. Sesto San Giovanni (MI): Mimesis.
Bartalesi, L. (2020) «Modelos estéticos en la ciencias humanas: un estudio epistemológico». [traduzione di F. Bey]. Boletín de Estética. 51: 8-36.
Desideri, F. (2011) La percezione riflessa. Estetica e filosofia della mente. Milano: Raffaello Cortina.
Desideri, F. (2018) Origine dell’estetico. Dalle emozioni al giudizio. Roma: Carocci.
Diodato, R. (2020) Immagine, arte, virtualità. Per un’estetica della relazione. Brescia: Morcelliana.
Garroni, E. (2020) Estetica. Uno sguardo-attraverso. Con un’introduzione di S. Velotti. Roma: Castelvecchi.
Iannilli, G. L. (2022) Co-operative aesthetics: a quasi-manifesto for the 21st century. Sesto San Giovanni (MI): Aesthetica edizioni.
Matteucci, G. (2019) Estetica e natura umana. La mente estesa tra percezione, emozione ed espressione. Roma: Carocci.
Perullo, N. (2020) Estetica ecologica. Percepire saggio, vivere corrispondente. Sesto San Giovanni (MI): Mimesis.
Perullo, N. (2021) Epistenologia. Il vino come filosofia. Sesto San Giovanni (MI): Mimesis.
Perullo, N. (2022) Estetica senza (s)oggetti. Per una nuova ecologia del percepire. Roma: DeriveApprodi.Portera, M. (2020) La bellezza è un’abitudine. Come si sviluppa l’estetico. Roma: Carocci. una nuova ecologia del percepire
-
“Quando l’Agnello aprì il quarto sigillo, udii la voce del quarto essere vivente che diceva: “Vieni”. Ed ecco, mi apparve un cavallo verdastro. Colui che lo cavalcava si chiamava Morte e gli veniva dietro l’Inferno.”
Apocalisse (6, 7-8)
Nell’Apocalisse la fine del mondo è rappresentata come un’epocale resa dei conti tra il bene e il male, tra il dio dei cristiani e il suo acerrimo nemico, Satana, che emerge dal mare sotto forma di immonda bestia cornuta e getta nello scompiglio più totale l’umanità prima di essere sconfitto da un angelo salvatore e rigettato negli abissi dove resterà incatenato per mille anni. L’epico scontro con il quale si conclude la Bibbia inoltre è annunciato dall’avvento di quattro figure misteriose, i quattro cavalieri dell’apocalisse che per millenni hanno infestato gli incubi e l’immaginario occidentale al punto da saturarne l’universo iconografico: dalle xilografie di Dürer alla musica heavy metal (basti pensare al brano The four Horseman dei Metallica) fino al riferimento subliminale presente nelle prime, memorabili scene di Terminator 2: il giorno del giudizio, in cui si vede una giostra sulla quale bruciano quattro cavalli che hanno gli stessi colori di quelli immaginati dall’apostolo Giovanni. Secondo l’interpretazione allegorica del testo invalsa sino ad oggi, infatti, ogni dettaglio numerico, lessicale e cromatico presente nel libro dell’Apocalisse dovrebbe avere un significato esoterico e così il cavallo bianco starebbe a simboleggiare la guerra poiché chi lo cavalca brandisce un arco, quello rosso sangue sarebbe la metafora della violenza umana, quello nero rappresenterebbe la morte ed il cavallo verdastro (spesso raffigurato con tinte che ricordano la carne in putrefazione) sarebbe l’effige della peste e della malattia. E se l’avvento stesso dei quattro cavalieri è da intendersi come un’infausta allegoria dell’incipiente giudizio universale è perché per millenni l’umanità è stata veramente afflitta da guerre, carestie, violenze e pestilenze che hanno lasciato pronosticare la fine imminente di tutte le cose.
Ora, se è vero che grazie allo sviluppo scientifico e alle innovazioni tecnologiche l’umanità è riuscita ad affrancarsi, o quantomeno a mettersi al riparo, dai poderosi colpi sferzati da quei mali che per millenni hanno falcidiato e svilito la vita umana su questo pianeta è anche vero che, se volessimo riscriverlo oggi, al passo dell’Apocalisse in questione dovremmo aggiungere almeno una nuova figura.
All’emblematico corteo di sciagure che l’umanità è destinata a fronteggiare da sempre, e che segnalano come oscuri presagi una catastrofe incombente, manca infatti il riferimento figurativo a quella nuova e nefasta condizione mentale che connota il nostro vissuto quotidiano. Questo si scopre oggi afflitto da una condizione storicamente inedita di assoluto disorientamento cognitivo e di totale mancanza di punti di riferimento, sia simbolici che ideologici, frammista ad una patologica dipendenza da news (vere o fake che siano) e da stimoli percettivi filtrati attraverso gli schermi di tablet e telefonini. Il flagello che ammorba l’epoca contemporanea potremmo allora immaginarlo, in continuità con la lisergica visione giovannea, come un cavallo pixelato montato da un cavaliere che regge in mano un cellulare mentre è intento a twittare un articolo in cui si dimostra, ad esempio, che la terra in realtà è piatta. E se è vero che quest’immagine esula dalle capacità immaginifiche dell’apostolo Giovanni, è altrettanto indubbio che la comparsa di un tale spauracchio oggi si profila come una vera e propria piaga che nulla ha da invidiare alle altre (fame, guerra, pestilenza e malattia) e come il segno inequivocabile di una catastrofe sociale tanto inevitabile quanto imminente.
Nel suo ultimo saggio dal titolo Apocalypse Cognitive, Gérald Bronner (professore di sociologia all’Université Paris-Diderot e membro del rinomato Institut Universitaire de France) scandaglia con salacia, eclettismo e con grande rigore scientifico le ragioni che hanno condotto la nostra specie a smarrirsi nel vicolo cieco della distrazione permanente, nella palude dell’infotainment e nel baratro cognitivo che, se da una parte non lascia pronosticare nulla di buono per quanto riguarda il futuro della nostra specie, dall’altra offre quantomeno la possibilità di gettare uno sguardo inedito sui moventi ultimi e sugli apriori psicologici della natura umana. Il lavoro di Bronner infatti è da sempre incentrato sullo studio dei fenomeni sociali e culturali a partire dalla prospettiva offerta dalla sociologia cognitiva. Nei suoi libri si analizzano, con una particolare attenzione posta all’analisi statistica e quantitativa dei fenomeni presi in esame, tanto i meccanismi psicologici che presiedono alla formazione delle credenze collettive (Bronner 2006) quanto quelli che inducono a forme di radicalizzazione ideologica (Bronner 2012), tanto la naturale proclività umana a commettere grossolani errori di valutazione (Bronner 2015) quanto il costo sociale e politico, per le democrazie occidentali, della disinformazione e della credulità (Bronner 2016). Apocalypse Cognitive costituisce a tal riguardo una sorta di ricapitolazione e di rilancio dell’intera opera del sociologo francese, è un lavoro figlio di una lunga e ponderata gestazione intellettuale e suscita un particolare interesse per chi si occupa di filosofia. L’autore, infatti, oltre ad esaminare la problematica relazione che sussiste tra lo sviluppo tecnologico e l’evoluzione della mente umana, solleva questioni relative al senso della storia, al ruolo dell’intellettuale nel mondo contemporaneo e al concetto stesso di “verità”, intesa nel suo senso eminente di “disvelamento” e di “rivelazione”.
L’assunto principale dal quale muove Bronner consiste nel prendere atto che «la situazione inedita di cui siamo testimoni è quella relativa all’incontro tra il nostro cervello ancestrale e la concorrenza generalizzata degli oggetti di contemplazione mentale associata ad una liberazione, fino ad ora impensabile, del tempo cerebrale a disposizione» (p. 21). In altre parole secondo l’autore il mondo in cui viviamo sarebbe contraddistinto da una sorta di collisione tra da una parte l’attività psichica (finalmente liberata, grazie allo sviluppo tecnico e all’evoluzione della civiltà, da quegli oneri che per millenni hanno gravato tanto sulla disponibilità quantitativa quanto sulle modalità qualitative d’impiego dell’attenzione) e dall’altra la cornucopia di oggetti virtuali offerti dall’esplosione incontrollata del mercato cognitivo. Con questa formula ci si riferisce a quel bazaar globale di nozioni, idee e concetti le cui origini sono tracciabili all’incirca con l’invenzione della carta stampata, ma rispetto al quale l’impulso più determinante è stato dato, in anni recenti, dall’avvento e dalla diffusione di internet. In Apocalypse Cognitive i meccanismi squisitamente economici sottesi alla ricerca di un equilibrio tra la domanda e l’offerta all’interno del suddetto mercato vengono interpretati, in modo assai originale, come un vero e proprio esperimento sociopsicologico su scala globale. Il punto di equilibrio che ne risulta lascia emergere, come vedremo, uno specifico profilo antropologico.
Ogni secondo vengono prodotti nel mondo ventinovemila Gigabyte di informazione. Nel 2017 sono stati inviati, in media, duecentocinquantatremila messaggi al secondo e nello stesso lasso di tempo su Google venivano effettuate sessantamila ricerche sui temi più disparati. I numeri relativi alla quantità di informazione che la nostra civiltà globale produce e consuma sono sconcertanti (basti pensare, ad esempio, al fatto che il novanta percento delle informazioni disponibili in questo momento al mondo è stato prodotto negli ultimi due anni…) (p. 97) – ma a cosa servono precisamente tutti questi dati?
Anche se Homo Sapiens fosse genuinamente intenzionato a capire il mondo che lo circonda, infatti, dovrebbe comunque fare i conti con quei meccanismi ancestrali che regolano, inibendola e stornandola alla bisogna, la sua attenzione.
Ad esempio, se nel bel mezzo di una festa siamo immersi nel chiacchiericcio che rende indistinguibile ogni conversazione e qualcuno nella sala pronuncia il nostro nome ecco che, come per magia, questo si staglia sullo sfondo del brusio. Certo, è la prova più evidente che il cervello umano è stato plasmato dalla selezione naturale per prediligere ogni stimolo inerente a ciò che che ci riguarda. Ma questo fenomeno, studiato per la prima volta nel 1953 e definito “effetto pop up”, (p. 94) se da una parte ci permette di disporre immediatamente delle informazioni di cui abbiamo più urgentemente bisogno, dall’altra limita inevitabilmente il nostro accesso alla realtà nella misura in cui rigetta tutto ciò che non pertiene al nostro interesse personale. E la perversa alleanza che è venuta a crearsi in anni recenti tra questi meccanismi modellati dall’evoluzione e quella tecnologia che, oltre a facilitare le nostre ricerche su internet anticipa, prevedendole, le nostre preferenze, è tale da suscitare qualche legittimo timore dal retrogusto apocalittico. I “tunnel attenzionali” nei quali l’evoluzione ci ha condotti lungo il tortuoso sentiero dell’adattamento trovano infatti nella struttura algoritmica dei motori di ricerca uno strumento il cui utilizzo spesso amplifica a dismisura le convinzioni degli utenti che se ne servono. In fondo è come se quella preziosa risorsa che è la nostra attenzione confluisse, per ristagnarvi all’infinito, in virtuali casse di risonanza per ogni tipo di credenza, anche per le più ottuse e irragionevoli. Non solo risulta così impossibile fuoriuscire dal loop autocatalitico di superstizioni infondate: il rischio è quello di alimentare forme di ignoranza collettiva, di causare catastrofiche diffusioni di notizie fasulle e di nutrire i bias cognitivi proprio attraverso le modalità dalle quali ci si aspetterebbe il contrario. Ma la nostra attenzione può essere deviata e sussunta in altri modi.
Nella cacofonia informazionale costituita da tutto ciò che circola in modo assolutamente deregolamentato all’interno del mercato cognitivo si stagliano infatti, al di là di questi vicoli ciechi, alcuni elementi dotati di un intrinseco vantaggio concorrenziale. Non a caso l’umanità intera ammira attonita ogni anno centrotrentasei miliardi di video hard che corrispondono a ben un terzo dei filmati attualmente visionabili su internet. La somma totale del tempo immolato da tutti gli utenti del mondo alla visione di materiale pornografico annualmente ammonta a seicentonovantaduemila anni, mentre ne servirebbero solo centosessantanove ad un solo individuo (senza calcolare le pause fisiologiche come dormire e mangiare) per guardare tutti i filmati proposti solo da PornHub, (pp. 103-104) il primo sito al mondo nel settore. Anche in questo caso, certo, è perfettamente comprensibile leggere il fenomeno in questione come una continuazione, magari imprevista da un punto di vista strettamente naturale, degli automatismi comportamentali che presiedono alla riproduzione nella misura in cui la sessualità gioca un ruolo cruciale nella perpetuazione della vita. Quel che stupisce e che merita l’attenzione dell’indagine sociopsicologica di Bronner è semmai la smodata quantità di tempo, energie e risorse che ogni anno letteralmente evapora tra le mani di un’umanità avvinta nelle grinfie della masturbazione compulsiva.
Oltre al sesso, poi, nel cocktail globale di stimoli offerti sul mercato cognitivo c’è almeno un altro ingrediente che risalta in modo deciso: la paura. Ne più né meno dello zucchero o della cocaina, ogni informazione finalizzata ad allertarci riguardo a qualsiasi tipo di pericolo crea in noi dipendenza. È così difficile resistere allo stimolo del terrore che nel 2016 il quaranta per cento degli articoli letti su internet aveva come suo contenuto principale un evento cruento (incidenti stradali, morti improvvise, cataclismi naturali) (p. 116). Nel 2014 il sito d’informazione russo CityReporter è stato addirittura al centro di un involontario esperimento sociopsicologico teso a capire se per un giornale deciso a pubblicare solo notizie positive fosse possibile sopravvivere nel mercato editoriale: dopo poche settimane il crollo del settanta percento dei lettori ha obbligato la redazione ad una repentina retromarcia. Il direttore del giornale ha commentato l’esperienza con questi toni amareggiati: «Noi abbiamo cercato di pubblicare notizie positive, e pensavamo di averle trovate. Ma forse nessuno ne ha bisogno: è questo il problema» (pp. 201-202). E come nel caso della pornografia e dei tunnel attenzionali, anche quando si tratta di spiegare l’appetibilità suscitata dalla paura Bronner ricorre alla teoria dell’evoluzione, ponendo l’accento sugli inaspettati sentieri verso cui è stata condotta la vita nel suo sforzo di adattarsi ad un ambiente sempre meno naturale e via via più virtuale:
«C’è qui in ballo una logica preistorica. Questa logica radicata nella nostra biologia ha avuto la sua utilità evolutiva, ma provoca degli effetti collaterali nelle nuove condizioni storiche generate dall’esplosione del mercato cognitivo. Il rischio più evidente nel quale incappiamo è quello di consacrare le nostre risorse per delle lotte contro dei pericoli infondati o di costruire delle gerarchie di pericoli fondamentalmente arbitrarie» (p. 117)
Tutti gli esempi qui riportati indicano anzitutto come «la captazione della nostra attenzione, che è una merce limitata, molto spesso non obbedisce alla qualità dell’informazione scambiata ma piuttosto alla soddisfazione mentale che essa induce» (p. 215) e dimostrano anche come i moventi ultimi di questi mercanteggiamenti facciano capo ad una serie di bisogni innati che non trovano di che soddisfarsi. E se da una parte questo disorientamento rende palese la condizione di fondamentale incompletezza ontologica in cui riversa la psiche umana, dall’altra esprime, al negativo, le preferenze che indicano un particolare, connaturato interesse per alcuni oggetti e non per altri. Se «nel mondo contemporaneo, certi elementi fondamentali della nostra natura mentale sono presi in carica più facilmente dall’offerta» (pp. 164-165) è perché allora, evidentemente, la mano invisibile che regola il mercato cognitivo è mossa da una volontà sulla quale il sesso, la paura e le informazioni riferite al proprio sé esercitano una sorta di fascino irresistibile, e questo è il vero e proprio oggetto di studio di Apocalypse Cognitive.
Bronner presenta infatti un’analisi che si serve delle indagini quantitative offerte dalla statistica, dei dati raccolti dalle rilevazioni informatiche e dei risultati sperimentali in più di un secolo di indagini psicologiche, come di una sorta di setaccio che rileva il peculiare vantaggio concorrenziale di tutti i prodotti offerti dal mercato cognitivo – e questi, come per riflesso, offrono preziosi spunti per inedite ed originali riflessioni antropologiche. Scandagliando le fluttuazioni di questa compravendita dell’attenzione è infatti possibile (seguendo modalità non dissimili da quelle che nel mondo del marketing vengono definite customer profiling) azzardare una sorta di analisi incrociata che a ritroso offre un’immagine piuttosto verace del soggetto economico che agisce dietro a questi scambi. E così, forte di un solido impianto bibliografico che spazia da Bernard Stiegler ad Antonio Damasio, dalle neuroscienze fino alle rilevazioni prodotte da multinazionali come Youtube e Google, e attraverso una fitta rete di riferimenti alla cronaca e agli episodi di Black Mirror, l’autore di Apocalypse Cognitive avanza una tesi solenne, una sorta di diagnosi epocale relativa al nucleo scabroso e abietto che pulsa al cuore della nostra natura.
E il profilo dell’umanità che si intravede tra le pagine del libro è lo stesso, verrebbe da dire, di quel soggetto che vediamo riflesso negli schermi opachi di quei telefonini che assorbono implacabilmente, giorno dopo giorno e sempre di più, il nostro prezioso capitale attenzionale:
«Il mondo contemporaneo, così come viene dispiegato dalla deregolamentazione del mercato cognitivo, offre una rivelazione – ovvero un’apocalisse – fondamentale per comprendere sia la nostra natura che i rischi che ci attendono. Questa deregolamentazione ha come sua conseguenza primaria la fluidificazione generale tra la domanda e l’offerta, in particolare per quanto riguarda il mercato cognitivo, e questa coincidenza tra l’una e l’altra non fa apparire né più né meno che le grandi invarianti specie specifiche dell’umanità. La rivelazione, allora, è relativa a quella che definirei un’antropologia non ingenua. Il fatto che il nostro cervello sia recettivo rispetto ad ogni informazione egoriferita, agonistica, legata in qualche modo alla sessualità o alla paura, per esempio, disegna un profilo piuttosto verace di Homo sapiens. La deregolamentazione del mercato cognitivo attualizza in un certo senso quello che esisteva solo sotto forma di possibilità. Nei tempi lunghi della storia queste potenzialità sono state limitate da ogni sorta di regolamentazioni e di impedimenti: censura, interdetti religiosi, ostacoli geografici, limiti informazionali, forme di paternalismo più o meno permissive…Oggi, grazie alla deregolamentazione del mercato cognitivo, l’offerta e la domanda si accordano al meglio – e al peggio – e ci permettono di scrutare da vicino l’immagine di noi stessi». (pp. 191-192)
Lungi dal configurarsi quale semplice avvisaglia della fine del mondo o come il mero epilogo della plurimillenaria avventura del genere umano, l’apocalisse di cui ci parla Bronner va intesa allora nel senso etimologico più proprio all’etimo greco: ἀποκάλυψις (apokálypsis), ovvero “rivelazione”. Il termine ha un significato drammaticamente prossimo a quello di ἀλήθεια (aletheia), comunemente tradotto con “verità” ma che può essere meglio reso come “lo stato del non essere nascosto; lo stato dell'essere rivelato”, e com’è noto fu Martin Heidegger a dedicare più di una pagina alla questione di quale verità sarebbe stata disvelata all’uomo dallo sviluppo tecnologico (Heidegger 1991). Ma Heidegger, così attento ai movimenti tortuosi del disvelamento, si muoveva a sua volta sul solco teoretico tracciato da Immanuel Kant. Nella sua Critica della ragion pura, (Kant 1997) il titanico filosofo di Köningsberg si era posto come obiettivo proprio l’indagine relativa alle condizioni di possibilità della conoscenza che precedono ogni esperienza empirica e che, non potendo essere raggiunte dai sensi, devono essere descritte da un'analisi critica svolta dalla sola ragione. E siccome lo scopo che accomuna Kant e Bronner sembra proprio essere quello di voler rivelare, seppur con metodi e strumenti concettuali differenti, la verità che in fondo pertiene alle “grandi invarianti specie specifiche dell’umanità”, noi non possiamo che accogliere le recenti osservazioni condotte in Apocalypse Cognitive se non come una sorta di continuazione alla o di compendio della filosofia trascendentale. Il parallelismo, al contrario di come può sembrare a tutta prima e nonostante il fatto che Kant non figuri tra i riferimenti di Bronner, non è affatto forzato. Infatti, se Kant cercava di estrarre per via squisitamente speculativa dalle fonti della ragion pura (in quanto scevra da ogni contaminazione empirica) le forme intellettuali che regolano, limitano e lavorano a priori ogni pensiero, per Bronner al contrario la scommessa della sociologia cognitiva consiste proprio nell’individuare il sostrato impuro dell’animo umano: quella dimensione che plasma a nostra insaputa le nostre performance cognitive ma che può essere approcciata solo a posteriori.
Ma la dialettica tra purezza e impurità, che ci permette di leggere Apocalypse Cognitive come una vera e propria Critica della Ragion Impura, può essere interpretata anche in senso lato, più letterale: se infatti l’analitica trascendentale risultante dalla speculazione filosofica kantiana elicita quanto di più razionale e puro l’animo umano disponga (i concetti, le categorie ed i principi) l’indagine promossa da Apocalypse Cognitive rivela al contrario i funzionamenti atavici che regolano tutto quello spettro della cognizione umana filosoficamente spurio, istintuale e irriducibile all’intelletto. La dipendenza dai vari bias di conferma, la viscosa attrazione esercitata dal sesso e dalla paura, così come la zavorra mentale costituita dalla strutturale incompletezza ontologica della natura umana, sono infatti caratteristiche precipue ed inemendabili di questa natura, vere e proprie strutture trascendentali che fungono da contrappeso a tutto l'equipaggiamento razionale individuato da Kant, e che contribuiscono così a restituire un’immagine di Homo Sapiens più realistica, meno astratta e intellettualistica.
Un’immagine più respingente e scabrosa di quella tanto in voga presso quegli ambienti intellettuali nei quali fermentano teorie critiche alla moda e vengono prodotte analisi sociali intellettualmente seducenti, ma in cui è diffuso, nelle parole dell’autore, un approccio “antropologicamente ingenuo”. Quando Bronner afferma, ad esempio, che «non ci sono forze sociali misteriose e potenti che orientano il comportamento degli individui, come si crede quando si pratica della sociologia ingenua, ma micro-anticipazioni che producono effetti collettivi involontari, benché prevedibili» (p. 214), sembra allora riferirsi alla disinvoltura con cui molti degli intellettuali di oggi sono portati ad accanirsi contro il saracino dell’assoggettamento sistemico – sia esso incarnato dal capitalismo, dal neoliberalismo o da quella cangiante chimera dalla discutibile credibilità che è l’eterocispatriarcato…
Gli strali polemici del libro sono infatti indirizzati a tutti quegli autori stregati dalla militanza e inebriati dall’attivismo che, anteponendo le loro schematiche concezioni del mondo all’esperienza diretta dei fatti più elementari, rimangono vittima di una concezione parziale, romantica e idealista tanto delle scienze sociali quanto della politica:
«Piuttosto che degli esseri eteronomi sballottati dalle malvage intenzioni di un misterioso sistema di dominazione, gli individui sono spesso degli attori che tentano strategicamente di conciliare i loro interessi materiali e simbolici. A volte dissimulano nei loro discorsi delle virtù che sono disposti a sottoscrivere a giorni alterni. Alcuni tra loro, certo, lo fanno solo per ipocrisia ma non è il caso di generalizzare sposando una tesi così misantropa. Basta ricordarsi dell’esistenza di quei conflitti che risiedono al cuore stesso del nostro cervello. La soluzione a questi conflitti, spesso, è tributaria di quelle soddisfazioni a breve termine rispetto alle quali siamo disposti ad indulgere e che ci illudono di risolvere problemi a lungo termine» (pp. 291-292).
L’invito a valutare la portata di “quei conflitti che risiedono al cuore stesso del nostro cervello” quindi va letto come un’esortazione di stringente attualità indirizzata tanto ai fruitori quanto ai produttori dei manufatti virtuali in vendita sugli scaffali del mercato dell’informazione. E la rivelazione cognitiva epocale che descrive Bronner, come sarà ormai chiaro, riguarda proprio la carsica rilevanza culturale e politica dei funzionamenti inconsci che governano il rapporto tra informazione, consumo e soddisfazione e che allignano nel profondo della psiche umana, da dove preferiremmo distogliere lo sguardo. Apocalypse Cognitive costringe al contrario il lettore a scrutare nei meandri di questa rivelazione come se si trattasse di fissare gli occhi della testa di Medusa (la stessa che, dipinta dal Caravaggio, campeggia non a caso sulla copertina del libro…) il cui potere, secondo il mito, era quello di pietrificare chiunque l’avesse guardata.
È infatti solo vincendo le resistenze mentali nei confronti di quelle verità scomode che fanno capo ad una “antropologia non ingenua” che è possibile oggi assolvere seriamente al ruolo dell’intellettuale. E al contrario di quanto affermato da Thomas Jefferson, secondo cui “solo l’errore necessita di un aiuto da parte del governo, la verità si difende da sola” (p. 216), Bronner sostiene che la verità nel mondo in cui viviamo non si difenderà affatto da sola ma, anzi, avrà bisogno dello sforzo di studiosi, giornalisti e ricercatori capaci di discernere il vero dal falso, e il plausibile dall'irragionevole, in un contesto di assoluta anarchia informazionale. Il lavoro intellettuale, oggi, non può dunque prescindere dal dovere di riconoscere l’ombra lunga che le strutture psichiche ancestrali proiettano nel bailamme indifferenziato del mercato cognitivo. E al fine di scongiurare la deriva identitaria del dibattito politico, per limitare la circolazione incontrollata di idee ingannevoli e per imparare a muoversi con disinvoltura in quella “battaglia di narrazioni” (p. 312ss) che imperversa nell’agone multimediale della società globale informatizzata, l’autore di Apocalypse Cognitive consiglia saggiamente che imparare a resistere allo sguardo pietrificante della verità, prima ancora che a difenderla, è un compito duro ma inevitabile.
Filippo Zambonini
Bibliografia:
Bronner G, Vie et mort des croyances collectives, Hermann Editeurs des sciences et des arts, Paris 2006
Bronner G, Il pensiero estremo. Come si diventa fanatici, Il Mulino, Bologna 2012
Bronner G., L’empire de l’erreur. Éléments de sociologie cognitive, PUF, Paris 2015
Bronner G, La democrazia dei creduloni, Aracne, Roma 2016
Bronner G, Apocalypse Cognitive, PUF, Paris 2021
Heidegger M., La questione della tecnica, in Saggi e Discorsi, a cura di Gianni Vattimo, Mursia, Milano 1991
-
PK#21 \ settembre 2024
a cura di Carlo Deregibus e Aurosa Alison
Siamo abituati a guardare alle forme dell’architettura come portatrici di significati. Quello tra forma e significato era un nesso così ovvio, così connaturato alla costruzione e alla realtà sociale, da rimanere perlopiù implicito, premessa a qualsiasi discorso e trattato. Valeva nell’architettura classica come in quella medievale, in quella egizia come in quella barocca, in quella moderna come, persino, in quella propriamente detta postmoderna. Solo in tempi relativamente recenti, quando il postmodernismo fa vacillare non tanto quel legame, quanto la la sua univocità, il significato diventa un problema per l’architettura. Da un lato, perché la missione del Moderno, così assoluta da polarizzare qualsiasi dibattito, si rivela alla prova del tempo quantomeno aleatoria. Dall’altro, perché si avvertono i primi sentori di quel cambiamento, fatto di globalizzazione e moltiplicazione del pensiero che diverrà travolgente nel nuovo millennio. Nasce cioè l’idea che la forma sia parte di un sistema di comunicazione di significati, più che la latrice di un univoco messaggio.
In questo contesto usciva in Italia, ormai 50 anni fa, Il significato in architettura, curato da Charles Jencks e Georges Baird e pubblicato a Londra cinque anni prima. Raccoglieva una quindicina di testi tra loro spesso in contrasto, editati e commentati, che indagavano il significato da vari punti di vista: secondo approcci semiotici o fenomenologici, con accenti teoretici od operativi, con critiche o proposte, i testi tracciano una storia del significato possibile. Tanto che proprio il contrasto, a volte violento ed esplicitamente sobillato dai curatori, diventa il tratto più distintivo del volume: un contrasto reso possibile dalla convinzione, vana, che fosse ancora possibile definire il rapporto tra significato e forme.
Cosa resta, cinquant’anni dopo, di quel dibattito? Poco, in effetti. Lungi dall’essere sparito dai radar degli architetti, in questi decenni il significato si è moltiplicato in rivoli talmente frammentati da non permettere più una geografia culturale precisa. Nuovi significati - la globalizzazione appunto, ma anche i temi dell’antropocene, della gentrification, delle ecologie, della resilienza, dei gender studies, e così via - offrono infinite possibilità di teorizzazione, sempre legate a pratiche tra loro distinte, separate e che non comunicano. Ma che si considerano tutte Architettura. È uno sfilacciamento riflesso anche dalle teorie sull’arte e dalla crescente distanza tra arte e mercato, tra significato e esperienza, tra percezione e comprensione. Eppure, continuiamo a progettare, a produrre e a criticare l’Architettura, continuamente attribuendo alle sue forme significati, e rivestendola di intenzioni e speranze.
Così, questo numero di PK esplora, una volta di più, questa sfuggente ma insieme ineludibile relazione tra significato e architettura. Lo fa secondo tre assunti metodologici. Il primo è che, lungi dall’essere scomparso, il significato oggi ecceda, e largamente, la forma, e dunque sia sempre e di nuovo possibile riscoprire e riprogettare la loro relazione: certo quel legame muta a velocità variabili, secondo sistemi diversi la cui reciproca irritazione produce cambiamenti spesso imprevedibili, ma tuttavia esiste. Il secondo è che le dimensioni teoretica e pratica dell’architettura non siano pensabili separatamente, se non come coppia oppositiva derridiana: il progetto dell’architettura deve essere sempre inteso nella sua dimensione performativa e secondo gli effetti che questo produce, e la distinzione tra progetto e progetto di architettura è ad essi strettamente quanto problematicamente legata. Il terzo è la dimensione sistemica dell’architettura, che deve essere intesa nelle sue condizioni socio-tecnico-economiche: questo vale sempre, storicamente, e oggi implica una relazione costitutiva con un pervasivo sistema neoliberale, un confronto con una dimensione produttiva che cancella le tensioni artigianali, e la modifica delle modalità di produzione del progetto che, circolarmente, ne stravolgono concezione e quindi significato. Le connessioni tra i tre assunti - ad esempio nella tensione tra agire individuale e dimensione sistemica, da cui emerge una valenza tattica e strategica del progetto - sono altrettanto decisive.
Le proposte possono affrontare il tema del significato in architettura da una prospettiva ontologica ed epistemologica, anche con una prospettiva storico-critica, oppure rientrare in uno dei quattro nuclei tematici qui enucleati, anche esplorandone connessioni e interrelazioni e trattandoli da diversi punti di vista - storico, teoretico, critico:
- Nuove forme del significato. I luoghi sono sempre stati collettori del senso di comunità, sia in senso simbolico sia in senso esperienziale. Come coordinare il continuo moltiplicarsi di forme di socializzazione reale e digitale (dal metaversale alla visual turn) con l'aspetto ontologico e reale della progettazione? Sulla scorta della retorica di una democratizzazione dei processi comunicativi, sociali e relazionali, è davvero possibile innestare un significato nello spazio pubblico, o questi progetti non fanno altro che illudere i partecipanti di farlo? È il processo, o il programma, a dare un significato a un’architettura in cui le forme non hanno rilevanza alcuna se non come trasposizione tecnica o, al contrario, l’architettura va considerata e trattata come un palinsesto che vive persino indifferentemente dagli usi, diventandone uno sfondo neutrale? Nel mezzo, un’infinita sfumatura di pratiche e approcci.
- Nuovi significati delle forme. Vorremmo riflettere su quei significati che più sembrano trasversali e sostanziali nell’impattare l’architettura. Il primo è ascrivibile al tema della sostenibilità: ad esempio, come superare pratiche estetizzanti e approcci puramente prestazionali e sviluppare una dimensione autenticamente ecologica del progettare? È un tema di norme, di cultura, di azioni, di tecniche, di approcci, di forme, di strategie, o ancora di altro tipo? Il secondo è il cosiddetto design for all, che raccoglie questioni pratiche - come l’accessibilità - e culturali - come l’urbanistica di genere - e che però, curiosamente, si sostanzia in limitazioni burocratiche variamente normate: quasi che il progetto non definisse, ontologicamente, i limiti di qualche libertà. Come superare questa visione, aggrappata a una logica di tutela dei gruppi di minoranza, per sviluppare il tema della libertà nel progetto e nelle forme?
- Resilienza dei significati. C’è Architettura e architettura. Gran parte dei progettisti nel mondo non si occupano di quelle rare opere “straordinarie” (auditorium, chiese, musei), cioè i tradizionali portatori di significati condivisi: bensì di ordinarie, comuni, quotidiane costruzioni. Non parliamo dell’ordinario sperimentale e d’élite esplorato dagli architetti di punta, ma proprio della pratica comune, di quel significato che nasce e si sostanzia in una continua variazione e ripetizione, nel real estate come negli slum. Spogliata dalle stratificazione semantiche dell’Architettura, resta cioè un’architettura: lontana dalle accademie e dalle pagine patinate, ma che traccia il nostro mondo. A livello ontologico e pratico, il progetto di questa architettura è diverso da quello di Architettura? E in che modo si evolve, ad esempio guardando all’ascesa impressionante dei software basati sull’Intelligenza Artificiale?
- Resilienza delle forme. Il costruito ha una immensa capacità resiliente. Certo, non sempre questa va d’accordo con gli usi, e i significati di quelle forme. Il caso italiano è emblematico, tra tensioni verso la rigenerazione e l’esigenza di tutela e conservazione del patrimonio. Casi come Palazzo dei Diamanti a Ferrara o lo stadio Meazza a Miano sono solo le evidenze mediatiche di un problema diffuso e in inevitabile crescita: lo scontro tra valori e significati diversi, che si sovrappongono nelle forme. La risposta è nella qualità del progetto? Oppure in quella del processo? È un problema di procedure e soggetti decisori, oppure di proposte e gestione? In che modo significati sempre più essenziali e inconciliabili - ad esempio la fruizione dei beni storici, la sicurezza in caso di sisma, il risparmio energetico, il costo degli interventi, vincoli antincendio, di accessibilità e così via - si intersecano nelle forme?
È nostra intenzione, in omaggio al tratto più distintivo de Il significato in architettura, promuovere una circolazione dei contributi tra gli autori prima della pubblicazione, in modo da raccogliere commenti specifici da parte di tutti gli autori e offrire una possibilità di controreplica ai commenti da parte degli autori stessi. Un dibattito interno al volume, unico quanto prezioso.
Bibliografia:
Ando, T., (1990), Complete Works, Taschen
Armando, A. & Durbiano, G. (2017). Teoria del progetto architettonico. Dai disegni agli effetti. Roma: Carocci.
Aureli P.V. (2008). The Project of Autonomy: Politics and Architecture Within and Against Capitalism. Hudson: Princeton Architectural Press.
Berlin, I. (1969). Four Essays on Liberty. Oxford: Oxford University Press
Booth C., Darke J. & Yeandle S. (edi) Changing Places: Women’s Lives in the City. London: Paul Chapman Publishing Ltd.
Boudon, R. (1984). La place du désordre. Critique des théories du changement sociale. Paris: Presses Universitaires de France.
Chia, R. & Holt, R. (2011). Strategy without Design: The Silent Efficacy of Indirect Action, Cambridge: Cambridge University Press.
Deregibus, C. (2016). Intention and Responsibility. Milano: IPOC.
Derrida, J. (2008). Adesso l’architettura. Milano: Scheiwiller, 2008.
Haraway, D. (1985). Manifesto for cyborgs: science, technology, and socialist feminism in the 1980s. Socialist Review, no. 80, 65-108.
Holl, S., Pallasmaa, J. & Perez-Gomez (2007). A. Questions of Perception: Phenomenology of Architecture. San Francisco: William K Stout Pub.
Jencks, C. & Baird, G. (ed) (1974). Il significato in architettura. Bari: Dedalo.
Jullien, F. (2004). A Treatise on Efficacy. Between Western and Chinese Thinking. Honolulu: University of Hawai Press.
Koolhaas, R. (1978). Delirious New York. A Retrospective Manifesto for Manhattan. New York: Oxford University Press.
Luhmann, N (2012). Introduction to Systems Theory. Cambridge: Polity Press.
Moneo, R. (1989). “The Solitude of Buildings”, A+U: architecture and urbanism, 227.
Norberg-Schulz, C. (1967). Intentions in Architecture. Cambridge & London: The MIT Press.
Norberg-Schulz, C. (1975). Meaning in Western Architecture. New York: Praeger Publisher.
Norberg-Schulz, C. (1979), Genius Loci. Paesaggio, Ambiente, Architettura. Milano: Electa.
Paci, E. (1961). Tempo e verità nella fenomenologia di Husserl. Roma-Bari: Laterza.
Paci, E. (1965). Relazioni e significati. Milano: Lampugnani Nigri.
Pallasmaa, J. (1996). The Eyes of the Skin. Architecture and the Senses. New York: John Wiley & Sons.
Pareyson, L. (1954). Estetica. Teoria della formatività. Torino: Edizioni di Filosofia.
Ponti, G. (1957). Amate l’architettura. Genova: Società Editrice Vitali e Ghianda (Quodlibet, 2022).
Preciado, P. B. (2020). Un appartamento su Urano. Cronache del transito. Roma: Fandango libri.
Preciado, P. B. (2022). Dysphoria Mundi, Paris: Grasset.
Rogers, E. N. (1958). Esperienza dell’architettura. Torino: Einaudi (Skira, 2002).
Rogers, E. N. (1961). Gli elementi del fenomeno architettonico. Roma-Bari: Laterza (Marinotti, 2006).
Rowe, C. (1994). The Architecture of Good Intentions. Towards a Possible Retrospect. London: Academy.
Vitali, W. (Ed.). Un'Agenda per le città. Nuove visioni per lo sviluppo urbano. Bologna: Il Mulino.
Ward, C. (1973). Anarchy in Action. London: Freedom Press.
Windhoff-Héritier, A. (1992). City of the Poor, City of the Rich: Politics and Policy in New York City. Berlin: de Gruyter.
Procedura:
Per partecipare alla call, inviare all'indirizzo redazione@philosophykitchen.com, entro il 16 luglio 2023, un abstract di massimo 4.000 caratteri, indicando il titolo della proposta, illustrando la strutturazione del contributo e i suoi contributi significativi, e inserendo una bibliografia nonché una breve biografia dell’autore o dell’autrice.
L'abstract dovrà essere redatto secondo i criteri scaricabili qui [Template Abstract], pena esclusione.
Le proposte verranno valutate dai curatori e dalla redazione. I contributi selezionati, che saranno sottoposti a double-blind peer review.
Lingue accettate: italiano, inglese, francese.
Calendario:
- 16 luglio 2023: consegna degli abstract
- 03 settembre 2023: comunicazione degli esiti
- 17 dicembre 2023: consegna dei contributi selezionati
- 03 luglio 2023: comunicazione degli esiti della selezione
- Primavera 2024: circolazione dei pezzi tra gli autori
- Settembre 2024: pubblicazione del volume
-
Capita spesso che alcune idee filosofiche abbiano una cattiva fama; fino a qualche secolo fa, per esempio, nell’Europa cristiana era piuttosto rischioso professare l’ateismo. Da questo punto di vista la situazione è migliorata e se si porta avanti delle idee proibite più che un rogo si rischia una shitstorm, ma è comunque interessante vedere quali sono i tabù filosofici di un’epoca. Che sia per via dei suddetti retaggi cristiani o a causa di una struttura sociale che ci vuole prima di tutto consumatori, a Occidente una di queste tesi sgradite è il rifiuto del libero arbitrio. La libertà dopotutto è un fondamento ideologico di democrazia e neoliberismo e negarla viene interpretato come un’aggressione filosofica. Mi auguro dunque di non ricevere troppo biasimo, perché mi trovo nella sgradevole condizione di sposare un’idea che la maggior parte delle persone aborre, ovvero che il futuro sia determinato. In breve, credo nella necessità degli eventi: non esistono eventi meramente possibili, ogni fatto o non ha luogo o ha luogo necessariamente.
Più che esserne convinto la trovo addirittura un’ovvietà – ed è proprio questa sicurezza a insospettirmi, perché l’esperienza insegna che spesso ovvietà e verità non vanno d’accordo. Voglio dunque mettere al vaglio questa opinione, che per mia fortuna ha illustri precursori e sostenitrici. Oltre all’antico filosofo greco Diodoro Crono, che ha aperto la strada al determinismo col suo “Argomento dominatore”, come scrive il filosofo lettone Nicolai Hartmann nel suo Possibilità ed effettività,
«la concezione, per cui solo l’effettivo è realmente possibile, storicamente non è affatto svanita. Crisippo la combatté con argomenti che permettono di riconoscere ancora la sua forza. Cicerone l’adoperò volgarizzata nella sua dottrina del fato. Al culmine della Scolastica riemerse in forme nuove e – come pare – completamente autonome. Abelardo la applicò al fare creativo della divinità (Dio “può” soltanto creare ciò che crea effettivamente); Averroè sostenne una dottrina dello sviluppo secondo la quale tutto ciò che è possibile diviene anche effettivo».
Nella fisica moderna questa posizione ha prevalso fino allo sviluppo della meccanica quantistica, che ha messo in dubbio il determinismo einsteiniano a favore della tesi che a livello microscopico i fenomeni della natura sono descrivibili solo in termini probabilistici. Anche in quest’ambito però sussistono dei disaccordi, come dimostra la posizione superdeterminista di una studiosa come Sabine Hossenfelder, per la quale l’apparente casualità dei fenomeni quantistici deriva dalla nostra ignoranza di variabili nascoste, un’ipotesi che è stata scartata erroneamente. Per Hossenfelder,
«L’errore che i fisici hanno fatto decenni fa è stato quello di trarre la conclusione sbagliata da un teorema matematico dimostrato da John Bell nel 1964. Questo teorema dimostra che in qualsiasi teoria in cui le variabili nascoste ci permettono di prevedere i risultati delle misurazioni, le correlazioni tra i risultati delle misurazioni obbediscono a un limite. Da allora, innumerevoli esperimenti hanno dimostrato che questo limite può essere violato. Ne consegue che le teorie a variabili nascoste a cui si applica il Teorema di Bell sono state falsificate. La conclusione che i fisici hanno tratto è che la teoria quantistica è corretta e le variabili nascoste no, ma il teorema di Bell fa un’assunzione che non è supportata da prove: che le variabili nascoste (qualunque esse siano) siano indipendenti dalle impostazioni del rivelatore. Questa assunzione, chiamata “indipendenza statistica”, è ragionevole finché un esperimento coinvolge solo grandi oggetti come pillole, topi o cellule tumorali. (E in effetti, in questi casi una violazione dell’indipendenza statistica suggerirebbe che l’esperimento è stato manomesso). Se questo valga anche per le particelle quantistiche, tuttavia, resta ignoto. Per questo motivo possiamo anche dire che gli esperimenti che provano il teorema di Bell, piuttosto che sostenere la teoria quantistica, dimostrano che l’indipendenza statistica è stata violata».
La posizione di Hossenfelder è minoritaria e non ho le competenze per valutarla, ma finché non avremo una visione pacifica della fisica quantistica appellarsi a essa per confermare o negare una tesi resta una mossa rischiosa. Dopotutto il fatto che esistano eventi casuali resta ancora un’ipotesi e in ogni caso la loro esistenza, che falsificherebbe il determinismo causale, non avrebbe alcun effetto sul determinismo acausale che difendo – e che devo spiegare[1].
Nella Stanford Encyclopedia of Philosophy, sotto la voce determinismo, si legge che «Il mondo è governato dal (o è sotto l’influenza del) determinismo se e solo se, dato un determinato stato in cui le cose sono in un momento t, lo stato in cui le cose saranno in seguito è fissato da una legge naturale». Questa definizione sembra più vicina a quel che chiamo determinismo causale, ovvero l’idea che gli eventi futuri siano prevedibili o comunque causalmente determinati dagli eventi passati. La mia proposta è più debole: ciò che accade nel futuro è determinato, ma non è necessariamente legato al passato. Gli eventi futuri, infatti, potrebbero avvenire per caso o essere del tutto imprevedibili, ma non sarebbero per questo meno determinati.
Per spiegare questo inusuale concetto propongo un esempio: diciamo che cade una tegola da un tetto. Per l’indeterminismo, che è la posizione più vicina al senso comune, potevano darsi diverse condizioni tali che la tegola non sarebbe caduta; poteva non subire urti, non essere erosa dalla pioggia o spostata da un forte vento, eccetera. Il futuro è aperto e può accadere in vari modi. Per il determinismo causale, quello sostenuto da Einstein e Hossenfelder, è scritto nelle leggi della natura che la tegola sarebbe caduta, perché è altresì scritto che pochi istanti prima un colpo di vento l’avrebbe spostata, che le condizioni meteorologiche siano tali da far alzare il vento e così via, di causa in causa, fino all’inizio dell’universo. Il futuro è chiuso ed è causato dal passato. Anche per il determinismo acausale era necessario che la tegola cadesse, ma non che l’evento sia collegato alla ventata, come sostiene il determinista causale. Potrebbe infatti avvenire spontaneamente, senza una causa. Il futuro è chiuso, quale che sia il suo legame col passato.
Ora che ho chiarito (spero) cosa intendo per determinismo acausale, devo spiegare perché credo che gli eventi siano determinati al netto della loro relazione col passato. Per farla breve, il motivo per cui penso che necessità e possibilità coincidano è che credo nella verità di questa frase: «domani accadrà qualcosa, anche se non so cosa»; tanto basta per sapere che quel che avverrà domani è determinato, sebbene adesso lo ignori – qualsiasi cosa accada, infatti, non può che accadere così come accadrà. Ora non so se tra cinque minuti berrò un caffè, ma, qualora accada, non poteva che andare così. Un attimo: potevo decidere di non prendere il caffè! Sì, ma in tal caso sarebbe questo secondo evento a esser stato determinato. C’è insomma una previsione che posso sempre fare con assoluta certezza: qualcosa avverrà e a venire in essere sarà esattamente il fatto che ora ignoro. Se vivessi in un universo di cui concepisco solo due possibilità, come il “testa o croce” del lancio di una moneta, sarei sicuro che una di esse si verificherà – e sarà esattamente quella – ma non potrei dire quale. Insomma, so che accadrà un fatto e che nulla potrà impedirlo; l’unica differenza rispetto a un evento del passato è che non ne conosco la natura, perché è fuori dalla mia portata. Quel che accadrà è dunque inevitabile, perché una volta accaduto non può cambiare – anche se si potesse cambiare, inoltre, a essere inevitabile sarebbe l’evento modificato. Persino qualora si creda che per ogni evento la realtà si moltiplica in dieci, cento o infiniti piani temporali, a essere determinati saranno tutti gli eventi nei vari rami del tempo.
L’ipotesi che esistano alternative al passato mi sembra una proiezione retroattiva degli schemi che usiamo per prevedere e immaginare cosa accadrà nel futuro. Per quel che riguarda il passato, infatti, so che gli eventi sono accaduti in un solo modo. Cosa mi fa supporre che poteva andare diversamente? L’unica conoscenza di cui dispongo è che è accaduto esattamente quel che è accaduto. La possibilità è un concetto bifronte; applicato al futuro è una bussola per navigare nella nostra ignoranza, ma rivolta al passato è semplicemente un errore. Tutto il futuro però diventerà passato; come scrive Vladimir Jankélévitch in La morte,
«Tutto il possibile, dice Schelling, deve accadere; e noi aggiungiamo: tutto l’avvenire avverrà, essendo avvenire solo per venire effettivamente un giorno. Qualunque cosa accada, il futuro (come indica il suo nome) sarà, vale a dire finirà per essere, poiché è un essere semplicemente posticipato».
Anche se il tempo fosse infinito, infatti, ogni istante accade dopo un intervallo finito, dunque prima o poi diventa effettivo. Data la nostra abitudine ad anticipare il futuro tutto questo suona molto strano, eppure non abbiamo alcun indizio a favore del fatto che un evento non dovesse accadere esattamente com’è accaduto. Al contrario, ne abbiamo almeno uno a favore del fatto che doveva andare proprio in quel modo: il fatto stesso che sia accaduto. Su cosa fondiamo l’idea che “sarebbe potuta andare diversamente”, se sappiamo che l’ipotetica alternativa non è accaduta né accadrà mai?
Tra i primi paladini del determinismo troviamo, come accennavo, il filosofo greco Diodoro Crono (fine 4° – inizi 3° sec. a.C). L’argomento da lui sviluppato contro la possibilità (noto con il nome di κυριεύων, il «dominante») schiaccia la nozione di possibile su quella di necessità: se una cosa è possibile, o è o sarà vera, giacché: a) ogni cosa passata è vera e necessaria; b) dal possibile non consegue l’impossibile. Nelle parole di Epitteto, l’idea di Crono è come segue:
«[...] c’è un mutuo conflitto tra le seguenti tre proposizioni insieme: [1] ogni verità passata è necessaria, [2] al possibile non segue l’impossibile, [3] c'è del possibile che né è vero né sarà vero. Diodoro, avendo visto questo conflitto, si valse della plausibilità delle prime due per stabilire che nulla, che né sia vero né sarà vero, è possibile».
Questo argomento ha subito varie riformulazioni, come quella del filosofo neozelandese Prior, e molte critiche, tra cui Crisippo, Occam, Pierce e lo stesso Hartmann, che pur sposando le conclusioni del dominatore, sostiene che «dopo un buon inizio, cala molto di livello». Non voglio addentrarmi in un’analisi della tesi di Crono, ma ne proporrò una versione ibridata con il celebre esempio che Aristotele fa nella sezione 9 di Sull’interpretazione, quello della battaglia navale. Invece delle navi però, userò Napoleone Bonaparte.
(1) Un evento impossibile è un evento che non è mai accaduto né potrà mai accadere. (2) Che Napoleone vinca a Waterloo non è vero nel passato, nel presente e nel futuro. (3) “Napoleone viene sconfitto a Waterloo il 18 giugno 1815” è vero in qualunque momento nel tempo, quindi era impossibile che vincesse.
Ancora una volta è la certezza che il futuro sarà esattamente in un modo, per quanto ignoto, che mi porta a credere nel determinismo (acausale); la possibilità è una proiezione della nostra ignoranza, più che una realtà effettiva.
Che un evento possieda varie versioni possibili è un’ipotesi che chiunque esclude per il passato e il presente, perché abbiamo (o crediamo di avere) una buona conoscenza dei fatti. Per il futuro invece la pensiamo diversamente. Eppure, come si diceva, tutto il futuro prima o poi diventa passato e anche se continuo a immaginare che “poteva andare altrimenti”, una volta accaduto il futuro non suggerisce in alcun modo altre opzioni. Se proietto sulla realtà questa mia fantasia è perché ho esperienza di fatti analoghi veri (ad esempio di altri condottieri che vincono o perdono battaglie), ma non ne ho mai di quel preciso fatto, come la vittoria di Napoleone a Waterloo, che non esiste né esisterà mai. Una previsione esatta espressa nel passato, se confermata dal futuro, resta tale anche nel passato e se un francese nel 1814 avesse affermato che “Napoleone viene sconfitto a Waterloo il 18 giugno 1815” avrebbe detto il vero, anche se la sua affermazione precede di un anno la battaglia.
Riprendo ora il precedente esempio di un universo con solo due stati immaginabili, come testa o croce: mentre lancio la moneta so che nel futuro un esito è vero e l’altro falso. Non so ancora quale sia falso, ma in ogni caso non è “possibile” – è solo falso.
Chi crede come me nella necessità del futuro, a questo punto si domanderà che cosa rende questa ipotesi assurda per la maggior parte delle persone. Un’ipotesi è che questa reticenza sia dovuta alla radicata abitudine di cercare di prevedere il futuro, un’operazione mentale per cui è indispensabile l’idea di “possibilità”. Un altro ostacolo nell’accogliere il determinismo è che va contro alla necessità psicologica di considerare le persone responsabili delle proprie azioni, soprattutto quando si parla di errori. Dato che il determinismo implica l’assenza del libero arbitrio, chi sposa questa tesi deve difendersi dalla critica che senza la libertà di scelta l’umanità sprofonderebbe in un caos etico, perché le persone si sentirebbero libere di compiere ogni efferatezza sapendosi prive di una reale responsabilità. Questa critica è filosoficamente debole, perché le conseguenze spiacevoli di un’ipotesi non dicono nulla sul suo valore di verità – è un po’ come ribattere a un medico che diagnostica una malattia che si sbaglia perché non si desidera essere malati.
L’idea che abbandonare il libero arbitrio sia un pericolo etico, inoltre, mi sembra priva di fondamento. Come scrive Sabine Hossenfelder in un articolo in cui cerca di smontare dieci errori in materia di determinismo, «se il risultato dei tuoi processi cerebrali rende difficile la vita di altri, sarai tu a essere incolpato, recluso, mandato in psicoterapia o preso a calci. È del tutto irrilevante che la tua elaborazione difettosa delle informazioni sia o meno inscritta nelle condizioni iniziali dell’universo; la questione rilevante è ciò che ti porterà il futuro, se altri cercano di sbarazzarsi di te» e ancora, «anche senza il libero arbitrio, le persone devono comunque prendere decisioni e saranno comunque biasimate se rendono infelice la vita di altre persone». Determinate o meno, le nostre azioni hanno conseguenze e a scomparire non è l’idea di responsabilità ma semmai quella di colpa – la cui sparizione non ritengo affatto un male.
In un lungo articolo sul libero arbitrio sul Guardian, Oliver Burkeman porta l’esempio di un assassino e di un pedofilo i cui crimini erano legati alla presenza di un tumore al cervello; una malattia che, in determinate condizioni, può mutare drasticamente i comportamenti e i desideri di chi la sviluppa. Una volta scoperta la vera causa del male, la nostra opinione su questi criminali cambia inevitabilmente. Se non esistesse il libero arbitrio, ogni delinquente sarebbe da considerare come una persona condannata alle sue azioni. Questa idea ci porta a rivedere la giustizia in chiave riabilitativa o come una quarantena per motivi di salute pubblica, rinunciando così alla legittimità della nostra indignazione. Sembrerebbe un effetto negativo, se non fosse che l’accanimento morale non ha alcuna utilità sociale, anzi, porta alla erronea impressione di essere immuni al male e alla giustificazione di ulteriori atti immorali, come un trattamento violento nei confronti dei criminali. La società non rischierebbe di sprofondare nel caos, perché il male resterebbe tale e le norme per proteggersi da chi lo attua rimarrebbero intatte, senza però indulgere in sadismi o accanimenti. Sempre nello stesso articolo Burkeman scrive:
«se il libero arbitrio si dimostrasse davvero inesistente le implicazioni potrebbero non essere del tutto negative. [...] È un buon motivo per essere più gentili con noi e con gli altri. Per chi tende a essere duro con se stesso, è terapeutico pensare di aver fatto esattamente quello che poteva fare e che, nel senso più profondo, non avrebbe potuto fare di più. E per chi tende a infuriarsi con gli altri per i loro piccoli misfatti, è rassicurante pensare con quanta facilità le loro colpe avrebbero potuto essere le nostre. Alcune ricerche hanno collegato l’incredulità nel libero arbitrio a una maggiore gentilezza. Harris sostiene che se comprendessimo a pieno la tesi dell'assenza di libero arbitrio, sarebbe difficile odiare gli altri: come si può odiare qualcuno che non si incolpa per le sue azioni? Ma l’amore ne uscirebbe in gran parte indenne: dal momento che “amare significa volere che coloro che amiamo siano felici, ed essere noi stessi felici di quel legame etico ed emotivo”, nessuna di queste cose ne risulterebbe indebolita. Anche altri aspetti positivi della vita rimarrebbero indenni. Come dice Strawson, in un mondo in cui non si crede nel libero arbitrio, “le fragole avrebbero comunque un buon sapore”».
Se si parla dell’effetto che fa una credenza, la risposta non può che essere personale. L’idea del “nulla” ad esempio, pur nelle sue molteplici declinazioni, è capace di causare sconforto a Occidente e di risultare salvifica a Oriente. Anche per quel che riguarda il determinismo non esiste l’effetto giusto, ma solo una moltitudine di reazioni che questa idea genera una volta a contatto con delle individualità che si diversificano per storia biografica, costituzione fisica e contesto culturale – ogni risposta, insomma, è personale e tutto quel che posso offrire è la mia.
Come ho detto non ho mai confidato nel libero arbitrio e in ogni mio gesto mi sono sempre sentito come spinto da una volontà che vivo senza decidere; come aveva già detto Schopenhauer, una persona fa ciò che vuole ma non può non volere ciò che vuole. Se osservo i miei processi mentali, mi sembra di notare che i pensieri, più che un deliberato prodotto della mente (quale mente decide cosa pensa la mente?) sono qualcosa che accade, su cui non ho alcun controllo. Ma non è una consapevolezza dolorosa, tutt’altro. Nei rari momenti in cui riesco a contemplare senza giudicare desideri e repulsioni, lo spettacolo che intessono coi miei pensieri ha la bellezza di un’innocua catastrofe.
Il determinismo acausale, inoltre, mi aiuta a essere più indulgente con me e con gli altri, senza per questo negare o rifiutarmi di correggere i miei errori – in fondo se non mi impegnassi per risolverli sarebbe solo una dimostrazione che sono destinato a non farlo. L’idea che il futuro esista di già mi permette di non avere troppa paura del tempo che passa, perché nulla nasce e nulla scompare, se non alla mia vista. Decostruendo l’idea di colpa, infine, mi sono convinto che nessuna persona merita il dolore e mi è più facile essere tollerante nei confronti di chi la pensa diversamente, perché nessuno decide come nascere. E se questa è la tanto temuta débâcle etica, be’, ben venga.
[1] Tra i nomi sotto cui ho trovato questo concetto segnalo anche “fatalismo logico” o “fatalismo metafisico”. Uso determinismo acausale perchè in italiano la parola “fatalismo” è un po’ fuorviante (cfr. Conee, Earl Brink, and Sider, Theodore. Riddles of Existence: A Guided Tour of Metaphysics. Clarendon Press 2014).
di Francesco D'Isa
Bibliografia
Aristotele, De interpretatione, a cura di Attilio Zadro, Napoli, Loffredo (collana Filosofi antichi. Nuova serie), 1999
Clark, C. J., Winegard, B. M., & Shariff, A. F. (2021). Motivated free will belief: The theory, new (preregistered) studies, and three meta-analyses. Journal of Experimental Psychology: General, 150(7), e22–e47. https://doi.org/10.1037/xge0000993
Conee, Earl Brink, and Sider, Theodore. Riddles of Existence: A Guided Tour of Metaphysics. Regno Unito, Clarendon Press, 2014.
Burkeman, Oliver, The clockwork universe: is free will an illusion?, Guardian, 27 aprile 2021, https://www.theguardian.com/news/2021/apr/27/the-clockwork-universe-is-free-will-an-illusion
Hartmann, Nicolai, and Pinna, Simonluca. Possibilità ed effettività. Mimesis, Milano, 2018.
Hoefer, Carl, Causal Determinism, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2016 Edition), Edward N. Zalta (ed.), https://plato.stanford.edu/archives/spr2016/entries/determinism-causal/
Hossenfelder, Sabine, Palmer, Tim, How to Make Sense of Quantum Physics, Nautilus, issue 83, 12 marzo 2020 https://nautil.us/issue/83/intelligence/how-to-make-sense-of-quantum-physics
Hossenfelder, Sabine, Dieci errori concettuali in materia di libero arbitrio, Le Scienze, 4 gennaio 2014, https://www.lescienze.it/news/2014/01/04/news/libero_arbitrio_emergennza_propriet_leggi_natura-1950046/
Jankélévitch, Vladimir. La morte. Einaudi, Torino, 2009.
Schmidhuber, J. Don't forget randomness is still just a hypothesis. Nature 439, 392 (2006). https://doi.org/10.1038/439392d
Repellini, Ferruccio Franco (a cura di) (2016). L'argomento dominatore, traduzione di passi scelti.