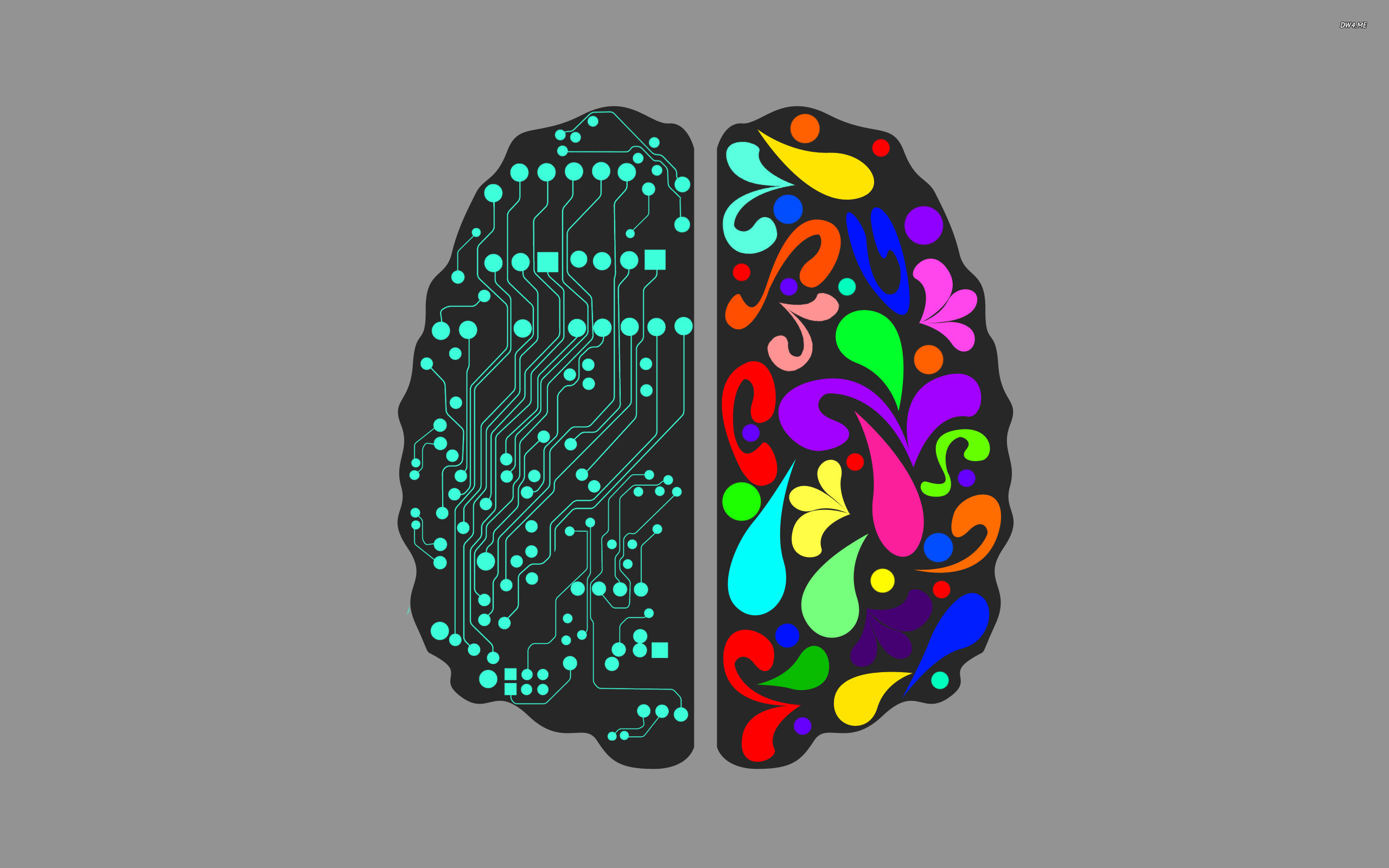-
La genesi della filosofia può essere rintracciata in un doppio movimento: da un lato essa si pone come discorso sulla verità, dall’altro tenta di escludere la doxa come suo succedaneo, un’ombra rispetto al sole della verità. La filosofia, come luogo dell’episteme, vorrebbe porsi come discorso sulla verità che si colloca (stenai) sopra (epi) le opinioni, la storia e la contingenza. Il concettuale sarebbe così l’elemento chiaro e distinto capace di purificare l’opacità e l’equivocità del discorso che lo articola, ponendo così ai margini il momento comunicativo e retorico in quanto prezzo da pagare per giungere alla verità: una scala da buttare giù una volta raggiunto il piano dell’ideale. Ecco che il momento retorico è così degradato a semplice mezzo, un’ombra di esteriorità, di contaminazione con ciò che è fattuale, ossia storico: un’ombra che il sole della verità promette di dileguare. La lotta tra filosofia e retorica si configura dunque come una lotta di legittimazione; si pensi allo scontro – non solo teorico ma anche politico – tra Platone e i sofisti, i quali, incapaci di mostrare la luce del sole del vero sapere, si accontentavano di offrirne la parvenza, l’artificialità, attraverso l’abilità retorica – cioè una tecnica che mira soltanto ad abbellire, per accennare ad altri due grandi esclusi dal discorso epistemico. Tale lotta di legittimazione non si gioca mai semplicemente sul piano teorico, ma coinvolge il modo in cui questa prende forma, viene articolata e strutturata. In altre parole, i rigidi confini che il discorso filosofico, come discorso sulla verità, si pone non sono mai semplicemente teorici, bensì sempre legati alla retorica che i filosofi, inconsapevolmente o meno, non possono fare a meno di usare, pur cercando di presentare il loro discorso come radicalmente separato da quest’ultima. Nicola Zambon
Su questo argomento scivoloso e pericoloso, tanto per la filosofia – impegnata a mantenere rigidi i confini tra sé e il proprio altro – quanto per il filosofo che se ne occupa – sempre a rischio di trovarsi dalla parte dei sofisti –, si situa il testo di Nicola Zambon, Persuasione ed evidenza. Sul rapporto tra retorica e fenomenologia in Husserl, Heidegger e Blumenberg (Inschibboleth, Roma 2024). Zambon, curatore di numerosi inediti di Blumenberg, muovendosi a partire da questi complessi nodi teorici, affronta il rapporto tra retorica e filosofia all’interno della tradizione fenomenologica in un’ottica non soltanto ricostruttiva ma anche pienamente, e fruttuosamente, teorica. L’ossessione della filosofia per l’evidenza e per la claritas del suo discorso non fa spazio qui alla semplice inversione del rapporto – rendendo, come accade in Nietzsche, filosofia e retorica omogenee –, bensì ad una proposta più articolata: «la filosofia deve aspirare ad essere più che mera retorica, non può derogare da questa pretesa senza tradire se stessa; al contempo, essa è sempre e inevitabilmente anche retorica» (p. 14). Questo rappresenta dunque il tentativo di ridare centralità alla retorica come, secondo un’espressione di Blumenberg, “tutto ciò che rimane al di qua dell’evidenza”. Zambon indica qui la necessità di concepire la filosofia come più accorta riguardo ai mezzi che usa: il retorico o, in altri termini, il metaforico, lungi dal rappresentare il fatale intorbidimento di un discorso, quello filosofico, che si pretende puro (ma che deve necessariamente scendere a patti con l’esteriorità della comunicazione), ne è un intimo alleato. Prova di questa alleanza sia la metaforologia di Blumenberg, che permette di leggere la filosofia come la lotta teorica intorno alle proprie metafore, che non sono quindi semplici abbellimenti del discorso, ma i luoghi delle svolte più profonde di un pensiero, gli archi di volta di un edificio concettuale. Questo movimento permette così di dare voce al metaforico all’interno del filosofico, affrontando l’utilizzo delle metafore con gli strumenti della filosofia e offrendo una critica filosofica alla retorica, di cui Zambon fornisce un esempio nella parte finale del testo, dedicata ad Heidegger e alla retorica dell’autenticità.
Il testo mostra come lo spazio per questa discussione si apra a partire dal fallimento husserliano di una logica pura, cioè l’impossibilità di un ritorno ad un «“fondamento originario” dell’intuizione sul quale ogni sistema simbolico deve poggiare» (p. 23). Proprio in questo tentativo potrebbe situarsi il “peccato originario” della fenomenologia di Husserl: la riduzione del momento retorico-comunicativo e, quindi, l’opposizione tra logica e retorica. La retorica risulterebbe così nuovamente esclusa come opacità, cioè come una perdita di evidenza che si pone dal lato dell’espressione, elementi da purificare per raggiungere la circolarità del significato nel monologo interiore dell’anima con sé stessa. Il fallimento di questa purificazione è ciò che concede il diritto di cittadinanza filosofica alla retorica. L’impossibilità che tutto poggi sull’intuizione è a sua volta l’impossibilità dell’univocità: se «il linguaggio adempie alla sua funzione comunicativa originaria» (p. 39), ciò implica l’impossibilità di escludere il fattuale e lo storico, e cioè che il solipsismo, che tanto occupò Husserl, è da sempre infestato dall’intersoggettività e dalla fattualità di una lingua che lo articola al di qua dell’evidenza.
Il superamento di questa problematica viene affrontato da Zambon nei capitoli successivi: prima in Heidegger e, poi, in Blumenberg. Questi due autori condividono infatti numerosi punti di contatto, sicuramente più di quanto il ritorno di Blumenberg ad Husserl in chiave «anti-heideggeriana» (p. 141) faccia pensare. In entrambi si ritrova la critica all’impostazione cartesiana e alle sue conseguenze rintracciabili nel solipsismo e nella distanza tra soggetto e oggetto. In particolare, per entrambi la questione è quella dell’epochè, «espressione dell’indifferenza del metodo husserliano verso questo mondo fattuale, la sua storia e le sue contingenze» (p. 106). In molti di questi aspetti forse Blumenberg è più vicino ad Heidegger di quanto spesso egli non voglia ammettere: se, come nota Zambon, «il dilemma cruciale dello sforzo husserliano» (p. 117) è per Blumenberg l’indessicalità e l’occasionalità del linguaggio – e le loro profonde radici pragmatiche –, ciò non può che fare eco al Da-sein heideggeriano, la cui scelta terminologica, lungi dall’essere mero artificio, rappresenta esattamente il gesto di porre la situatività all’interno della costituzione del soggetto. Anzi è proprio questo gesto ad aprirlo alla storicità della lingua e al suo fondamentale elemento retorico – come ricorda giustamente anche Zambon, la Retorica di Aristotele rimane per Heidegger un testo fondamentale nel distacco dal maestro Husserl.
Al fine di superare in maniera radicale la luce dell’evidenza fenomenologica, il discorso heideggeriano si rivolgerà ad una Phänomenologie des Unscheinbaren, cercando di ritrovare una vicinanza tra pensiero e poesia e trasformando entrambi i termini della relazione: la filosofia non è più il luogo della purezza dell’evidenza e la poesia non è più soltanto quello di un mero piacere estetico. Questa trasformazione, purtroppo, avrà numerose radici ma pochi frutti, lasciando spesso l’idea che la filosofia debba finire ad assumere i toni oracolari, e quasi sofistici, del filosofo che ha scoperto il potere della retorica, un sentiero interrotto, per quanto spesso copiato e ripetuto da numerosi studiosi che ne hanno subito il fascino e hanno cercato di copiarne lo stile – questione, quella dello stile in filosofia, che il libro di Zambon permetterebbe di pensare proprio per la vicinanza essenziale tra retorica e filosofia.
Se l’ultimo Heidegger sembra dunque rivolgersi verso sentieri che forse soltanto lui potrà percorrere, il ritorno di Blumenberg ad Husserl rappresenta una fedeltà ad Husserl necessariamente oltre Husserl, cioè un «approccio genuinamente descrittivo» (p. 138). Come mostra Zambon, ciò significa rettificare il metodo husserliano, allergico all’opacità della retorica, senza però spegnere la necessità epistemica nella radura heideggeriana. Voler salvare, pur rettificandolo, il metodo husserliano, accogliendo e superando i guadagni heideggeriani della fatticità del soggetto e dell’impossibilità di ridurre il linguaggio ad un’univocità ideale, significa tuttavia approfondire tale fatticità come «fatto biologico» (p. 135). In altre parole, significa radicare la possibilità del linguaggio come medium tanto dell’evidenza quanto dell’opacità nella storia evolutiva della nostra specie. Da questo punto di vista,il richiamo alla storia evolutiva, e quindi ad un dialogo con l’antropologia, è la sfida che Blumenberg (e Zambon) rivolgono tanto ad Husserl quanto ad Heidegger – entrambi avversi a quello che può essere troppo facilmente escludibile come una tentazione psicologista, nome di un altro grande escluso dalla filosofia come la retorica. Vale la pena però prendersi questo rischio in modo da non ridursi ad incontrare i fenomeni soltanto quando sono esangui, privi di quella vita che è la storia non di una coscienza trascendentale ma della storia di homo sapiens, il cui mondo si è aperto quando ha iniziato a maneggiare utensili – questione quella della tecnica, non lontana dagli interessi di Blumenberg – e a camminare in andatura eretta.
Questa svolta antropologica, esplorata nel lavoro postumo Beschreibung des Menschen, è una delle sfide principali poste da Blumenberg e Zambon. La mancanza di una traduzione italiana di questo testo non può che acuirsi a partire dalla pubblicazione del testo di Zambon, che mostra la necessità di riprendere il pensiero di Blumenberg, autore che in Italia è stato a lungo messo da parte e che invece, come mostra l’autore, è ben lungi dall’essere superato.
Pietro Prunotto
-
“Marxismo comune” ed economia
Longform / Novembre 20241. marxismo
Molti intellettuali non solo italiani – in particolare i filosofi - anche quando hanno preso direzioni di pensiero distanti dal marxismo, poi, quando devono valutare il mondo politico, sociale, economico… di oggi, spesso guardano a tutto ciò sempre con occhiali marxisti. Parlo di persone insospettabili - fenomenologi, storici dell’arte, filosofi della scienza, teologi. Costoro di solito guardano e giudicano le cose dell’oggi secondo categorie marxiste. In particolare, per l’intellettuale non-economista, soprattutto se lavora in campo umanistico, leggere il mondo economico in chiave marxista è parte della propria fisionomia di uomo o donna colta. E siccome da tempo non leggo la vita storica ed economica secondo griglie marxiste, mi chiedo spesso se io sia ancora un intellectuel. Userò il termine francese. Il marxismo è economia per umanisti non per economisti, e c’è da chiedersi perché.
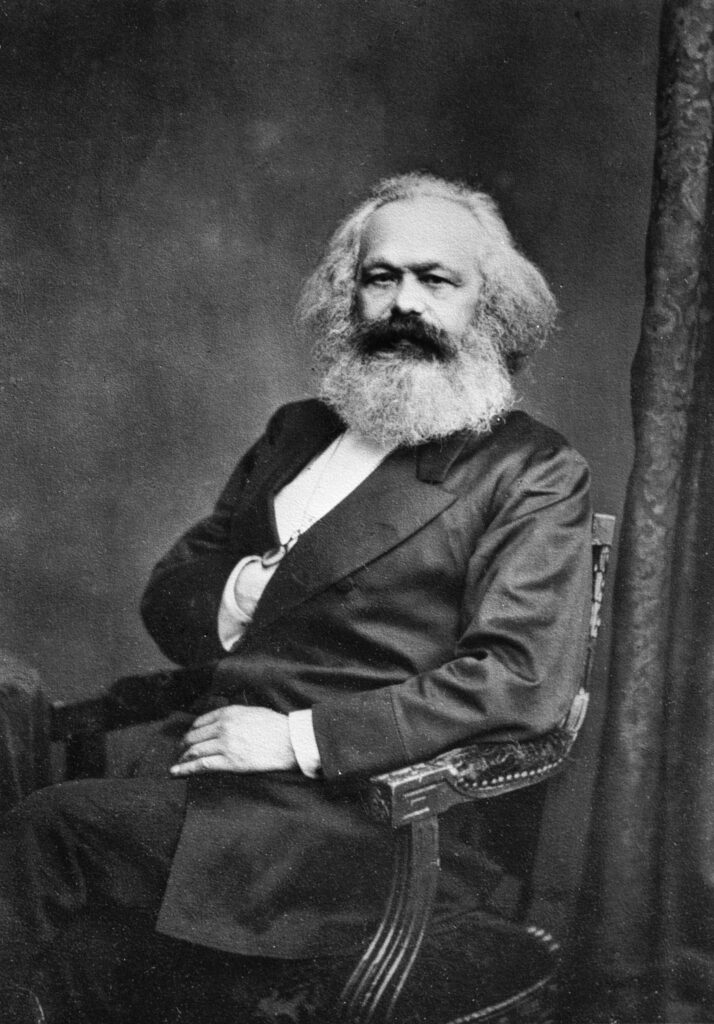
Karl Marx (Foto di Roger Viollet) Con “chiave marxista” mi riferisco a una certa reattività alle cose della società che riassumerei così:
In politica conta la lotta di emancipazione di tutti coloro che sono in una posizione subalterna o assoggettata ad altri.
Quasi tutti i mali sociali vengono oggi dall’assetto capitalistico delle nostre società.
L’intellettuale si batte al fianco di tutti i diseredati e il suo spirito è essenzialmente anarchico. La società del futuro dovrà essere una società anti-gerarchica, libertaria.
Questo è il sostanziale atto di fede dell’intellectuel di oggi.
Tutto ciò implica l’assunto che il marxismo, in particolare Il Capitale di Marx, sia la descrizione in sostanza definitiva della società moderna, anche odierna. I grandi problemi economici e geo-politici di oggi vengono interpretati sulla falsariga marxista del funzionamento del capitalismo. Talvolta, si ammette l’aggiunta rinfrescante del “borghese” Keynes, nella misura in cui preconizzava l’intervento dello stato nell’economia. Da un secolo e mezzo a questa parte, Marx sta a questi intellectuels così come la Bibbia sta agli Ebrei. Le idee di Marx non vengono mai messe in questione. Per esempio, la tesi secondo cui il lavoro è ad un tempo una merce e ciò che dà valore alle merci è stato ripreso tante e tante volte, anche in sistemi di pensiero che si rifanno a paradigmi diversi. Ma penso che il Grund marxista sia piuttosto una sabbia mobile.
Eppure oggi nemmeno gli economisti considerati più a sinistra – come A. Sen, J. Stiglitz, P. Krugman – applicano criteri marxisti alle loro analisi, ma si rifanno all’economia successiva a quella “classica”. Marx appartiene, con Smith Malthus e Ricardo, all’economia detta classica[1].
2.
Un filosofo teoretico molto prestigioso tiene una lezione sul terzo libro del Capitale di Marx. La svolge in chiave filosofica. E si sofferma sui punti in cui Marx afferma che la ricchezza finanziaria funziona secondo una logica interna (che diremmo speculativa) del tutto sciolta dal valore economico, il quale valore – disse Marx – è dato dal lavoro vivo. La prima alienazione capitalista - ce ne sono altre - è quella per cui il danaro produce danaro e perde quindi contatto con ciò che dà senso e valore al danaro, il lavoro.
Il filosofo teoretico dice di aver investito una somma in banca: ha versato 100 e dopo un anno se ne ritrova 120. “Come è possibile che i soldi siano aumentati? Hanno fatto all’amore?” I soldi producono soldi perché la rappresentazione si aliena da ciò che rappresenta e si riproduce da sé. E cosa avrebbe pensato se invece, dopo una stagione di orso azionario, si fosse ritrovato con soli 80 euro? Avrebbe pensato che la banca lo ha derubato?
Eppure ogni economista sa che la banca non ha operato alcuna magia, semplicemente ha investito in modo avveduto i 100 iniziali. Cerca di investire su attività che, sui tempi lunghi, si riveleranno produttive, ovvero, che producano ricchezza. Attraverso la banca, il professore ha finanziato attività fruttuose, anche se, ovviamente, tra l’investimento iniziale e il guadagno finale c’è tempo per attività speculative, ovvero per la possibilità di fare denaro a partire dal danaro. Ma le speculazioni prima o poi mostrano la corda, portano a crolli in borsa, fallimenti di banche… Le grandi crisi – come quelle del 1929 e del 2008 – nascono come crisi finanziarie (e non, come credono tanti, per sovrapproduzione industriale) quando cioè il mercato finanziario si scolla troppo dalle basi produttive.
In genere gli intellectuels detestano i commercianti. Costoro risultano più odiosi degli industriali. Il fatto che il panettiere si prenda 20 in più rispetto ai 100 da lui spesi per comprare il pane fresco dal forno viene visto come l’imposizione di una gabella, dato che il filone di pane è rimasto nel frattempo identico. Questo è effetto del pregiudizio che chiamerei produttivista: che il vero valore di una merce è quello del prodotto così come esce dalle mani del suo produttore diretto. Il resto sarebbe parassitismo. Eppure il panettiere all’angolo di strada svolge una funzione distributiva molto utile. Se ogni giorno io dovessi andare alle 6 di mattina dal fornaio per comprare il mio pezzo di pane, questo risulterebbe molto più costoso per me in termini di tempo e di soldi. Il panettiere non è un grassatore, svolge un servizio. Questo servizio va remunerato.
Ma la questione di fondo è: che cosa fa sì che qualcosa valga 100? Quel che conta nel valore matematizzato non è la cifra assoluta, ma la differenza numerica rispetto a tutti gli altri valori. In effetti, il problema di Marx e degli economisti che lo avevano preceduto era questo: che cosa determina il valore economico di una qualsiasi merce? La risposta di Marx fu la teoria del valore-lavoro. Ovvero, il vero valore di una merce è dato dal lavoro vivo in esso contenuto. Ma allora, se quel che dà valore è il lavoro, che cosa remunera l’imprenditore, il datore di lavoro? Risponde Marx: il plusvalore, ovvero la parte non pagata all’operaio. Per Marx non la proprietà, ma il profitto imprenditoriale, è un furto.
Cosa lo aveva portato a questa conclusione?
3.
La teoria del valore-lavoro era già stata formulata da David Ricardo. Era un ebreo arricchitosi come agente di cambio e che poi aveva vissuto da gentiluomo di campagna. Vide chiaramente che il valore economico è dato dallo scambio e non dall’uso, eppure avanzò la teoria secondo cui il valore di scambio dei beni è regolato dal lavoro in esso incorporato. Ricardo cita Adam Smith: “È naturale che ciò che è normalmente il prodotto di due giorni o di due ore di lavoro debba valere il doppio di ciò che è normalmente il prodotto del lavoro di un giorno o di un’ora”[2]. Questa idea oggi ci appare bizzarra. Se i lavoratori di una fabbrica ci mettono un giorno solo per produrre mille pantaloni alla moda mentre quelli di un’altra fabbrica mettono due giorni per produrre mille pantaloni ma non più alla moda – ammettendo identica la loro produttività - vedremo che i mille della prima fabbrica saranno molto più costosi di quelli della seconda. Evidentemente Ricardo non teneva conto di un fattore che per noi oggi è fondamentale: la variabilità della domanda, ovvero, in parole povere, delle mode.
Ricardo è l’inventore della terribile legge bronzea dei salari. Secondo lui il salario aveva la funzione di assicurare la sussistenza fisica del lavoratore e la sua riproduzione, senza aumenti né diminuzioni. Insomma, chi viveva del proprio lavoro sarebbe rimasto sempre povero e nulla, né uno stato compassionevole né un forte sindacato, avrebbe potuto modificare quel destino. Va detto che per “povertà” Ricardo intendeva non la semplice sussistenza biologica ma anche “le comodità divenute essenziali per abitudine” (un Ricardo di oggi vi inserirebbe anche il possesso di un computer, di un frigorifero, di una utilitaria…). Inoltre lo sviluppo dell’economia avrebbe potuto spingere verso l’alto il “prezzo naturale del lavoro” anche per periodi prolungati. Comunque, la conclusione più immediata era l’ineluttabilità della miseria di chi lavora in una società capitalista: la legge economica che ne è alla base non può essere cambiata. Miele per le orecchie di Herr Marx.
Quel che restava comunque inspiegato nel sistema ricardiano era il profitto industriale. Se il valore di un prodotto è dato dal costo del lavoro richiesto per produrlo nella condizione marginale (ovvero al minor costo possibile), allora da dove vien fuori la remunerazione del capitale, il profitto di chi ha investito? Ricardo risponde: viene sempre dal lavoro. Viene dal lavoro passato necessario per costruire gli stabilimenti e il macchinario (captale fisso) e per acquistare beni capitali (capitale circolante o d’esercizio). Il profitto sarebbe allora il pagamento posticipato di questo lavoro passato.
Se i profitti corrispondono alla remunerazione del lavoro impiegato in passato nella formazione del capitale, allora la conclusione ad alcuni apparve ovvia: l’investitore si appropria di una ricchezza che a rigore appartiene all’operaio. Il guadagno dell’imprenditore è del tutto ingiusto. Una conclusione del genere poteva essere evitata rigettando la teoria del valore-lavoro e la legge bronzea dei salari di Ricardo come inadeguata. Marx non la rigettò, la prese alla lettera: il profitto, che chiamò plusvalore, era la parte non pagata all’operaio.
Certamente Marx non divenne comunista leggendo Ricardo, piuttosto usò le teorie economiche di punta del proprio tempo per dare un fondamento “di testa” al proprio comunismo “di cuore”. Come per i teologi: prima viene la fede, poi viene la ragione che la giustifica. Chi è mai divenuto un credente a seguito di una impeccabile dimostrazione dell’esistenza di dio? Secondo me nessuno. La teoria – in questo caso economica – è una pezza d’appoggio intellettuale alla propria passione religiosa o politica. Marx ebbe il genio di stabilire un ponte tra fede comunista e la scienza economica dell’epoca sfruttando certe carenze interne al sistema esplicativo di Ricardo. marxismo
Joseph Schumpeter[3] sosterrà poi che la linea Ricardo-Marx nel pensiero economico è rimasta sempre, in fondo, un ramo secondario. La teoria del lavoro-valore e l’ingiustificabilità del profitto non è mai stata veramente presa sul serio dagli economisti successivi. Il valore è stato sempre visto come dipendente dal gioco della domanda e dell’offerta, non come espressione di un lavoro “trascendente”. Ma la teoria del lavoro-valore è stata sempre presa molto sul serio, per circa due secoli, dagli intellectuels.
4.
Allora, perché qualcuno come Marx ha creduto nella teoria del lavoro-valore a cui di fatto non ha mai creduto nessuno? Perché quella teoria gli faceva troppo comodo. Innanzitutto questa teoria permette di quantificare, e quindi di obiettivare, la denuncia di sfruttamento. In effetti, riconoscersi come sfruttato è atto più che mai soggettivo. A che punto comincia lo sfruttamento? Quando per un lavoro ricevo 200, o 150, o 100…? Anche se sono una star strapagata posso dire che sono sfruttato perché pagano troppo poco le mie esibizioni rispetto a qualche altra star. Grazie all’escamotage del plusvalore, credo allora di misurare lo sfruttamento con precisione: è il profitto dell’imprenditore. Punto. La lotta per avere salari più alti e condizioni di lavoro migliori diviene allora “scientifica”. Dalla mera compassione per l’operaio si passa a chiedere giustizia per lui su una base obiettiva.
Soprattutto, la teoria del valore-lavoro ci fa credere che quello che dovrebbe essere – che più lavori, più ha valore quello che produci – è nel fondo ciò che è. In effetti, tendiamo a trovare ingiusto che chi lavori tanto guadagni meno di chi lavora poco. Il fatto che per un’ora di lavoro una domestica prenda 12 euro mentre un luminare della medicina in un’ora ne guadagni 500 ci dà un senso d’ingiustizia. L’ingiustizia risulta da un nostro presupposto, che tutti siamo eguali, come afferma l’etica cristiana. Ma è fattualmente vero che siamo eguali?
Conoscevo un artista che non ebbe mai molto successo. Una volta mi indicò la sua ultima creazione, una scultura, dicendo “Ci ho lavorato per otto mesi giorno e notte… e poi nessuno la vuole comprare!” Lo diceva col tono di chi subiva un sopruso. Ma l’ingiustizia è inscritta nella vita stessa. Così ci suona terribilmente ingiusto che un bambino nasca deforme o malato, e che resti così per tutta la vita. Non l’ha meritato. In questo caso però non ce la possiamo prendere con l’assetto perverso dell’ordine sociale, ma piuttosto con la malvagità di dio o della natura.
La strategia tacita di Marx consiste nel dire che in fondo la realtà (l’essere) è giusta, che davvero il lavoro dà valore alle cose prodotte, ma è la società a distorcere la realtà. La società falsifica la natura. Il dover-essere (Sollen) viene celebrato come verità dell’essere (Sein). Sarebbe la società umana a introdurre un’ingiustizia che nella realtà non si dà. Discende dall’argomentazione di Rousseau, quando, per esempio, sosteneva contro Voltaire che il terremoto di Lisbona, in quanto naturale, non poteva essere “cattivo”. Erano le case costruite a Lisbona quelle cattive[4].
Ora, la teoria secondo la quale il Sein e il Sollen nel fondo coincidono - ciò che è vero è anche giusto, e l’ingiusto è sempre falso, un abuso - è profondamente consolatoria. È una forma di teologia laicizzata. Per il pensiero cristiano dio è sempre buono e giusto, anche se viviamo in un mondo strapieno di malvagità e di ingiustizia. Secoli di talento teologico sono stati spesi per dimostrare che il mondo creato da dio è pur sempre il migliore dei mondi possibili, ed è l’essere umano a introdurre il male nel mondo. Nel XIX° secolo al posto di dio si è messa natura (Natura sive Deus), per cui l’antropologia marxista ha voluto dimostrare che la realtà è buona e giusta, e che il male e l’ingiustizia sono prodotti della perversità umana.
Abbiamo visto questa visione emergere in occasione della recente pandemia di Coronavirus. Tanti filosofi hanno dato per certo che questa epidemia fosse del tutto diversa dalle altre del passato, perché era una epidemia scatenata dall’uomo. Ciò fa parte di un riflesso ereditato dal rousseauismo-marxismo: anche la mutazione di un virus, cosa vecchia come il mondo, deve essere messa sul conto della perversità della società industriale. Non si accetta la monotonia di natura, che se la ride della potenza umana e produce nuovi virus nocivi come faceva millenni fa. Anche se certo la grande mobilità umana ha accelerato e ampliato la circolazione dei virus. I virus circolano molto più velocemente in popolazioni di animali numerose e molto mobili. Il marxismo, per il quale il vero essere è sempre giusto e buono, si è insomma sostituito al cristianesimo nel dire che l’ingiustizia cosmica non esiste, e che noi umani, con un po’ di buona volontà, restituiremo alla realtà il suo onore. Come nella concezione cattolica, sono gli umani, col libero arbitrio, a introdurre il male nel mondo.
Eppure questa promozione immensa della volontà umana – l’essere umano può ripristinare la giustizia nel mondo – ha come condizione la denuncia dell’umanità come causa prima artefice del male. Da Rousseau fino a Žižek, questa è la storia del mondo post-cristiano. Che solo gli umani possono restituire al mondo quella giustizia che essi stessi gli hanno tolto. L’umanità sarà la salvatrice del mondo (anche naturale) proprio perché è stato lei a introdurre il Male nel mondo.

(Pixels) 5.
In che modo invece gli economisti, liberisti e anti-liberisti, vedono oggi il valore economico? Secondo me, già Aristotele aveva detto l’essenziale sullo scambio economico: in realtà di tutto si può fare scambio: esso trae la prima origine da un fatto naturale, che cioè gli uomini hanno di alcune cose più del necessario, di altre meno[5]. Si scambia sempre un eccedente con qualcosa che si desidera. Non importa perché si desideri questa o quell’altra cosa, l’importante è che si desideri qualcosa. Alla fonte dello scambio economico non c’è il lavoro, c’è il desiderio. In particolare, il desiderio di qualcosa che ci manca. È quel che genera la demand, domanda. (Questo non toglie che l’offerta, supply, possa creare nuove domande. Se invento il viagra, mettiamo, e lo offro sul mercato, il desiderio di erezione creerà un demand di viagra.)
Ovviamente, se voglio scambiare devo produrre questo eccedente – a meno che io non lo possieda già come patrimonio acquisito. La produzione di questo eccedente ha un costo per me, e quindi il prezzo finale del mio prodotto dovrà includere i costi di produzione, tra cui il costo del lavoro mio o di altri. Se sono io il lavoratore, il costo sarà il tempo e l’energia da me spesi per produrre quel prodotto. Ma molte cose hanno un valore economico che non dipende affatto dal lavoro impiegato per produrle.
Mettiamo il caso che io abbia ereditato un casale contadino costruito nel XV° secolo. Mi rendo conto oggi che quel casale si trova in un contesto che consideriamo “incantevole”, e quella regione è divenuta alla moda. Potrò affittare a prezzi altissimi quel casale a chi voglia fare turismo, e così diverrò benestante. Sfrutto il lavoro di coloro che costruirono quel casale sei secoli fa? Non ha senso. Rendo redditizio quel casale perché è molto desiderato oggi. Approfitto dell’altrui desiderio.
Avere danaro è avere quindi sempre un eccedente. Anche un poveraccio che possegga solo dieci euro, ha un eccedente di dieci euro. Per una ragione semplice: che quei dieci euro non può usarli direttamente come oggetto per soddisfarsi, gli servono solo per lo scambio. Certo, potrebbe sempre usare quella banconota come fazzoletto di carta, mettiamo. Ma negli ultimi tempi il danaro si è del tutto smaterializzato, e un numerino sul computer non posso usarlo affatto, nemmeno soffiarmici il naso.
È stupefacente: solo oggi, grazie alla completa smaterializzazione del danaro, abbiamo finalmente compreso – anche intellettualmente e non solo praticamente – che il danaro sin dai primordi è stato sempre e solo questo: numeri. Eppure l’invenzione di una moneta di scambio è precocissima, si è passati ben presto dal baratto all’uso di monete, fossero queste conchiglie, penne, ecc. La moneta è sempre la rappresentazione di una ragione di scambio[6].
Immaginiamo un mercato primitivo in cui due patate si scambiano con quattro mele o con dieci pesche. Abbiamo già una precisa ragione di scambio. Ovvero, se diamo a una patata il valore arbitrario di 10 - mettiamo: conchiglie - possiamo dire che in questo mercato:
1 patata = 10 conchiglie; 1 mela = 5 conchiglie; 1 pesca = 2 conchiglie
Possiamo materializzare questi numeri anche con banconote, ma il loro senso resta sempre lo stesso: sono equazioni. Per cui, se metto a, b e c al posto rispettivo di patate, mele e pesche, avremo:
a = 2 b = 5 c oppure c = b / 2 = a / 5
Banali equazioni.
Alla base dello scambio c’è il desiderio per ciò di cui manco. Se ho due patate in più che non mangerò mai e sono privo di pesche che invece desidero gustare, so che devo dar via una mia patata eccedente per avere cinque pesche. Tutte le complessità dei mercati internazionali di oggi sono una enorme complicazione di questa logica semplicissima che è alla base di ogni economia.
Marx considerava il danaro una merce imperitura perché credeva nell’essenza religiosa dell’economia. Il danaro, come la divinità, è imperitura. E come ogni divinità va denunciata come alienazione (Feuerbach), così il danaro va denunciato come astrazione sempre incompiuta. Per Marx il concreto è vero, l’astratto è falso. Ma questo carattere imperituro del danaro non viene da un assunto quasi-religioso nel suo uso, viene dal fatto che il danaro è sempre stato, sin dagli albori, matematica. E i numeri, pur senza essere divini, sono imperituri. Scambiando, gli esseri umani matematizzano i loro rapporti senza volerlo. Insomma, credere che la realtà sia concretezza e l’astrazione, i numeri, siano fede è una fede sbagliata. La matematizzazione crescente della natura a opera della scienza mostra che ciò che c’è di più concreto, la natura, è sempre matematizzabile – perché la scienza nella natura cerca sempre relazioni. Le equazioni sono la verità profonda delle cose. E i prezzi delle merci non sono altro che equazioni.
6.
L’umanità ci ha messo millenni per capire questa cosa così semplice, che la moneta rappresenta delle ragioni di scambio. L’essere umano sa tante cose inconsciamente, ma ci mette secoli per pensarle. Così, per secoli, si tendevano a usare buone monete, ovvero oggetti che avessero di per sé un valore d’uso. La logica del baratto si è prolungata nella ricerca della buona moneta. Da qui il mito dell’oro, pregiudizio giunto grazie a Keynes fino al 1971, anno del crollo del sistema di Bretton Woods, che si basava ancora sull’oro. Ma perché l’oro è visto come prezioso? Perché l’oro era molto desiderato, quindi appariva prezioso di per sé. Era usato come moneta anche perché agevole, non si degrada facilmente - ma oggi ci rendiamo conto che delle cifre in un programma di computer sono meno degradabili dell’oro. Da qui l’illusione del Gold Rush, che ci si arricchisse ammassando oro. Il fatto che gli esseri umani abbiano fatto ben presto abile uso di monete, non implica affatto che le abbiano intellettualmente capite. Dopo tutto, funzione della filosofia è capire finalmente ciò che già sappiamo.
Sulle banconote della lira era scritto “Pagabili a vista al portatore”. Il pagante era la Banca d’Italia. Ma pagabile con che? All’epoca erano considerate vere monete l’oro e il dollaro. Ma non esiste vera moneta materiale. Abbiamo visto che per Marx il valore è il lavoro accumulato, invece il vero valore è lo scambio stesso. Un paese ricco è un paese che scambia molto, un paese povero è un paese che scambia poco. E lo scambio a sua volta trae il suo valore dal desiderio d’altro. Si scambia con l’altro per desiderio d’altro.
Sappiamo che da un paio di secoli l’economia mondiale si espande, in quasi tutto il mondo. Prima non era così. L’espansione economica si basa sul modo espansivo del desiderio, ovvero, si è sempre insoddisfatti, vogliamo sempre di più, more… Il capitalismo è il blob del desiderio. Certo pensiero post-moderno ama pensare che alla base della moneta come oggetto di scambio non ci sia nulla, che il danaro sia copie senza alcun originale, sembiante di sembiante. Non ci sarebbe nulla alla base del danaro. Ma non è vero: alla base c’è lo scambio. Certo lo scambio non è una cosa ma un processo. Questo processo, visto da lontano, sembra una cosa. In un certo senso, lo scambio si vede, si illustra nella ricchezza appariscente di un paese, grattacieli, autostrade trafficate, ristoranti pieni…
Dunque il danaro, qualcosa di connesso all’intera economia di un paese, rappresenta, dettaglia, la potenza di scambio di questo paese. Dico bene la potenza di scambio, non la ricchezza. Se c’è un clan che vive in perfetta autarchia, produce tutto quello di cui i suoi membri hanno bisogno o desiderano senza dover scambiare nulla con l’esterno, potrà essere un clan felice ma economicamente irrilevante: nella misura in cui non scambia, non è un’entità economica[7].
In fondo, il socialismo è il sogno di essere questo clan: chiudere la società in modo che essa produca solo oggetti d’uso, mai nessun eccedente da scambiare. Ma non appena qualcuno nel clan socialista desidera qualcosa che nel clan non c’è… cominciano i guai. In particolare, il mercato nero. Il socialismo vorrebbe sopprimere quel desiderio d’altro che per alcuni (basti pensare a Lacan) è essenziale all’essere umano. Il comunismo crollò in URSS proprio per questo: i sovietici cominciarono a desiderare ardentemente qualcosa che si trovava solo in Occidente. Ma l’URSS non aveva granché da scambiare con l’Occidente. Anche oggi, del resto, la Russia non ha molto di più da scambiare del suo petrolio.
Se ho in tasca 100 euro, questa banconota rappresenta – nel senso che sta al posto di – una certa frazione dei beni di scambio, non di consumo, prodotti all’interno dei paesi dell’eurozona. È ingenuo pensare che il danaro sia qualcosa di puramente simbolico, un’astrazione: come tutti sappiamo, è qualcosa di ben reale. Atrocemente reale per chi non ce l’ha! Andate a dire a un poveraccio che il danaro si basa su una fede religiosa, come pensava Walter Benjamin! Preferirà derubarvi del portafoglio.
Insomma, il capitalismo non ha nulla della fede religiosa[8]. La ferrea realtà del danaro è dovuta al fatto che è il corrispettivo di una potenza, quella di poter scambiare. Certo questa corrispondenza è incerta, varia giorno per giorno, nessuno sa precisamente quanta parte della potenza di scambio dell’eurozona rappresenta quella banconota euro che ho in tasca… da qui le continue fluttuazioni del cambio, i giochi speculativi. Posso aver rubato quella banconota, eppure sappiamo che è ben reale perché tutti desiderano quei 100 euro. Il danaro è l’unico bene che tutti desiderano in quanto è il bene che tutti devono usare per soddisfare le loro domande, e si domanda qualcosa perché la si desidera. Che c’è di più concreto di questo?
Quindi, quando dico che il danaro rappresenta, intendo qualcosa che è al posto di, ma che proprio per questo ha il potere di ciò che rappresenta. È come quando un re inviava un suo rappresentante a un negoziato: quel che decideva il plenipotenziario del re era come se fosse deciso dal re stesso. Il danaro non è un sembiante della potenza di scambio, è un rappresentante della potenza che ha esso stesso potere di scambio.
Potremmo andare oltre, e dire che ogni società è una rete di scambi. Per Claude Lévi-Strauss, ogni società è scambio di parole, di doni e di donne. E possiamo inserirvi anche lo scambio economico di beni. La società non è un “qualcosa” ma un insieme di processi, tra cui ci sono i processi economici, ovvero produrre per scambiare. Marx lamentava il fatto che nel capitalismo tutto diventi scambio, anche la vita coniugale. Ma è sempre stato così. Per lo più i marxisti quando parlano di “società capitalista” in realtà stanno parlando della società tout court, di tratti che il capitalismo non ha fatto che rendere evidenti ed esaltare. Una famiglia può essere basata sull’amore, ma essa implica sempre delle regole implicite di scambio. Nella famiglia tradizionale lo scambio era: “io uomo porto i mezzi per vivere, e tu donna ti occupi della casa e dei marmocchi”. Nella famiglia moderna, basata sull’eguaglianza dei sessi, il patto di scambio non è più così preciso e chiaro, ragion per cui essa è tanto fragile.

(Pixels) 7.
Perché allora l’intellectuel è rimasto fedele all’idea del valore-lavoro (e con questa: del plusvalore, dello sfruttamento, dell’ingiustizia sociale) anche se l’evidenza ci dice il contrario? Credo che alla base ci siano dei presupposti metafisici molto forti a cui l’intellectuel non rinuncia.
Anche se l’idea che il desiderio è l’essenza dell’umano risale a Spinoza, una certa austerità filosofica ha avuto sempre una certa diffidenza nei confronti del desiderio. Vi ha sempre visto la fonte del capriccio, una sorta di patrizia scioperatezza. Meglio parlare di bisogni, di qualcosa di molto più pesante, necessario e quindi sacrosanto. E l’economia ci appare come qualcosa di estremamente solido, pesante, serio – “the dismal science”, la scienza lugubre[9]. Da qui l’idea che il valore economico e la ricchezza siano dovuti a qualcosa di pesante e serio come è il lavoro umano, che fa sudare, annoia, infligge lombaggini. Per Marx la sostanza (substantia) è questo sudore della fronte. Da qui l’idea per cui il vero valore economico, la sua sostanza, ciò che sta sotto ai prezzi, sia proprio questa fatica che produce oggetti in grado di soddisfare bisogni elementari: cibo e oggetti d’uso. L’operaio e il contadino producono valore - qui morale ed economia si fondono - ma non l’artista, la prostituta o il filosofo. E questo a dispetto del fatto che i servizi dell’artista, della prostituta o del filosofo possono essere molto ben remunerati.
Il filosofo marxista tende a sentirsi, in quanto intellettuale, una sorta di saprofita, e sviluppa quindi una filosofia la quale esalta quel lavoro che lei o lui non fa, dato che per questo filosofo lavorare è zappare la terra o avvitare bulloni. La critica all’economia capitalista è sempre, sottilmente, un’auto-critica del marxista come bourgeois. Il quale può riscattarsi solo diventando “intellettuale organico al proletariato” nel senso di Gramsci. Invece, per l’economia di oggi non c’è differenza sostanziale di valore economico tra il mettere bulloni o tenere lezioni di filosofia. Il fatto che un avvitatore di bulloni rimanga povero mentre un filosofo marxista possa scrivere bestseller e diventare una persona più che agiata non sia un’ingiustizia sociale, è cosa difficile da capire per un intellectuel. Perché una lezione di filosofia può valere economicamente di più di una serie di chiavarde? Perché in certi casi una lezione di filosofia può essere desiderata – e far godere – più di una serie di chiavarde.
In un certo senso, partendo dalla premessa meta-economica secondo cui il faticoso lavoro umano dà valore ai prodotti, il marxista pensa così di riparare a un’ingiustizia cosmica del mondo, al fatto insomma che la natura – e quindi la vita sociale umana – non è affatto eticamente corretta. Anche se questa scorrettezza è introdotta nella natura da una parte traviata di essa: dalla specie umana.
Il pregiudizio fondamentale di gran parte dell’economia classica consisteva nel credere che il valore economico poggiasse sulla produzione o scambio di oggetti che soddisfano bisogni essenziali – mangiare, bere, ripararsi dalle intemperie… Ma siccome, come Aristotele aveva già visto, l’economia comincia quando si scambia ciò che si ha in più – ovvero, quando l’uso dei beni si socializza - possiamo dire che l’economia comincia invece proprio dopo che si sono soddisfatti i bisogni elementari. L’economia comincia con il “di più”. L’idea di Ricardo secondo cui il salario paga solo la sussistenza e la riproduzione del lavoratore è vaga, perché la sussistenza include sempre il bisogno… d’altro. Oggi avere un computer connesso a internet è una prima necessità. Al contrario, gli antichi filosofi cinici hanno dimostrato che per sussistere basta solo una ciotola. Tutto è superfluo, tutto è necessario. Per alcuni una lezione di filosofia può essere indispensabile quanto una ciotola.
Una carriera filosofica è una impresa economica come tutte le altre, se la si vede dal punto di vista appunto economico. Per divenire un professore di filosofia ben pagato occorre un lungo e costoso investimento: anni di studi, comprare libri, fare concorsi, fastidiose trasferte… Costi in termini di danaro, tempo ed energia psichica. Chi intraprende una carriera filosofica spera di recuperare le spese e poter guadagnare, non diversamente da uno che intraprenda una carriera di allevatore. La conditio sine qua non è che ci siano abbastanza persone che desiderino ascoltare filosofia o abbastanza persone che desiderino mangiare carne bovina.
L’economia classica ha dato per scontato questo primato dei beni elementari, pur essendo già noto all’epoca che motore dell’economia spesso erano i beni di lusso. Nel XV° secolo le prime grandi esplorazioni verso l’Asia, la circumnavigazione dell’Africa, ecc., erano spinte dal commercio di spezie, che erano per loro delle droghe. Le spezie erano quel dell’altro che, proprio perché raro, era fortemente desiderato. Ma per i primi economisti era imbarazzante ammettere che alla base del benessere ci fossero le spezie! I physiocrates trovarono più decente mettervi alla base i beni agricoli.
Alla base del presupposto che il valore vero sia connesso alla soddisfazione di bisogni primari c’è indubbiamente una gerarchia morale: ovvero, che la povertà è la verità dell’essere umano. Il cristianesimo, prima del marxismo, aveva santificato la povertà. I bisogni del povero, insomma, sarebbero quelli buoni. Il resto, il desiderio del superfluo, è vizio. (Eppure nemmeno la povertà dispensa da un di più. La base sono il pane e il vino: il pane ci fa sopravvivere, il vino è una droga che ci dà solo piacere.) E questo in contrasto col fatto che la filosofia sia stata esaltata come eros in senso platonico, come desiderio di andare sempre oltre. Ma si immagina che il filosofo sia fuori del circuito economico, anche se anche lui vive di quello. Socrate, al contrario dei sofisti, non si faceva pagare. Oggi quasi tutti i filosofi, pagati per lo più dallo stato o da privati, sono quindi sofisti. Comunque, l’ideale filosofico resta proprio quello socratico: puro otium, ricerca disinteressata e signorile della verità.
All’inverso, il mondo dell’economia, immaginato come mondo della soddisfazione dei bisogni primari, è visto come anti-filosofico. Il filosofo è sdegnato all’idea che il proprio lavoro possa essere valore di scambio. Preferisce immaginare che uno stato mecenatico lo paghi per dedicarsi alla meditazione, come il Pritaneo che Socrate reclamava per sé. Ma non è affatto così. Se nessun giovane si iscrivesse più a filosofia, lo stato cancellerebbe le facoltà di filosofia. E se tutti diventassero vegetariani – cosa oggi non inverosimile – non esisterebbero nemmeno più allevatori. Sia la carne commestibile che la filosofia hanno bisogno di domanda, di desiderio.
Lo scambio mercantile si basa sul desiderio di ‘altro’, e implica sempre una certa penuria: se non mancassi di qualcosa, non scambierei. Ma d’altro canto devo ingegnarmi per disporre di quell’eccedente che mi consente, scambiandolo, di tappare la mia mancanza. Come si vede, abbiamo qui la definizione platonica di eros, desiderio: figlio di penuria (penia) e capacità di sbrogliarsela (poros). Questo perché anche lo scambio mercantile è un prodotto del desiderio umano, a sua volta espressione dell’impulso che anima ogni vivente.
8.
L’idea che il lavoro sia la fonte del valore economico non è però solo il corollario di un materialismo metafisico, che vede alla base del valore qualcosa di materiale. Questa idea rinvia a un’esigenza sempre molto importante nel mondo moderno, ripresa dalla fenomenologia: l’esigenza di un Lebenswelt, di mondo-della-vita, di ciò che dà valore ai valori. È l’idea che capire fino in fondo le cose sia giungere a un livello pre-categoriale, a qualcosa di originario nella storia della costituzione del nostro sapere. E questo pre-categoriale, questa fonte da cui provengono le strutture più o meno complesse della vita sociale, ha a che fare con la vita stessa come sorgente dei valori.
Il mondo in cui viviamo – per il marxismo la società divisa in classi, per la fenomenologia credenze e saperi attraverso cui leggiamo il mondo – è alienato, perché non si ricorda di ciò che ha dato origine a questo mondo, non ringrazia l’origine. E ciò che ha dato origine è il lavoro vivo. Il marxismo si vuole un pensiero critico che al di là delle ideologie coglierebbe la verità della realtà sociale come conflitto tra classi. Fa appello a una natura pre-culturale, a una dimensione autentica del vivere e del pensare prima di ogni alienazione culturale.
Insomma, il marxismo crede nella differenza fondamentale tra natura e cultura, al ritorno a uno stato naturale, pre-categoriale, del pensiero e della vita. Da rousseauiani, i marxisti credono che ci sia stato un comunismo primitivo, ovvero uno stato autentico, naturale, vero del vivere sociale a cui dovremmo in qualche modo tornare. Sfruttamento dell’altro e sperequazioni non vengono da una dimensione originalmente malvagia, hobbesiana, degli esseri umani; invece si presuppone che gli umani siano originariamente cooperativi, buoni, insomma comunisti. Il capitalismo è ad un tempo violenza e menzogna, ragion per cui ristabilire la verità rivoluzionaria è ipso facto superare la violenza. Il comunismo, in cima alla storia, restaura una socialità primitiva e quindi vera.
In altre parole, il comunismo – che sarebbe sia all’inizio che alla fine della storia – sarebbe non solo un modo di vivere ottimale per gli umani, ma anche la verità della comunità umana.
9.
Come si vede, l’intellectuel dà per scontata la divisione antropologica, che è anche divisione morale, tra natura e cultura, dove la cultura è alienazione. Il fine politico ultimo sarà di tornare a una cultura naturale. Questa alienazione per Marx è prima di tutto religiosa, in quanto l’essere umano attribuisce a divinità, cioè a feticci, quella potenza generativa che è degli umani stessi. Per il marxismo, il paradigma stesso dell’alienazione è religioso, ma a sua volta il marxismo si pone come riscatto di tipo religioso.
Questa alienazione religiosa deriva in alienazione economica quando il valore di scambio prevale sul valore d’uso. Quando il danaro, potremmo dire, prevale sull’amore. Il capitalismo sarebbe una religione in cui il danaro prende il posto di dio. L’amore è ciò che ci porta a dar da mangiare agli affamati, a consolare gli afflitti, vestire gli ignudi, prenderci cura degli ammalati… Mentre una società mercantile è vendere cibo agli affamati e vestiti agli ignudi, farsi pagare dallo stato per curare gli ammalati, mettere una tariffa psicoterapica per consolare gli afflitti… Il comunismo, dove ciascuno avrà secondo i propri bisogni, è lo stato in cui la misericordia non sarà più l’eccezione ma la regola. La filantropia è lo stato natural-sociale degli umani, lo scambio di beni è lo stato cultural-sociale degli umani.
L’intellectuel è convinto nel fondo che le società siano l’effetto di un cataclisma storico. Il cataclisma è l’appropriazione privata dei mezzi di produzione, analogon dell’alienazione prima religiosa e poi ideologica. Il marxismo vede il mondo storico come Aristotele vedeva il mondo fisico: effetto di una violenza originaria che ha spostato tutto, dove le cose non sono più dove dovrebbero stare. Il mondo sociale per Marx, come il mondo fisico per Aristotele, sono il prodotto di un disordine inaugurale, per cui ci siamo allontanati da quella fonte che è allo stesso tempo origine e verità del sociale.
Il ricorso a una conseguenza logica della teoria ricardiana fu quindi l’occasione, per Marx, per far accettare la sua metafisica antropologica nel salotto buono, scientifico, illuminista in cui vivevano gli economisti, tutti britannici. Il salotto buono voleva non tanto indignazione etico-politica, voleva teorie sci-en-ti-fi-che cioè inglesi, come il darwinismo o come la teoria dell’elettromagnetismo di Maxwell, scienze britanniche. L’economia marxista è stato l’atto grazie a cui il comunismo è stato ammesso nel club esclusivo delle sciences dell’epoca. Ma gli intellectuels di oggi non si sono accorti che da un bel po’ il marxismo è stato espulso dal Rotary della scientificità.
La visione storica marxista, non meno di quella biblica, narra in effetti una storia morale: è spiegazione e denuncia allo stesso tempo, spiega il sistema economico capitalista con un’ingiustizia (l’appropriazione indebita del plusvalore) e denuncia l’ingiustizia (le vistose diseguaglianze tra gli umani) con una spiegazione socio-economica. L’assetto del mondo è denunciato come carenza morale, la carenza morale è spiegata attraverso l’assetto del mondo.
Insomma, Marx non ha la sfrontatezza di dire “I proletari vogliono di più!”, deve dire “I proletari vogliono di più perché è il loro dovuto”. Le rivendicazioni operaie – salari più alti, migliori condizioni di lavoro, orari di lavoro più corti, ecc. – devono rientrare nel discorso legittimante della giustizia, non in quello sfacciato del “vogliamo di più!” E siccome nessuno sa bene che cosa sia giustizia, allora si costruisce una teoria economica “scientifica” del valore che pretende di quantificare esattamente l’ingiustizia perpetrata.
E se times are out of joint, “i tempi sono fuori dai gangheri” – come diceva Amleto – allora l’intellectuel si propone, anche se obliquamente, come leader di un mondo raddrizzato. Si offre come colui che rimetterà a posto questo mondo devastato dal diluvio del valore di scambio. Riemerge qui la passione platonica di riformare la società secondo princìpi di cui solo il filosofo è il tutore. Il sogno del filosofo-re deriverà poi nel mito del Partito Comunista, del partito-filosofo che dall’alto della piazza Rossa ristabilisce l’ordine morale del mondo – è la svolta leninista e gramsciana. Un ordine che non si basi più sul traffico cieco dei desideri, ma sulla legittimità biologica del bisogno. Eppure il Partito Comunista, questo principe (Gramsci lo paragonò al principe di Machiavelli), alla fine si risolve in stalinismo, ovvero nel regno di burocrati paranoici. La filosofia, quando pretende di applicarsi direttamente alle cose del mondo, tende a risolversi in burocrazia, che è l’automazione dei concetti. Il principe non è più chi sta sul trono con una corona, è un funzionario dietro un tavolo.
Sergio Benvenuto
[1] Tra le eccezioni c’è l’opera di un economista, Piero Sraffa, celebre soprattutto per l’influsso da lui esercitato su Ludwig Wittgenstein. Il suo Produzione di merci a mezzo di merci (1960) è uno dei rari testi che riprenda il sistema teorico di Ricardo, alla base del sistema di Marx. Ma si tratta di un unicum che non ha avuto mai veramente seguito tra gli economisti.
[2] A. Smith, La ricchezza delle nazioni, UTET, Torino 1975, p. 132.
[3] J. A. Schumpeter, Capitalismo, socialismo e democrazia, Etas Kompass, Milano 1967.
[4] A. Tagliapietra, a cura di, Sulla catastrofe. L'Illuminismo e la filosofia del disastro. Trad. di Silvia Manzoni e Elisa Tetamo, con un saggio di Paola Giacomoni. Bruno Mondadori, 2004.
[5] Aristotele, Politica, Libro 1, A, 9, 1257a.
[6] Gli economisti chiamano commodity money (moneta merce) un oggetto che abbia anche un valore d’uso, e moneta a valore legale la moneta convenzionale (carta, metallo vile) emessa dalle Banche centrali di paesi che battono moneta.
[7] Era questo in parte il caso del Giappone prima che fosse costretto nel 1854, sotto minaccia delle cannoniere americane, ad aprirsi ai commerci internazionali. I visitatori del Giappone all’epoca erano impressionati dal diffuso benessere dei giapponesi, isolati completamente nel loro arcipelago dal mondo esterno. L’obbligo ad aprirsi dice tutto della moderna società aperta: il capitalismo si basa su un’illimitata apertura.
[8] Cfr. W. Benjamin, “Il capitalismo come religione”, 1921, https://www.marxists.org/italiano/benjamin/capitalismo-religione.htm. Ho criticato l’impostazione benjaminiana, e la sua ripresa oggi da parte di molti, in: S. Benvenuto, "Il capitalismo e i cani. Danaro e desiderio", aut aut, 391, settembre 2021, pp. 161-182. https://www.sergiobenvenuto.it/communitas/articolo.php?ID=185. Il teatro di Oklahoma, Castelvecchi, 2022.
[9] Così chiamata da Thomas Carlyle nel saggio del 1849 "Occasional Discourse on the Negro Question".
-
Strani strumenti
Recensioni / Maggio 2024Strani strumenti. L'arte e la natura umana è un libro che tratta di arte, scritto da un filosofo. Eppure, non è un libro di filosofia dell’arte, o quantomeno non negli intenti del suo autore. Secondo Noë, l’arte non è un fenomeno da analizzare, come può esserlo invece un rito d’iniziazione, o la riproduzione cellulare. Di cosa si tratta allora? La tesi principale di Noë è che l’arte, proprio come la filosofia, sia piuttosto una pratica di ricerca. Gli oggetti artistici, in quest’ottica, non valgono propriamente come oggetti, ma come strumenti—strumenti dotati di una natura peculiare—attraverso cui è possibile fare luce sulla natura umana, tanto da chi li produce, quanto da chi ne fruisce.
Pubblicato nel 2015 da Hill & Wang, e tradotto da Vincenzo Santarcangelo per Einaudi nel 2022, Strani strumenti propone una riflessione sui rapporti—solo in apparenza superficiali—tra arte e filosofia. Noë intende infatti queste due discipline come specie diverse di un genere comune: pratiche di ricerca «assillate dalla volontà di comprendere in che modo gli esseri umani sono organizzati e quali possibilità di riorganizzazione possiedono» (p. ix). L’analisi delle relazioni che intercorrono tra organizzazione e pratiche riorganizzative costituisce il cuore teorico della proposta di Noë. Cerchiamo di ricostruirne brevemente le dinamiche.
Innanzitutto, Noë osserva che il tratto fondamentale della vita umana e delle attività in cui essa si dispiega è l’organizzazione. «Parlare, camminare, mangiare, percepire, guidare: siamo costantemente catturati in strutture organizzative. È la nostra condizione naturale, anzi biologica. È ciò che ci rende esseri umani» (p. 13). Siamo dunque organizzati per natura—ed è questo un punto su cui sarebbe difficile non convenire. Il vero nocciolo della questione è piuttosto cercare di comprendere l’estensione del concetto di natura, e il suo rapporto con la sfera della cultura. Rispetto a questo tema, Noë sposa la tesi—sostenuta, nella sua veste più contemporanea, da Andy Clark e David Chalmers—della mente estesa. In breve, noi non siamo il nostro cervello: «Le nostre menti sgorgano dalle nostre teste e vanno a finire sulla carta, nel mondo» (p. 34). Da una parte, il livello cognitivo dipende costitutivamente dall’ambiente (naturale e sociale) in cui siamo inseriti, dall’altra, le nostre pratiche tecnologiche—ad esempio, scrivere, o disegnare su un pezzo di carta—sono parte integrante del livello cognitivo. Con le parole di Noë: «Il fatto è che noi non ci limitiamo a usare strumenti; noi pensiamo con essi» (p. 27).
L’attenzione di Strani strumenti si dirige soprattutto su quest’ultimo punto. Noë sostiene che gli esseri umani sono designer per natura. Le pratiche tecnologiche, come la scrittura, la produzione di immagini o di artefatti dotati di funzioni specifiche, sono fenomeno naturali che organizzano la vita umana: «Le persone usano gli strumenti in modo naturale, come fossero api che costruiscono alveari o uccelli che nidificano» (p. 25). Non vi è dunque soluzione di continuità tra natura e cultura, tra organizzazione biologica e organizzazione tecnologica. Gli strumenti tecnologici non sono che «l’armamentario grazie al quale svolgiamo le nostre attività organizzate» (p. 24), e dunque grazie al quale gli esseri umani esprimono le loro potenzialità.
Tuttavia, le nostre attività organizzate non sono di per loro autoriflessive, o autocritiche. In un certo senso, tali attività semplicemente si dispiegano. L’arte (come la filosofia) fa invece di più, poiché, secondo Noë, è una pratica di ricerca che si sostanzia di tali attività, che riflette sulla loro organizzazione e che così facendo è in grado di riorganizzarle, e dunque di riorganizzarci. Noë propone di individuare «due livelli: il livello 1 è quello dell’attività organizzata o della tecnologia; il livello 2 è quello in cui questa organizzazione di più basso livello è esposta e indagata» (p. 36). Al livello 2 troviamo così le diverse arti (pittura, musica, letteratura, ecc.) e la filosofia. La coreografia, per riprendere uno degli esempi più ricorrenti del libro, è una pratica che mette a tema l’attività della danza e ne riscrive le regole, la riorganizza. La pittura fa lo stesso con la produzione di immagini, mentre la filosofia con le idee, i concetti e le credenze.
La separazione tra il primo e il secondo livello non è netta. Vi è infatti una costante retroazione delle pratiche riorganizzative sulle attività organizzate. La coreografia riorganizza l’attività del ballo, e così facendo questa attività non sarà più la stessa di prima: «In un mondo in cui il ballo è stato già rappresentato, non sarà più possibile ballare prescindendo dall’immagine di tale attività» (p. 36). La danza ri-organizzata costituirà così il materiale per le coreografie a venire. La sfera delle attività di livello 1 e la sfera delle pratiche di livello 2 risultano dunque separabili solo analiticamente; di fatto, secondo Noë, sarebbe fuorviante pretendere di pensare a un modo di ballare che prescinde dalla rappresentazione del ballo (coreografia), e altrettanto impossibile sarebbe tornare a un vedere o a un modo di produrre immagini che precede la pittura.
Come si può allora distinguere tra il ballo per così dire spontaneo, irriflesso, e una rappresentazione coreografica, oppure tra un’immagine pubblicitaria e un’opera d’arte conclamata? Una distinzione fondata sul loro modo di apparire risulterebbe inefficace. Noë sostiene infatti che «l’arte tenderà sempre a essere materialmente indistinguibile dalle sue fonti tecnologiche» (p. 75), dalle attività di livello 1 da cui attinge. Una pubblicità che mostra un paesaggio montano per spingerci a prenotare una vacanza e una fotografia artistica che raffigura la stessa scena sono materialmente indistinguibili; si basano sulla stessa tecnologia. La distinzione tra il livello delle arti e il livello delle attività organizzate e della tecnologia passa invece attraverso la nozione di funzionalità. Gli oggetti tecnologici sono propriamente degli strumenti che utilizziamo per ottenere determinati risultati. Gli oggetti artistici sono invece oggetti inutili, spogliati delle loro funzioni: «L’arte è nemica della funzionalità, è il sovvertimento della tecnologia» (p. 115). Ed è proprio per questo che gli oggetti d’arte si rivelano come strumenti anomali, ossia strumenti cui è stata sottratta la loro funzione.
Noë porta avanti le sue tesi attingendo ampiamente dal panorama delle avanguardie artistiche. E non è certo un caso: le opere d’arte concettuale di Marcel Duchamp, le tele di Barnett Newman, le sculture di Robert Lazzarini e le installazioni di Robert Irwin—per ricordare alcuni degli artisti discussi in Strani strumenti—esemplificano perfettamente l’idea che l’arte sia una pratica che «interrompe, rende strano, e dunque sovverte» (p. 135) le nostre abitudini e attività organizzate. L’orinatoio Fontana di Duchamp è visibilmente un oggetto tecnologicamente elaborato spogliato della sua funzione originaria; il fatto che sia capovolto sottolinea il sovvertimento della sua funzione, e dunque un’operazione di straniamento rispetto al suo utilizzo abituale. Resta tuttavia da capire se tale concezione sia davvero in grado di abbracciare l’intero mondo dell’arte, attraverso le diverse epoche e latitudini, e se non sia invece una concezione troppo intellettualistica. In che senso—verrebbe spontaneo domandarsi—un dipinto rinascimentale o una statua greca dovrebbe essere uno strano strumento? Noë anticipa in realtà perplessità di questo genere, e riconosce che la carica sovversiva dei capolavori dei maestri del passato potrebbe non risultarci più perspicua, soprattutto se li osserviamo con il nostro sguardo contemporaneo. Si tratterà allora di guardarli di nuovo, di guardarli più a fondo per cercare di riattivarne il senso e riportare alla luce gli interrogativi e il potere sovversivo che rende quegli oggetti strani strumenti.
Ora, non vi è dubbio che si possa ripercorrere la storia dell’arte per trovare illustri esempi di opere capaci di mettere in crisi la nozione di rappresentazione, o di sovvertire le abitudini estetiche dei loro fruitori; ed è questa un’operazione assolutamente valida. Dei dubbi sorgono invece se si pensa che questa concezione dell’arte debba valere incondizionatamente. In altre parole, l’arte deve sovvertire per essere tale? Noë sembra piuttosto assertivo sulla questione, ma sarebbe forse più prudente rimodulare questa tesi e intendere la sovversione come una delle modalità dell’arte. In seguito, ci si potrebbe chiedere se questa modalità goda di uno statuto speciale, se sia la più nobile, e, nel caso, per quali ragioni. Forse quelle opere che lasciano il segno devono davvero essere sovversive. Ma è altrettanto chiaro che non tutti gli oggetti che, per motivi diversi, fanno parte del mondo dell’arte posseggono una carica sovversiva o sono in grado di sollevare questioni sostanziali. Il mercato dell’arte sembra spesso meno esigente, e i suoi oggetti meno strani (nel senso delineato in Strani strumenti), di quanto Noë probabilmente si auspicherebbe.
È dunque possibile che Strani strumenti non riesca a catturare il senso ultimo del fare arte; ed è del resto dubbio che una teoria possa riuscirci. In compenso, sulla base dei suoi lavori di filosofo e scienziato cognitivo, Noë riesce a metterci efficacemente in guardia da un approccio che una simile pretesa la ha, e che cerca risposte sul senso dell’arte nel posto sbagliato: il cervello. Vi è infatti, secondo Noë, una tendenza diffusa in campo scientifico a voler spiegare che cos’è l’arte facendo appello alle neuroscienze. Questo approccio accetterebbe acriticamente una tesi riduzionista, di provenienza cartesiana, secondo cui per comprendere un dato fenomeno bisogna guardare a quello che accade nel cervello. La neuroscienza dell’arte, ossia la neuroestetica, assume che gli oggetti d’arte siano «triggers per eventi che si producono nel sistema nervoso» (p. 149). Per Noë si tratta tuttavia di un approccio fallimentare: cercare il senso e il valore dell’arte dentro al cervello «sarebbe come cercare il valore dei soldi nella carta su cui sono stampate le banconote» (p. 114). Credo che la posizione di Noë su questo tema sia condivisibile; le ragioni a suo favore non vengono però sviluppate in modo perspicuo in Strani strumenti.
Vale forse la pena spendere qualche parola in più su questo punto. In linea con le argomentazioni presentate da Noë, si potrebbe sostenere che una disciplina come la neuroestetica non può in alcun modo dirci che cosa sia l’arte. La ragione non è difficile da scorgere. La neuroestetica studia i correlati neurali delle nostre esperienze di fronte alle opere d’arte o durante i processi creativi. Un approccio di questo tipo potrà dunque essere altamente informativo su quello che accade nel cervello, ma dovrà tuttavia dare per presupposto che le esperienze prese in esame riguardino oggetti artistici, e non altro. In altre parole, la ripartizione degli oggetti del mondo in oggetti artistici e oggetti non artistici è un’operazione che precede l’attivazione di determinati correlati neurali, e non potrà dunque essere spiegata da essi. Un neuroscienziato che si accinge a studiare l’esperienza di un soggetto di fronte ad alcune opere d’arte dovrà già sapere—ancor prima di iniziare l’esperimento—che cosa vale come arte, e non potrà scoprirlo dopo aver compiuto la sua indagine. La domanda è allora la seguente: da dove proviene questa consapevolezza?
Noë ci mette qui sulla buona strada. Nessuno intende negare che l’arte interagisca con il sistema nervoso, ed è del tutto sensato affermare che senza un sistema nervoso non ci sarebbe alcuna esperienza dell’arte (né alcuna esperienza in generale). Tuttavia, il nesso causale che sussiste tra eventi neurali ed esperienza dell’arte non ci dice niente di significativo su quest’ultima. Il suo senso e il suo valore emergono altrove: «le opere d’arte sono atti comunicativi, transazioni che avvengono in una certa comunità, mosse nel contesto di un paesaggio fatto di nozioni e conoscenze condivise» (p. 114). In conclusione, il libro di Noë si rivela un valido strumento per ripensare il senso del fare arte, ma anche per smorzare le pretese di alcuni approcci riduzionistici contemporanei.
Federico Fantelli
-
Maurice Merleau-Ponty: l’apparire del senso
Recensioni / Febbraio 2024Se, solitamente, le frasi scelte ad epigrafe di una monografia servono più a ringraziare qualcuno di caro o a restituire il senso più generale del testo che ci si approccia a leggere, le parole tratte da Nietzsche con cui Taddio dà il via al suo nuovo lavoro su Merleau-Ponty - Maurice Merleau-Ponty. L'apparire del senso - sono invece programmatiche e ci offrono un ottimo punto di inizio per analizzare il contenuto del libro. Dalla Nascita della tragedia Taddio estrapola questo passaggio essenziale: “Solo come fenomeno estetico l’esistenza e il mondo sono eternamente giustificati”. Il termine per noi fondamentale è “estetico”, che utilizzeremo (secondo l’accezione che a breve chiariremo) per leggere tutto il lavoro di Taddio. Com’è noto la parola può essere interpretata e usata in più modi, sia per indicare la filosofia dell’arte, sia - sfruttando la radice greca del termine - per includere il campo di indagine che analizza la dinamica tramite cui le cose ci appaiono, ovvero la fenomenologia. “Estetico” è il senso stesso della presenza dei fenomeni, che manifestandosi chiamano in causa il nostro sistema percettivo. In Nietzsche, tuttavia, il termine viene utilizzato in una terza accezione, per indicare un nuovo modo di interpretare la realtà senza il bisogno né di dividerla in due parti (fenomeno e noumeno) né di giudicarla a partire da degli assiomi eterni (il bene e il male). Tutto si gioca sul piano dell’apparire, del fenomeno, della pellicola che stimola i nostri sensi, e tutto – di conseguenza – si gioca e trova spazio unicamente sul piano dell’esperienza, che come tale è assoluta e illimitata e non può venire spartita in verità e illusioni. In questo senso, Nietzsche ci propone una lettura della natura del reale come effetto di superficie, come puro gioco di forme, o, per dirla altrimenti, ci permette di pensare a un significato ontologico del termine estetica.
Ed è proprio questa accezione radicale del concetto di estetico che permette di cogliere la tesi sostenuta dal libro di Taddio. Il quale, pur riconoscendo l’importanza delle arti e della pittura (quindi del primo significato del termine) nel pensiero di Merleau-Ponty, e pur dichiarando di voler «riscoprire il pensiero del filosofo come luogo ove far vibrare in modo inedito le corde della fenomenologia» (p. 13), ovvero rimanendo fedeli al secondo significato della parola “estetica”, propone una versione ontologica del pensiero di questo maestro del Novecento basandosi sugli ultimi scritti – incompleti e postumi – che questi ci ha lasciato. Il risultato è che Merleau-Ponty ci viene offerto in una veste classica e insolita al tempo stesso, perché se da un lato ne viene evidenziata la matrice già ampiamente studiata dalla letteratura secondaria di continuatore e critico della fenomenologia di Husserl, nonché di grande esperto di arte e letteratura, dall’altro il testo di Taddio lo installa su una prospettiva ontologica radicale da cui è possibile trarre degli spunti per trascinare gli strumenti classici merleau-pontiani in territori nuovi, come quelli della trasformazione digitale che stiamo tutti vivendo. Il libro, quindi, si pone come obiettivo quello di ripercorrere le vie più note del pensiero di Merleau-Ponty, ma di farlo secondo un orientamento differente e apertamente ontologico, utilizzando le pagine di Merleau-Ponty come i prolegomeni a un’ontologia delle relazioni pure di cui nel corso del libro viene, non a caso, delineato il profilo.
I primi cinque capitoli mettono in chiaro tutti gli elementi fondamentali per comprendere la portata generale del pensiero di Merleau-Ponty. Taddio costruisce un dialogo tra l’arte, la filosofia e le scienze così come Merleau-Ponty stesso ha inteso fare, ovvero intrecciandole tra loro in un movimento perpetuo ed ermeneutico che impedisca, da un lato, un irrigidimento soffocante in categorie troppo vincolanti (per la scienza) e, dall’altro, la ricaduta in un solipsismo esasperato e relativizzante (per la filosofia). Merleau-Ponty è stato in grado di proporre un movimento per cui l’arte accorre a sfumare i contorni della scienza moderna, mentre il linguaggio delle scienze (contemporanee) serve alla filosofia e, in particolare, alla fenomenologia, come ricettacolo di esempi, prove e dimostrazioni utili per ancorare la riflessione teoretica a un fondamento stabile. Merleau-Ponty ha però un indubbio bersaglio polemico, che Taddio chiarisce sin dalle prime pagine del libro: non la scienza in generale, ma la scienza moderna che ha poi trovato in Cartesio la sua nobilitazione filosofica. La modernità ha infatti prodotto un’interpretazione algebrica, geometrizzante e standardizzata della realtà, organizzandola – sul piano scientifico – all’interno di due contenitori assoluti e neutrali (lo spazio e il tempo) dentro cui ogni singolarità e specificità scompaiono, mentre – sul piano della filosofia – dividendo l’oggetto percepito dal soggetto percipiente come se fossero due mondi e sostanze distinte. Come Taddio riassume, «con l’inizio della modernità, possiamo assegnare alla scienza sperimentale il compito di indagare la realtà sottostante l’esperienza» (p. 26, corsivo nostro); in altre parole, con la modernità si configura una distinzione tra ciò che è percepito e chi percepisce, e tra ciò che i sensi offrono e ciò che le cose realmente sono al di là, o al di sotto, di questi. Riassumendo, possiamo dire che la modernità installa sulle precedenti categorie greche la distinzione tra ciò che è apparente e ciò che è reale, conferendo a questi due poli non soltanto un carattere distintivo, ma marcatamente rivale. Il risultato è che il mondo dei sensi viene derubricato a un ruolo passivo o scarsamente rilevante dal punto di vista teoretico, non possedendo mai in sé la propria stessa verità.
Per uscire da questa impasse costruita dalla complicità tra la filosofia e un sapere matematico-geometrizzante, Merleau-Ponty si rivolge all’arte: è l’arte che «ci conduce alle cose stesse. Per Merleau-Ponty i pittori e, più in generale, gli artisti hanno in effetti qualcosa da insegnare ai filosofi: innanzitutto, spiegano come guardare il mondo e le cose» (p. 19). L’arte pittorica, in particolare quella di Cézanne, è lo strumento per eccezione con cui Merleau-Ponty si imbarca nell’impresa di rieducare lo sguardo a non essere esclusivamente un occhio contemplativo che sbircia il mondo dal riparo di un guscio privilegiato e chiuso (la soggettività). La pittura, infatti, insegna all’uomo contemporaneo ad analizzare lo spazio che lo circonda come un mondo in divenire attraversato da «forze invisibili-visibili che agiscono nel campo fenomenico» (p. 20). L’arte è ciò che permette di ritornare alle cose stesse perché è ciò che permette la riscoperta di quell’intrinseco scambio dinamico e attivo che da sempre coinvolge chi percepisce e la cosa che viene percepita; uno scambio in cui il soggetto non è un punto privilegiato, ma è il nodo di una relazione più originaria e “orizzontale” con gli altri elementi che costituiscono l’esperienza. L’arte è dunque, in conclusione, secondo Merleau-Ponty, la cura alla modernità perché dissolve le gerarchie tra un sopra e un sotto, tra un alto e un basso, e restituisce all’esperienza lo statuto di una dinamica relazionale tra diversi livelli costantemente implicati gli uni negli altri, tra cui quelli del soggetto e dell’oggetto. La fenomenologia deve quindi partire da qui: da una dose di anti-modernità che le permetta di superare la distinzione tra apparenza e realtà e di divenire una scienza delle relazioni percettive pure.
In questo senso è chiaro che il bersaglio polemico di Merleau-Ponty non è la scienza tout court, bensì quello specifico sapere tecnico-organizzativo che si trova riassunto nel termine “modernità”. Questo dettaglio è, a nostro avviso, il contributo principale del libro di Taddio, che permette di lasciarsi alle spalle un’immagine antiquata del filosofo francese e ci porta a pensare con lui un rapporto nuovo, più ampio e solidale, sebbene non per questo meno critico, tra scienza, filosofia e arte. I capitoli che vanno dal sesto al sedicesimo sono infatti dedicati da Taddio a dimostrare quanto Merleu-Ponty fosse influenzato e apprezzasse le scienze a lui contemporanee, in particolar modo la Psicologia della Gestalt. Analizzando l’illusione di Müller-Lyer, di Zöllner, l’esperimento di Ternus e il movimento stroboscopico di Wertheimer, Taddio ci mostra non soltanto quanto la psicologia della Gestalt e una fenomenologia ad essa ispirata possano introdurci a un mondo fatto di costanti relazioni reciproche tra le parti, ma anche come Merleau-Ponty conoscesse a fondo queste teorie e che, proprio a partire dai loro risultati, formulò l’idea di una fenomenologia intesa come l’approccio più efficace per « indicare una via alternativa sia alla tradizione “empirista” sia a quella “intellettualista”» (p. 107). La fenomenologia intesa da Merleau-Ponty permette quindi di scappare sia dalle trappole di un riduzionismo spicciolo e “moderno” degli enti a cose, sia dal rischio – anche questo squisitamente moderno – di precipitare in un solipsismo in cui è il soggetto l’unico perno che garantisce l’oggettività e il senso del mondo. Questa mossa merleau-pontiana ha due effetti importanti. Il primo è quello di predisporre un’idea innovativa, che Taddio sembra condividere, di fenomenologia, la quale separandosi in parte dal solco husserliano si caratterizza per un movimento doppio: è sia la scienza delle essenze, ma è anche «quel metodo che ci consente di ricondurre le essenze al piano dell’esistenza, ovvero a quel piano che ci permette di comprendere il senso stesso dell’uomo e del mondo» (p. 74). In altre parole, per Merleau-Ponty la fenomenologia «non fonda il proprio sapere su essenze (eidos) concepite come modelli eterni e immutabili», perché questo rischierebbe di rimettere in campo tutte le “storture moderne” che Merleau-Ponty stesso vuole superare, in primis l’idea che ci sia una realtà più vera e oggettiva di quella che costituisce la nostra esperienza. Ne consegue che il principio epistemologico per il quale esisterebbe un velo tra apparenza e realtà, oppure una differenza ontologica tra un mondo superiore e un mondo inferiore, non è più applicabile. Piuttosto, in maniera profondamente nietzscheana, secondo questa “nuova” fenomenologia ogni «trascendenza si genera nell’immanenza» (p. 75), ovvero ogni diverso livello della realtà si genera dentro e a partire dalla realtà stessa; inclusi il soggetto e l’oggetto. Per mostrare questo punto, Taddio fa un esempio a nostro avviso efficace utilizzando il gioco degli scacchi (p. 155). Negli scacchi, le regole d’azione non sono tutte equivalenti, ma ottengono un senso preciso all’interno della partita specifica che si sta giocando: muovere un alfiere invece che il cavallo, in questa partita, assume un senso differente che farlo in un’altra, dove ci sono altre disposizioni dei pezzi nello spazio. Ne consegue che non esiste La Partita Perfetta, bensì una griglia di senso che si concretizza e muta nella dinamica composta dalle mosse possibili, dai movimenti scelti e dalla disposizione dei pezzi. In altre parole, «non esiste un modello atemporale e trascendente» (p. 155): è l’immanenza costituita da relazioni tra parti a concretizzare le proprie strutture durante il suo stesso svolgersi.
Avevamo detto, però, che le conseguenze di questo approccio erano due. Questa nuova idea di fenomenologia si trova, infatti, ad avere un alleato forse insperato in un pensatore che, pochi decenni prima rispetto a Merleau-Ponty, aveva già tentato di superare la distinzione tra intellettualismo e empirismo, formulando un concetto specifico. Il pensatore è Henri Bergson, che nel capitolo IV di Materia e Memoria introduce il concetto di virtuale per proporre un’ontologia immanente alle forme stesse (che lui chiama «immagini») che costituiscono la nostra esperienza, senza però far sì né che queste forme siano pensate come prestabilite da modelli già inscritti nel virtuale (ovvero non sono delle mere possibilità che concretizzano delle essenze già note) né, tantomeno, senza che il virtuale si riduca esclusivamente alle forme stesse in cui si attualizza, cosa che provocherebbe un arrestarsi del movimento del divenire per esaustione. Il virtuale di Bergson è il nuovo termine ontologico capace di sostituire l’ontologia essenzialistica di Cartesio, ovvero di compiere un passo radicalmente anti-moderno, come Manuel DeLanda (un realista, come Taddio stesso si dichiara essere nel corso del libro) ha ampiamente dimostrato nel suo Scienza intensiva e filosofia del virtuale, ricostruendo l’importanza di questo concetto nel pensiero di un altro filosofo francese assimilabile per certi versi a Merleau-Ponty stesso, ovvero Gilles Deleuze . Il virtuale, in altre parole, è l’idea che la realtà sia costitutivamente un flusso di divenire che si auto-genera e auto-struttura in un equilibrio semi-permanente, meta-stabile, e secondo cui il «mondo emerge con le proprietà fenomeniche che conosciamo nell’esperienza immediata» (p. 163) senza il bisogno di convocare un principio trascendente o esterno. Nietzscheanamente, non serve andare oltre la realtà creando un’apparenza da superare: il piano dell’esperienza immediata è sufficiente a spiegare, anche scientificamente, se stesso. Leggere dunque Merleau-Ponty secondo questa prospettiva permette di inserirlo in un contesto più ampio interno alla storia della filosofia francese contemporanea, in un arco che va da Bergson, Simondon, Thom, e corre fino a Deleuze.
Da questo quadro Taddio trae alcuni fondamenti epistemologici per una nuova fenomenologia delle relazioni basata sulle intuizioni di Merleau-Ponty, dove è possibile pensare a mondi distinti che però restano allacciati dallo stesso e unico piano di realtà. La filosofia e l’arte indagano il senso che questa configurazione delle cose si trova continuamente a generare, mentre la scienza studia e analizza il fondamento stesso della realtà in cui i mondi si trovano, col risultato che arte, scienza e filosofia (intesa, principalmente, come fenomenologia) si trovano a collaborare senza rivalità e senza sovrapposizioni in un unico piano ontologico che costantemente produce senso e costantemente si svolge e differenzia. La prospettiva ontologica del virtuale, che secondo Taddio Merleau-Ponty ha cominciato a delineare soprattutto a partire dagli ultimi scritti e dalle lezioni tenute al Collège de France dedicate al concetto di natura, può, alleggerita dal penso di una dualità insanabile tra soggetto e oggetto, aiutarci a descrivere ciò che oggi sta accadendo. In particolare, il libro propone un’analisi poco scontata dell’evoluzione tecnologica che i nostri corpi e le nostre società stanno subendo, invitando a considerare il digitale non come una mera illusione, una falsa realtà, un’apparenza, ma come un mondo interno alla realtà dentro cui stanno emergendo nuove strutture, come tali né negative né positive di principio. Solamente se analizzate senza dicotomie pregiudiziali (artificiale/naturale, umano/animale, falso/vero), quindi attraverso le lenti di questa fenomenologia “eretica” pensata da e a partire da Merleau-Ponty, le rivoluzioni in cui ci troviamo immersi si offrono nelle loro logiche di base, da cui poi è possibile prendere delle decisioni politiche accorte e efficaci. Il Merleau-Ponty di Taddio è un pensatore realista, anti-moderno ma non per questo anti-scientifico: un fenomenologo dell’immanenza che la sua morte avvenuta a soli cinquantatré anni, nel 1951, non ha forse permesso di vedere chiaramente.
Andrea Colombo
Bibliografia
Bergson, H. Materia e Memoria. Saggio sulla relazione tra il corpo e lo spirito, Laterza, Roma-Bari, 2014.
DeLanda, M. Scienza intensiva e filosofia virtuale, Meltemi, Milano, 2022.
Nietzsche, F. La nascita della tragedia, Adelphi, Milano, 1972.
-
Esattamente vent’anni dopo la prima pubblicazione nell’originale francese (Éditions Belin, 2003), L’istituzione, la passività. Corso al Collège de France (1954-1955) di Merleau-Ponty è ora disponibile anche nella traduzione italiana, edita da Mimesis (2023) e curata da Giovanni Fava e Riccardo Valenti. Il testo rende accessibili al pubblico italiano gli appunti redatti da Merleau-Ponty per i corsi tenuti al Collège de France tra il 1954 e il 1955; corsi che, come ricorda Claude Lefort nella prefazione alla prima edizione francese, «si sovrappongono […] e al contempo scelgono vie divergenti in direzione di una nuova ontologia» (Merleau-Ponty 2023, p. 7). Difatti, nonostante sia la fenomenologia a contrarre il debito maggiore con l’opera di Merleau-Ponty – in primo luogo per la fedele lettura del testo husserliano e, correlativamente, per la sua decisiva promozione nel panorama filosofico francese – è il problema ontologico a coronare la riflessione teoretica del filosofo. A partire dalla presa d’incarico al Collège de France (1953), tale problema diviene per Merleau-Ponty sempre più urgente. Di conseguenza, a dispetto della ricezione tardiva per il pubblico italiano, tali appunti ricoprono un ruolo cruciale nella produzione del filosofo, essendo in grado di restituirci una preziosa istantanea di quella che fu la virata filosofica che interessò Merleau-Ponty a partire degli anni Cinquanta, da una prima fase più autenticamente fenomenologica – marcata dalla sua opera principale, Fenomenologia della percezione (1945) – agli ultimi scritti, in cui Merleau-Ponty prepara il terreno per la sua ontologia.
In queste pagine, è possibile, infatti, partecipare a quel cambio di prospettiva che si stava man mano consolidando nella riflessione di Merleau-Ponty, muovendo da un’analisi fenomenologica del corpo vivo (Leib) verso il carattere necessariamente anonimo o disumano dell’essere carne (chair), al di là della stessa distinzione tra soggettivo e oggettivo. Tale ristrutturazione teoretica prende le mosse da una riconfigurazione generale del contesto in cui Merleau-Ponty operava, e nel quale i presenti corsi si collocano, cronologicamente, a metà: tra la presa d’incarico come docente al Collège de France – periodo che ha come opera di riferimento il testo della sua lezione inaugurale, Elogio della filosofia (1953) – e la rottura definitiva con Sartre e con l’ideologia marxista, la quale legava i due intellettuali fino a quel momento, e che fu segnata dalla pubblicazione dell’Avventure della dialettica (1955). A partire da questi anni, le ricerche del filosofo si orientano sempre più all’interrogazione del senso e dell’espressione, al tema della verità e del rapporto tra linguaggio e mondo, nella ricerca di un terreno esistenziale originario che Merleau-Ponty, comunque, non rinuncia a voler indagare attraverso la lente fenomenologica, coniando, per l’appunto, l’espressione di “ontologia fenomenologica” o indiretta (Merleau-Ponty 2003, p. 203).
Contrariamente ad alcune letture che accusano Merleau-Ponty di ricadere nello stesso impianto metafisico o sostanzialistico che per primo criticava, è importante precisare che anche nella deriva ontologica lo sguardo fenomenologico non viene affatto abbandonato. Piuttosto, Merleau-Ponty evidenzia l’importanza di una ridefinizione dei rapporti tra fenomenologia e ontologia, nell’ottica di una loro reciproca integrazione. L’ambizioso progetto merlopontiano, che si preannuncia come uno degli itinerari filosofici più complessi e stimolanti del Novecento, rimarrà purtroppo nella forma di un discorso interrotto prematuramente a causa della morte improvvisa del filosofo. Rimettere in circolazione questi appunti risulta, perciò, un passaggio determinante per avvicinarsi maggiormente a quell’eredità che Merleau-Ponty ha lasciato in forma incompiuta e frammentaria, in modo da proseguire lungo quella traccia che avrebbe portato alla pubblicazione del suo più grande progetto redazionale, Il visibile e l’invisibile (1964), pubblicato postumo sottoforma di note di lavoro, dando così avvio a quello che appare come un cantiere ancora – e sempre – aperto.
Il perché del rinnovato interesse dopo all’incirca un ventennio per questa fase transitoria e trasformativa di Merleau-Ponty – che si evince, oltre che nel presente volume, anche nel recente progetto di traduzione del corso appena precedente, Il mondo sensibile e il mondo dell’espressione (Mimesis, 2021) – è probabilmente da attribuire al rinnovato stato di buona salute di cui gode il concetto di istituzione nel dibattito scientifico contemporaneo [1], concetto che torna ricorsivamente nelle pagine di Merleau-Ponty e che, presente fin dalle sue prime pubblicazioni, viene posto in queste lezioni come impalcatura portante di tutta la sua riflessione filosofica a venire. In particolare, è nella prima parte del volume, corrispondente al corso sull’Istituzione nella storia personale e pubblica, che si può constatare «la portata filosofica di questa riformulazione del concetto di istituzione» (p. 9), come evidenzia, con sostanziale anticipo, Lefort. In primo luogo, perché Merleau-Ponty, a discapito dell’erronea e fin troppo diffusa sinonimia, mostra come l’accezione fenomenologica di costituire risulti persino l’opposto dell’istituire: «l’istituito ha senso senza di me, il costituito ha senso soltanto per me e per il me di questo istante» (p. 61). Inoltre, un aspetto tra i più interessanti e innovativi della sua proposta filosofica risulta essere il legame imprescindibile che il concetto di istituzione intrattiene con la questione della passività. Difatti, sebbene «non dobbiamo intendere passivo e istituito come equivalenti» (p. 7), tali concetti vengono trattati da Merleau-Ponty in quanto concetti operativi strettamente connessi – indice di ciò la scelta del filosofo francese di inserire una sola introduzione a incipit di entrambi i corsi. Concetti che prendono strade diverse e, al tempo stesso, risultano in grado di chiarirsi reciprocamente, nel processo di comprensione di quella che, in quegli anni, rappresenta l’unica verità ontologica per Merleau-Ponty, a cui in seguito egli darà tanti nomi, anzitutto quello di reversibilità.
Osservando la questione da una prospettiva più estesa, ciò che, di primo acchito, accumuna istituzione e passività è la loro funzione retorica di rintegrare nel discorso tutto quello che la filosofia occidentale per secoli aveva mantenuto sullo sfondo – l’opacità del corpo, la passività istituente, l’inconscio – o, meglio, “al loro posto”, un posto subordinato a quello della trasparenza del concetto, del primato dell’attività e della coscienza intenzionale. In questo senso si configurano gli obiettivi polemici di entrambi i corsi, condensabili in quell’assolutismo del soggetto costituente che viene promosso, in primis, dal criticismo kantiano e che risulta mantenuto, in parte, dalla fenomenologia husserliana. A prescindere dalla legittimità o meno delle obiezioni teoretiche avanzate da Merleau-Ponty alla fenomenologia di Husserl – argomento vagliato ampiamente nella letteratura italiana sul filosofo, fra cui ricordiamo l’importante lavoro di Sandro Mancini [2]–, è rilevante sottolineare come uno dei principali motori dei corsi sull’Istituzione, la passività sia la volontà di Merleau-Ponty di rompere con un certo aspetto della fenomenologia, inerente, nella fattispecie, la nozione di attribuzione del senso (Sinngebung) e, correlativamente, al primato della coscienza intenzionale come coscienza costituente.
Ciò non toglie il grande debito che Merleau-Ponty riconosce a Husserl e a quello che, altrove, definisce il suo «impensato» (Merleau-Ponty 2015, p. 193), il quale sembra coincidere, in qualche modo, con ciò che lo stesso Husserl aveva formulato, anche se con poca convinzione. D’altronde, è proprio Merleau-Ponty ad affermare che, «se dobbiamo molto allo stesso Husserl, non siamo in grado di vedere esattamente ciò che gli appartiene» (Merleau-Ponty 2015, p. 187). In particolare, ciò da cui Merleau-Ponty prende le mosse per formulare la sua idea di istituzione è la nozione husserliana di Stiftung – che, significativamente, Merleau-Ponty sceglie di non usare nella traduzione più diffusa di “fondazione” –, la quale riposa a sua volta sui concetti fenomenologici di sedimentazione e sintesi passive. A tale ripresa segue subito, però, un distacco di Merleau-Ponty da Husserl e da quella che egli evidenzia essere l’incapacità di quest’ultimo di andare fino in fondo alle sue stesse intuizioni, rimanendo imbrogliato fino alla fine in quella che Merleau-Ponty definisce una «analitica degli atti» (Merleau-Ponty 2003, p. 256). A favore, cioè, di una logica della costituzione soggettiva. Al contrario, come fa notare giustamente il co-curatore Giovanni Fava nella prefazione alla prima parte del volume, per Merleau-Ponty è necessario mostrare che «l’istituzione è anzitutto istituzione di un tra, di una giuntura tra esterno e interno, ed è per questo che la parola ‘istituzione’ non ha senso per la coscienza» (p. 48). È necessario, perciò, riconoscere il carattere impersonale della genesi del senso: proprio come il cuore continua il suo battito senza di me, ossia senza che io lo voglia o lo intenzioni – esempio caro a Merleau-Ponty –, allo stesso modo il senso si istituisce, passivamente e pre-soggettivamente, a prescindere dal gesto inaugurale soggettivo e intenzionale. «Affinché ci sia coscienza di qualcosa, occorre che non si dia coscienza di tutto» (p. 202), scrive nelle ultime pagine dei suoi appunti Merleau-Ponty, il quale, prendendo sul serio lo stesso concetto husserliano di coscienza intenzionale, deve ammettere l’impossibilità di una sua universalizzazione. Restituire il carattere non-intenzionale alla coscienza significa, allora, introdurre, anzitutto, un’idea di coscienza che non si riduca al processo di Sinngebung e, poi, una costituzione del senso che non dipenda dall’attività soggettiva. Il soggetto perde così il ruolo privilegiato di agente costituente il senso, e diviene colui a cui il senso delle cose accade, marginalizzandosi rispetto a un’attività pre-teoretica e temporale, «dove non si sente più la pulsazione della coscienza costituente» (Merleau-Ponty 2015, p. 194). Proprio il tempo risulta essere il modello stesso dell’istituzione, che viene descritta efficacemente da Merleau-Ponty nel riassunto del corso come tutti quegli eventi capaci di dotare l’esperienza di dimensioni durevoli, in rapporto alle quali tutta una serie di altre esperienze avranno senso, formeranno un seguito pensabile o una storia, oppure gli eventi che depositano in me un senso […] come appello a un seguito, come esigenza di un avvenire (p.176).
È, quindi, nella struttura fenomenologica del tempo che l’istituzione si esplica, ossia nell’istituirsi del futuro attraverso il passato che «conserva nell’istituito un’efficacia dell’istituente» (p.8), di modo che, «se l’istituzione è apertura a, quest’ultima si produce sempre a partire da» (p.9). La sedimentazione fenomenologica svolge, in questo senso, un ruolo fondamentale nell’economia dell’intero discorso, permettendo un circolo continuo tra passato-presente-futuro che, per Merleau-Ponty, ha la forma della simultaneità, in cui il pensare è, al tempo stesso, sempre un ri-pensare, alla luce di quell’archivio di pensieri già istituiti.
Nell’intima non-coincidenza tra produzione e ri-produzione, si immette quella tra attività e passività, concetti che convivono nella stessa definizione ambigua di istituzione, a un tempo stato di cose stabilite e atto di cominciamento. Al chiasmo passività-attività Merleau-Ponty decide di dedicare il corso del lunedì parallelo a quello sull’istituzione che, in questo volume (analogamente all’edizione francese), si colloca nella parte seconda. Come ricorda Riccardo Valenti – a cui si deve la prefazione al corso su Il problema della passività, arricchita da riferimenti cinematografici che, nell’ottica di un’ibridazione tra filosofia e non-filosofia, rimane piacevolmente coerente con l’insegnamento di Merleau-Ponty – il tema della passività «permea non solo le poche ma densissime pagine che compongono questa lettura, ma anche l’intera opera e riflessione – precedente e posteriore – del filosofo francese» (p. 180).
La passività, infatti, non si limita a rappresentare uno stato del soggetto, ma corrisponde, invece, alla sua propria modalità di relazionarsi con il mondo; rivelazione, questa, di «un genere dell’essere in relazione al quale il soggetto non è sovrano, senza tuttavia che vi si trovi inserito» (p. 333). Tale modalità risulta particolarmente evidente in quei casi limite da cui Merleau-Ponty sceglie di prendere le mosse nel suo discorso: il sonno, il sogno, la memoria e l’inconscio, dimensioni che «sembrano, per principio, escludere la ‘decisione’ di un Soggetto» (p. 22).
Se nel corso dedicato al tema dell’istituzione Merleau-Ponty compie il passaggio dalla frontalità del rapporto soggetto costituente/oggetto costituito alla lateralità propria del soggetto in quanto coscienza incarnata, istituente-istituita, è nella seconda parte delle sue lezioni che si interroga sulla morfologia di tale lateralità soggettiva. In questo contesto il sonno ha un ruolo fondamentale, in quanto è proprio nello stato di coscienza del dormiente-sognante che risulta evidente come il senso si produca autonomamente rispetto a una presa della coscienza intenzionale. La questione che emerge a questo punto è se tale autonomia nella genesi del senso onirico debba essere comunque rimessa a un agire soggettivo, quindi a un’attività di coscienza, oppure no. Interessandosi a tale tematica, Merleau-Ponty è consapevole di inserirsi in un dibattito già aperto, rispetto al quale richiama, nei suoi appunti, le posizioni di Freud e di Sartre (a cui seguiranno Bergson e Proust in merito alla questione, a questa connessa, della memoria involontaria). Sartre e Freud, pur partendo da presupposti teorici differenti, risultano concordi nel riconoscere nello stato assopito della coscienza una spiccata attività soggettiva, che, essendo lontana dal mondo, risulterebbe libera di agire al di là delle sue predeterminazioni fattuali. Non d’accordo con questa tesi, Merleau-Ponty rinviene, sia nella psicoanalisi freudiana sia nella filosofia coscienzialistica sartriana, un presupposto errato, che riguarderebbe, ancora una volta, l’indiscusso monopolio della coscienza: in Sartre, nell’assenza del mondo percettivo, che sarebbe soppiantato da un mondo onirico immaginario o irreale; in Freud, attraverso la traduzione della produzione passiva del senso inconscio e onirico nell’attività sotterranea di un “secondo io”. È chiaro come la questione del sonno, negazione o conservazione del mondo, si traduca, in tal senso, nel problema più generale del rapporto tra immaginario e reale, che per Merleau-Ponty risultano ambiti intrecciati nel campo comune dell’essere in quanto carne, nella contemplazione tanto di una “veglia del sonno” – data dal legame indissolubile tra corpo e mondo – quanto di un “onirismo della veglia”, dato in primis dalla nostra capacità immaginativa [3]. L’immaginario, quindi, non ha una minore rilevanza ontologica rispetto al reale, ma diviene esso stesso trama della realtà percettiva, invisibile tessitura di ogni visione possibile. È proprio in questo clima di “riabilitazione ontologica” dell’immaginario che Merleau-Ponty crea un legame tra fenomenologia e psicoanalisi, attribuendo a Freud il merito di aver scoperto un «simbolismo positivo» passando dall’idea di una trasparenza della verità all’idea di una sua stratificazione, per la quale «l’analisi di una condotta vi trovi sempre più livelli, più strati di significato, i quali hanno tutti una loro verità» (p. 336). Utilizzando lo stesso resoconto delle sedute che Freud riporta a sostegno della propria concezione di psiche, Merleau-Ponty mostra, con e oltre Freud, come la questione dell’inconscio si risolva attraverso la questione del corpo: «l’inconscio come coscienza percettiva è la soluzione che Freud cerca» (p. 263). Per Merleau-Ponty, infatti, è il corpo in quanto luogo dell’inconscio a dettare quel simbolismo primordiale di cui parlava Freud e che per il fenomenologo si articola sempre a partire da un campo percettivo, collocandosi quindi non più dietro o al di sotto dello stato cosciente, ma davanti a noi, come modalità del nostro vivere nel mondo, non prima ma tra gli atti intenzionali, «come l’intervallo degli alberi fra gli alberi, o come il loro livello comune» (Merleau-Ponty 2003, p. 205).
In una coincidenza quasi paradossale, per Merleau-Ponty l’inconscio non è altro che l’essere della coscienza corporea e percettiva, per mezzo di cui facciamo esperienza del mondo, la quale si origina sempre da quel puntum caecum, o in-conscio, dato dall’essere incarnato della coscienza in un corpo. Il contatto tra istituzione e passività è stabilito, in definitiva, dal materiale inconscio come “sedimentazione percettiva” che si radica nel nostro schema corporeo, venendo a costituire, secondariamente, una sedimentazione di matrici simboliche in grado di influenzare la stessa genesi del senso del mondo percepito.
In conclusione, questi appunti ci parlano della necessità di Merleau-Ponty di attingere alla teoria dell’inconscio come via d’accesso privilegiata per parlare di quella passività della nostra attività che, in quegli anni, lo costringeva alla riflessione. La passività si installa nel cuore della attività attraverso il riconoscimento dell’inconscio come modalità del nostro fare esperienza del mondo in modo essenzialmente corporeo e percettivo. Questa idea – introdotta da Merleau-Ponty nei corsi che, grazie a questa traduzione, sono ora disponibili in italiano – resterà fino alla fine della sua riflessione, rappresentando uno dei guadagni teoretici più importanti della sua ontologia.
Guardare ancora una volta ai corsi del Collège de France rappresenta, allora, un passaggio imprescindibile per gli attuali studi su Merleau-Ponty. Da un lato, questo è dovuto al fatto che L’istituzione, la passività consente di mettere in discussione gli assolutismi di un Merleau-Ponty fenomenologo o di un Merleau-Ponty onto-metafisico, per guardare a quella che fu l’idea rivoluzionaria di filosofia ambigua, fondata sulla reversibilità tra il piano ontologico e quello fenomenologico. Dall’altro, questo testo permette di evidenziare l’importanza che ebbe il contatto tra fenomenologia e psicoanalisi per costruire quella che ad oggi possiamo considerare una filosofia dell’immaginario e dell’invisibile, sforzandoci di intravedere la direzione che, da queste premesse, Merleau-Ponty avrebbe dato alla sua ontologia fenomenologica.
Marta Gailli
Note
[1] Dell’ampia letteratura sul tema, ci limitiamo a citare il recente fascicolo dal titolo Il problema dell’istituzione. Prospettive ontologiche, antropologiche e giuridico politico, a cura di E. Lisciani-Petrini e M. Adinolfi, in “Discipline filosofiche”, 29, n. 2, 2019; e il penultimo numero della rivista “Humamente” curato da F. Buongiorno e X. Chiaramonte e dedicato proprio al tema dei nostri corsi, Institution and Passivity: Rethinking Embodiment and Social Practices in the Contemporary Debate, in “Humanamente. Journal of Philosophical Studies”, 41, 2022.
[2] Su questo tema in particolare, si veda S. Mancini (2001). Sempre di nuovo. Merleau-Ponty e la dialettica dell’espressione. Milano: Mimesis.
[3] Sul medesimo terreno battuto da Merleau-Ponty si muoverà circa vent’anni dopo il filosofo greco-francese Castoriadis, nella sua ricerca teoretica-politica – che chiama in causa la stessa psicoanalisi – intorno al concetto di istituzione, legato intimamente al tema dell’immaginario. Cfr. C. Castoriadis (2022), L’istituzione immaginaria della società. Milano-Udine: Mimesis.
Bibliografia
Merleau-Ponty, M. (2003). Il visible e l’invisibile. Milano: Bompiani.
Id. (2015). Il filosofo e la sua ombra in id., Segni. Fenomenologia e strutturalismo, linguaggio e politica. Costruzione di una filosofia. Milano: Il Saggiatore.
Id. (2023). L’istituzione, la passività. Corso al Collège de France (1954-1955). Milano-Udine: Mimesis.
-
Waggle dances. Oscillazioni scodinzolanti
Filosofia e danza / Dicembre 2023Lungo la via
e i nostri passi
ronzio di api
(F. Nun)
Anche se lontane chilometri, le api sanno sempre orientarsi prendendo come riferimento il sole, l’arnia e il prato, spazializzando con la loro danza scodinzolante (waggle dance, ovvero danza scodinzolante delle api che agiscono facendo vibrare il corpo e spostandosi con movimenti ondulatori per comunicare la distanza e la posizione dalla fonte di cibo, Frisch 1967) la distanza da percorrere per comunicare alle compagne dove si trova il nuovo fiore. È un lavoro continuo di esplorazione e mappatura. L’ape non lavora mai per sé stessa ma per procurare il cibo necessario alla sopravvivenza della colonia, l’alveare è un organismo; la colonia di api assomiglia a un corpo, ma un corpo senza organi, un campo di forze, un corpo che si fa sempre ancora e ancora, desiderio in-comune che è ricerca continua.
Alcune azioni delle api sono pulire, nutrire, costruire, immagazzinare, proteggere, raccogliere e con i loro enzimi trasformare il nettare in miele. Quando penso a cosa faccio quando faccio filosofia penso alle api operaie, che prestano servizio, che sono alveare, il singolare che può esistere solo come molteplicità; penso alle api operaie che stanno sulla soglia tra esterno e interno, cercano, trovano, raccolgono, costruiscono collettivamente. Mi piace pensarmi come operaia della filosofia con tutte le valenze che il termine porta con sé: etiche, politiche, autobiografiche che richiamano la dimensione del fare, del maneggiare, della plasticità e della materialità di un pensiero che prende forma, che si forma nella pratica, che si fa azione. Quello delle api operaie della filosofia è un viaggio geografico, fatto di voli di soleggiamento davanti all’arnia che costudisce concetti distillati e incamerati, dove la danza allora assume la forma di un otto, crea un infinito; di voli di orientamento, che sono esercizi per imparare a volare e di voli di esplorazione, di ricerca, di immersione nel fiore e di raccolta del polline e del nettare. Curioso è il modo con cui recuperano il polline, che si posa e aderisce al corpo, pulviscolo che plasmano dandogli una forma morbida per portarlo all’arnia, un primo nutrimento che non diventerà miele, ma che sarà energia per altre esplorazioni. Una filosofia che è questo modo di fare, un viaggio del pensare, che è stata ed è la mia formazione nelle pratiche di filosofia con l’Insieme di Pratiche Filosoficamente Autonome (Giovine Proietti 2021); un viaggio geografico e concettuale, come lo definiscono S. Bevilacqua e P. Casarin, che provi a mappare il territorio delle molteplici esperienze che non trovano spazio per prendere parola; una mappatura che osserva e interroga le trasformazioni della pratica, che non si concentra solo sulle finalità, ma anche sulle inizialità, termine usato da Bevilacqua come gioco di parole, avendo sempre più cura dei mezzi, delle modalità e delle relazioni con cui e insieme a chi si attua la pratica (Bevilacqua 2016, 40-46); un pensare come Pensosità. «Quella pensosità che Blumenberg definisce come esperienza della libertà del divagare, quella che si allontana dall’idea di filosofia intesa solo come una metodica disciplina del pensiero e che invece si avvicina deve avvicinarci al mondo-della-vita, quella pensosità che non esaurisce tutta la filosofia, ma che fa parte della sua possibilità di essere. Quello della pensosità è un rapporto con la realtà di conoscenza e riconoscenza di sé, una meditazione critica trascendentale che trascende l’irreale per conquistare il reale e viceversa. Un’inedita esperienza del mondo, corpo pensante presente non in un’ora, ma in un qua» (Bevilacqua 2023);un pensare che è movimento in cui Filosofia si declina in filosoficamente, da sostantivo diviene avverbio.Un abitare la distanza e, sul prato, immaginare fiumi e confluenze per inaugurare un viaggio osservativo e interrogativo verso la foce per confondere gli argini (Casarin 2016, 35-39); un esercizio di erosione delle rive, che fa pensare al Tra le cose descritto da Deleuze e Guattari in Millepiani, un “tra” le discipline e le pratiche che abitano il mondo. Una filosofia che attraversando il prato, l’enciclopedia, torni a interrogarsi su se stessa e sulle proprie pratiche, pensandone di nuove per ri-cartografare il presente. Proverò allora a restituire di queste pratiche in essere che abitano il presente e di tentativi di immaginarne altre, di come le pratiche interroghino la filosofia e la danza e di come insieme possano inaugurare nuove coreografie. Coreografia qui intesa, assumendo la definizione di Alva Noë, come pratica riorganizzativa che si interroga sulla danza, mostrando come essa sia connaturata all’essere umano, facendo emergere come ci organizza e mettendo in luce ciò che è nascosto, implicito, ovvio, per vedere vedersi, per mappare il presente e ri-coreografarlo. «Filosofia e coreografia sono pratiche organizzative e riorganizzative. Sono pratiche (non attività) – metodi di ricerca – che mirano a far luce sulle modalità in cui siamo organizzati e pertanto anche sui possibili modi in cui potremmo riorganizzarci» (Noë 2015, 17-23).
Un assaggio del polline raccolto, che come pulviscolo si stacca dal corpo, è un primo rigurgito di quel nettare già in parte metabolizzato, ma che necessita però degli enzimi di tutto l’alveare per farsi concetto. Danze scodinzolanti, che oscillano come il soggetto, che sono nel punto cieco di ogni osservatore nel tentativo di vedere vedersi; un soggetto indebolito, direbbe Rovatti, che affonda nel fiore, nell’esperienza, guardando l’arnia senza perderla mai di vista, ma rinfrescandola con le ali. Una danza di ripetute oscillazioni tra prassi e teoria, una nuova cartografia dello spazio e dell’appoggio di quel nuovo salto, descritto nell’articolo introduttivo, che potrà spiccare soltanto spaccando il selciato, immergendosi nella terra. Viene in mente il gesto fenomenologico e Paci: «[S]e i fenomenologi sono coloro che sanno che tutto ciò che scrivono e insegnano è in fondo un’autobiografia, e se poi confessano apertamente questo fatto, è chiaro che si trovino ai margini della filosofia mainstream. Quest’ultima non può accogliere il gesto fenomenologico, il quale non si configura tanto come una metodica universale quanto come un atteggiamento. Una possibile via d’uscita è data – suggerisco – dal rendersi conto che non si potrà mai fornire una giustificazione definitiva dell’oscillazione tra epistemologia e ontologia. Questa oscillazione va in un certo senso abitata, ed esibita di volta in volta, quando si costruisce un discorso filosofico, senza togliere nulla alla contingenza che la intacca costitutivamente» (Leghissa 2021, 85-95).Un gesto che possa costruire carte e non calchi, mappe che non sono il territorio, sempre di nuovo, Immer Wieder, sempre nuove: «Il selciato sul quale cammino…La durezza, la compattezza, l’impenetrabilità delle cose. Per un filosofo, per l’uomo che vive nel filosofo, tutto questo può diventare enigmatico, diventa enigmatico» (Paci 2021, 42).
Immaginate che i voli di ritorno all’arnia somiglino a zig zag di intuizioni e ancoraggi, di composizioni istantanee di pensiero che intravedono un concetto, di accostamenti e allontanamenti, forse concatenamenti pensando a Deleuze; immaginatevi un’ape operaia che esausta si segga su un filo d’erba, sporca di polline, stordita dal viaggio, allora inizierà ad attingere al polline per risollevarsi e a rendersi conto del nettare piano piano; ripercorrendo il suo zigzagare individuerà i nodi delle varie linee tracciate e comporrà un paesaggio con quei nodi. Riemersa dall’innesto con il fiore-danza percorrerà la distanza dall’arnia avendo sempre più chiaro il percorso in modo da poterlo comunicare, ma inevitabilmente oscillando, danzando un avvitamento nel tentativo di vedersi, nel desiderio di produrre un lampo che come fessura taglia il reale e apre altri mondi, disegno di una possibile coreografia. Questo disegno che si ritrova tracciato nelle restituzioni successive alla pratica artistica Dance Well e che si possono leggere in quegli scritti che abbiamo nominato bollettini, nel senso che il temine assume di “comunicazioni periodiche”, che nel corso dell’esperienza ho accompagnato al disegno di piante che di volta in volta seguiamo come modello di soluzioni di esistenza, riprendendo un’espressione di Gilles Clément, per designare le dinamiche di scambio del Terzo paesaggio. Un Terzo paesaggio che è anche descrizione che Alessandro Pontremoli utilizza per definire una certa area della danza contemporanea. «Il nuovo panorama è costituito da tre paesaggi estetici: quello ‘museale’, che conserva il balletto classico e il suo repertorio; quello di una ‘terra di mezzo’, in cui si mantiene il paradigma del moderno con forme e linguaggi riconoscibili; e infine un ‘terzo paesaggio’, una riserva ai margini della cultura mainstream, in cui artisti diversi, esiliati, trascurati dal sistema, sperimentano e producono danza fuori dagli schemi» (Pontremoli 2020).
Spazio delle possibili ibridazioni tra discipline, spazio – come analizza Dal Sasso – di nuove varianti e terreno in cui germoglia «l’arte che dopo il concettualismo è l’arte che ritorna all’ars, alla operosità umana. È arte che esprime il suo profondo legame con i progetti e le pratiche. È arte che rivela talune delle sue regole dando risalto più al fare che non alle apparenze, ai processi anziché le forme, alla creatività piuttosto che agli aspetti visivi delle opere» (Dal Sasso 2020, 323-324). Un concetto quello di “Terzo paesaggio” che Bevilacqua utilizza per definire lo spazio delle pratiche di filosofia: «Probabilmente l’idea di una cartografia filosofica sembra sbagliare strada rispetto alla tradizionale forma di scrittura che la filosofia ha considerato opportuna per esprimersi. E al tempo stesso apparirà strano alla cartografia come tecnica geografica che si possano rappresentare di paesaggi e territori concettuali. Qualcuno forse dirà che queste discipline sono straniere una per l’altra. A mio avviso tuttavia proprio in queste considerazioni ci sono i riferimenti teorici e pratici che ci indicano che stiamo ricercando qualcosa di infinitamente prezioso forse un terzo paesaggio, eterogeneo e caotico, che tenga presente la diversità delle pratiche dei contesti e dei soggetti» (Bevilacqua 2020). Infine un Terzo paesaggio abitato da concetti mobili, sfumati, smarginati e non univocamente definiti come creatività, performance, pratica, improvvisazione, ambiente, drammaturgia e autorialità. «Questo affiorare del terzo paesaggio insegna, ad un ricercatore o una ricercatrice, ad andare a riguardare il paesaggio, anche quello abbandonato, o apparentemente non adatto. Insegna che la collettività della ricerca è data da un impegno politico inteso come pratica dell’accoglienza di saperi altri, dotati di linguaggi differenti e metodologie che sembrano inizialmente improprie secondo uno standard regolamentato. Il terzo paesaggio indica una possibile strada etica di ricerca in cui la sapienza proviene da un dialogo, anche accidentale e inesperto, con ciò che ci sta intorno» (Bevilacqua 2019).
La pratica filosofica da cui prendo ispirazione è il canone della Philosophy for Children/Community. Come per la p4c, anche la pratica di movimento di Dance Well (https://www.lavanderiaavapore.eu/events/dance-well-dancers-2/) si origina e interroga una condizione, quella del Parkinson; come per il termine children diLipman, che definisce ogni soggetto in una condizione di possibile apprendimento, essa diventa possibilità di ripensamento delle pratiche non in un’ottica terapeutica o assistenzialistica, ma di autodeterminazione e trasformazione di una comunità che si fa estesa, aperta: una comunità mobile e mai fissa, nomade nel suo sperimentare e nel mettersi in gioco attraverso il coinvolgimento libero di soggetti che danzano. La comunità è un ambiente in cui ogni partecipante si fa carico ed è responsabile del proprio e altrui sviluppo attraverso l’interazione e la condivisione. L’impegno reciproco al dialogo e all’opportunità di sperimentare l’ibridazione tra la pratica di danza e la pratica di filosofia, per generare una ulteriore variante, accompagna l’esperienza torinese del progetto dal 2019. Le istruzioni si trasformano in immagini attraverso metafore che informano il soggetto per generare la danza. La parola si fa corpo e il corpo si fa parola in un senso che emerge nei dialoghi, nella pratica di danza e nelle restituzioni scritte (bollettini). Si fa esperienza di una comunità di eguali come quella descritta da Rancière, ovvero di soggetti che, nella ripetizione dello stesso gesto, mostrano la differenza, nuove possibilità e nuove creazioni, soggetti la cui patologia mostra altri modi, altre possibilità, e ci mostra come la differenza sia sottesa a ognuno. Questo è un luogo in cui la condizione del Parkinson è prima di tutto “nuovo inizio”, possibilità di pensare e danzare altrimenti, riprendendo la felice espressione di S. Vaccaro (2011). Le tracce lasciate sulle agende durante il dialogo e le restituzioni sono frutto di ulteriore pratica di riflessione e scrittura, che ri-manipola il corpo-pensiero comune dandone conto come pluralità di voci diventando nuovo pretesto e nuovo materiale per l’indagine sul corpo attraverso una nuova ri-creazione concettuale preparatoria alla pratica successiva. La pratica stessa si fa dunque pretesto, gli scritti subiscono una trasformazione, dove le immagini prendono il posto delle parole e viceversa, attraverso un tono che chiamo poetico; poiché la prosa lascia il posto a lampi di componimenti, tentano la comunicazione della creazione comunitaria restituendo la coralità delle voci e dei corpi che contribuiscono alla creazione dei concetti; l’esperienza appena compiuta riflette su se stessa per riorganizzarsi. L’idea del bollettino è maturata subito dopo il primo incontro cercando di capire quale fosse il modo più fecondo per non sovrapporre informazioni, ma per far dialogare le due pratiche.
Attraverso il dialogo, che restituisce la temperatura dell’esperienza e lascia traccia nella memoria favorendo l’incorporazione dei concetti, il permanere degli stati di danza e le tracce dei bollettini, la comunità ha contribuito e contribuisce tuttora alla ricerca, una ricerca che non si è mai interrotta. I pensieri e i gesti agiscono nelle vite di tutti arricchendo tutta la comunità, le riflessioni e i bollettini accompagnano le nostre vite mantenendo un legame, una presenza nell’assenza. L’invisibile prova a farsi visibile, con un segno.
Se la parola scritta e il segno sono un’interruzione nel processo che tentano di dare conto del processo stesso, esprimono una volontà di fermarsi, un primo approdo, una prima raccolta, sono allo stesso tempo una possibilità di inciampare, di intravedere una linea di fuga, un altro possibile scarto. Pensando con Benjamin si potrebbe affermare che la parola e il segno sono quello che la danza non può esprimere, il “di più”. Sono lo scarto, il resto del qui e ora ma anche il non visto, ciò che sta tra le pieghe di quel corpo, l’inagito. wag
Se, come da me appuntato in occasione di un intervento seminariale di Giovanni Leghissa, «la filosofia è il filosofo che scrive e noi che lo leggiamo. E cosa cerchiamo in quel libro? Le zone d’ombra, l’impensato»; parafrasando si potrebbe sostenere che la coreografia è il danzatore che danza. E cosa cerchiamo osservandolo?
La filosofia, la ricerca, l’elaborazione dei contenuti e la volontà di approfondimento ha reso il “gruppo formatori” cosciente dei sentieri che potevamo continuare a percorrere, così da sviluppare gesti, movimenti e riflessioni torcendo lo sguardo su ciò che stavamo facendo, intercettando la possibilità e il desiderio di riuscire ad arrivare alla trasmissione di pratiche specifiche generate dalla profonda osservazione del processo di creazione, guidati dall’osservazione della natura e delle piante in primis. Pratiche che potessero portare il corpo e il pensiero all’essenza dell’ascolto, dell’armonia, dello sguardo, della comunicazione, della vitalità, dell’attenzione e del respiro, per generare una danza consapevole come cura del bene comune. Divenire trasmettitori di buone pratiche, imparando a osservare e rinominare il mondo che ci circonda rivedendo e vedendo esseri con cui conviviamo e che ai nostri occhi si erano tramutati in scontati e invisibili, rinominando relazioni e ri-mappando il territorio. waggle dances
Questo “altro”, questi esseri, hanno spinto l’indagine a osare concetti formulati nelle filosofie, che qui chiamo genericamente postumaniste, come le teorie di T. Morton e D. Haraway. Ci interroghiamo sul concetto di natura e sull’osservazione di assemblaggi di corpi, facendo sì che le creazioni concettuali spingano la ricerca sull’essenza delle nostre percezioni, sullo statuto ontologico del soggetto, sul pensiero di una metafisica che il mondo vegetale ci indica. waggle dances
L’esperienza della scrittura, del corpo che danza, dell’immissione delle parole della filosofia anche durante la pratica corporea, dei concetti del filosofo con cui abbiamo rintracciato correlazioni con le nostre ricreazioni e riflessioni e con cui entriamo in dialogo spingono il pensare insieme come sciame. I concetti della filosofia provano a danzare, s’innestano chiamati dal gesto che li raccoglie in una simultaneità di rimbalzi; il corpo e la comunità dialogante richiamano la connessione con un concetto della tradizione che viene rivitalizzato e ri-creato, facendo riferimento qui alla creazione di concetti di Deleuze e Guattari, una creazione che non avviene ex nihilo, ma che, immergendosi nel pensiero del pensatore e nel concetto, ne trova altre condensazioni. Una co-creazione di contenuti che è segno e possibilità di una co-costruzione della pratica, di una drammaturgia mappata dalla traccia delle scritture e di una coreografia nelle quali l’autorialità è diffusa. waggle dances
La capacità trasformativa del fare filosofia si esplica nell’evoluzione delle informazioni dei danzatori alla comunità, nel cambiamento del loro linguaggio e di un pensare filosofico come attitudine, atteggiamento, postura; le scritture diventano segno visibile di questa trasformazione, re-informando la comunità inscrivendone tracce nel corpo che danzerà. Esperienza di una comunità estetica di indagine, autocorrettiva, che proietta con la consapevolezza della propria fallibilità il cammino della ricerca sin dove essa conduce, in un tempo che può metaforicamente definirsi vegetale, altro, lungo, dilatato, il tempo del processo. waggle dances
Le pratiche di danza e la pratica di filosofia sono accomunate dal desiderio di documentare, trattenere il momento del fare, dell’oralità del pensare e dello stato di danza, che sembra non lascino resti e che, tuttavia, trasformano sia il corpo che il pensiero. Le riflessioni su questi segni hanno spinto la mia indagine all’incontro con la filosofia della traccia di B. Morizot, dove l’impronta dell’animale, per gli umani preistorici e cacciatori, indica la possibile origine del pensiero astratto come exattamento di questo immaginare e pensare insieme l’invisibile. «Seguire una pista consiste dunque nel ricostruire ed estrapolare una storia dell’attività animale decisamente più ricca di quello che mostrano le sole tracce. Accedere all’invisibile attraverso le poche tracce visibili lasciate dall’invisibile, sistemare il segno nel suo intimo e metterlo in serie in costellazione critica con altri segni; la braccata esige l’indagine prima di aver ottenuto abbastanza segni per dare una conferma. Si devono studiare le tracce con attenzione e riflettere prima di prendere una decisione» (Morizot 2020, 213). Si tratta di inforestarsi, di sostare nel movimento della mano dove le scritture col tempo si sono trasformate in disegno, nella danza della mano, in quella corrispondenza che Ingold definisce come movimento in tempo reale e senziente, quando la parola riesce a liquefarsi senza interrompere, o meglio, quando l’interruzione si fa fluida e il corpo aderisce al concetto, al discorso, al logos. Una danza dell’animacy e non più dell’agency, una danza che avviene tra le parti (Ingold 2019, 166-182) dove mi faccio trasduttore per farmi attraversare dalla pratica e tradurla, per reinterrogarla spinta dal richiamo ad abitare la propria pelle come nel momento della pratica di movimento. La parola si fa linea, si assottiglia senza mai sparire e l’oscillare in questo innesto di pratiche mi fa comprendere che il libero gioco tra pratica di danza e pratica di filosofia potrebbero essere lo spazio di quello che P. Montani definisce concetto allo stato nascente, quel punto in cui il «lavoro dell’immaginazione perlustra il sensibile tenendosi costantemente in contatto con l’istanza logica di cui è responsabile l’intelletto»; lo spazio di una semantica fondamentale da cui corpo e pensiero entrambe provengono senza ordine di priorità (Montani 2022), esperienza di quella struttura dell’iscrivibiltà contemporanea all’esperienza «poiché nello stesso istante in cui percepisco ritengo una traccia e da questa ritenzione nascono tanto la possibilità del lavoro del concetto, quanto l’attualità della percezione stessa» (Leghissa 2022, 114-115).
Allora forse qui, in quella linea del disegno si rende manifesto il pensare filosoficamente e la corporeità, lì le discipline s’innestano per mettere in comune i rispettivi saperi, dove chi fa filosofia trova un linguaggio sulla soglia, non solo metaforico e poetico, e si reimmerge nel corpo attraverso le pratiche di danza che richiamano il discorso e le immagini concettuali; dove chi coreografa la danza si appropria di un discorso che tradurrà in gesto con l’esperienza e gli strumenti della propria disciplina.
Dalle tracce lasciate nel tempo, disegni di una mappa già percorsa, emerge una drammaturgia che conduce la costruzione delle pratiche verso un possibile altrove e che fa avanzare la tensione e la narrazione. Le pratiche, hanno bisogno di definizione, di chiarire procedure e ciò che ci interroga. Qui sta la necessità di torcere lo sguardo al lavoro della drammaturgia, delle scritture e dei dialoghi filosofici collettivi. La drammaturgia collettiva come discorso che sottende e che restituisce un ordine di senso, documentazione che diventa opera e opera (Dal Sasso 2020, 323-324), producendo innovazioni del canone. Per innovare devo avere però un punto di partenza e considerare la filosofia e la danza come tecniche artigianali, devo conoscere la materia come l’artigiano conosce la creta e il tornio. Come sostiene F. Saquarcini la parola ‘pratica’ è la pratica stessa, è di difficile definizione, bisognerebbe rimanere perennemente in un regime scopico, ma senza possibilità di afferrarne il concetto e allora non resta che stare nell’oscillazione col regime topico, danzare una waggle dance, dove il bersaglio e io siamo la stessa cosa e dove rimetto in moto ciò che mi ha portato davanti a esso; un pensare da dentro, un essere coinvolti con i propri strumenti, saperi e corpi. Pratiche che nella preparazione si interrogano su se stesse continuamente, sulle proprie modalità più che le finalità; sullo spazio della creatività umana, dell’improvvisazione e della ripetizione in un processo che sonda l’essenza dell’essere umano, i suoi rapporti con gli esseri viventi non umani, con le cose. Pratiche relazionali, che stanno sempre nel tra, nello spazio bianco, sempre in allerta, sulla soglia, in disequilibrio, nel momento del salto, né prima né dopo, oscillando.
Pratica come atto performativo che mettono in questione il significato mobile e smarginato del concetto di performance che, in questo Terzo paesaggio della danza, si sporge a indicare i processi più che i prodotti e indaga la natura e possibilità degli spazi di improvvisazione e creazione che si aprono in essa. Sul concetto di “improvvisazione” che ha guidato le mie riflessioni sulle pratiche in questo articolo, si vedano gli studi di A. Bertinetto. In particolare ringrazio per i dialoghi intercorsi Michela Bloisi che, nella sua tesi Esperienza estetica: una prospettica a partire dalla Contact Improvisation, «abbracciando la concezione pragmatista deweyana dell’arte, articola una prospettiva dell’esperienza estetica come modalità dell’esperienza ordinaria, attraverso le lenti performative della Contact Improvisation: una pratica di danza improvvisata collettiva nata negli anni Settanta a partire da Steve Paxton. Portando in scena movimenti quotidiani, nel contatto tra i corpi, la Contact Improvisation si rivela paradigmatica per descrivere l’esperienza umana: quella di una mente somatica, situata, multisensoriale ed ecologica, costitutivamente immersa in un ambiente. Un’esperienza che, nella sua contingenza, contiene il germe dell’estetico, che può dischiudersi nella percezione creativa dell'inatteso. I due termini che danno nome alla pratica, ‘Contact’ e ‘Improvisation’, saranno utili per sviluppare un doppio percorso che permetterà di approfondire, da un lato, le teorie della percezione, della mente e della sensorialità post-cognitiviste; dall’altro, l’improvvisazione come condizione della creatività, e pertanto come apertura alla possibilità di cogliere l’estetico nell'ordinario». Come l’imprevisto che incontro nello spazio di libertà del processo può emergere, essere accolto e innovare per riorganizzare la pratica stessa? Ri-coreografare ancora e ancora corpi e pensieri per ricominciare sempre di nuovo a danzare l’esistente.
Gaia Giovine Proietti
Bibliografia
Alva, N. (2022). Strani strumenti. L’arte e la natura umana. Torino: Einaudi, pp.17-23.
Bevilacqua, S. (2016). I due (:) della filosofia. Una possibile punteggiatura nelle pratiche di filosofia. Comunicazione filosofica. Rivista telematica di ricerca e didattica filosofica della SFI, 36, 40-46.
Bevilacqua, S. (2019). Cartografie d’infanzia. Un percorso di ricerca fra Philosophy for Children. Ethics in Progress,Vol. 1, N. 1.
Bevilacqua, S. (2023). L’infanzia pensa. Filosofia, letteratura, immaginario. Milano: Mimesis
(In press).
Casarin, P. (2016).Appunti geo-filosofici verso la post-philosophy for children. Comunicazione
filosofica. Rivista telematica di ricerca e didattica filosofica della SFI, 36, 35-39.
Ingold, T. (2019). Making. Antropologia, archeologia, arte e architettura. Milano: Raffaello Cortina Editore.
Dal Sasso, D. (2020). Nel segno dell’essenziale. L’arte dopo il concettualismo.Torino: Rosenberg&Sellier.
Frisch, V. (1967). The Dance Language and Orientation of Bees. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.
Gallangher, S. & Zhahavi, D. (2022). La mente fenomenologica. Filosofia della mente e scienze cognitive. Milano: Raffaello Cortina Editore.
Giovine Proietti, G. (2021). Dalla Philosophy for Children alla post-philosophy for children. Il movimento di Insieme di Pratiche Filosoficamente Autonome, analisi e declinazioni sul territorio piemontese. Tesi di laurea magistrale in Discipline Filosofiche, Università degli Studi di Torino, Relatore Giovanni Leghissa, discussa nella sessione di novembre 2021.
Leghissa, G. (2021). Dalla scienza rigorosa al diario. aut aut, 390, 85-95.
Leghissa, G. (2022). L’inconscio e il trascendentale. Saggi tra filosofia e psicoanalisi. Napoli-Salerno: Orthotes.
Montani, P.(2022).Concetti vuoti e immagini cieche. Una dissimmetria. aut aut,396, 75-94.
Morizot, B. (2020). Sulla pista animale. Milano: Nottetempo.
Nun, F. & Celej, Z. (2022). Ła danza delle api. Milano: Albe Edizioni.
Paci, E. (2021). Diario fenomenologico. Napoli-Salerno: Orthotes Edizioni.
Vaccaro, S. (2011). Pensare altrimenti. Milano: Eleuthera.
-
Non è certo facile restituire la complessità e la densità del volume di Maurice Merleau-Ponty, Il mondo sensibile e il mondo dell’espressione (Mimesis 2021), recentemente tradotto e curato per il pubblico italiano da Anna Caterina Dalmasso, senza dubbio una delle studiose più autorevoli del pensiero del filosofo francese (suo l’importante saggio di Introduzione, pp. 17-52). Non è facile innanzitutto per la stessa natura di questo (non) libro, che raccoglie il materiale del filosofo prodotto in vista del suo primo corso al Collège de France dell’a.a. 1952-53. Il volume contiene tanto l’effettivo materiale utilizzato dal filosofo nelle sue esposizioni orali, quanto appunti che ne ampliano e approfondiscono l’orizzonte teoretico.
L’opportunità per il pubblico italiano di studiare e apprezzare il pensiero di Merleau-Ponty svolto al Collège si amplia così, dopo la traduzione di altri corsi avvenuta a cavallo tra la fine del secolo scorso e l’inizio del millennio: La nature (Seuil, 1995, tr. it. Cortina, 1996) e Notes de Cours 1959-1961 (Gallimard, 1996; tr. it. Cortina, 2003). Quello che qui discuteremo è stato pubblicato nel 2011 dall’editore svizzero MētisPresses[1] sotto la direzione scientifica di E. de Saint Aubert e di S. Kristensen e la traduzione italiana permette di accedere a un materiale teorico molto fecondo, sia per chi si occupa direttamente di Merleau-Ponty sia per chi sia interessato al pensiero francese del Novecento. In queste quattordici lezioni, infatti, si anticipano o si sviluppano in modi originali piste che attraversano, carsicamente a volte, altre in superficie, una tradizione di pensiero gravida ancora oggi di ampi sviluppi teorici. Lungi dall’essere una pubblicazione per soli addetti ai lavori, questo volume può essere di grande aiuto a chi volesse comprendere meglio alcuni intrecci - sia detto solo a titolo di esempio non esaustivo — tra Gestaltpsychologie e filosofia dell’esistenza, tra bergsonismo e fenomenologia, nonché — come segnala la Prefazione di Mauro Carbone (pp. 9-16) foriera di stimolanti riflessioni sull’arte e l’estetica. Insomma, pur non essendo di facile accesso — e tuttavia l’ottimo lavoro di Dalmasso aiuta chi non fosse specialista — il volume non potrà che trovare interesse in molti ambiti degli studi filosofici contemporanei.
Qui ci proponiamo di tracciare una possibile via d’accesso in questo universo filosofico ancora da esplorare anche da parte di chi, da molti anni, vi si dedica con studio attento. Come ogni pista d’accesso, non ne impedisce di altre e non può essere pienamente esaustiva della ricchezza contenuta nelle quasi trecento pagine del volume. Tuttavia, può essere utile a meglio orientarvisi. Come segnala la curatrice, il volume ha il merito di offrire «un punto di vista privilegiato» (p. 17) sul back-office della produzione di Merleau-Ponty, un vero e proprio laboratorio artigianale di concetti situato al fondo del lavoro pubblicato in vita dall’autore.
A differenza degli altri corsi già tradotti per il lettore italiano, la peculiarità de Il mondo sensibile e il mondo dell’espressione consiste nel fatto che esso ci mostra un Merleau-Ponty sul punto di farsi, che non è più quello della Fenomenologia della percezione e non è ancora quello de Le avventure della dialettica, un Merleau-Ponty per così dire “intermedio”, in divenire (Lanfredini 2011): «Le note del corso del ’53 — continua Dalmasso — offrono un insieme di argomentazioni e di fonti in grado di gettare luce su alcuni punti più oscuri o anelli mancanti della riflessione merleau-pontiana successiva» (p. 18). Insomma, il corpus magmatico di questo volume permette, a chi voglia avventurarvisi, di «cogliere “un filosofo al lavoro” e di “accompagnare Merleau-Ponty” nel farsi del suo lavoro» (p. 20). Una vera e propria avventura filosofica che permette al lettore di oggi di risemantizzare molte antinomie che nel nostro presente appaiono ovvi se non addirittura vetusti. Del resto, non siamo noi oggi figli di quella temperie culturale che genericamente potremmo definire post-moderna e che ha fatto della lotta al manicheismo dualistico la sua pars destruens ? È un pensiero non dualistico, senza per questo, vedremo, rinunciare alla duplicità, quello che l’autore — che ovviamente di post-moderno non sapeva nulla — prova a mettere in forma, e che noi abbiamo occasione di studiare proprio nell’atto del suo generarsi.
Mondo sensibile e mondo dell’espressione definiscono un’antinomia che trova le proprie radici, a voler estremizzare, quanto meno nella distinzione platonica tra mondo ideale e mondo sensibile. Se si volessero fissare delle tappe a noi più vicine — come sempre troppo semplicistiche, ma utili a orientarsi — sensibile ed espressione rimandando alle distinzioni moderne di Descartes (quella tra materia estesa e pensiero inesteso) e di Kant (mondo sensibile della natura e mondo intelligibile dei valori) generalizzabile nella distinzione del pensiero antropologico tra natura e cultura (Lévi-Strauss 1969 pp. 39-52; Descola 2005). Già dunque nel tema stesso delle lezioni contenute in questo volume si comprende lo sforzo teorico che le sottende, un lavoro filosofico e fenomenologico che chiama in causa le principali architravi del nostro sensus communis moderno.
Potrebbe essere utile contestualizzare brevemente queste note di corso (si rimanda all’introduzionedella curatrice per i dettagli). L’anno accademico, come detto, è il 1952-53 ed è l’esordio di Merleau-Ponty al Collège de France, dopo che ha già tenuto il suo Elogio della filosofia nella lezione inaugurale (Merleau-Ponty, 2008) e mentre sta aprendo il cammino che lo consacra ai livelli più alti della cultura e della filosofia francese e forse mondiale. Non sono anni facili, gli anni Cinquanta, sia a livello storico (sono gli anni della guerra fredda, delle prime notizie in occidente del regime staliniano, della guerra di Corea, ecc.) sia a livello personale (Merleau-Ponty ha in cantiere La prosa del mondo che resterà incompiuto, sta rivedendo le sue posizioni rispetto all’URSS espresse in Umanismo e terrore del 1948, ma, soprattutto, sta per rompere il grande sodalizio filosofico e affettivo con J.-P. Sartre). Sul piano scientifico ha qualche sassolino nelle scarpe dopo la conferenza del 1946 presso la Société de philosophie dal titolo Il primato della percezione e le sue conseguenze filosofiche (Merleau-Ponty2004) nella quale presentava davanti a un pubblico composto dalle migliori menti filosofiche del tempo i risultati conseguiti con Fenomenologia della percezione. Amici e colleghi (Hyppolite, Bréhier, Lachièze-Rey per citarne alcuni) accolgono in maniera polemica e critica la tesi di fondo di quel libro accusandolo in alcuni casi di sensismo e positivismo. La sensazione di non essere stato compreso si radica nel filosofo e sette anni dopo è proprio da quella discussione che, con certosina attenzione, riparte (p. 61). Il primato della percezione diventa un punto di partenza ottimale per penetrare nel fitto bosco del sensibile e dell’espressione.
Sin dalla prima lezione, quasi un brevissimo compendio di Fenomenologia della percezione, emerge il tema cruciale con un gusto programmatico. Si tratta, cioè, di pensare l’unità del mondo percepito tale che questa unione non sia la “sintesi determinante”, la sintesi intellettuale, cioè, di una molteplicità sensoriale di stimoli empirici. L’unità cercata nella sua opera principale (ma anche in La struttura del comportamento del 1942) non era una sintesi del giudizio, ma di ordine “percettivo”. Si può dunque capire come qui emergano molte ambiguità che il filosofo dovrà in qualche modo dipanare.
Primato della percezione non significa postulare l’esistenza delle cose fuori di me o la corrispondenza oggettiva di mondo e conoscenza né di opporre a una filosofia intellettualista un empirismo sensista à la Hume, bensì di «fare una teoria concreta dello spirito» (p. 59). Il primato della percezione non postula «un primato del sensoriale, del dato naturale» (p. 60), ma è ricerca di un piano originario che non sia né empirico né trascendentale in cui il sensibile e l’espressione possano divenire indiscernibili: è lo statuto stesso della fenomenologia a modificarsi con questo primato. Fenomenologia della percezione non sta ad indicare solo che è possibile trattare la percezione come “noema”, ma che nel farlo si segue il divenire della percezione nel suo stesso attuarsi, ossia che la percezione indica un piano ontologico intermedio tra l’essere oggettivo e l’essere soggettivo. Si può trattare fenomenologicamente la percezione solo se essa non è né l’oggetto di un sapere né il soggetto della sensazione. È questo né né a non essere stato compreso alla Société nel ’46 (pp. 61-62). Il punto è che la percezione non rimanda solo al mondo del sensibile, ma implica anche un carattere espressivo: «Intenderemo qui per espressione o espressività la proprietà che ha un fenomeno, per la sua organizzazione interna, di farne conoscere un altro che non è dato o che non è mai stato dato. […] È in questo […] senso che la percezione è espressione, espressione del mondo» (pp. 62-63).
Fare una fenomenologia della percezione è studiare il farsi del mondo, una fenomenologia che acquista sempre più caratteristiche “hegeliane” (Vuillerod, 2018) risemantizzando il concetto di coscienza. Se c’è percezione, infatti, non è detto che vi sia necessariamente soggetto (nel senso del Cogito trascendentale che accompagna ogni io empirico), ma vi è senz’altro coscienza, che non è il pieno possesso di sé che la tradizione cartesiana e kantiana ci ha consegnato. La coscienza percettiva non è esterna alle cose, si situa tra di esse, ma non è cosa estesa tra cose estese: essa si fa negli scarti, nelle differenze (cromatiche, uditive, sensibili…) tra le cose, è trans-individuale (Ruyer 2018; Simondon 2011), passività creativa (Ménasé 2003). A differenza di quella trascendentale, essa «non ha a che fare con valori […], ma con esseri esistenti» (p. 64). Potremmo dire, cioè, che attraverso il primato della percezione Merleau-Ponty intraveda la possibilità di emancipare la coscienza percettiva dalla sovranità dell’intelletto dell’estetica trascendentale e di riscoprire nella materialità il suo proprio valore/valere.
L’espressività della percezione — il suo “primato” — è dunque ontogenetico, essa non è la facoltà inferiore della coscienza — come all’origine dell’estetica riteneva, ad esempio, A.G. Baumgarten (1993: 41) — ma la sua espressione “sensibile”, è «configurazione, struttura» (p. 65). Ecco un secondo termine fondamentale nel lessico merleau-pontiano che richiama il suo primo grande libro, La struttura del comportamento. Il primato della percezione implica una materialità della coscienza percettiva da intendersi come processo di strutturazione. Se la percezione non è (solo) la passività di un soggetto empirico, ma l’attività — quantunque “passiva” — di una coscienza “materiale”, allora essa è a tutti gli effetti concepibile nei termini di un comportamento (nel senso, ad esempio, in cui quantisticamente una particella ha un comportamento), un’attività vincolata ad un mondo-ambiente. L’espressione percettiva non è un atto puro, ma una prassi “situata” in uno “sfondo” di passività. Il richiamo è qui alla Gestaltpsychologie, che Merleau-Ponty aveva studiato attentamente nel libro del 1942 (e che nel corso affronta tra la settima e la nona lezione). Ogni coscienza percettiva è una figura (Gestalt) che emerge da uno sfondo e «vi è sempre qualcosa di inarticolato e di sottinteso in ciò di cui vi è coscienza» (p. 67). Lungi dall’essere un’astratta sensazione senza soggetto, l’espressione sensibile è un processo di figurazione (Gestaltung) e la coscienza percettiva è una figura o forma materiale. La coscienza percettiva non è un cogito ma un corpo, non un’anima che emerge e s’innalza dalla materia, ma l’individuazione, l’attività immanente, la configurazione sensibile e materiale di un corpo. Il primato della percezione è il primato del corpo sull’anima, non nel senso “empiristico-naturalistico” di un primato dell’esteso sull’inesteso, ma di una indiscernibilità tra il mondo sensibile della corporeità e la sua espressione animale.
Allora fenomenologia diviene sinonimo di strutturazione ontologica — «non vi è differenza tra ontologia e fenomenologia» (p. 61) — e il primato della percezione conduce a una ontologia dinamica e processuale (Vanzago, 2001). Il mondo dell’espressione non è riducibile a un mondo formale, ha una sua materialità; il sensibile non è inerte o passivo. C’è espressività sensibile tanto quanto vi è sensibilità “spirituale”. Né inerte né formale: l’espressività del sensibile è movimento e la fenomenologia della percezione è manifestazione non richiudibile negli steccati formali dell’estetica trascendentale, poiché non vi è più un primato del formale estetico (dello spazio e del tempo formali). Si avvia qui quello che con Husserl (1991) potremmo chiamare rovesciamento della rivoluzione copernicana: è il movimento a determinare le forme del tempo e dello spazio, non il contrario. Anzi: spazio e tempo non sono più forme, ma figure (Gestalten). Il movimento (si veda in particolare la sesta lezione) è il fenomeno espressivo per eccellenza, tutt’altro dunque che l’esito di una rappresentazione soggettiva. Come la percezione, esso non è l’oggetto di un sapere né l’attributo di un cogito (p. 99), ma è qualcosa che può essere solo sentito, in cui si manifesta il movente. Non è neppure un mero accidente che capita a un oggetto empirico, non è, cioè, la variazione di luogo nel tempo di una “cosa” (Sache), ma il fenomeno per il quale “qualcosa” (Ding) si esprime, emerge spazialmente e temporalmente (geograficamente e storicamente) in quanto figura su sfondo.
Il movimento espressivo è l’installazione sensibile di una coscienza percettiva nel cuore dello spazio e del tempo, il suo modo di abitare lo spazio e il tempo (p. 103), i quali non sono relazioni formali né empiriche, bensì modali. C’è movimento, ovvero qualche cosa appare, c’è della percezione, c’è del comportamento, c’è della coscienza, c’è figurazione: espressione di un’immagine materiale. Il movimento espressivo (siamo alla quarta lezione del corso) è «spirito che si fa corpo e corpo che si fa spirito […] una logica del funzionamento percettivo» (p. 105). Rovesciamento della fenomenologia hegeliana: fenomenologia e logica della percezione; il corpo è lo spirito, il mondo sensibile esprime il mondo spirituale; l’unione non è sintesi assoluta, ma l’affinità trascendentale (p. 107) dello spirito col sensibile in sopravanzamento (overlapping) l’uno sull’altro, «sintesi di enjambement» (p. 109).
Il movimento espressivo è la sintesi senza concetto di spazio e tempo. La mente va a Bergson che più di chiunque altro nel Novecento si è sforzato di pensare il soggetto implicato nel movimento (pp. 119-125). Dopo aver esposto, all’inizio della sesta lezione, gli «argomenti di Zenone» (p. 118) sull’impossibilità ontologica del movimento, Merleau-Ponty vi si richiama: «Per lui quello che rende impossibile il movimento nel pensiero di Zenone è la divisione infinita e attuale del tempo e dello spazio, […] per rendere possibile il movimento occorre che il tempo e lo spazio siano divisibili, ma non divisi, che, posti a partire dal tutto, ammettano uno spazio “tra” le posizioni e gli istanti, cosa che non è possibile nell’in sé. È quindi necessario che il movimento , che è fatto del mondo, sconfini su di me come durata, sia anche fatto di coscienza» (p. 119). Tuttavia, Bergson nel cercare un tout indivisé del movimento è ancora troppo intellettualista, «resta coscienziale» (p. 121). Occorre essere, si legge tra le righe delle note di lavoro, più bergsoniani di Bergson, il quale «trionfa su Zenone mostrando che il tempo non è fatto di istanti né lo spazio di limiti di spazio, ed è vero. Ma resta da esplicitare la conseguenza […] crede che il problema sia concluso» (p. 239). Diventa necessaria «una teoria del corpo percipiente» (p. 240), un paradigma del corpo (Iofrida 2019) che troviamo tra l’undicesima e la tredicesima lezione (nel cuore, dunque, del corso): il movimento è sì un dato immediato della coscienza, ma di una coscienza percettiva, una coscienza-immagine che sia la sintesi esistenziale (materiale) della durata, la quale viene così reinterpretata come espressione sensibile, immagine-spaziotempo, figurazione espressiva.
La durata bergsoniana è “astratta” e manca, agli occhi di Merleau-Ponty, la “e”tra sensibilità ed espressività, una unità (dodicesima lezione) non teoretica, ma pratica, «unità dello schema corporeo […] unità di un’azione sul mondo, di una prassi» (p. 187), non nel senso di un pragmatismo utilitaristico (che per Merleau-Ponty manterrebbe la sussunzione dell’azione sensibile a uno scopo sovrasensibile), ma come attività passiva di creazione di immagini, una prassi che «comporta una teoria [Theoria] o gnosis che ne è lo sfondo, che essa modifica e che a sua volta la modifica» (ibidem). La durata espressiva è unità di teoria e di prassi, una praktognosia che non è un pragmatismo — esiste una materialità dei valori — né un empirismo — c’è, come rileva Dalmasso, una intenzionalità del sensibile (pp. 46-52). La durata come congiunzione del mondo sensibile e del mondo dell’espressione, una unità che si può a buon diritto definire estetica (se con Kant intendiamo “estetica” l’unità senza concetto, pre-logica).
Non è un caso che i corsi del ’53 si chiudano (quattordicesima lezione) con delle considerazioni sull’Arte in generale, e sul cinema in particolare. Le considerazioni estetiche di Merleau-Ponty sul cinema meriterebbero ben altre analisi (si rimanda ai lavori di Carbone e di Dalmasso), qui ci limitiamo solo a trarre una brevissima conclusione. Il cinema è la “prova ontologica” del primato della percezione e del movimento espressivo. Esso è una ritmologia della durata dell’immagine, un contrappunto di punti di vista, di immagini che sopravanzano l’una sull’altra. Nell’arte cinematografica si realizza l’unità di sensibile ed espressione, il vinculum substantiale di una molteplicità di immagini sensibili senza sussunzione entro i decreti formali dell’intelletto trascendentale. Nel movimento cinematografico appare una vera e propria monadologia sensibile (p. 64) che si insinua nel mezzo dei due mondi, che sono “separabili” ma non separati e nelle cui pieghe emergono molteplici mondi intermedi. Come scrive Carbone, nel cinema «si celebra il venire ad espressione […] del mondo sensibile» (p. 16).
Questi mondi intermedi sono il legame tra mondo sensibile e mondo dell’espressione e costituiscono l’ambiente originario nel quale la nostra capacità creativa di corpi animali o anime materiali riesce a trovare spazio per esprimersi e manifestarsi attraverso un’inaspettata fenomenologia dello spirito-carne che solo un primato della percezione può rendere visibile. Già solo questa breve conclusione a cui perviene Merleau-Ponty nei corsi dedicati alla duplicità sensibile/espressione, forse, vale da sola lo studio attento di questo volume.
di Gianluca De Fazio
[1] L’editore continua ancora oggi il suo lavoro di pubblicazione dei corsi al Collège de France di Merleau-Ponty. Si segnala il numero monografico dedicato al Mondo sensibile e mondo dell’espressione della rivista Chiasmi International (n. s. 12-2010).
Bibliografia
Baumgartem, A.G. (1993), Progetto dell’estetica, in A.G. Baumgarten, I. Kant, Il battesimo dell’estetica, a cura di L. Amoroso, ETS, Pisa.
Descola, P. (2005), Par-delà nature et culture, Gallimard, Paris.
Husserl, E. (1991), Rovesciamento della dottrina copernicana della corrente visione del mondo, «Aut-Aut», 245, pp. 3-18.
Iofrida, M. (2019), Per un paradigma del corpo: una rifondazione filosofica dell’ecologia, Quodlibet, Macerata.
Lanfredini, R. (2011, a cura di), Divenire di Merleau-Ponty. Filosofia di un soggetto incarnato, Guerini, Milano.
Lévi-Strauss, C. (1969), La struttura elementare della parentela, a cura di A.M. Cirese, Feltrinelli, Milano.
Ménasé, S. (2003), Passivité et création. Merleau-Ponty et l’art moderne, PUF, Paris.
Merleau-Ponty, M. (2004), Il primato della percezione e le sue conseguenze filosofiche, a cura di R. Prezzo, F. Negri Medusa, Milano.
Merleau-Ponty, M. (2008), Elogio della filosofia, a cura di C. Sini, SE, Milano.
Ruyer, R. (2018), Neofinalismo, a cura di U. Ugazio, V. Cavedagna, G. Vissio, Mimesis, Milano-Udine.
Simondon, G. (2011), L’individuazione alla luce delle nozioni di forma e d’informazione, a cura di G. Carrozzini, Mimesis, Milano-Udine.
Vanzago, L. (2001), Modi del tempo: simultaneità, processualità e relazionalità tra Whitehead e Merleau-Ponty, Mimesis, Milano-Udine.
Vuillerod, J.B. (2018), Merleau-Ponty hégélien?, «Chiasmi International», n.s. 19, pp. 101-114.
-
L’Universo come cinema in sé
Recensioni / Settembre 2021Ogni appassionato di cinema lo sa: quello che cerca, guardando un film, non è soltanto una fuga dal proprio quotidiano – magari attraverso l’intermediazione delle vite altrui, immaginarie o meno che siano –, ma una certa, difficilmente definibile estraneazione dal “sé”, un modo per disaderire sic et simpliciter da quel centro gravitazionale per il resto onnipresente che è il proprio stesso “io”. Ciò che insomma seduce, sino al fanatismo, nella settima arte, non è tanto o solamente la capacità di raccontare storie, ma di immettere piuttosto lo spettatore in uno svincolamento possibile dalla sua prospettiva personale, di, in altre parole, autorizzarlo per un certo tempo ad abbandonare le rive tumultuose del proprio monologo interiore in favore di una partecipazione tendenzialmente assoluta al divenire delle cose (‘cose’ di cui faranno parte, a questo punto, persino le persone rappresentate). È per questo motivo che Gilles Deleuze, proseguendo un’intuizione che era già stata prima, perlomeno, di André Bazin («Il cinema come mummia del tempo») e di Pier Paolo Pasolini («Il cinema come lingua scritta della realtà»), ha riconosciuto nel cinema la facoltà di pensare, a tutti gli effetti, e anzi di permetterci di riconoscere come lo stesso universo possa essere a sua volta pensato alla stregua di un «cinema in sé». In quei due capolavori che sono L’immagine-movimento (1983) e L’immagine-tempo (1985), il dispositivo cinematografico assurge infatti a metodo di indagine cosmologico e persino cosmogenetico, rivelando a tutti noi che il mondo è tutto fuorché un semplice tutto, dato e costituito come un «Grande Oggetto» (Roger Chambon), ma si configura piuttosto come un complesso cangiante di processi infinitamente prolungati gli uni negli altri, come uno specchio mutevole, insomma, del pensiero in atto.
È questa allora la tesi che campeggia al centro di Cosmogenesi dell’esperienza. Il campo trascendentale impersonale da Bergson a Deleuze (Mimesis 2021, pp. 314), primo e importante libro di Giulio Piatti. Pur dedicando soltanto una parte della sua indagine al cinema (pp. 217-37), questo studio permette infatti di reperire nel cuore di una certa tradizione filosofica novecentesca una tendenza sempre più precisa e acuminata a vedere nel reale la sua stessa messa in immagine e anzi a cercare in un reale liberato di ogni ipoteca antropocentrica l’origine tanto della nostra prerogativa a rappresentarci il mondo quanto della predisposizione del mondo a divenire rappresentazione, secondo un modello di intelligibilità che eleva la genesi a forma vera dell’ontologia.
Un campo trascendentale impersonale non è quindi soltanto un concetto, ma una serie generativa di (altri) concetti. Si tratta di qualcosa che Henri Bergson interpreta, sia pure non servendosi dell’espressione, come insieme di immagini in sé e per sé (immagini di niente e per nessuno), assimilandolo a una materia in cui la percezione, ricondotta al suo stadio più puro, spogliata di ogni ricordo interpretativo, sarebbe come «già scattata» nelle cose stesse (pp. 31-72). È da qui che l’esperienza propriamente soggettiva sorgerebbe, nel momento in cui un corpo vivente comincia a deflettere un movimento materiale che altrimenti si propaga senza sosta in tutte le direzioni e su tutte le superfici. Ma si tratta anche di ciò che Raymond Ruyer, contestando a sua volta Bergson, è costretto comunque a rintracciare nella stoffa della sensazione, da pensarsi come modello di ogni coscienza e dunque di ogni essere veramente unitario (dall’elettrone all’universo). Da pensarsi come, in altre parole, una superficie che, senza poter prendere le distanze lungo una qualche perpendicolare, è comunque in presa diretta su di sé, quasi che il soggetto della sensazione fosse diffuso senza velocità limite in ogni punto del suo sentire e del suo essere al contempo la sensazione che ha (pp. 160-164). Ancora, è quanto Maurice Merleau-Ponty si troverà a ipotizzare per correggere in corso d’opera la rigidezza bipolare dell’intenzionalità husserliana e riuscire a pensare un percepire che è già sempre incarnato e co-implicato con il mondo, secondo un chiastica convergente-divergenza o divergente-convergenza che spariglia una volta per tutte la correlazione lineare tra soggetto e oggetto (pp. 149-153). E, infine, sarà il piano d’immanenza che Deleuze stesso e Félix Guattari evocheranno nella loro ultima opera, Che cos’è la filosofia? (1991), come operazione archetipale che ogni filosofo deve compiere per resistere a quel caos che dissipa altrimenti ogni pensiero e che pure bisogna poter frequentare per trarne nuova linfa, sia essa filosofica, artistica o scientifica (p. 213 e ss). Lo stesso piano che il solo Deleuze aveva già identificato appunto come la prestazione più tipica del cinema (soprattutto in alcune delle sue espressioni più tipicamente anti-narrative), quale sua capacità di restituirci a una visione che, per quanto strano possa sembrare, ci fonda senza mai essere stata nostra e senza poterlo mai essere del tutto.
Il campo trascendentale impersonale altro non è, insomma, che il cinema come reale o il reale come cinema, in quanto fattore di radicamento immediato della gnoseologia nell’ontologia, del sapere nell’ente, della ricerca nel mondo. La peculiarità di un trascendentale desoggettivizzato consiste infatti nel mettere in comunicazione, rivelandone l’irriducibile simmetria, il fulcro centripeto della conoscenza con quello centrifugo, vale a dire, nel mostrare come il presupposto di ogni apprensione conoscitiva sia anche il terminus ad quem ultimo della stessa.
Persino nei nostri traffici meno teorici, non possiamo fare a meno infatti di basarci su una cieca «credenza» nel reale che nessuno meglio di Deleuze ha saputo tematizzare, una credenza che la dialettica altrimenti interminabile di «comprensione» e «incontro», declinata in termini fenomenologici da Jean Hyppolite nel corso di un convegno Husserl delle 1957 a Royaumont (p. 155 e ss.), impone di ricollocare appunto sullo sfondo di un campo trascendentale a-soggettivo. È questa credenza che il nome di “trascendentale” significa, in ultima istanza, e che un certo gesto filosofico converte in questione esplicita, conferendogli per l’appunto lo statuto di un’implicatura a doppio senso tra pensiero ed essere, tra conoscenza e mondo, tra logica ed esistenza. Cosa altro sta ad indicare, infatti, la questione posta da Kant circa la legittimità dei giudizi sintetici a priori se non lo sforzo di un pensiero che, legiferando in maniera necessaria e universale su una materia interna al suo medesimo operare, costituisce nondimeno un incremento effettivo di conoscenza? Che cosa sta a segnalare, appunto, quest’intreccio se non la possibilità per il pensiero di toccare l’essere almeno quanto si lascia toccare da esso, restando in se stesso? Sia pure in maniera ancora insufficiente, perché troppo ancorata allo stampo dell’empiria (sostanzialmente, della coscienza), il pensatore di Könisberg ha proiettato comunque la conoscenza al di sopra di sé, nell’incrocio in cui il suo guardare si costella insieme al suo fare e in cui non si dà più alcun altro reale oltre un differire da sé intrinsecamente «autopoietico» (così lo definisce efficacemente Piatti).

Henri Bergson A parte allora la sibillina previsione foucaultiana circa l’avvenire del suo pensiero (che avrebbe dovuto informare di sé il XXI secolo), c’è forse un motivo poco avvertito all’origine dell’interesse con il quale la filosofia del presente continua, con un grado di ossessività altrimenti incomprensibile, a rivolgersi all’opera di Deleuze. La sua riflessione non si limita infatti a proporre un’ontologia tra le altre, fondata magari sul ruolo auto-costitutivo della differenza e/o su quello sovversivo dei divenire (con Guattari), ma conferisce alla stessa esigenza filosofica di totalizzazione dell’esperienza la sua ultima giustificazione. Deleuze, in altre parole, è il filosofo che più di ogni altro ha fatto della necessità in quanto tale di filosofare l’architrave della propria concezione del reale, rendendo così particolarmente arduo, ai suoi successori, proseguire su questa strada senza rendergli un ripetuto omaggio. C’è insomma una sorta di esplosione proiettiva, nella sua opera, che, per quanto per lo più non vista, ne fa uno dei luoghi in cui la filosofia, pur conservandosi del tutto realista, si ritrova comunque a contemplare la propria immagine, a vedersi insomma nel mondo come la superficie cangiante nella quale prende forma ogni realtà. La sua insistenza sulla scaturigine esternalista del desiderio di filosofia, come riposta a una sollecitazione che costringe letteralmente a pensare, è a tale proposito sintomatica: ne va della stessa situazione in cui si ritrova ciascun filosofo, quando sperimenta l’azione di un appello incessante di cui non coglie mai del tutto il senso, a meno che non ne faccia la cifra decisiva del reale stesso. Si capisce dunque il tenore quasi ossimorico di molte delle nozioni capitali della sua concezione. “Empirismo trascendentale”, “piano di immanenza”, “sintesi disgiuntiva”, solo per prendere tre esempi tra gli altri, realizzano una sorta di fusione a freddo di quanto per natura sarebbe dovuto rimanere separato: l’a posteriori e l’a priori, il liscio e lo striato, l’unario e il molteplice, ritrovando così nella “cosa stessa” la logica che anima da sempre la sua ricerca in-finita.
Per quanto si tratti infatti di una locuzione di Jean-Paul Sartre, escogitata in La trascendenza dell’ego (1936) per distanziarsi dalla piegatura egologica presa dalla fenomenologia husserliana, il “campo trascendentale impersonale” assume subito la portata di una meta-questione, atta a dare forma al gesto filosofico in quanto non si distingue più dal suo correlato paradossale. Nella prefazione, Rocco Ronchi la definisce appunto, con un’espressione di Arthur O. Lovejoy, un’«idea-unità» (p. 9), nozione distinta tanto dal singolo concetto, quanto dal principio generale, proprio dal fatto di avere una «carriera» (p. 10), un cursus specifico attraverso i pensieri di coloro che in modi sempre eterogenei pure vi si richiamano. Questo correlato non ha perciò più nulla dell’oggetto contrapposto a un osservatore, né tantomeno del soggetto che si ripiega su di sé per guardarsi guardare il mondo, come avviene per lo più in ambito fenomenologico, ma si presenta piuttosto sotto la forma di un mondo che si vede e che si costituisce mentre si vede, senza avere però mai alcun centro privilegiato da cui accedere a questa ‘visione’ che non sia il proprio stesso esistere. Leggendolo, assistiamo insomma a una lunga e sempre più decisa emersione di questa istanza teorica attraverso un corteo di filosofi che, nel corso del Novecento, si sono chiesti che cosa rendesse effettivamente possibile l’incontro conoscitivo, non più assimilabile semplicemente, dopo la débâcle kantiana della metafisica, alla forma paradigmatica di una relazione tra poli numericamente distinti e ontologicamente difformi (il soggetto e l’oggetto, la rappresentazione e la cosa, l’archetipo e il simulacro). Ne va insomma della stessa questione, come l’Autore si premura di sottolineare (pp. 288-9), sollevata da Menone, nel dialogo eponimo di Platone e che un Socrate stupefatto riassume con queste parole: «non è possibile per l’uomo ricercare né ciò che sa [perché lo sa già] né ciò che non sa [perché non saprebbe come riconoscerlo]!» (Men., 81a). In questa celebre aporia si profila un dubbio che, se spinto alle sue conseguenze più radicali, fa tremare non soltanto i polsi dei filosofi, in quanto disconnette per sempre ricerca e sapere, ma anche le fondamenta del nostro commercio quotidiano con il mondo.
L’ontologizzazione del Filosofico (con la maiuscola a capolettera) da parte della filosofia medesima è allora il vero oggetto della trattazione di Piatti. Il percorso proposto in queste pagine, nella sua ricchezza di riferimenti, è insomma una meditazione reiterata sull’inclinazione del pensiero a fare corpo con il suo altro – l’essere – e a ritrovarsi quindi nel proprio altro in forza della sua essenziale estraneità. Si badi, infatti, sotto il nome iper-tecnico di «campo trascendentale impersonale» non si intende qualcosa di adeguabile o di avvicinabile attraverso un movimento che lo supponga esistente al di là di sé. L’esperienza si rivela nella sua fattura cosmogenetica, e quindi non più come l’attributo di un qualche genere di soggettività, soltanto nel momento in cui si mostra nella sua natura pressoché artificiale, nel suo essere il prodotto di una genesi pre-individuale che la pone insieme, simultaneamente, a tutti i suoi altri prodotti (in senso stretto individuali e persino personali). L’effettuarsi dell’esperienza rimane lo stesso, che lo si trovi dal lato del soggetto o da quello dell’oggetto.
L’enunciato chiave della prospettiva di Piatti è perciò il seguente: «L’esibizione delle strutture cosmogenetiche del reale coincide insomma con la costruzione stessa del mondo che si abita» (p. 286). Questo enunciato ha infatti un’implicazione cruciale: esso stabilisce una corrispondenza tra il metodo filosofico e quello scientifico che ci permette di aggirare molte delle difficoltà che affliggono ancora il dibattito speculativo contemporaneo, caratterizzato spesso da una certa, residuale diffidenza nei confronti della scienza o da una simmetrica resa totale nei suoi confronti. Tale enunciato, in altre parole, si pone come il titolo di un programma filosofico che trova la propria scientificità, si parva licet, nel suo prestarsi a una in-finita serie di riformulazioni, ogni volta più approfondite. Il «costruzionismo» di questa concezione fa tutt’uno allora con il carattere a sua volta costruttivo del dispositivo discorsivo scientifico, il quale riconosce nel reale soltanto ciò che può ri-produrre grazie agli apparati formali e materiali delle tecnologie matematiche e sperimentali di cui si dota. Esso si identifica insomma con il non plus ultra del «naturalismo» (p. 287), ovvero, con la sostanza mutevole di una natura non-umana accessibile solo trasformandola. Ecco dunque che la ricognizione condotta da Piatti ci porta su una soglia critica con la quale la filosofia stessa ha da confrontarsi oggi, se non vuole rinunciare al suo compito propulsivo non tanto di scientia scientiarum (ruolo intenibile per tanti motivi) ma, si potrebbe dire, di tecnica delle tecniche, nella loro insindacabile e indispensabile pluralità.
Al di là della maggiore o minore confidenza che si può avere con il dibattito che il libro ricostruisce accuratamente – transitando anche attraverso l’ampia diatriba sulle aporie dell’intenzionalità fenomenologica dipanatasi tra gli anni ‘20 e gli anni ‘50 dello scorso secolo e le traversie del bergsonismo riletto da Vladimir Jankélévicth, Georges Canguilhem, Gilbert Simondon, Bento Prado Jr. e Victor Goldschmidt –, la questione in ballo è quindi immediatamente tangibile. Si sta parlando di vita – cos’altro dovrebbe essere infatti una tecnica delle tecniche? –, una vita da intendersi tanto in termini esistenziali che biologici, a questa altezza inscindibili. Si sta concependo una vita, in breve, che si concreta in una operazione sempre fallita eppure mai veramente evacuata come impossibile, una vita risolta in un tentativo di essere qualcosa di definito, e al limite di definitivo, coincidente però a sua volta con la propria costante messa in questione e quindi con la sua costante trasmutazione. Il vitalismo ostinatamente rivendicato da Deleuze (p. 240 e ss.) è in questo senso oltremodo rivelativo.
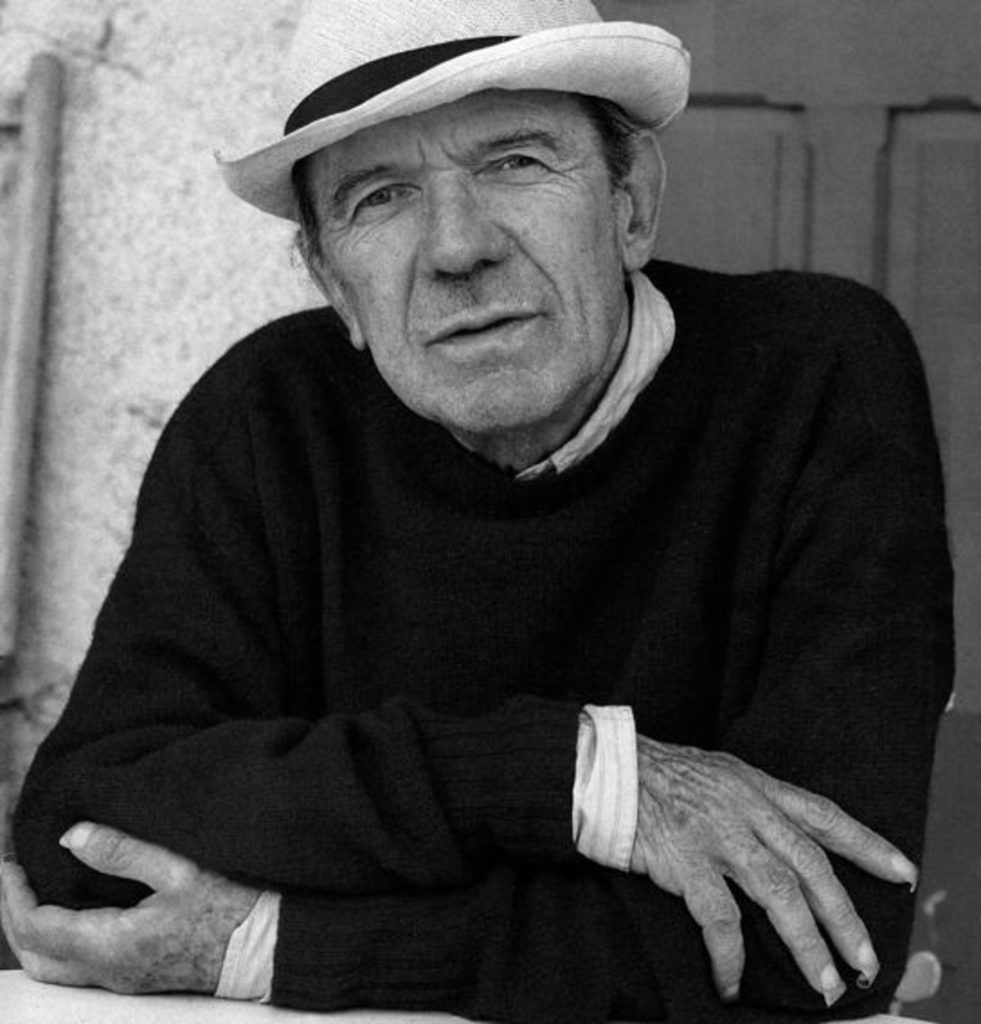
Gilles Deleuze La messa a fuoco del virtuale, nella vicenda allestita da Piatti, assume perciò un valore emblematico, capace di portare alla luce l’agentività stessa del Filosofico e della vita in generale. Il «ricordo puro» di cui parla Bergson in Materia e memoria (1896) e al quale non attribuisce nessuna efficacia determinata, se non quella di un’ipotesi teorica simmetrica a quella altrettanto «di diritto» della percezione pura, si rivela, nel prosieguo dei riarrangiamenti che subisce arrivando nelle mani di Deleuze, dotato di una sua specifica operosità, riconducibile al tentativo di fondare un’esperienza propriamente filosofica, distinta da tutte le altre esperienze di cui la nostra specie è capace. Un’esperienza che ha come sua cifra paradigmatica una certa auto-progressione, un lento procedere non verso qualcosa d’altro, ma verso se stessa, nel suo restare comunque parzialmente opaca al proprio medesimo sapere (come accade d’altronde a tutte le altre nostre attività, almeno sin quando non se ne fa carico, appunto, la filosofia). Un’esperienza che ci rivela inerenti, insomma, al cosmo in quanto è una genesi e non uno stato di cose, più o meno articolato che sia. Ecco perché Piatti, con sottile quanto significativa decisione, insiste col chiamare l’insieme delle immagini bergsoniano un «sistema» (p. 32) delle immagini. Il “sistema” (dal greco synistemi, “raccolgo”) è l’elemento elettivo dell’esperienza filosofante, in quanto resta al di qua (o al di là) di se stessa, nel mentre che ne ricava sempre ulteriori prospezioni. Il virtuale si mostra insomma quale statuto della filosofia, in quanto non riesce mai del tutto nel compito al quale non può comunque rinunciare: istruire un sistema in cui tutte le altre esperienze possano tenere e fare uno. Un’esperienza delle esperienze, insomma, che le raccordi lasciandole essere per quello che sono (e per quello che stanno diventando, soprattutto). In tal senso, le analisi di Piatti sono rilevanti anche nella misura in cui riconoscono una sorta di andamento a soffietto che contraddistingue tanto la metafisica di Bergson, quanto quella dei suoi variegati prosecutori, e che scandisce la stessa forma dinamica dell’universo come cinema in sé. Questo andirivieni conservativo e cumulativo tra presupposto e risultato, tra premessa e conclusione, dà la misura dell’estendersi delle considerazioni bergsoniane da un nucleo soggettivo-interiore (nel Saggio sui dati immediati della coscienza, del 1889) a uno sempre più apertamente cosmologico-evolutivo [in L’evoluzione creatrice e Durata e simultaneità, innanzitutto, (1907, 1922)], con un procedere che mima di fatto la vitalità dello stesso campo trascendentale impersonale. L’archetipo diventa qui simulacro del suo simulacro almeno quanto l’inverso e l’immagine si sutura infine senza scarti al suo referente. È così che viene in chiaro insomma la forma logica della progressività filosofica, manifesta soltanto allo sguardo di chi, con ritrovata consapevolezza del proprio mestiere, non si limita a guardarsi guardare, ma si si impegna a «vedersi vedersi» (Paul Valéry). Di colui, in breve, che tenta di cogliere non solamente il mondo nello specchio della sua apprensione soggettiva, ma come immagine cangiante della medesima dislocazione di sé che è necessario compiere per reperirsi nel mondo, quale essere già da sempre immerso in esso. Per dire la cosa altrimenti, che si scopre quale effetto di un’auto-differenziazione che coincide immediatamente con il divenire delle cose, quali che siano, e che le mette in comunicazione, senza alcun grado gerarchizzato o stratificato di partecipazione, con un principio sempre anche immanente a ciascuna di esse. Donde le splendide osservazioni riservate al processo di cristallizzazione (p. 250 e ss.), come modello di qualsivoglia genesi.
Allo stesso modo in cui è allora possibile leggere nella fisica relativistica un colpo di sonda nelle condizioni di osservabilità empirica del reale (fissate una volta per tutte dal valore-limite della velocità della luce) e nella meccanica quantistica un’insorgenza di quelle relative alla spiegazione scientifica in generale (come ha notato di recente Sergio Benvenuto su Philosophy Kitchen, identificandole nei paradossi della localizzazione che caratterizzano quella disciplina), così è possibile rintracciare nella direttrice di pensiero ripercorsa da Piatti un chiarimento sempre più dirimente di che cosa significa pensare e di come il pensiero non pensi mai altro che se stesso, pensando anche sempre qualcosa di altro da sé. È qui che il filosofo, guardandosi allo specchio, raggiunge il mondo stesso, esce fuori di sé e si confonde con la polvere di stelle di cui è fatto (il) tutto. Per provare quindi a rispondere a Menone, secondo questo impianto teorico, si dovrebbe dire che si cerca sempre quello che non si sa, ma solo perché si crede, si crede solamente, di saperlo già.
Ora, l’uso della scienza da parte della filosofia avviene quasi sempre sul crinale malfermo delle difficoltà incontrate dalla prima. Non è in forza delle convergenze tematiche oggettive tra funzioni scientifiche e concetti filosofici che il filosofo è chiamato a sua volta a dare una sistematizzazione di risultati per altro tra loro non necessariamente (e anzi, necessariamente non) comunicanti, ma grazie appunto alle scuciture, alle esitazioni e alle impasse che caratterizzano e forse caratterizzeranno per sempre il discorso scientifico. Il filosofo ha insomma l’ambizione di ‘curare’, per dir così, l’esperienza efficace della scienza dalla sua pur inevitabile dispersione, di farne il punto di partenza di una qualche sintesi integrale, in cui ci si possa riconoscere anche il famigerato “senso comune”.
Non è vero però l’inverso. Lo scienziato ha sì bisogno di filosofia, ma, come è stato notato per esempio da Canguilhem, non alla stregua di un ausilio finalizzato alla contestualizzazione metafisica delle proprie asserzioni. È piuttosto nella funzione di un’ideologia da scardinare, di un sistema di credenze da far saltare, che la filosofia interviene all’interno del lavorio continuativo dei saperi positivi; è come errore da emendare, insomma, che il palinsesto teorico volto alla “totalizzazione dell’esperienza” può funzionare fruttuosamente nel procedimento della ricerca scientifica, pronta a istruirsi nello spazio vuoto (nello spazio svuotato) lasciato dal primo. Anzi, quando ci si serve di ritrovati filosofici in ambito scientifico si corre spesso il rischio di dogmatizzare inutilmente quanto invece fa la forza dell’impresa scientifica moderna – la sua fallibilità esibita senza vergogna e il suo tenore auto-critico organizzato tecnologicamente e collettivamente. La scienza pretende insomma di curare a sua volta l’intelletto umano dalla sua peraltro irresistibile tendenza alla totalizzazione. A meno che, con una piroetta meta-filosofica degna di un acrobata del pensiero, il filosofo non si chieda che cosa rende concretamente possibile la sua stessa pratica e faccia persino di questa domanda, portando la propria vocazione riflessiva al suo punto critico, l’oggetto privilegiato e inesauribile della propria interrogazione. A meno che, insomma, il filosofo non arrivi a lambire direttamente il cuore della pratica che lo riguarda, cuore isomorfo, nel suo chiedere conto della possibilità medesima del filosofare, alle virtù della scienza in senso stretto, perché esposto, infine, a un continuo e felice fallimento.
Per quanto allora non si fondi su un confronto circostanziato con i risultati scientifici della contemporaneità, il lavoro di Piatti fornisce una perlustrazione preziosa tanto da un punto di vista metafisico quanto, a ben vedere, da uno epistemologico e, quindi, meta-filosofico. È infatti in questo nodo – in questo sovrapporsi vertiginoso di immagine e reale o di interrogazione e genesi – che scienza e filosofia si incontrano a loro volta, alla luce, reciprocamente, delle loro insufficienze e dunque del loro (de-)completarsi, per così dire, a vicenda. Tanto il filosofo che lo scienziato scoprono qui di aver a che fare con uno sfondo fungente di processi che li travalica, insediandoli però nella loro postura interrogativa, istituendoli anzi come interrogazione continuata che il mondo opera su se medesimo. L’universo come cinema in sé appare insomma in forma di una domanda che le cose pongono a se stesse, incessantamente (donde la deleuziana attribuzione di statuto del reale al «problematico» in quanto tale). La nostra credenza inossidabile nel reale può perciò coincidere infine con la sua incessante ri-costruzione e la cura scientifica dalla totalità diventare la stessa cosa della cura filosofica dalla disseminazione.di Daniele Poccia
-
Il diario di Enzo Paci
Recensioni / Aprile 2021È arduo elaborare un quadro unitario ed esaustivo degli interrogativi con cui il punto di vista fenomenologico si è confrontato nella sua storia relativamente breve. Il rischio è quello di risultare riduttivi. Le interpretazioni della filosofia husserliana, infatti, si moltiplicano parallelamente alla comparsa di nuovi ambiti applicativi del metodo fenomenologico, spesso tra loro eterogenei: estetica, neuroscienze, filosofia della mente, gli studi sulla natura e sul vivente. La difficoltà del compito di fornire un quadro unitario delle sfide intraprese dalla fenomenologia sembra perciò derivare da un’esigenza più storica e filologica che teorica. Ciononostante, confronti ragionati tra i principi della fenomenologia e altre prospettive teoriche possono non solo allargare il campo di indagine, ma anche gettare nuova luce sui problemi centrali del pensiero di Husserl. È ciò di cui è particolarmente convinto Enzo Paci, uno degli esponenti più noti della fenomenologia italiana del novecento, nonché il principale artefice dell’introduzione delle opere di Husserl in Italia nel secondo dopoguerra. Pur aderendo con grande convinzione al metodo fenomenologico, Paci non ha mai smesso di tentare di avvicinarlo a questioni e prospettive apparentemente distanti quali il pragmatismo, la filosofia di Whitehead, l’antropologia e il materialismo dialettico, spesso attirandosi le critiche e i sospetti di buona parte del mondo accademico.
Parallelamente al suo programma teorico e ai progetti accademici, Paci conduce un ampio lavoro di divulgazione dei contenuti della filosofia e della scienza. Diversi sono i volumi che, secondo un intento propedeutico, spiegano il contesto storico e il significato ancora attuale di correnti di pensiero e scoperte scientifiche succedutesi dall’antichità all’età contemporanea. Con uno stile decisamente inconsueto e originale rispetto ai più classici saggi, il Diario fenomenologico si pone in questo filone. Pubblicato originariamente nel 1961 e fino ad oggi mai più ristampato, il Diario non riporta il semplice resoconto degli eventi vissuti da Paci tra il 1956 e il 1961, ma costituisce anche una ricca fonte di osservazioni utili alla comprensione della speculazione di Paci e della fenomenologia in generale. L’ampiezza dei contesti teorici a cui Paci fa riferimento, inoltre, fa sì che queste osservazioni convergano in un punta di vista complesso e del tutto originale sulla filosofia di Husserl.
A dispetto dell’odierno proliferare di prospettive a impianto fenomenologico, nell’Italia degli anni sessanta buona parte degli studi fenomenologici non è accolta con favore unanime. Se fraintesa come forma di idealismo o soggettivismo, la fenomenologia trascendentale può in effetti essere rimproverata per la scarsa attenzione riservata all’oggettività. Gli sforzi di Paci sono perciò volti in primo luogo a dimostrare l’intima unità delle diverse fasi del pensiero husserliano e a prevenirne le possibili interpretazioni idealiste. Nemmeno le proposte teoriche del fenomenologo italiano, tuttavia, godono di grande consenso. Con la pubblicazione, nel 1963, di Funzione delle scienze e significato dell’uomo, si apre una proficua e mai abbandonata linea di indagine volta a integrare le prospettive filosofiche di Husserl e di Marx. Sia da un punto di vista politico sia da uno filosofico, un simile progetto desta la perplessità di molti studiosi, tra cui quella di Norberto Bobbio, che per gli assunti del materialismo dialettico auspica una verifica scientifica, piuttosto che una fondazione filosofica – strumentale, peraltro, a una rinnovata interpretazione di Husserl.
In linea con i presupposti fondamentali del materialismo dialettico, in ogni caso, le riflessioni di Paci non si limitano alla mera speculazione teorica: al contrario, anche alla luce delle categorie husserliane, mirano a un effettivo cambiamento dei saperi e delle prassi storicamente costituite che stanno alla base dei rapporti sociali. Proprio nel Diario, in una nota del 10 settembre 1958, Paci scrive che il suo «tentativo è quello di influenzare la filosofia e la cultura italiane con la fenomenologia» (p. 75). Questa ambizione si traduce, in primo luogo, in un lavoro di rifondazione fenomenologica delle scienze, in particolare delle scienze umane. Il principio fondamentale di questa rifondazione stabilisce che l’uomo, in quanto soggetto intenzionale, non può essere considerato da alcuna scienza come mero oggetto, poiché misurazioni e analisi quantitative falserebbero il suo vero essere. Il modello delle scienze naturali, anzi, comporterebbe lo stesso effetto di oggettivazione e alienazione implicato dai modi di produzione capitalista. Andando oltre le sole considerazioni epistemologiche, la fenomenologia, nella trattazione di Paci, sembra quasi costituire un imperativo morale per le scienze umane: la psicologia, per esempio, viene riconosciuta come «scienza che ha una sua funzione intenzionale… per la costituzione di una società umana libera dallo sfruttamento» (Paci 1963, p. 313). Quando Paci formula simili considerazioni nel tentativo di tracciare le linee di una sociologia intenzionale, è Pietro Rossi a intervenire criticamente, osservando che considerare l’uomo secondo un approccio contrapposto a quello delle scienze naturali contravverrebbe al metodo analitico-formale husserliano.
Alla luce di tale giudizio, sembra ironico che la nuova ristampa del Diario fenomenologico, edita da Orthotes (https://www.orthotes.com/diario-fenomenologico/), sia dovuta proprio all’iniziativa di un sociologo. In effetti, nonostante certe proposte possano sembrare azzardate, dagli scritti di Paci si possono trarre considerazioni ben diverse da quelle dei suoi interlocutori diretti. Nella Postfazione, Massimo Cerulo mostra così che l’importanza che le note del Diario danno all’interazione sociale e al contesto storico nell’indagare l’individuo umano è in particolare consonanza con le teorie di noti sociologi come Alfred Schutz, Erving Goffman e Pierre Bourdieu. Sebbene il tono dei suoi scritti sia spesso ispirato, Paci medita a fondo problematiche e concetti provenienti da numerosi ambiti teorici, trovando legami e tratti in comune tra teorie solitamente considerate incompatibili. Psicologia, fisica, sociologia, biologia, antropologia: Paci esplora appassionatamente e considera analiticamente i maggiori risultati di tutte queste discipline al fine di spiegare l’uomo nella sua specificità e, al tempo stesso, nelle radici naturali della sua esistenza. La natura e il suo rapporto con l’uomo, in effetti, rappresentano due temi centrali per il pensiero più proprio di Paci, quel relazionismo che, alla luce delle riflessioni più mature, può a buon titolo essere inteso anche come fenomenologia relazionista. Il Diario fenomenologico condensa i nuclei fondamentali di questa complessa proposta filosofica che assume la relazione e il processo come categorie più fondamentali dell’essere, e testimonia del periodo in cui si compie la vera e propria svolta fenomenologica di Paci.

Nonostante l’esplicito rifiuto di ogni ontologia, le prime formulazioni del relazionismo paciano possono essere comprese come una peculiare posizione metafisica. In primo luogo, sono la natura e gli enti naturali di ogni sorta a essere costituiti secondo un principio relazionale e processuale. Ben presto, tuttavia, il concetto di relazione è sempre più spesso impiegato da Paci secondo una prospettiva gnoseologica. È infatti il punto di vista intenzionale della fenomenologia a costituire il miglior alleato nella critica al sostanzialismo, vale a dire l’erronea attribuzione di una realtà fissa e immutabile al mondo fisico e a quello spirituale. A quest’ultima tesi si oppone, appunto, il relazionismo, che propone un’immagine dell’uomo coerente con quella della natura, secondo cui ogni individuo, piuttosto che una sostanza, è essenzialmente un processo costitutivo, un farsi attraverso l’esperienza. Il soggetto non è quindi una posizione assoluta, ma è preso in una stretta relazione di interdipendenza con i propri vissuti. A supporto di tale rivisitazione della soggettività, Paci trova preziosi alleati nello Husserl inedito.
L’incontro con i manoscritti, più volte raccontato nel Diario, segna una fase importante nella speculazione di Paci: come in quelle pagine muta e si approfondisce il pensiero di Husserl, così, nel leggerle, in virtù di una «affinità profonda» (p. 96), muta lo sguardo di Paci sulla filosofia, sul mondo e sull’uomo. Più precisamente, i manoscritti dei gruppi C, D, E e K portano Paci a dare sempre più importanza agli aspetti precategoriali e genetici della vita intenzionale. Ogni conoscere si rivela come il risultato di un atto sintetico che è in prima battuta fondato su un’esperienza che anticipa la riflessione e che è già di per sé sintetica. La relazione come fondamento della conoscenza, quindi, porta Paci a riconoscere un particolare valore ai concetti husserliani riguardanti ciò che precede l’autocoscienza, tra cui la motivazione, la sintesi temporale e l’associazione. Le leggi delle sintesi passive e la fenomenologia genetica in generale approfondiscono il lavoro inaugurato da Husserl con le indagini sul tempo delle Zeitvorlesungen. Con rinnovata radicalità, come anche recentemente non si è mancato di evidenziare, le lezioni sulla sintesi passiva rimettono in questione la presenza del soggetto a sé e, più in generale, l’unità della coscienza. Paci affronta tali problematiche, proseguendo la riflessione sulle dinamiche dell’esperienza che precedono gli atti di coscienza alla luce delle analisi sulla temporalità e sulla natura relative al primo periodo relazionista degli anni cinquanta.
Le considerazioni sul tempo e sulla fenomenologia genetica, insieme all’interpretazione del materialismo, confluiscono nel più profondo nucleo teorico del relazionismo, ovvero quel naturalismo non riduzionista che, attraverso la fenomenologia e, in particolare, il concetto di Lebenswelt, vuole rivelare la coscienza trascendentale nel suo «fondo naturale» (p. 63), cioè come natura vivente e non reificabile. Questo peculiare naturalismo, in buona parte influenzato dal pragmatismo di Dewey e James, oltre che dall’organicismo di Whitehead, si declina in una sorta di prospettiva non egologica per cui «il cogito, alla fine, è l’operazione, la Leistung del cogitare» (p. 69). Porre al centro della speculazione di Paci lo statuto della coscienza, perciò, consente di mettere le riflessioni sul materialismo dialettico in una prospettiva eminentemente teoretica, a dispetto dei rischi di sconfinamento in questioni extra-filosofiche contro cui mette in guardia buona parte dei commentatori. Molte considerazioni che Paci fa a partire dagli studi sul materialismo possono apparire ingenue o superflue, ma non minano la complessità e la coerenza della sua riflessione.
Durante il soggiorno di studio a Lovanio, Paci si dimostra pienamente consapevole dell’originalità della propria interpretazione di Husserl: «Normale incomprensione degli studiosi per la praxis in Husserl. Il conoscere stesso è praxisin quanto costituito di operazioni, di Leistungen che nel loro operare tendono al significato, alla verità» (p. 95). Di qui, si comprende non solo il senso dell’avvicinamento ai temi marxiani, ma anche il significato più generale che Paci attribuisce alla filosofia di Husserl. Come osserva Pier Aldo Rovatti nella Prefazione, l’intento fondamentale del Diario è dare prova della «concretezza dell’esercizio filosofico» (p. 8) come tratto essenziale della fenomenologia. Allo stesso tempo, tuttavia, il testo fornisce una presentazione della vera stoffa di cui è fatto l’io fenomenologizzante. I luoghi, gli incontri e gli eventi che Paci vive innescano complesse meditazioni che portano a riconoscere la natura del soggetto stesso come un intreccio di relazioni.
In ultima analisi, il Diario fenomenologico è l’illustrazione più fedele della fenomenologia come gesto, come costante «invito alla descrizione» (p. 82) di ciò che si presenta all’esperienza. L’intima relazione tra fenomenologia e vita si spiega così nell’immer wieder, il motto husserliano tanto caro a Paci. Sintesi per essenza incompiuta di biografia e riflessione teorica, il Diario contrasta ogni forma di essenzialismo, collocando l’uomo e la filosofia in un orizzonte teleologico aperto, in un processo di «scoperta e riscoperta continua che si pone tra l’oscurità dell’infinito del non percepire e la luce dell’infinito del vero» (p. 64).
di Federico Tosca
.
.
Bibliografia
E. Paci, Funzione delle scienze e significato dell’uomo, Il Saggiatore, Milano 1963.
-
Com’è noto, il volume XI della Husserliana 1 (1966) raccoglie i manoscritti che Husserl dedica al problema delle sintesi passive tra il 1918 e il 1926. In realtà, la più recente pubblicazione dei Bernauer Manuskripte nel volume XXXIII (2001), a cui Husserl lavorò con Edith Stein nelle estati 1917 e ’18, mostra come la tematica della passività fosse latentemente presente già da molto tempo, in quanto strettamente connessa con il problema – «il più complesso di tutti i problemi fenomenologici» (Husserl 1966a, 276) – della coscienza interna del tempo. E se si considera che quest’ultimo tema occupa Husserl almeno fin dai corsi sulla percezione del 1905-’08 (raccolti in Hua X e XVI), è lecito almeno supporre che la fenomenologia genetica “covasse” nel laboratorio fenomenologico husserliano molto prima degli anni Venti.
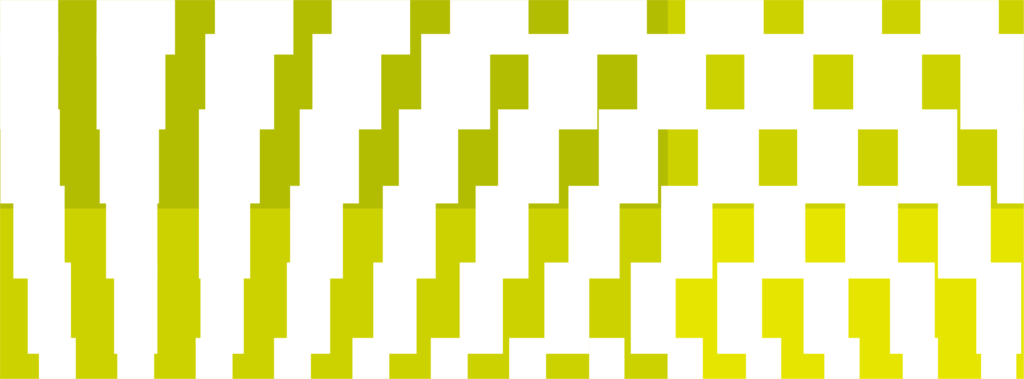
Anno più anno meno, un secolo fa. Un secolo in cui si è tentato dapprima di archiviare la fenomenologia husserliana, per fare spazio alle grandi ondate culturali esistenzialiste, strutturaliste e post-strutturaliste, per poi ridarle nuova linfa innestandola su tradizioni di pensiero anche molto lontane dalle sue origini. La storia della fenomenologia nell’ultimo secolo è dunque caratterizzata dalla sua continua ibridazione con altri modelli filosofici – iniziata ben prima della morte di Husserl: si pensi al § 7 di Sein und Zeit, dove troviamo in nuce il concetto di “fenomenologia dell’inapparente” (Heidegger 1976, 59) – e, soprattutto, con intenti teorici molto frequentemente in aperto contrasto con lo spirito fenomenologico che ha da sempre animato le ricerche husserliane.
A cura di Claudio Tarditi e Alberto Giustiniano
Scarica PDF
English version
DOI: https://doi.org/10.13135/2385-1945/12.2020
Pubblicato: marzo 2020
Indice
EDITORIALE
Claudio Tarditi - Le sintesi passive, un secolo dopo [PDF It]
Filippo Nobili - Oltre la stratificazione costitutiva:
per una lettura dialettico-ricorsiva del rapporto tra passività e attività in Husserl [PDF It]Eugenio Buriano - L’arca dell’origine. Follia tolemaica e deponenza del trascendentale nell’ultimo Husserl [PDF It]
Alessandra Campo - Presenza impossibile, assenza necessaria: aporia, diaporia ed euporia delle analisi husserliane sulla passività [PDF It]
Steven DeLay - Being Oneself Self-Consciousness in Husserl and Henry [PDF En]
Giovanni Jan Giubilato - A First Glimpse into the Ultimate Absolute. The Emergence of Genetic Analyses in Husserl’s Beranuer Manuscripts on Time-Consciousness and the Exploration of the Realm of Passivity [PDF En]
Stefano Gonnella - La sintesi passiva e le radici iletiche della sensibilità [PDF It]
Lavinia Martelli - Genesi passiva e hyle: la fondazione della coscienza trascendentale [PDF It]
OFF TOPIC
Raimondo Cubeddu - L'epicureismo nell'opera di Leo Strauss [PDF It]
Sergio Benvenuto - Freud oggi: che cosa mi pare essenziale conservarne [PDF It]
-
Extra#2 \ TURNS. Dialoghi tra architettura e filosofia
Extra / Febbraio 2018TURNS. Dialoghi tra architettura e filosofia è la traccia di un dialogo spesso acceso, ricco di incomprensioni e riconciliazioni, che coinvolge architetti e filosofi, docenti e professionisti, e ancora biologi, dottori di ricerca, studenti. È il racconto di due discipline, architettura e filosofia, che si voltano per guardarsi reciprocamente, provando a innescare una svolta concettuale che deve divenire un nuovo punto di partenza. Precisamente questo è il doppio significato del termine “Turns”.
Da un lato infatti, il filosofo ha sempre avuto difficoltà a interloquire con l’architetto, sia per ragioni storiche sia per ragioni strettamente legate al suo metodo e ai suoi obiettivi. L’architetto sembra infatti presentarsi allo sguardo del filosofo come un personaggio al contempo perturbante e conturbante, in un misto di attrazione e biasimo, di invidia e ammirazione: una figura tanto sfuggente da investire la riflessione filosofica con effetto retroattivo, facendo scricchiolare le sue fondamenta concettuali e mettendo in dubbio nozioni fondamentali quali verità, libertà, realtà, conoscenza, invenzione, possibilità, necessità, che hanno rappresentato per secoli il lessico base del pensiero occidentale. L’interesse verso una simile figura sembrerebbe ovvio. Eppure, quasi sempre è il filosofo che viene interpellato, utilizzato o coinvolto nel lavoro dell’architetto, in molti casi con l’intento di distillare spazialmente il senso dei suoi discorsi nel progetto. Non che ciò sia impossibile, ma, forse, dovremmo domandarci se è proprio questo quello che vogliamo: o se invece non sia compito del filosofo esercitare una sistematica e implacabile strategia di provocazione interessata, al fine di produrre un effetto, una particolare condizione dello sguardo. Creare la crisi, mettendo in discussione ciò che è dato, sapendo che, come spesso accade, l’apertura verso un nuovo oggetto di conoscenza lascia insoluti quei quesiti che lo vedono direttamente implicato per produrre un effetto retroattivo di chiarificazione nel soggetto indagatore, impegnato a leggersi ora attraverso una nuova forma di mediazione.
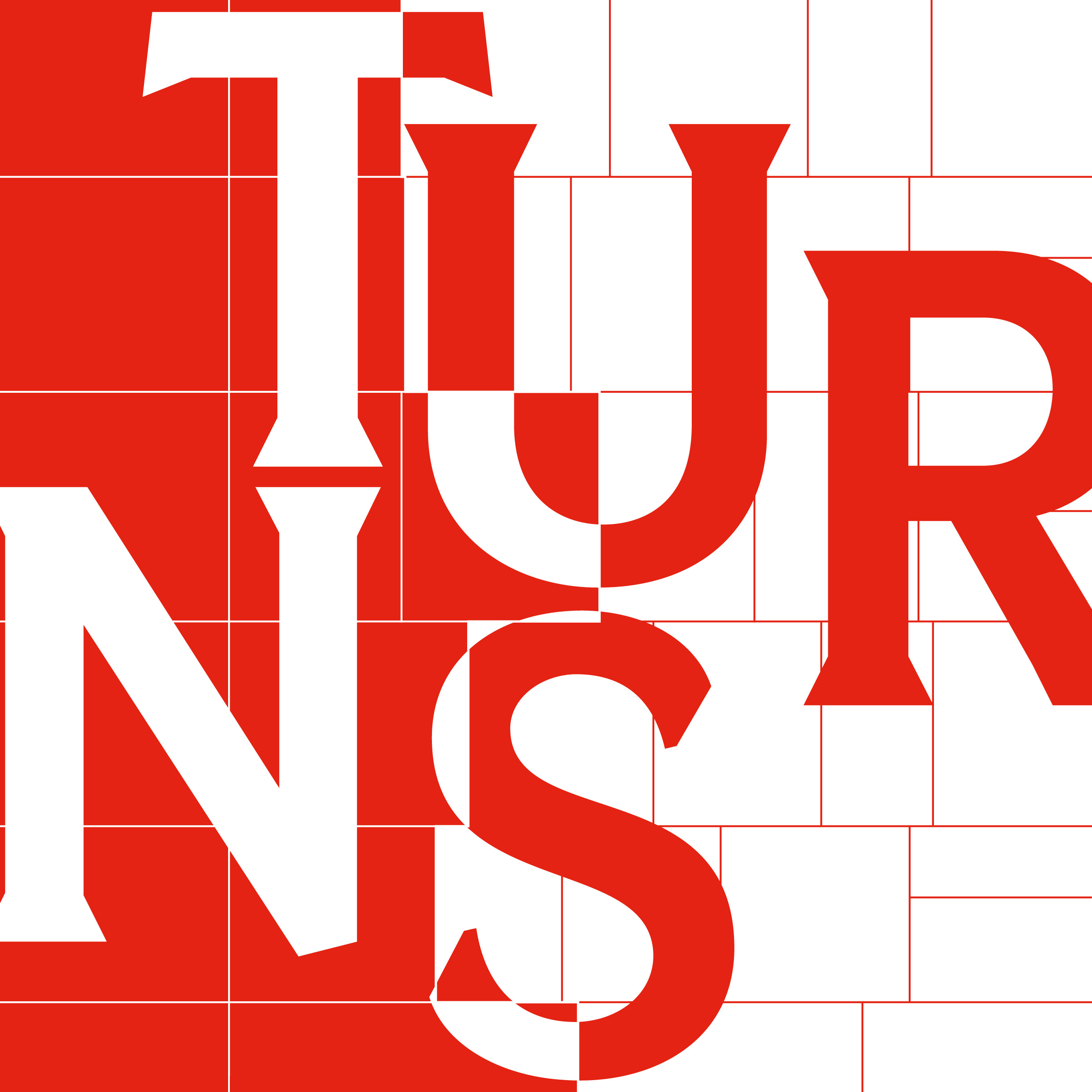
Dall’altro lato, per l’architettura il rapporto con la filosofia è storicamente naturale, quasi che questa fosse una visione complementare sul mondo rispetto al suo operato: questo era possibile perché la società si evolveva in modo relativamente lento, attraverso sedimentazioni di usi che diventavano convenzioni sociali, di pensiero, di stile. Così andava nell’architettura egizia, in quella classica, nel medioevo, nel rinascimento, finanche nel Modernismo: i significati erano decifrabili perché si condivideva un sostrato convenzionale. Ma qualcosa è cambiato. Le correnti durano pochi anni: poi passano, come le mode, spesso senza lasciar traccia – tranne edifici già superati, ovviamente. Così, spariscono le teorie dell’architettura, cioè sistemi che dicano cosa sia giusto costruire. E senza una teoria che legittimi le scelte, fioriscono le retoriche e le poetiche personali, spesso così ridicole da essere persino (e giustamente) oggetto di satira. La condizione di fragilità dell’architettura contemporanea è ormai fisiologica. Ed è qui che la filosofia diventa non solo utile, ma necessaria. A patto, certo, di non usarla in senso analogico, con derivazioni dirette che trasformano concetti in forme e pensieri in stili. Dialogare con i filosofi serve perché essi ragionano su temi che, in qualche modo, toccano gli architetti – ad esempio, lo spazio, l’invenzione, la città, la generazione della forma, il potere. Capire qualcosa di quei temi aiuterà a progettare con una maggior consapevolezza, o una più approfondita convinzione sulle ragioni del progetto, e a capirne meglio effetti ed esiti.
A cura di Carlo Deregibus e Alberto Giustiniano
Scarica PDF
English version
DOI: https://doi.org/10.13135/2385-1945/1.2018
Pubblicato: gennaio 2018
Indice
Alberto Giustiniano - ARCHITECTURAL TURN. Il filosofo e le sfide del progetto [PDF It]
Carlo Deregibus - PHILOSOPHICAL TURN. Fragilità dell’architettura contemporanea [PDF It]
(S)Block-Seminar
.
DA LASCAUX AI JUNKSPACE
Giovanni Leghissa - Da Lascaux ai junkspaces (passando per Ippodamo da Mileto) [PDF It]
Giovanni Durbiano – Descrivere il progetto dello spazio [PDF It]
Riccardo Palma – Molteplicità e non naturalità degli spazi nella produzione del progetto di architettura [PDF It]
RIFERIMENTI di Andrea Dutto [PDF It]
.
DECOSTRUZIONE, IMMANENZA, ILOMORFISMO
Giulio Piatti – Simondon e Deleuze di fronte all’ilomorfismo. Appunti sul rapporto forma-materia [PDF It]
Carlo Deregibus – Appunti su Chōra, spazio e architettura. Da Platone a Derrida [PDF It]
Paola Gregory – Le nuove scienze e la conquista dell’informale [PDF It]
Riccardo Palma – L’assenza necessaria dell’architettura [PDF It]
RIFERIMENTI di Andrea Canclini [PDF It]
.
FENOMENOLOGIA E PROGETTO
Claudio Tarditi – Fenomenologia e architettura. Introduzione al problema della percezione spaziale in Edmund Husserl [PDF It]
Alberto Giustiniano – Tempo, forma, azione. Il senso del progetto nel dialogo tra Enzo Paci e Ernesto Nathan Rogers [PDF It]
Silvia Malcovati – Per un razionalismo relazionale [PDF It]
Carlo Deregibus – L’orizzonte del progetto e la responsabilità dell’architetto [PDF It]
RIFERIMENTI di Federico Tosca [PDF It]
.
MORFOGENESI E AUTOORGANIZZAZIONE
Veronica Cavedagna & Danilo Zagaria - Quale spazio per la morfogenesi e l'auto-organizzazione? [PDF It]
Paola Gregory – Morfogenesi architettonica e “vita artificiale” [PDF It]
Carlo Deregibus – Progetto e complessità. Fascino dell’analogia e libero arbitrio [PDF It]
RIFERIMENTI di Edoardo Fregonese [PDF It]
.
ANTROPOGENESI E COSTRUZIONE DELLO SPAZIO
Roberto Mastroianni – Regimi dello sguardo. Sloterdijk e la metafora spaziale [PDF It]
Alessandro Armando – La scrittura del futuro e la promessa del progetto [PDF It]
Daniele Campobenedetto – Leggibilità e materialità dello spazio [PDF It]
RIFERIMENTI di Federico Cesareo [PDF It]
.
POTERE E SPAZIO
Luigi Giroldo – Genealogie dello spazio contemporaneo. Utopie moderne e nascita dell’urbanistica [PDF It]
RIFERIMENTI di Andrea Canclini [PDF It]
BIBLIOGRAFIA
.
-
Maurizio Ferraris – Emergenza
Recensioni / Maggio 2017 Sul problema del realismo in filosofia tanto si è detto negli ultimi anni da renderlo un tema inflazionato. Non di meno, è innegabile che la svolta realista sia uno degli eventi più importanti per la filosofia contemporanea dell’ultimo decennio, ed è quindi doveroso porre attenzione a quelle pubblicazioni che affrontano il tema del realismo in modo serio e ponderato. Emergenza di Maurizio Ferraris (Einaudi 2016) appartiene certamente a tale categoria. Il concetto di emergenza è per Ferraris l’asse portante di tutto il lavoro ed egli lo racconta a partire da una premessa ontologica: la realtà che emerge è qualcosa che prima non c’era, mentre la verità è la scoperta di qualcosa che già esisteva. Ciò per Ferraris equivale a dire che l’essere viene prima del conoscere. Tale premessa è necessaria in qualsiasi realismo che voglia davvero definirsi tale. Una volta messa in chiaro questa premessa l’Autore fa un altro passo nell’approfondimento del proprio realismo, definendolo attraverso due aspetti tra loro strettamente connessi. Si tratta innanzitutto di un realismo “negativo”, nel senso che la realtà “resiste” al pensiero, ci colpisce con una forza che a volte non è controllabile, che si impone in modo talvolta anche violento. La realtà possiede, insomma, una inemendabilità difficile da smentire, a cui dobbiamo sottometterci. Ma questa inemendabilità costituisce anche il primo “invito” del reale, la sua disponibilità per noi, lo stimolo a conoscerlo e a trasformarlo. Oltre a queste due accezioni del realismo – negativa la prima, positiva la seconda – ve ne è poi una terza, di carattere trascendentale. Resistenza e invito costituiscono infatti un movimento circolare che nel suo ripetersi, nel suo “iterarsi” direbbe Ferraris, produce accumulo, “registrazione”, e quindi, disponendo di abbastanza informazioni e di abbastanza tempo, produce “senso”. La documentalità è quindi secondo l’Autore il vero trascendentale, intendendo con questo termine una sorta di memoria sempre presente e operante – come aveva sostenuto già Bergson – nella materia ogni qualvolta un nuovo senso emerge da quello precedente. Essendo la memoria la materia stessa. Questo vale sia per le dinamiche che regolano l’evoluzione del vivente che per quelle sociali, non essendoci tra le due soluzione di continuità, ma anzi volendo questa prospettiva superare nettamente il dualismo tra biologico e culturale, tra materia e spirito, tra naturale e artificiale, in favore di una visione documentale, appunto, del regno naturale. In una simile prospettiva, dunque, abbiamo un solo tipo di significato, quello che l’Autore definisce “emergenziale”, il quale nasce dall’iterazione e dall’iscrizione, dall’accumulo di “tracce” prima e di “segni” poi. Questi ultimi sono allora la fonte del significato emergenziale, che di spirituale ha solo l’aspetto ma non la sostanza. Prima viene la documentalità, la traccia “cieca”, i rituali delle api e la costruzione dei formicai, l’accumulo di tecniche, di pratiche, ma anche il casuale sedimentarsi di riti e modi di affrontare problemi pratici, e poi viene il senso, la riflessione e la coscienza di cosa si è sedimentato. L’epistemologia perfetta è quindi la storia in quanto accumulo, registrazione e iscrizione da parte dei singoli. Ecco allora esplicato il senso della premessa ontologica di cui dicevamo: l’essere/accumulo/documentalità viene prima del conoscere/traccia/senso. Una radicale pre-esistenza dell’essere al pensiero che però sancisce anche una radicale ri-unificazione tra essere e pensiero nella categoria portante di “mobilitazione”. Cos’è la natura in questo sistema se non una sorta di infinito dispositivo tecnologico che produce emergenza attraverso la dinamica che abbiamo brevemente illustrato? E la mobilitazione è la nozione che Ferraris utilizza per provare a illustrare questa dinamica che percorre l’inerte e il vivente conferendogli una innata competenza tecnica che è sempre avanti rispetto alla sua comprensione (una sorta di neo-finalismo sul modello di quello proposto da Raymond Ruyer all’inizio degli anni 50 del secolo scorso).
Sul problema del realismo in filosofia tanto si è detto negli ultimi anni da renderlo un tema inflazionato. Non di meno, è innegabile che la svolta realista sia uno degli eventi più importanti per la filosofia contemporanea dell’ultimo decennio, ed è quindi doveroso porre attenzione a quelle pubblicazioni che affrontano il tema del realismo in modo serio e ponderato. Emergenza di Maurizio Ferraris (Einaudi 2016) appartiene certamente a tale categoria. Il concetto di emergenza è per Ferraris l’asse portante di tutto il lavoro ed egli lo racconta a partire da una premessa ontologica: la realtà che emerge è qualcosa che prima non c’era, mentre la verità è la scoperta di qualcosa che già esisteva. Ciò per Ferraris equivale a dire che l’essere viene prima del conoscere. Tale premessa è necessaria in qualsiasi realismo che voglia davvero definirsi tale. Una volta messa in chiaro questa premessa l’Autore fa un altro passo nell’approfondimento del proprio realismo, definendolo attraverso due aspetti tra loro strettamente connessi. Si tratta innanzitutto di un realismo “negativo”, nel senso che la realtà “resiste” al pensiero, ci colpisce con una forza che a volte non è controllabile, che si impone in modo talvolta anche violento. La realtà possiede, insomma, una inemendabilità difficile da smentire, a cui dobbiamo sottometterci. Ma questa inemendabilità costituisce anche il primo “invito” del reale, la sua disponibilità per noi, lo stimolo a conoscerlo e a trasformarlo. Oltre a queste due accezioni del realismo – negativa la prima, positiva la seconda – ve ne è poi una terza, di carattere trascendentale. Resistenza e invito costituiscono infatti un movimento circolare che nel suo ripetersi, nel suo “iterarsi” direbbe Ferraris, produce accumulo, “registrazione”, e quindi, disponendo di abbastanza informazioni e di abbastanza tempo, produce “senso”. La documentalità è quindi secondo l’Autore il vero trascendentale, intendendo con questo termine una sorta di memoria sempre presente e operante – come aveva sostenuto già Bergson – nella materia ogni qualvolta un nuovo senso emerge da quello precedente. Essendo la memoria la materia stessa. Questo vale sia per le dinamiche che regolano l’evoluzione del vivente che per quelle sociali, non essendoci tra le due soluzione di continuità, ma anzi volendo questa prospettiva superare nettamente il dualismo tra biologico e culturale, tra materia e spirito, tra naturale e artificiale, in favore di una visione documentale, appunto, del regno naturale. In una simile prospettiva, dunque, abbiamo un solo tipo di significato, quello che l’Autore definisce “emergenziale”, il quale nasce dall’iterazione e dall’iscrizione, dall’accumulo di “tracce” prima e di “segni” poi. Questi ultimi sono allora la fonte del significato emergenziale, che di spirituale ha solo l’aspetto ma non la sostanza. Prima viene la documentalità, la traccia “cieca”, i rituali delle api e la costruzione dei formicai, l’accumulo di tecniche, di pratiche, ma anche il casuale sedimentarsi di riti e modi di affrontare problemi pratici, e poi viene il senso, la riflessione e la coscienza di cosa si è sedimentato. L’epistemologia perfetta è quindi la storia in quanto accumulo, registrazione e iscrizione da parte dei singoli. Ecco allora esplicato il senso della premessa ontologica di cui dicevamo: l’essere/accumulo/documentalità viene prima del conoscere/traccia/senso. Una radicale pre-esistenza dell’essere al pensiero che però sancisce anche una radicale ri-unificazione tra essere e pensiero nella categoria portante di “mobilitazione”. Cos’è la natura in questo sistema se non una sorta di infinito dispositivo tecnologico che produce emergenza attraverso la dinamica che abbiamo brevemente illustrato? E la mobilitazione è la nozione che Ferraris utilizza per provare a illustrare questa dinamica che percorre l’inerte e il vivente conferendogli una innata competenza tecnica che è sempre avanti rispetto alla sua comprensione (una sorta di neo-finalismo sul modello di quello proposto da Raymond Ruyer all’inizio degli anni 50 del secolo scorso).Il libro di Ferraris ha il grande merito di presentare in modo chiaro e conciso la posizione critica comune a gran parte dei realismi contemporanei, ovvero l’attacco frontale e senza compromessi all’idealismo trascendentale e ai suoi molti eredi. Tale critica si può riassumere nel modo seguente: l’intenzionalità non è il cominciamento dell’essere. La correlazione coscienza-mondo non è la condizione di esistenza del reale. C’è qualcosa che viene prima e fonda la correlazione, qualcosa esisteva prima della correlazione e continuerà ad esistere dopo. L’idealismo trascendentale sbagliava quindi nel sostenere che la radice dell’esperienza si situasse nell’Io penso. Ed è così che persino in pensatori “emancipati” da una fenomenologia troppo kantiana, come Sartre ad esempio, l’esternalità rivendicata per la coscienza irriflessa, il suo essere “là fuori” insieme agli oggetti del mondo, non è altro che un’esternalità claustrale, claustrofobica, che rimanda immediatamente ad un dentro camuffato da esterno. Lo stesso dicasi per Heidegger e la sua angoscia, per Levinas e i suoi Altri. Tutti tentativi di demandare il problema del fondamento della correlazione ad un irrelato che però assume subito un carattere paradossale e ambiguo. Una sorta di circolo vizioso tra pre-riflessività e auto-riflessività che, come si diceva poc’anzi, non sfonda realmente verso nessun Grande Fuori. Tutti tentativi questi, come nota giustamente Ferraris, figli della rivoluzione kantiana prima e dell’idealismo trascendentale poi. Non sfuggono alla critica del realista nemmeno le versioni postmoderne del correlazionismo, come ad esempio la filosofia analitica e il costruttivismo. Anch’esse mosse dall’intenzione di individuare nel linguaggio o nel concetto un a-priori al quale ancorare l’esistenza del reale che conosciamo.
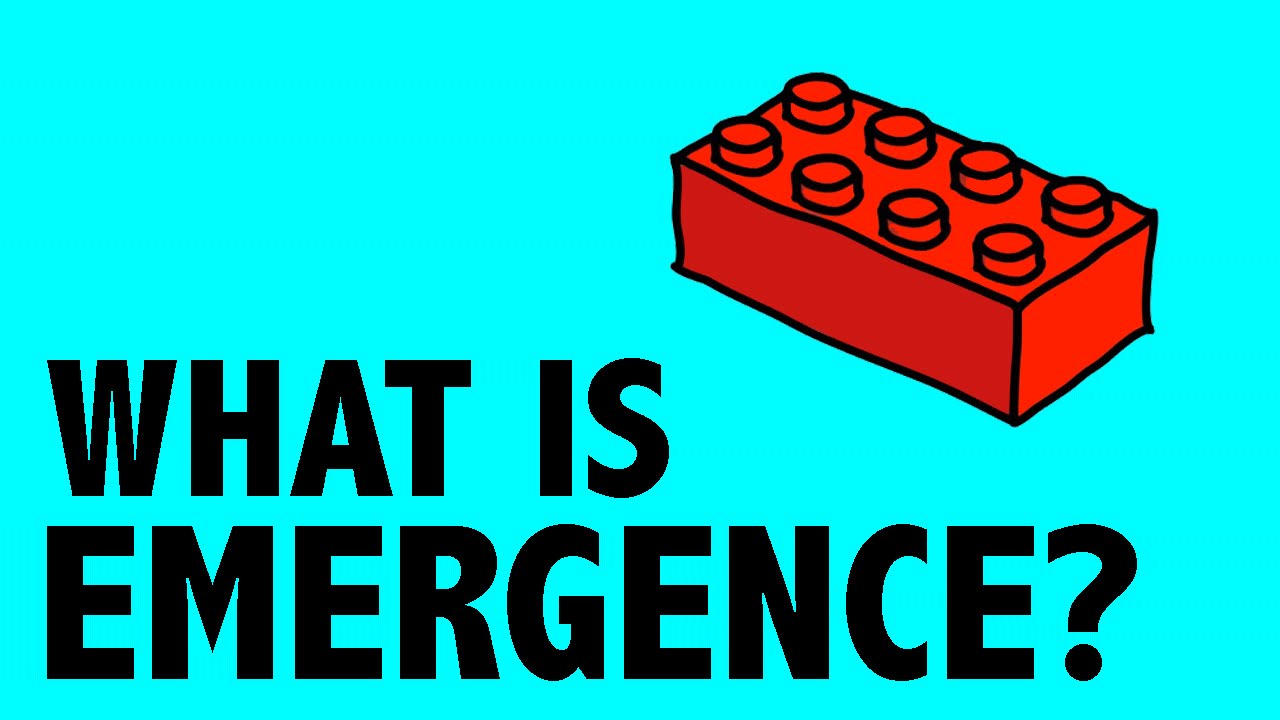
Detto questo, bisogna anche dire però che le argomentazioni di Ferraris corrono su di una linea sottile e sono sempre minacciate dal pericolo di finire nel baratro dell’eccessiva semplificazione. Semplificazione che spalanca poi le porte a facili fraintendimenti. Infatti, una cosa è dire che da Kant in avanti la filosofia dell’esperienza ha messo eccessiva enfasi sul soggetto, rischiando di diventare sempre di più una sorta di antropologia; cosa ben diversa è invece sostenere senza mezzi termini che per l’idealismo trascendentale «il mondo è il frutto della costruzione di un Io penso onnipresente e, almeno sulla carta, onnipotente» (p. 76). E quindi sostenere che per gli idealisti trascendentali il pensiero crea la realtà e dunque nulla esiste all’infuori di quello che penso, assimilando il trascendentalismo al solispsismo. Kant e i suoi successori avrebbero quindi sposato una posizione ontologicamente molto forte secondo la quale la materia non sarebbe pre-esistita allo spirito, identificando completamente ontologia ed epistemologia. Esempio sommo di questo slittamento verso il regno del puro pensiero sarebbe l’attualismo di Gentile. La stessa operazione Ferraris la compie nei confronti del postmodernismo, arrivando quindi a concludere: «l’idea è sempre che ci sia una qualche dipendenza della ontologia dalla epistemologia, ossia, in altre parole, che il Big Bang non abbia potuto aver luogo realmente perché noi non c’eravamo, o che il Big Bang abbia avuto luogo solo perchè noi sappiamo che ha avuto luogo» (pp. 83-84).
Attraverso una simile interpretazione dell’idealismo trascendentale si perde però l’aspetto utile della critica. Qual è infatti il senso di tale critica? Chi scrive ritiene che il senso sia quello di mostrare come da Kant in avanti la filosofia abbia progressivamente rinunciato alla sua vocazione originaria a occuparsi del Tutto. Quel Tutto che, per forza di cose, comprende il soggetto come un suo momento, ma non certo come suo fondamento. Un altro aspetto di questa faccenda che la critica mette in evidenza è il paradosso generato da una soggettività così scettica da mettere in discussione persino la propria stessa capacità di far filosofia, ripiegandosi su se stessa e accettando solo se stessa come metro di tutte le cose. Scetticismo che poi, inevitabilmente, ricade su tutto ciò che non è soggetto, compreso il tanto problematico “mondo esterno”. Ma il problema è così serio proprio perché in questione è il diritto della filosofia a spingersi tanto avanti nel dubbio sul mondo, non perché tale dubbio abbia realmente una valenza ontologica. Che poi la vulgata abbia interpretato la domanda come una domanda ontologica vera e propria fa parte della dispersione intrinseca ad ogni teoria che non possiede una vera e propria pars construens, ma questo Ferraris lo sa certamente molto meglio di chi scrive...
Giacomo Foglietta
-
Estesie #3 – Sul binario della deformazione
Estesie, Serial / Maggio 2016Nel senso più generico del termine, la deformazione consiste nell’alterazione, temporanea o definitiva, della configurazione originaria di un oggetto, e in pittura indica quel processo di alterazione delle forme naturali che porta a risultati spesso considerati mostruosi o aberranti. Attraverso le diverse riflessioni di artisti e filosofi, nel corso del Novecento la deformazione ha però subito una notevole evoluzione concettuale, passando dall’essere concepita come specifico fattore stilistico a processo genetico dello stile in quanto tale, fino a darsi addirittura come mediazione di più larghe operazioni estetiche o extra-pittoriche.

Untitled, Jannis Kounellis (1968)
A inizio Novecento, il simbolista francese Maurice Denis proponeva un’acuta distinzione tra deformazione “oggettiva” e deformazione “soggettiva”: la prima, accostabile alla coeva nozione worringeriana di abstraktion, si costituiva come principio regolatore delle tensioni formali interne all’immagine secondo quelle che Denis definisce le “leggi eterne della decorazione”; la seconda scaturiva dalla necessità di mediare la natura attraverso il proprio “temperamento” psichico. La nuova teoria della pittura di Denis si basa sull’espressione per “equivalenze” e non più per “mimesi”, individuando così le basi di quella che sarà la più valida e genuina pittura contemporanea. Alla luce di quanto si è visto nei decenni a venire, potremmo infatti intravedere in questa coppia polare il seme di due linee stilistiche dominanti nella cultura novecentesca: dalla prima la dipartenza dello sviluppo di tutti i decorativismi geometrici e delle ricerche di arte concreta, mentre dall’altra le contratture segniche e materiche degli espressionismi, manifestatisi nel corso del secolo a più riprese, fino agli esiti figurativi dell’Informale.
Il futurista Carlo Carrà, in un breve e puntuale scritto intitolato proprio La deformazione in pittura e pubblicato sulla rivista «Lacerba» del 15 marzo 1914, afferma che ormai non possa più sussistere opera senza l’intervento della deformazione, considerando questa soluzione non solo come “fattore predominante” nella costruzione del quadro, ma addirittura come un “altimetro” per misurare i vari gradi di espressione plastica di un’opera. Naturalmente, in piena fede futurista, Carrà vede la deformazione come conseguenza del movimento, della necessità di resa dinamistica della realtà e rivanga quel concetto riportato nel Manifesto tecnico della pittura futurista del 1910 secondo cui “per la persistenza dell’immagine nella retina, le cose si moltiplicano”, ma soprattutto “si deformano, susseguendosi, come vibrazioni, nello spazio che percorrono”. Le affermazioni di Carrà riguardano problematiche stilistiche ben precise e circoscritte al loro tempo, ma l’intuizione per cui la deformazione sia alla base di qualunque opera d’arte contemporanea è di una lungimiranza che solo anni dopo e in sede di riflessione estetica avrebbe trovato un più ampio sviluppo. Dovremo perciò aspettare la soglia degli anni Cinquanta perché il concetto di deformazione venga esteso da Maurice Merleau-Ponty fino ad assurgere a sinonimo di stile. Per il fenomenologo francese lo stile è un modo di ricreare i fenomeni e trovare per essi nuove modalità di essere nel mondo, perché solo il pittore riesce a percepire “le norme e le deviazioni dell’inaccessibile pienezza delle cose”. La sua dissertazione sullo stile muove dall’assorbimento sul piano fenomenologico del concetto di “deformazione coerente” formulato da André Malraux (autore esplicitamente richiamato nel titolo con le voci del silenzio), secondo il quale ogni pittore ha un proprio modo consapevole di deformare i dati visibili per risemantizzarli, investirli di nuovi significati. Quasi come in un lontano dialogo con Maurice Denis, anche Merleau-Ponty concepisce lo stile-deformazione come “sistema di equivalenze”, ma aggiunge che solo attraverso “l’indice universale della deformazione coerente” un artista “concentra il senso ancora sparso nella sua percezione e lo fa esistere espressamente”. Qui l’oggettivo e il soggettivo teorizzati da Denis sono come stati fusi in un unico canale di accesso alla realtà attraverso cui il pittore rielabora le qualità dei dati visivi nella più generale prospettiva di una propria definizione stilistica. A proposito di questa assimilazione del concetto di deformazione a quello di stile, andrebbe forse considerato il fatto che gli anni in cui scrive Merleau-Ponty sono anche i graffianti anni dell’Informale, rappresentato in Francia da maestri quali Jean Dubuffet e Jean Fautrier. Corrente pittorica di larga e capillare diffusione, incentrata su problematiche esistenziali affatto estranee al pensiero fenomenologico, essa ha, com’è noto, fervidamente applicato indici di deformazione estrema alle proprie figure, aspetto che può avere giocato un qualche ruolo nelle riflessioni del nostro filosofo.

Jean Dubuffet, Affluence (1961)
Il contributo più articolato sul concetto di deformazione arriva però da un filosofo italiano, sempre di scuola fenomenologica, Miro Martini, allievo di Antonio Banfi e autore di un ampio e complesso saggio intitolato La deformazione estetica, frutto di profonde riflessioni sull’atto estetico come atto deformante. Si tratta di un sistema che ingloba e sostiene la corrispondenza cara a Merleau-Ponty tra deformazione e stile, ma che va ben oltre i comuni processi di formalizzazione artistica per aprirsi al più generale piano dell’estetica. Martini estende tale concetto “all’intero mondo estetico nella varietà dei suoi piani fondamentali”, quasi intuendo che l’orizzonte mediale dell’arte si sarebbe a breve espanso enormemente fino a coincidere con quello della quotidianità; secondo Dino Formaggio, con questa “legge dell’esistere artistico in concreta esperienza” Martini intendeva sostenere che “l’arte compie un’opera di trans-valutazione dei momenti della vita, del vivere di ogni giorno”, una traslazione del mondano nell’artistico attraverso quella che oggi con Arthur Danto diremmo una trasfigurazione del banale. Si tratta di sottrarre quindi elementi concreti e dinamiche del quotidiano alla loro comune funzione pratico-utilitaristica per riscattarli esteticamente o, come rimarca Formaggio, “a dar forma compiuta e nobiltà di stile ad ogni esperienza del vivere”. Conferme pratiche alle idee di Martini sarebbero arrivate solo anni e anni dopo la sua scomparsa con fenomeni quali lo happening, la performance, l’Antiform o le poetiche del Concettuale; ma mi pare piuttosto significativo che nella Milano di metà anni Cinquanta, e poco dopo l’uscita (purtroppo postuma) del testo di Miro Martini, artisti spazialisti come Agostino Bonalumi o Enrico Castellani cominciassero a intervenire su delle tele monocrome per dilatarle, estrofletterle, alterandone la configurazione di base e sperimentando così la deformazione non più sul piano virtuale della figurazione, bensì su quello della piena materialità (pur rimanendo ancora legati a un supporto artistico tradizionale), producendo in definitiva una sorta di sinergia tra teorie e poetiche contemporanee, e riuscendo anzi a dare alle idee martiniane un’indiretta e probabilmente inconsapevole convalida.
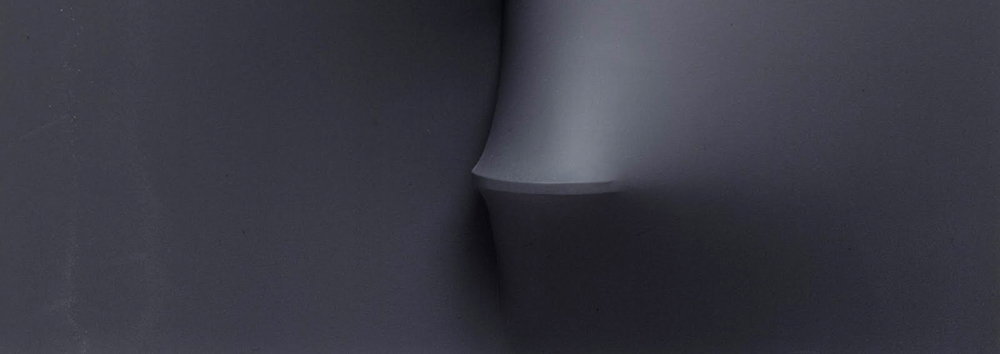
Agostino Bonalumi, Senza titolo - nero (1968)
Ecco dunque emerso lo status “bipolare” del concetto di deformazione nella cultura del Novecento, dove al primo polo, quello originario o dell’uso comune del termine e relativo a questioni plastico-formali (deformazione come alterazione di configurazione), se ne affianca un altro relativo a ridefinizioni artistiche dell’esperienza tramite mezzi, elementi e modalità dell’esperienza stessa (deformazione come stile e, solo dopo, come riformulazione estetica del quotidiano), ampliando così ad libitum le possibilità pratiche di stilizzazione. Quello tra deformazione plastica e deformazione estetica non è tuttavia un conflitto insolubile o un eterno scontro tra nemici giurati, ma al contrario una quieta e fruttuosa convivenza, spesso di reciproco supporto: le due istanze si incrociano e dialogano sempre più di frequente, e soprattutto oggi, nell’uso di mezzi come la fotografia o il video ormai divenuti imprescindibili per la ricerca contemporanea. La deformazione plastica, infatti, ha trovato in questi strumenti vie di aggiornamento oggi battutissime come l’uso delle distorsioni, delle alterazioni di segnale, e manipolazioni di ogni sorta, per le quali è proprio la deformazione estetica, lanciata nella prospettiva di una potenziale pan-artisticità dell’esperienza, a garantirne il valore espressivo. Da qui in poi, il concetto di deformazione in ambito artistico non potrà che vivere dunque di alternanze e distinzioni, ma questo suo bipolarismo lo manterrà, senza dubbio, fiamma di ogni dibattito sullo stile, sulle poetiche, sull’esistenza dell’arte. Attuale per sempre.
di Pasquale Fameli
Bibliografia
Carrà, C. (1978). La deformazione in pittura (1914). In M. Carrà (a cura di), Carlo Carrà. Tutti gli scritti (pp. 30-33). Milano: Feltrinelli.
Danto, A. (2008). La trasfigurazione del banale. Una filosofia dell’arte (1981). Bari: Laterza.
Denis, M. (1920). Théories 1890-1910. Du symbolisme et de Gauguin vers un nouvel ordre classique (1913). Paris: L. Rouart et J. Watelin Éditeurs; in particolare pp. 23, 268.
Martini, M. (2002). La deformazione estetica (1955). Milano: Unicopli; in particolare: pp. 55-57. Si veda inoltre la prefazione alla seconda edizione di Dino Formaggio, in particolare pp. 2-3.
Merleau-Ponty, M. (1967). “Il linguaggio indiretto e le voci del silenzio” (1952). In Id., Segni. Milano: Saggiatore; in particolare p. 81.
Worringer, W. (1976). Astrazione e empatia (1907). Torino: Einaudi.
-
Ancora troppo umani. Il postumano di Giovanni Leghissa
Recensioni / Ottobre 2015 Nel suo saggio Postumani per scelta. Verso un’ecosofia dei collettivi, ospite della collana “Spiritualità senza Dio?” diretta da Luigi Berzano, Giovanni Leghissa dà unitarietà a un tema che ormai lo vede occupato da alcuni anni (La fondazione, la fondazione dell’umano, il post-umano, 2013; Il postumano: un nuovo paradigma?, 2013; curatela di aut aut, La condizione postumana, 2014). Nonostante la brevità del saggio, l’autore si propone di soddisfare la duplice esigenza teorica di inquadrare da più vicino lo sfuggente dibattito sulla questione postumana e, insieme, di estrarne una possibile interpretazione critica. Così, alla messa in ordine di linee guida di una discussione spesso frammentaria, si affianca l’argomentazione di una tesi, frutto dell’incontro di assi di ricerca eterogenei ma convergenti. Le fonti e le questioni interpellate sono infatti numerose e provenienti dalle più disparate aree del sapere filosofico. Tra i “maestri” e le tradizioni di pensiero che vediamo avvicendarsi figurano l’illuminismo, l’evoluzionismo, la filosofia francese del dopoguerra, l’epistemologia, la fenomenologia husserliana, l’idea di un sapere enciclopedico alla Enzo Paci, la decostruzione e l’antropologia filosofica di Hans Blumenberg. Come dichiara l’autore, si tratterà allora di seguire questi molteplici stimoli nell’intento di definire la condizione postumana in termini filosofici, individuando e descrivendo schematicamente gli atteggiamenti caratteristici del suo approccio.
Nel suo saggio Postumani per scelta. Verso un’ecosofia dei collettivi, ospite della collana “Spiritualità senza Dio?” diretta da Luigi Berzano, Giovanni Leghissa dà unitarietà a un tema che ormai lo vede occupato da alcuni anni (La fondazione, la fondazione dell’umano, il post-umano, 2013; Il postumano: un nuovo paradigma?, 2013; curatela di aut aut, La condizione postumana, 2014). Nonostante la brevità del saggio, l’autore si propone di soddisfare la duplice esigenza teorica di inquadrare da più vicino lo sfuggente dibattito sulla questione postumana e, insieme, di estrarne una possibile interpretazione critica. Così, alla messa in ordine di linee guida di una discussione spesso frammentaria, si affianca l’argomentazione di una tesi, frutto dell’incontro di assi di ricerca eterogenei ma convergenti. Le fonti e le questioni interpellate sono infatti numerose e provenienti dalle più disparate aree del sapere filosofico. Tra i “maestri” e le tradizioni di pensiero che vediamo avvicendarsi figurano l’illuminismo, l’evoluzionismo, la filosofia francese del dopoguerra, l’epistemologia, la fenomenologia husserliana, l’idea di un sapere enciclopedico alla Enzo Paci, la decostruzione e l’antropologia filosofica di Hans Blumenberg. Come dichiara l’autore, si tratterà allora di seguire questi molteplici stimoli nell’intento di definire la condizione postumana in termini filosofici, individuando e descrivendo schematicamente gli atteggiamenti caratteristici del suo approccio. -
PK#1 \ Il prisma trascendentale. I colori del reale
Rivista / Settembre 2014Non occorre un grande impegno teorico per mostrare come si possa fare filosofia senza ricorrere alla nozione di “trascendentale” ‒ oppure, in maniera più profonda, senza assumere la posizione trascendentale. Lo mostra, banalmente, la storia del pensiero filosofico novecentesco. Dalla filosofia analitica alla filosofia ermeneutica, non si contano le tradizioni filosofiche che hanno reso persuasiva l’idea secondo cui l’interrogazione filosofica potesse ‒ e, anzi, dovesse ‒ articolarsi senza ripetere il gesto fondativo, ovvero senza declinare la domanda sulla fondazione in modo tale da dover passare attraverso la questione trascendentale.
Si fa prima se si interrogano i saperi che descrivono ‒ o spiegano ‒ l’esperienza. Si fa prima se si imposta il discorso filosofico immettendolo nell’alveo del discorso scientifico, il quale parla direttamente dell’esperienza. Un po’ come quando si deve insegnare a qualcuno come si nuota. Gli si mostrano i gesti del nuoto stando sulla riva? No, lo si butta in acqua, magari in acque poco profonde, e gli si insegna, dentro l’acqua, a nuotare. Così, appunto, si fa prima. Assumere la posizione trascendentale, in tale prospettiva, non risulta essere altro che un’inutile perdita di tempo.
Tuttavia, è lecito almeno sollevare un dubbio: si può davvero accordare alla filosofia il ruolo di sapere critico, che interroga i propri fondamenti, quelli degli altri saperi e, più in generale, il fondamento del rapporto tra sapere ed esperienza, senza passare attraverso la nozione di trascendentale? Si può davvero fare a meno di chiedersi sia come è fatto, in generale, il soggetto che fa esperienza del mondo, sia come sono fatti quei mondi ai quali si rapporta ogni esperienza possibile?
Se tale domanda, tale dubbio, risulta anche solo vagamente plausibile, allora si vede bene che perseguire l’obiettivo di praticare una filosofia in qualche modo definibile come “trascendentale” non si configura più come una semplice perdita di tempo.
Tutta la difficoltà sta, ora, nel mettersi d’accordo su ciò che l’espressione “in qualche modo” indica. Lo scopo di questo primo numero consiste nel mettere alla prova alcune possibili letture e declinazioni di tale espressione
A cura di Philosophy Kitchen
Scarica in PDF
English version
DOI: https://doi.org/10.13135/2385-1945/1.2014
Pubblicato: settembre 2014
Indice
Lato I
Giovanni Leghissa - Il trascendentale, ovvero il rimosso della filosofia. Proposte per una terapia [PDF It]
Rocco Ronchi - Puro apparire [PDF It]
Jean-Christophe Goddard - La Wissenschaftslehre. Une contribution décisive à l'anthropologie de la modernité [PDF Fr]
Lato II
Claudio Tarditi - Oltre il trascendentale, il trascendentale. In dialogo con Husserl [PDF It]
Paolo Vignola - La stupida genesi del pensiero. Trascendentale e sintomatologia in G. Deleuze [PDF It]
Lato III
Alberto Andronico - Custodire il vuoto. Uno studio sul fondamento del sistema giuridico [PDF It]
Emanuela Magno - Dal pensiero alla vacuità. La critica nāgārjuniana e il trascendentale [PDF It]
Carlo Molinar Min - Il ritmo della decostruzione. Un'esperienza quasi-trascendentale [PDF It]
Lato IV
Alessandro Salice, Genki Uemura - Naturalizzare la fenomenologia senza naturalismo [PDF It]
Traduzioni
Bernard Stiegler - Tempo e individuazione tecnica, psichica e collettiva nell’opera di Simondon [PDF It]
Claude Romano - Il problema del mondo e l'olismo dell'esperienza [PDF It]
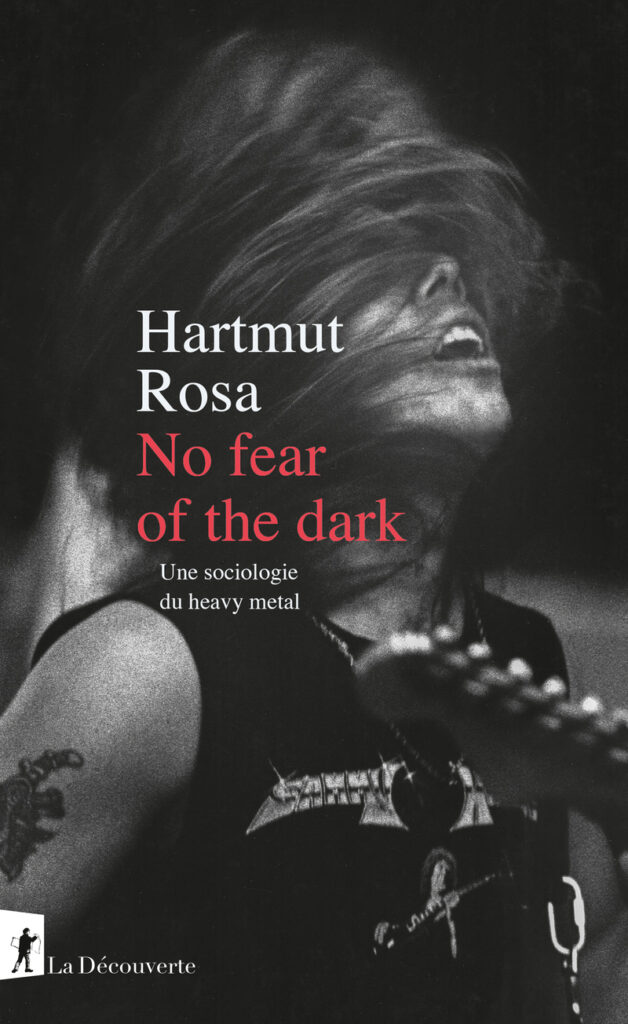
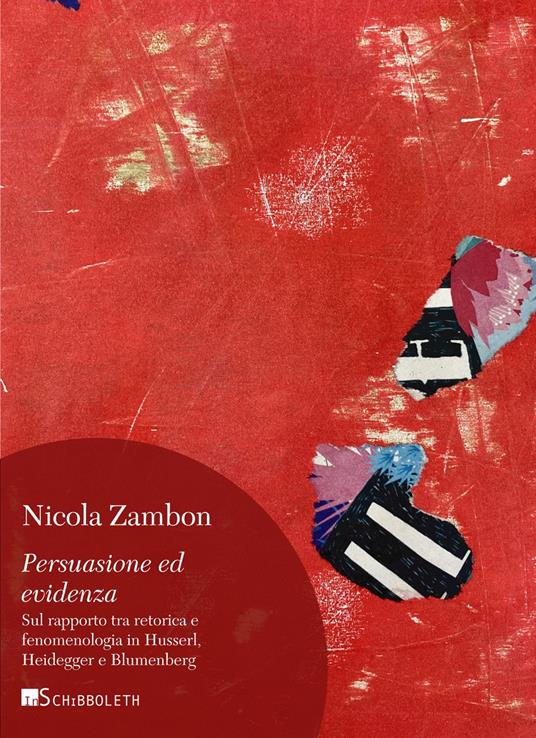



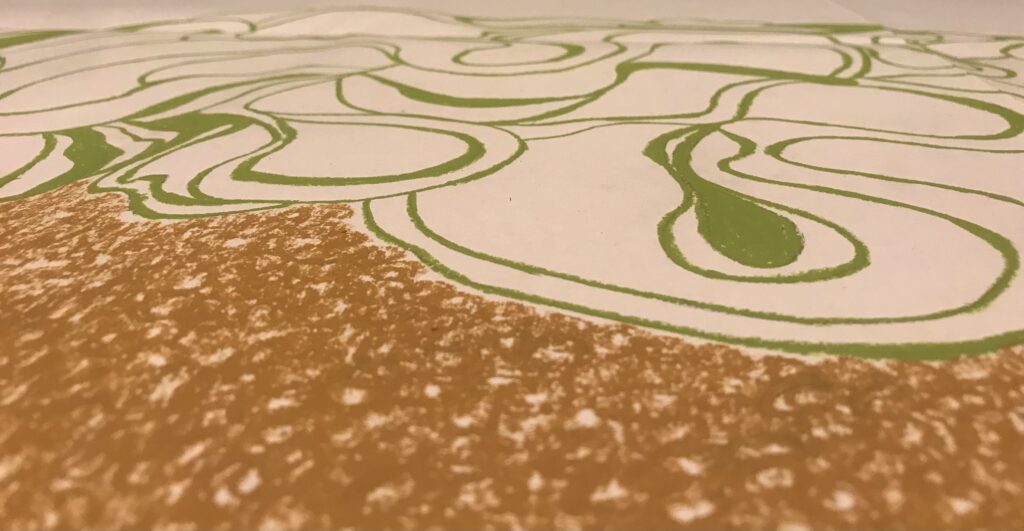

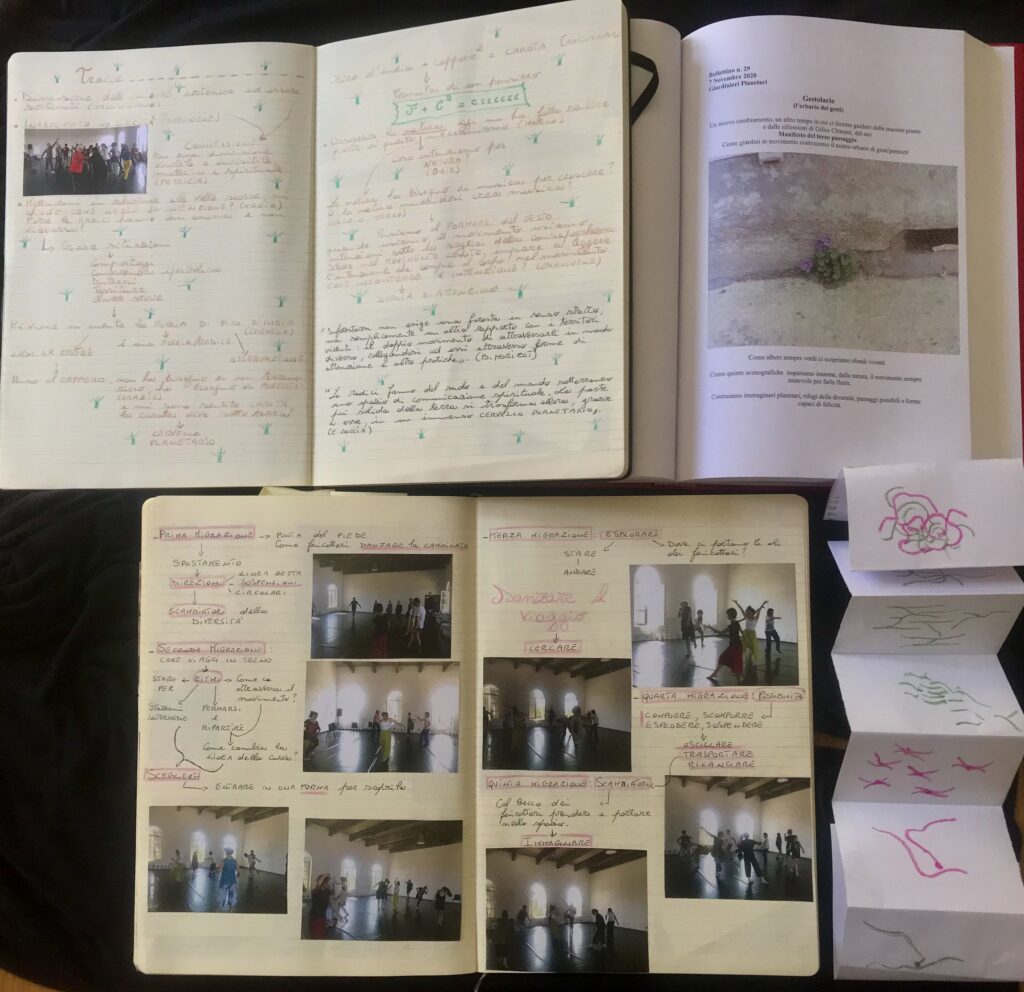
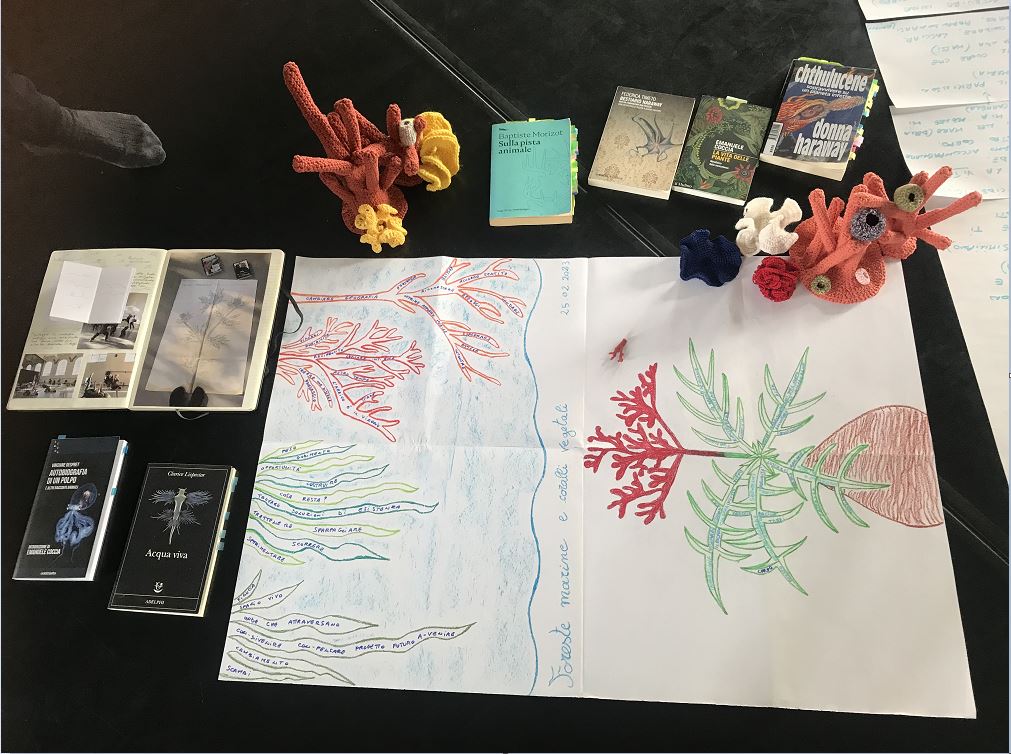
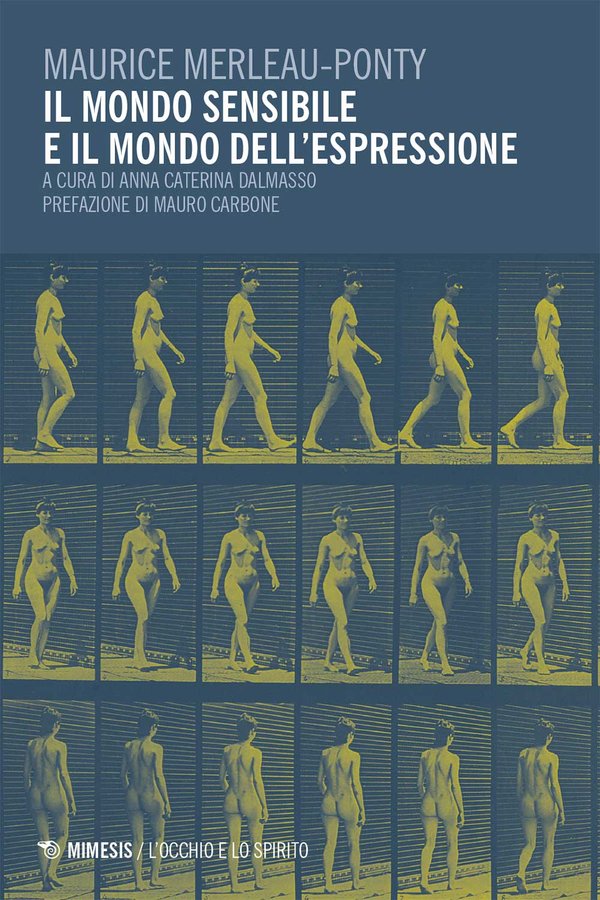


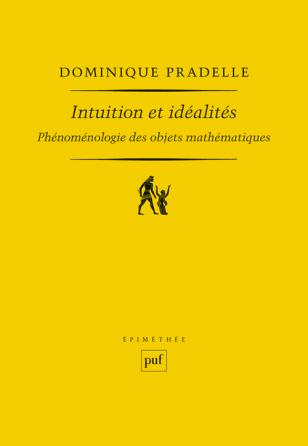
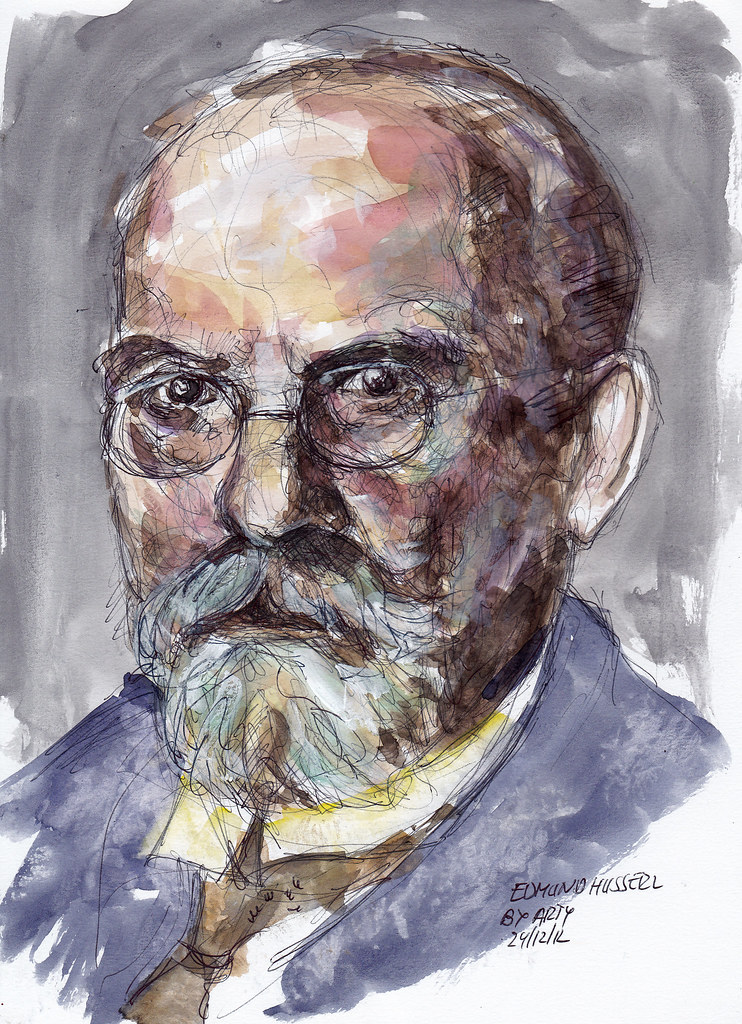
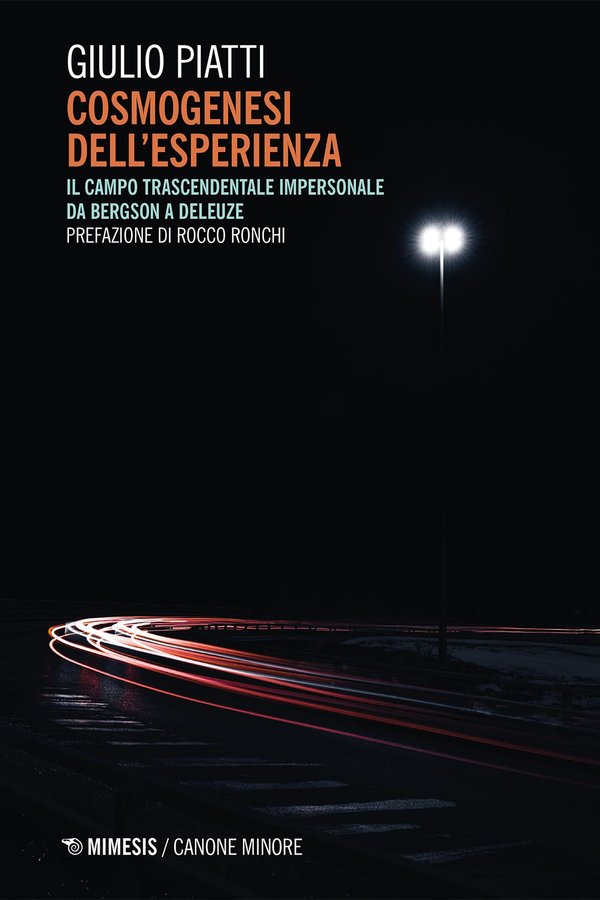
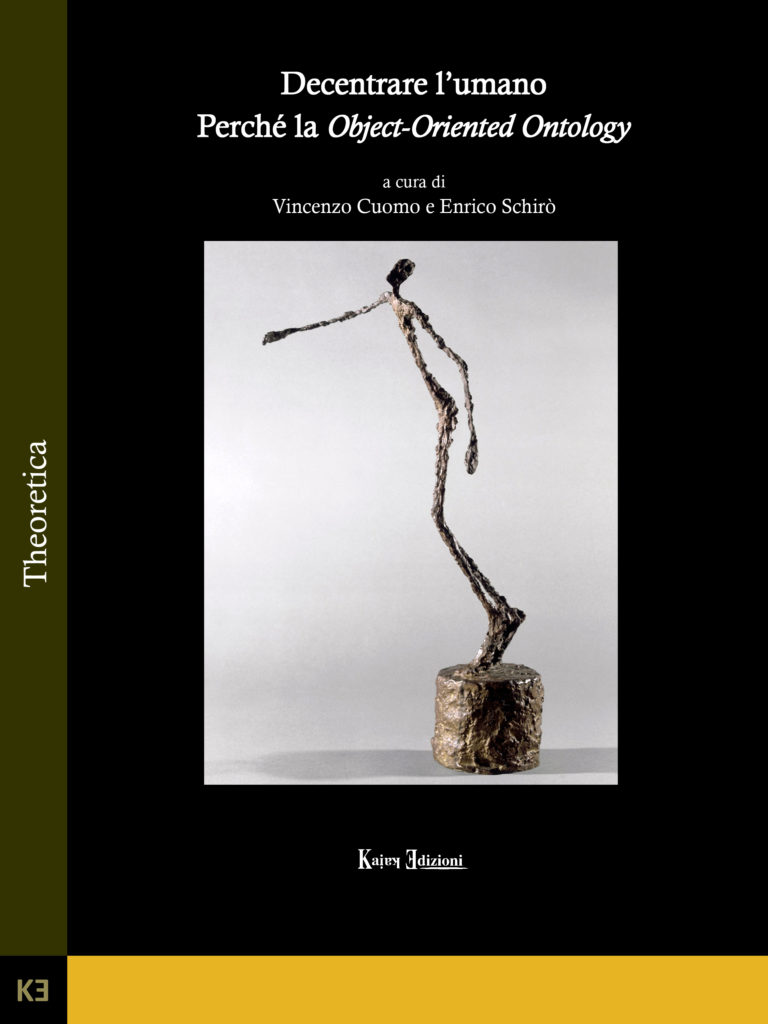

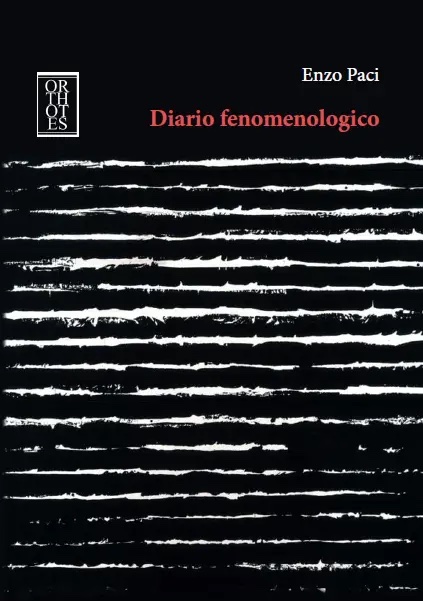
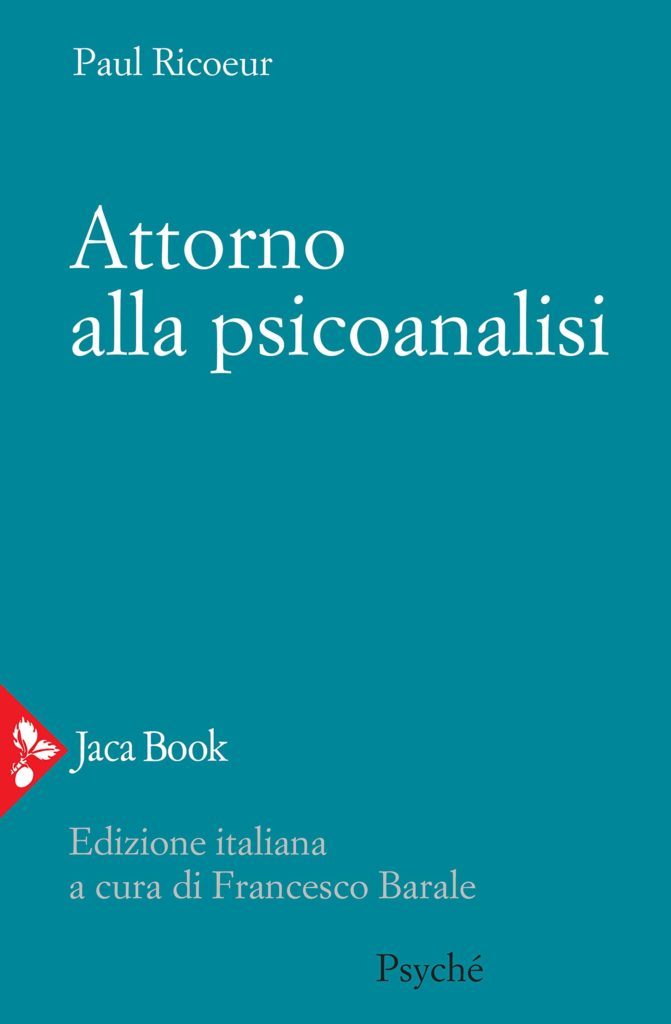


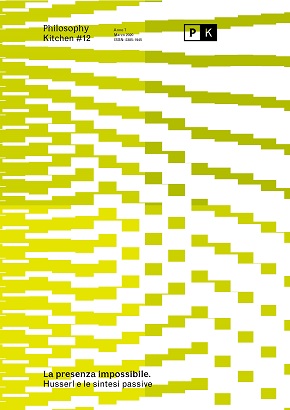


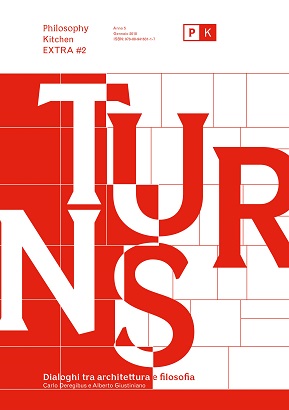
 È finalmente disponibile nella traduzione italiana l'opera che ha portato alla ribalta della scena intellettuale e accademica mondiale l'antropologo brasiliano Eduardo Viveiros De Castro:
È finalmente disponibile nella traduzione italiana l'opera che ha portato alla ribalta della scena intellettuale e accademica mondiale l'antropologo brasiliano Eduardo Viveiros De Castro: 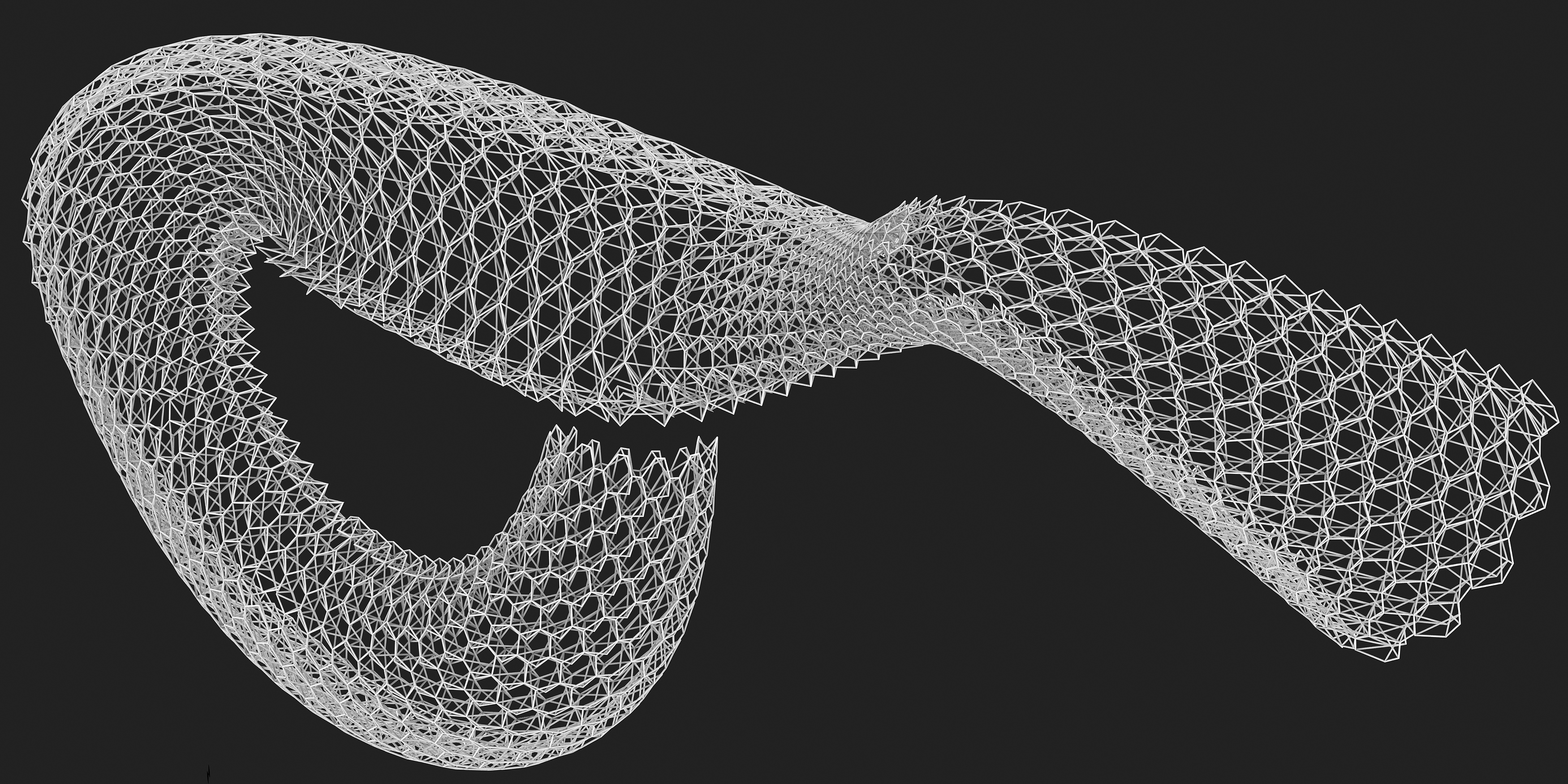
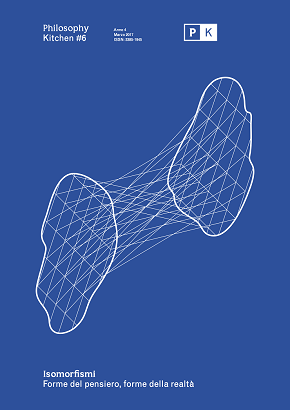
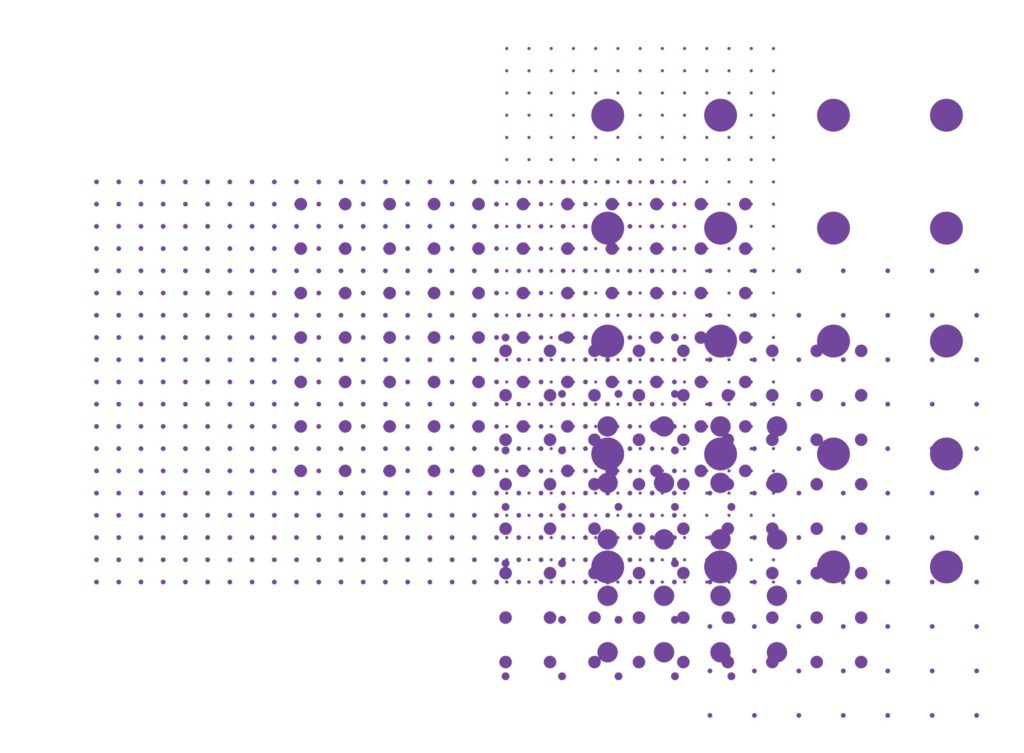
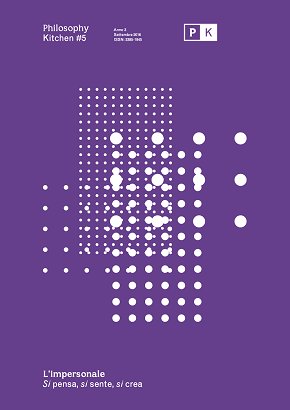

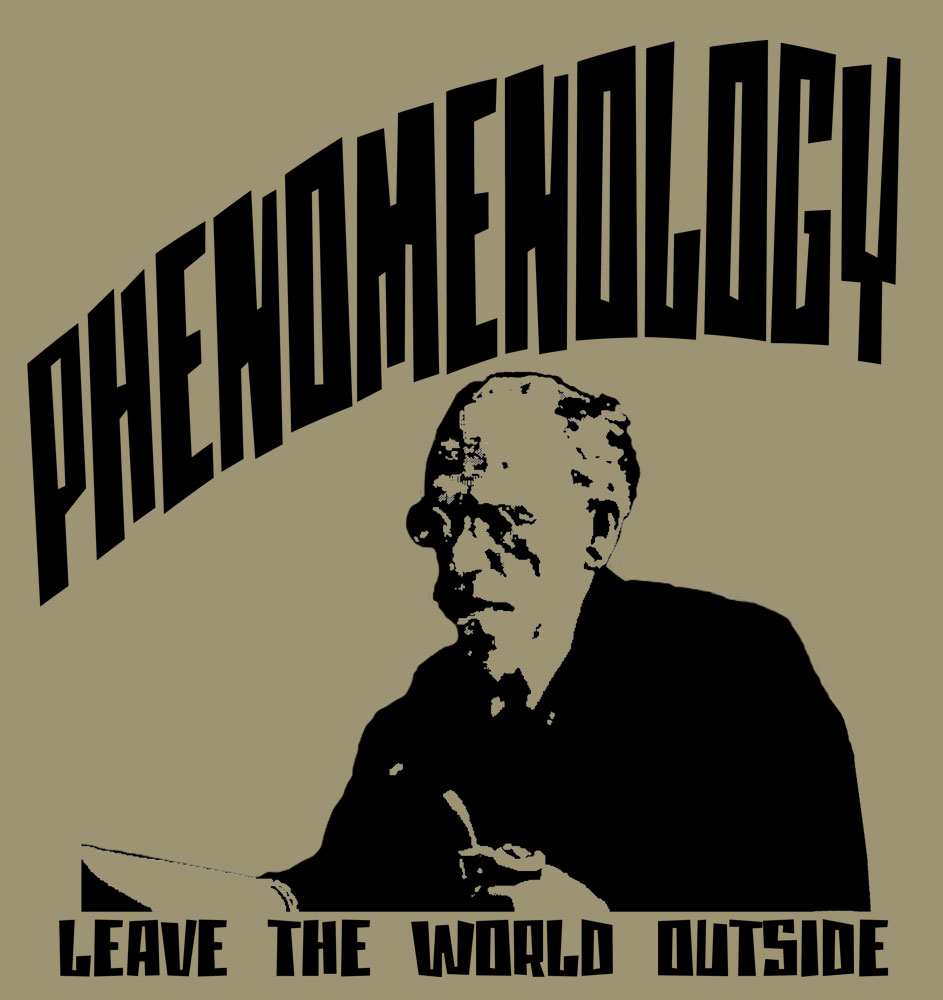
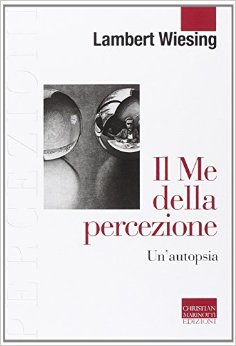

 zione ridisegnata da Wiesing, il trittico soggetto/oggetto/percezione si riconfigura, portando in primo piano la percezione come suo centro propulsore, in maniera non dissimile da quanto portato avanti, in un altro contesto, da Gilbert Simondon prima e da Bernard Stiegler oggi: nel passaggio all’individuazione non bisogna concentrarsi né sull’origine né sul termine, ma sul processo trasduttivo e relazionale in grado di articolare i due momenti. Al di qua della sclerotizzazione tra un soggettivismo autoreferenziale e un oggettivismo semplicistico, Simondon, Stiegler e Wiesing, in modi ovviamente differenti, propongono uno sguardo “terzo”, bergsonianamente orientato sui movimenti che riconfigurano le essenze statiche in poli di un processo.
zione ridisegnata da Wiesing, il trittico soggetto/oggetto/percezione si riconfigura, portando in primo piano la percezione come suo centro propulsore, in maniera non dissimile da quanto portato avanti, in un altro contesto, da Gilbert Simondon prima e da Bernard Stiegler oggi: nel passaggio all’individuazione non bisogna concentrarsi né sull’origine né sul termine, ma sul processo trasduttivo e relazionale in grado di articolare i due momenti. Al di qua della sclerotizzazione tra un soggettivismo autoreferenziale e un oggettivismo semplicistico, Simondon, Stiegler e Wiesing, in modi ovviamente differenti, propongono uno sguardo “terzo”, bergsonianamente orientato sui movimenti che riconfigurano le essenze statiche in poli di un processo.