TURNS. Dialoghi tra architettura e filosofia è la traccia di un dialogo spesso acceso, ricco di incomprensioni e riconciliazioni, che coinvolge architetti e filosofi, docenti e professionisti, e ancora biologi, dottori di ricerca, studenti. È il racconto di due discipline, architettura e filosofia, che si voltano per guardarsi reciprocamente, provando a innescare una svolta concettuale che deve divenire un nuovo punto di partenza. Precisamente questo è il doppio significato del termine “Turns”.
Da un lato infatti, il filosofo ha sempre avuto difficoltà a interloquire con l’architetto, sia per ragioni storiche sia per ragioni strettamente legate al suo metodo e ai suoi obiettivi. L’architetto sembra infatti presentarsi allo sguardo del filosofo come un personaggio al contempo perturbante e conturbante, in un misto di attrazione e biasimo, di invidia e ammirazione: una figura tanto sfuggente da investire la riflessione filosofica con effetto retroattivo, facendo scricchiolare le sue fondamenta concettuali e mettendo in dubbio nozioni fondamentali quali verità, libertà, realtà, conoscenza, invenzione, possibilità, necessità, che hanno rappresentato per secoli il lessico base del pensiero occidentale. L’interesse verso una simile figura sembrerebbe ovvio. Eppure, quasi sempre è il filosofo che viene interpellato, utilizzato o coinvolto nel lavoro dell’architetto, in molti casi con l’intento di distillare spazialmente il senso dei suoi discorsi nel progetto. Non che ciò sia impossibile, ma, forse, dovremmo domandarci se è proprio questo quello che vogliamo: o se invece non sia compito del filosofo esercitare una sistematica e implacabile strategia di provocazione interessata, al fine di produrre un effetto, una particolare condizione dello sguardo. Creare la crisi, mettendo in discussione ciò che è dato, sapendo che, come spesso accade, l’apertura verso un nuovo oggetto di conoscenza lascia insoluti quei quesiti che lo vedono direttamente implicato per produrre un effetto retroattivo di chiarificazione nel soggetto indagatore, impegnato a leggersi ora attraverso una nuova forma di mediazione.
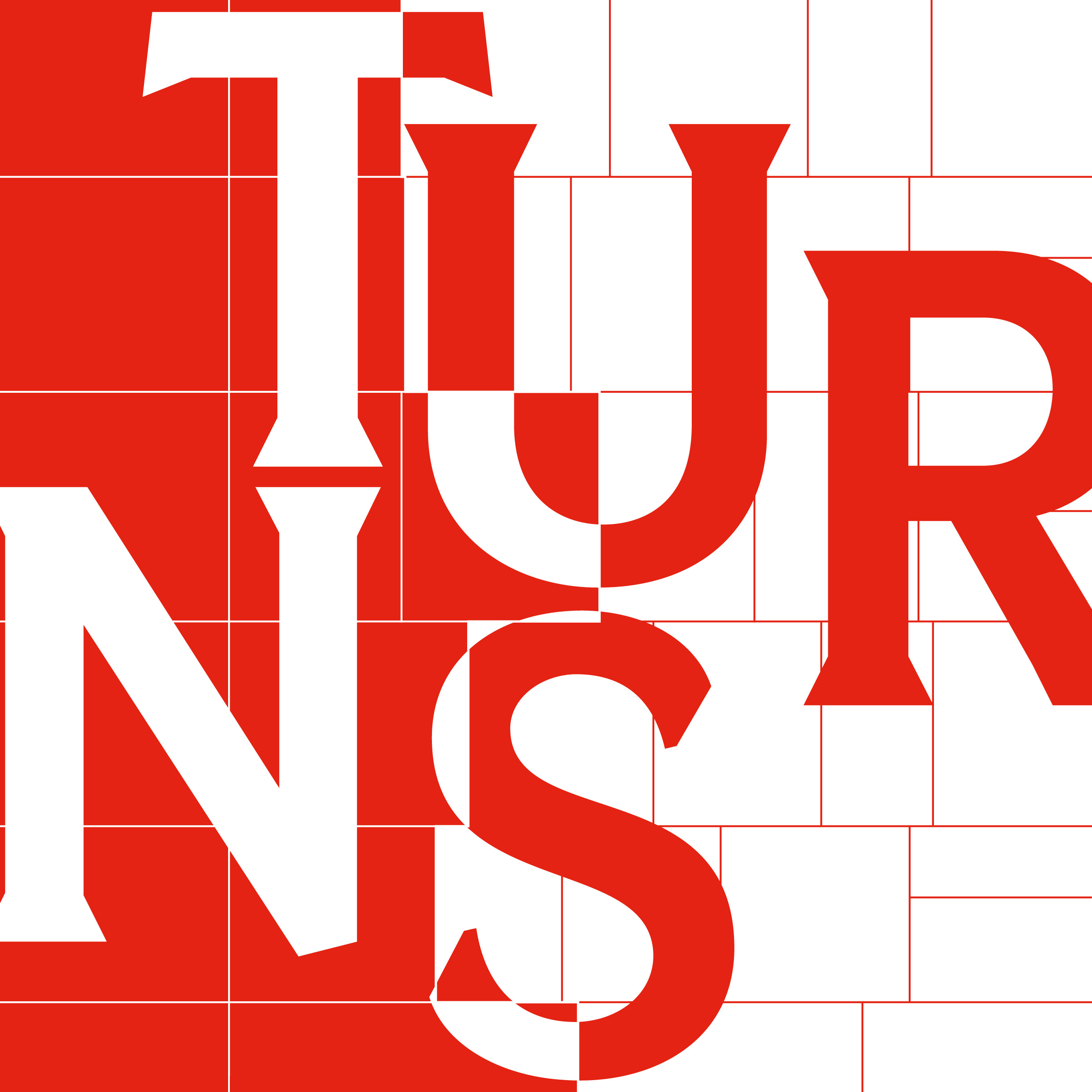
Dall’altro lato, per l’architettura il rapporto con la filosofia è storicamente naturale, quasi che questa fosse una visione complementare sul mondo rispetto al suo operato: questo era possibile perché la società si evolveva in modo relativamente lento, attraverso sedimentazioni di usi che diventavano convenzioni sociali, di pensiero, di stile. Così andava nell’architettura egizia, in quella classica, nel medioevo, nel rinascimento, finanche nel Modernismo: i significati erano decifrabili perché si condivideva un sostrato convenzionale. Ma qualcosa è cambiato. Le correnti durano pochi anni: poi passano, come le mode, spesso senza lasciar traccia – tranne edifici già superati, ovviamente. Così, spariscono le teorie dell’architettura, cioè sistemi che dicano cosa sia giusto costruire. E senza una teoria che legittimi le scelte, fioriscono le retoriche e le poetiche personali, spesso così ridicole da essere persino (e giustamente) oggetto di satira. La condizione di fragilità dell’architettura contemporanea è ormai fisiologica. Ed è qui che la filosofia diventa non solo utile, ma necessaria. A patto, certo, di non usarla in senso analogico, con derivazioni dirette che trasformano concetti in forme e pensieri in stili. Dialogare con i filosofi serve perché essi ragionano su temi che, in qualche modo, toccano gli architetti – ad esempio, lo spazio, l’invenzione, la città, la generazione della forma, il potere. Capire qualcosa di quei temi aiuterà a progettare con una maggior consapevolezza, o una più approfondita convinzione sulle ragioni del progetto, e a capirne meglio effetti ed esiti.
A cura di Carlo Deregibus e Alberto Giustiniano
Pubblicato: gennaio 2018
Indice
(S)Block-Seminar
.
DA LASCAUX AI JUNKSPACE
Giovanni Leghissa - Da Lascaux ai junkspaces (passando per Ippodamo da Mileto) [PDF It]
Giovanni Durbiano – Descrivere il progetto dello spazio [PDF It]
Riccardo Palma – Molteplicità e non naturalità degli spazi nella produzione del progetto di architettura [PDF It]
DIALOGHI [PDF It]
RIFERIMENTI di Andrea Dutto [PDF It]
.
DECOSTRUZIONE, IMMANENZA, ILOMORFISMO
Giulio Piatti – Simondon e Deleuze di fronte all’ilomorfismo. Appunti sul rapporto forma-materia [PDF It]
Carlo Deregibus – Appunti su Chōra, spazio e architettura. Da Platone a Derrida [PDF It]
Paola Gregory – Le nuove scienze e la conquista dell’informale [PDF It]
Riccardo Palma – L’assenza necessaria dell’architettura [PDF It]
DIALOGHI [PDF It]
RIFERIMENTI di Andrea Canclini [PDF It]
.
FENOMENOLOGIA E PROGETTO
Claudio Tarditi – Fenomenologia e architettura. Introduzione al problema della percezione spaziale in Edmund Husserl [PDF It]
Alberto Giustiniano – Tempo, forma, azione. Il senso del progetto nel dialogo tra Enzo Paci e Ernesto Nathan Rogers [PDF It]
Silvia Malcovati – Per un razionalismo relazionale [PDF It]
Carlo Deregibus – L’orizzonte del progetto e la responsabilità dell’architetto [PDF It]
DIALOGHI [PDF It]
RIFERIMENTI di Federico Tosca [PDF It]
.
MORFOGENESI E AUTOORGANIZZAZIONE
Veronica Cavedagna & Danilo Zagaria - Quale spazio per la morfogenesi e l'auto-organizzazione? [PDF It]
Paola Gregory – Morfogenesi architettonica e “vita artificiale” [PDF It]
Carlo Deregibus – Progetto e complessità. Fascino dell’analogia e libero arbitrio [PDF It]
DIALOGHI [PDF It]
RIFERIMENTI di Edoardo Fregonese [PDF It]
.
ANTROPOGENESI E COSTRUZIONE DELLO SPAZIO
Roberto Mastroianni – Regimi dello sguardo. Sloterdijk e la metafora spaziale [PDF It]
DIALOGHI_1 [PDF It]
Alessandro Armando – La scrittura del futuro e la promessa del progetto [PDF It]
Daniele Campobenedetto – Leggibilità e materialità dello spazio [PDF It]
DIALOGHI_2 [PDF It]
RIFERIMENTI di Federico Cesareo [PDF It]
.
POTERE E SPAZIO
Luigi Giroldo – Genealogie dello spazio contemporaneo. Utopie moderne e nascita dell’urbanistica [PDF It]
DIALOGHI [PDF It]
RIFERIMENTI di Andrea Canclini [PDF It]
BIBLIOGRAFIA
.









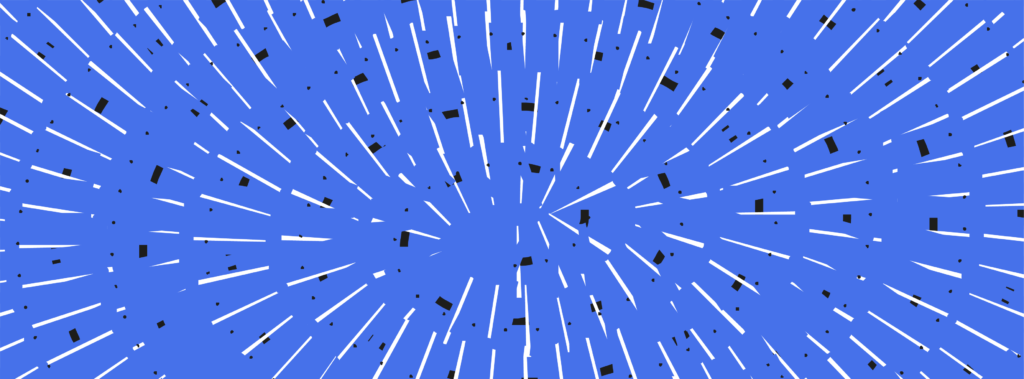
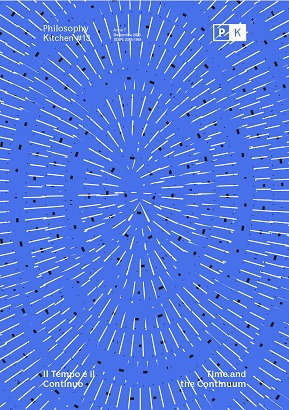

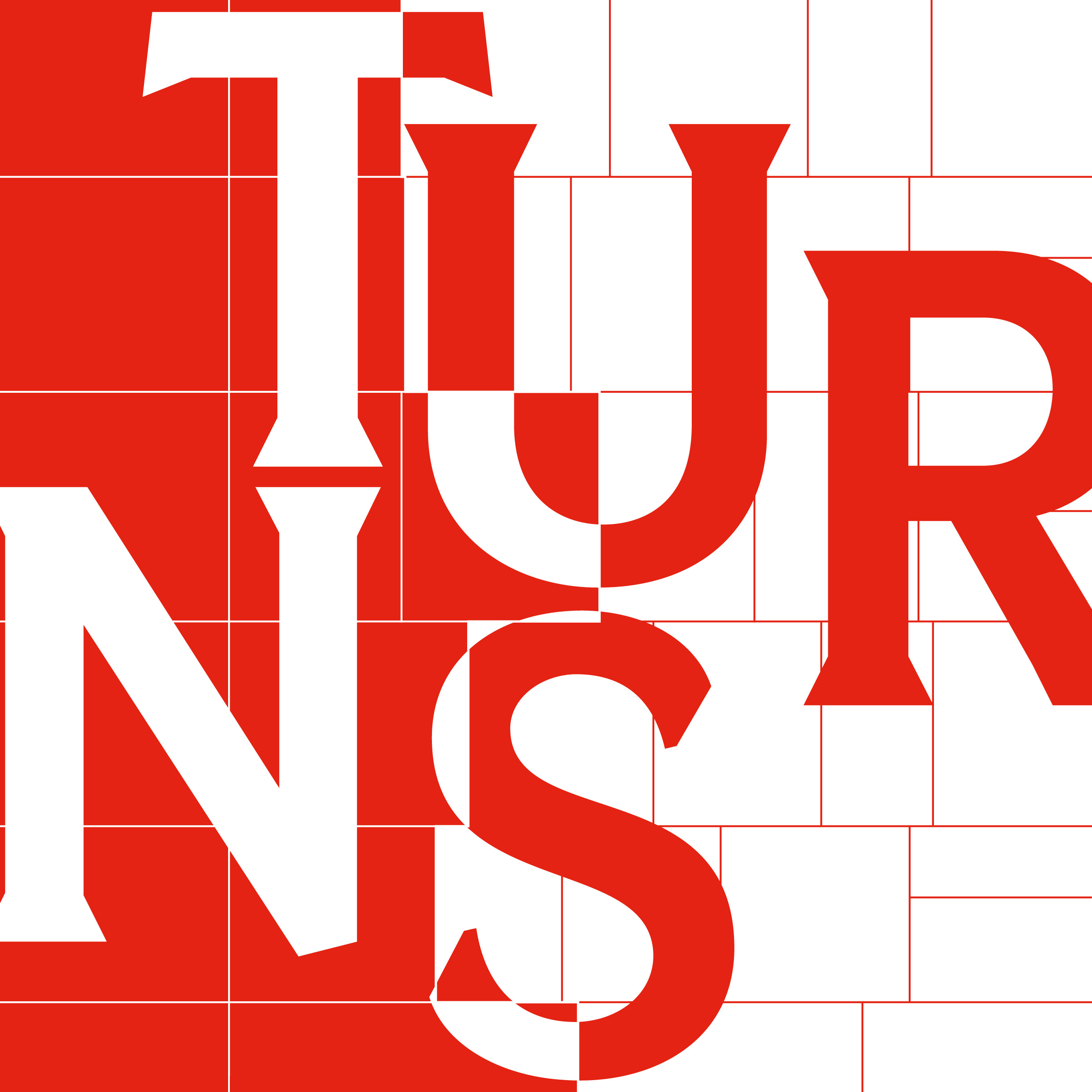
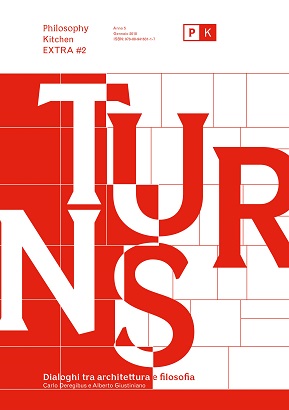



 Il rompicapo della realtà. Metafisica, ontologia e filosofia della mente in E. J. Lowe (Mimesis, Milano 2015) di Timothy Tambassi è la prima monografia dedicata interamente al pensiero di Lowe, il quale ha contribuito a impreziosirla seguendone la stesura passo per passo fino alla versione definitiva (la tesi di dottorato dell’autore) senza tuttavia potere assistere alla pubblicazione del volume, avvenuta a poco più di un anno dalla morte dello stesso Lowe. Il sottotitolo rivela il contenuto vero e proprio del libro: non ogni aspetto della ricerca di Lowe, ma quelli considerati più aderenti al suo nucleo teoretico, ossia la metafisica, l’ontologia e la filosofia della mente, a cui corrispondono i tre capitoli del libro. Più in particolare, Tambassi mira a mostrare la stretta connessione sussistente fra questi aspetti della proposta loweiana, la loro costitutiva apertura ai risultati delle scienze e, più in generale, ad altre forme di indagine della realtà. Secondo Lowe, infatti, la riflessione metafisica – focalizzata sui tre concetti cardine di realtà, di sostanza e di risorse esplicative – costituisce lo sfondo concettuale imprescindibile dell’ontologia e della filosofia della mente e conseguentemente, attraverso queste ultime, di ogni altra forma di indagine della realtà. Come vedremo, però, la scelta di presentare una sintesi coerente solo del nucleo essenziale della proposta loweiana, se da un lato abbrevia certamente la via per l’acquisizione di una certa dimestichezza col suo pensiero, dall’altro, però, rischia di contrarre nella pura dimensione dell’implicito la ricchezza di temi e questioni che pure hanno caratterizzato il lavoro filosofico di Lowe e che intrattengono un ruolo di continuo scambio col suo nucleo – e non semplicemente di mera applicazione o conseguenza.
Il rompicapo della realtà. Metafisica, ontologia e filosofia della mente in E. J. Lowe (Mimesis, Milano 2015) di Timothy Tambassi è la prima monografia dedicata interamente al pensiero di Lowe, il quale ha contribuito a impreziosirla seguendone la stesura passo per passo fino alla versione definitiva (la tesi di dottorato dell’autore) senza tuttavia potere assistere alla pubblicazione del volume, avvenuta a poco più di un anno dalla morte dello stesso Lowe. Il sottotitolo rivela il contenuto vero e proprio del libro: non ogni aspetto della ricerca di Lowe, ma quelli considerati più aderenti al suo nucleo teoretico, ossia la metafisica, l’ontologia e la filosofia della mente, a cui corrispondono i tre capitoli del libro. Più in particolare, Tambassi mira a mostrare la stretta connessione sussistente fra questi aspetti della proposta loweiana, la loro costitutiva apertura ai risultati delle scienze e, più in generale, ad altre forme di indagine della realtà. Secondo Lowe, infatti, la riflessione metafisica – focalizzata sui tre concetti cardine di realtà, di sostanza e di risorse esplicative – costituisce lo sfondo concettuale imprescindibile dell’ontologia e della filosofia della mente e conseguentemente, attraverso queste ultime, di ogni altra forma di indagine della realtà. Come vedremo, però, la scelta di presentare una sintesi coerente solo del nucleo essenziale della proposta loweiana, se da un lato abbrevia certamente la via per l’acquisizione di una certa dimestichezza col suo pensiero, dall’altro, però, rischia di contrarre nella pura dimensione dell’implicito la ricchezza di temi e questioni che pure hanno caratterizzato il lavoro filosofico di Lowe e che intrattengono un ruolo di continuo scambio col suo nucleo – e non semplicemente di mera applicazione o conseguenza.

