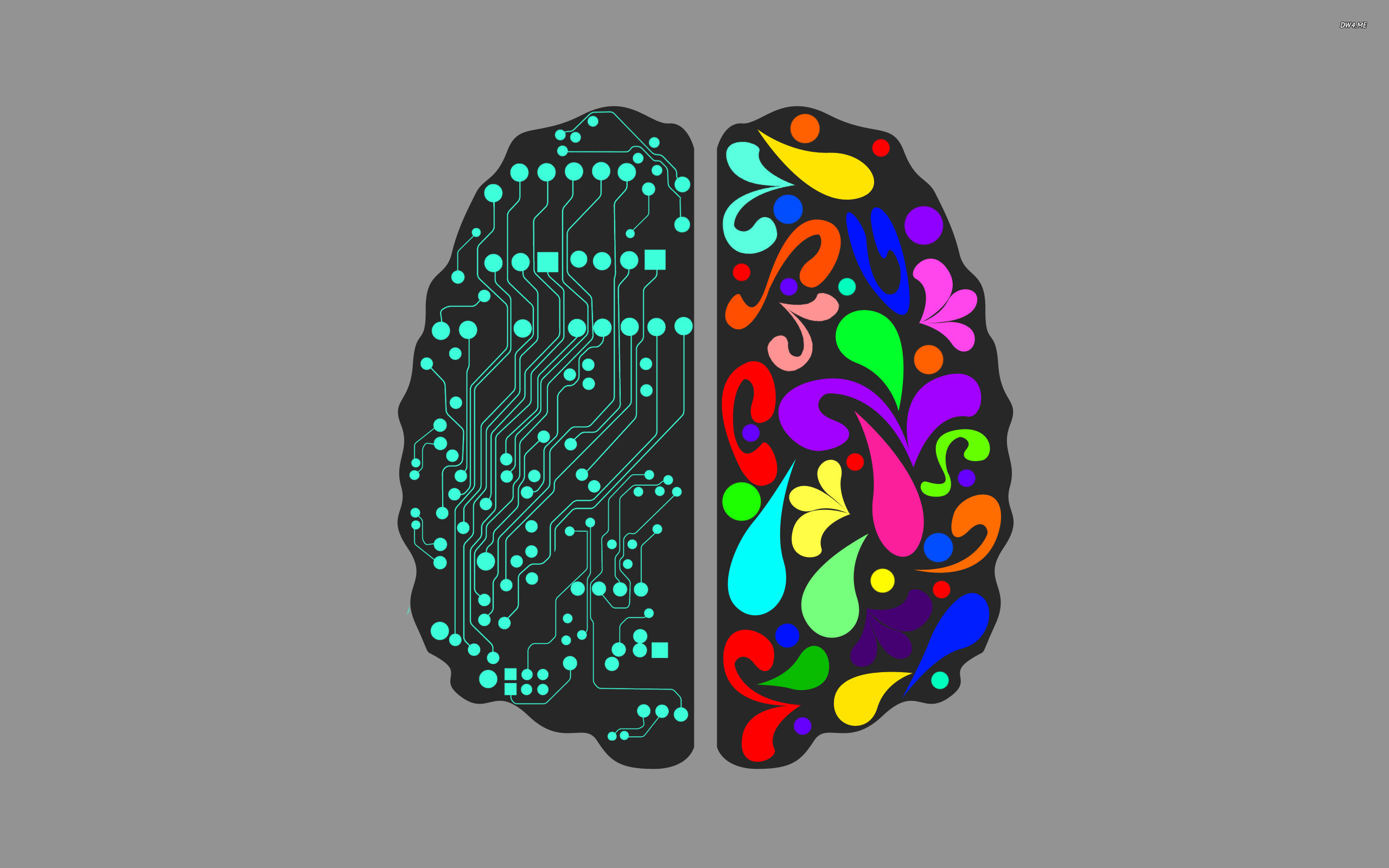-
-
Non è certo facile restituire la complessità e la densità del volume di Maurice Merleau-Ponty, Il mondo sensibile e il mondo dell’espressione (Mimesis 2021), recentemente tradotto e curato per il pubblico italiano da Anna Caterina Dalmasso, senza dubbio una delle studiose più autorevoli del pensiero del filosofo francese (suo l’importante saggio di Introduzione, pp. 17-52). Non è facile innanzitutto per la stessa natura di questo (non) libro, che raccoglie il materiale del filosofo prodotto in vista del suo primo corso al Collège de France dell’a.a. 1952-53. Il volume contiene tanto l’effettivo materiale utilizzato dal filosofo nelle sue esposizioni orali, quanto appunti che ne ampliano e approfondiscono l’orizzonte teoretico.
L’opportunità per il pubblico italiano di studiare e apprezzare il pensiero di Merleau-Ponty svolto al Collège si amplia così, dopo la traduzione di altri corsi avvenuta a cavallo tra la fine del secolo scorso e l’inizio del millennio: La nature (Seuil, 1995, tr. it. Cortina, 1996) e Notes de Cours 1959-1961 (Gallimard, 1996; tr. it. Cortina, 2003). Quello che qui discuteremo è stato pubblicato nel 2011 dall’editore svizzero MētisPresses[1] sotto la direzione scientifica di E. de Saint Aubert e di S. Kristensen e la traduzione italiana permette di accedere a un materiale teorico molto fecondo, sia per chi si occupa direttamente di Merleau-Ponty sia per chi sia interessato al pensiero francese del Novecento. In queste quattordici lezioni, infatti, si anticipano o si sviluppano in modi originali piste che attraversano, carsicamente a volte, altre in superficie, una tradizione di pensiero gravida ancora oggi di ampi sviluppi teorici. Lungi dall’essere una pubblicazione per soli addetti ai lavori, questo volume può essere di grande aiuto a chi volesse comprendere meglio alcuni intrecci - sia detto solo a titolo di esempio non esaustivo — tra Gestaltpsychologie e filosofia dell’esistenza, tra bergsonismo e fenomenologia, nonché — come segnala la Prefazione di Mauro Carbone (pp. 9-16) foriera di stimolanti riflessioni sull’arte e l’estetica. Insomma, pur non essendo di facile accesso — e tuttavia l’ottimo lavoro di Dalmasso aiuta chi non fosse specialista — il volume non potrà che trovare interesse in molti ambiti degli studi filosofici contemporanei.
Qui ci proponiamo di tracciare una possibile via d’accesso in questo universo filosofico ancora da esplorare anche da parte di chi, da molti anni, vi si dedica con studio attento. Come ogni pista d’accesso, non ne impedisce di altre e non può essere pienamente esaustiva della ricchezza contenuta nelle quasi trecento pagine del volume. Tuttavia, può essere utile a meglio orientarvisi. Come segnala la curatrice, il volume ha il merito di offrire «un punto di vista privilegiato» (p. 17) sul back-office della produzione di Merleau-Ponty, un vero e proprio laboratorio artigianale di concetti situato al fondo del lavoro pubblicato in vita dall’autore.
A differenza degli altri corsi già tradotti per il lettore italiano, la peculiarità de Il mondo sensibile e il mondo dell’espressione consiste nel fatto che esso ci mostra un Merleau-Ponty sul punto di farsi, che non è più quello della Fenomenologia della percezione e non è ancora quello de Le avventure della dialettica, un Merleau-Ponty per così dire “intermedio”, in divenire (Lanfredini 2011): «Le note del corso del ’53 — continua Dalmasso — offrono un insieme di argomentazioni e di fonti in grado di gettare luce su alcuni punti più oscuri o anelli mancanti della riflessione merleau-pontiana successiva» (p. 18). Insomma, il corpus magmatico di questo volume permette, a chi voglia avventurarvisi, di «cogliere “un filosofo al lavoro” e di “accompagnare Merleau-Ponty” nel farsi del suo lavoro» (p. 20). Una vera e propria avventura filosofica che permette al lettore di oggi di risemantizzare molte antinomie che nel nostro presente appaiono ovvi se non addirittura vetusti. Del resto, non siamo noi oggi figli di quella temperie culturale che genericamente potremmo definire post-moderna e che ha fatto della lotta al manicheismo dualistico la sua pars destruens ? È un pensiero non dualistico, senza per questo, vedremo, rinunciare alla duplicità, quello che l’autore — che ovviamente di post-moderno non sapeva nulla — prova a mettere in forma, e che noi abbiamo occasione di studiare proprio nell’atto del suo generarsi.
Mondo sensibile e mondo dell’espressione definiscono un’antinomia che trova le proprie radici, a voler estremizzare, quanto meno nella distinzione platonica tra mondo ideale e mondo sensibile. Se si volessero fissare delle tappe a noi più vicine — come sempre troppo semplicistiche, ma utili a orientarsi — sensibile ed espressione rimandando alle distinzioni moderne di Descartes (quella tra materia estesa e pensiero inesteso) e di Kant (mondo sensibile della natura e mondo intelligibile dei valori) generalizzabile nella distinzione del pensiero antropologico tra natura e cultura (Lévi-Strauss 1969 pp. 39-52; Descola 2005). Già dunque nel tema stesso delle lezioni contenute in questo volume si comprende lo sforzo teorico che le sottende, un lavoro filosofico e fenomenologico che chiama in causa le principali architravi del nostro sensus communis moderno.
Potrebbe essere utile contestualizzare brevemente queste note di corso (si rimanda all’introduzionedella curatrice per i dettagli). L’anno accademico, come detto, è il 1952-53 ed è l’esordio di Merleau-Ponty al Collège de France, dopo che ha già tenuto il suo Elogio della filosofia nella lezione inaugurale (Merleau-Ponty, 2008) e mentre sta aprendo il cammino che lo consacra ai livelli più alti della cultura e della filosofia francese e forse mondiale. Non sono anni facili, gli anni Cinquanta, sia a livello storico (sono gli anni della guerra fredda, delle prime notizie in occidente del regime staliniano, della guerra di Corea, ecc.) sia a livello personale (Merleau-Ponty ha in cantiere La prosa del mondo che resterà incompiuto, sta rivedendo le sue posizioni rispetto all’URSS espresse in Umanismo e terrore del 1948, ma, soprattutto, sta per rompere il grande sodalizio filosofico e affettivo con J.-P. Sartre). Sul piano scientifico ha qualche sassolino nelle scarpe dopo la conferenza del 1946 presso la Société de philosophie dal titolo Il primato della percezione e le sue conseguenze filosofiche (Merleau-Ponty2004) nella quale presentava davanti a un pubblico composto dalle migliori menti filosofiche del tempo i risultati conseguiti con Fenomenologia della percezione. Amici e colleghi (Hyppolite, Bréhier, Lachièze-Rey per citarne alcuni) accolgono in maniera polemica e critica la tesi di fondo di quel libro accusandolo in alcuni casi di sensismo e positivismo. La sensazione di non essere stato compreso si radica nel filosofo e sette anni dopo è proprio da quella discussione che, con certosina attenzione, riparte (p. 61). Il primato della percezione diventa un punto di partenza ottimale per penetrare nel fitto bosco del sensibile e dell’espressione.
Sin dalla prima lezione, quasi un brevissimo compendio di Fenomenologia della percezione, emerge il tema cruciale con un gusto programmatico. Si tratta, cioè, di pensare l’unità del mondo percepito tale che questa unione non sia la “sintesi determinante”, la sintesi intellettuale, cioè, di una molteplicità sensoriale di stimoli empirici. L’unità cercata nella sua opera principale (ma anche in La struttura del comportamento del 1942) non era una sintesi del giudizio, ma di ordine “percettivo”. Si può dunque capire come qui emergano molte ambiguità che il filosofo dovrà in qualche modo dipanare.
Primato della percezione non significa postulare l’esistenza delle cose fuori di me o la corrispondenza oggettiva di mondo e conoscenza né di opporre a una filosofia intellettualista un empirismo sensista à la Hume, bensì di «fare una teoria concreta dello spirito» (p. 59). Il primato della percezione non postula «un primato del sensoriale, del dato naturale» (p. 60), ma è ricerca di un piano originario che non sia né empirico né trascendentale in cui il sensibile e l’espressione possano divenire indiscernibili: è lo statuto stesso della fenomenologia a modificarsi con questo primato. Fenomenologia della percezione non sta ad indicare solo che è possibile trattare la percezione come “noema”, ma che nel farlo si segue il divenire della percezione nel suo stesso attuarsi, ossia che la percezione indica un piano ontologico intermedio tra l’essere oggettivo e l’essere soggettivo. Si può trattare fenomenologicamente la percezione solo se essa non è né l’oggetto di un sapere né il soggetto della sensazione. È questo né né a non essere stato compreso alla Société nel ’46 (pp. 61-62). Il punto è che la percezione non rimanda solo al mondo del sensibile, ma implica anche un carattere espressivo: «Intenderemo qui per espressione o espressività la proprietà che ha un fenomeno, per la sua organizzazione interna, di farne conoscere un altro che non è dato o che non è mai stato dato. […] È in questo […] senso che la percezione è espressione, espressione del mondo» (pp. 62-63).
Fare una fenomenologia della percezione è studiare il farsi del mondo, una fenomenologia che acquista sempre più caratteristiche “hegeliane” (Vuillerod, 2018) risemantizzando il concetto di coscienza. Se c’è percezione, infatti, non è detto che vi sia necessariamente soggetto (nel senso del Cogito trascendentale che accompagna ogni io empirico), ma vi è senz’altro coscienza, che non è il pieno possesso di sé che la tradizione cartesiana e kantiana ci ha consegnato. La coscienza percettiva non è esterna alle cose, si situa tra di esse, ma non è cosa estesa tra cose estese: essa si fa negli scarti, nelle differenze (cromatiche, uditive, sensibili…) tra le cose, è trans-individuale (Ruyer 2018; Simondon 2011), passività creativa (Ménasé 2003). A differenza di quella trascendentale, essa «non ha a che fare con valori […], ma con esseri esistenti» (p. 64). Potremmo dire, cioè, che attraverso il primato della percezione Merleau-Ponty intraveda la possibilità di emancipare la coscienza percettiva dalla sovranità dell’intelletto dell’estetica trascendentale e di riscoprire nella materialità il suo proprio valore/valere.
L’espressività della percezione — il suo “primato” — è dunque ontogenetico, essa non è la facoltà inferiore della coscienza — come all’origine dell’estetica riteneva, ad esempio, A.G. Baumgarten (1993: 41) — ma la sua espressione “sensibile”, è «configurazione, struttura» (p. 65). Ecco un secondo termine fondamentale nel lessico merleau-pontiano che richiama il suo primo grande libro, La struttura del comportamento. Il primato della percezione implica una materialità della coscienza percettiva da intendersi come processo di strutturazione. Se la percezione non è (solo) la passività di un soggetto empirico, ma l’attività — quantunque “passiva” — di una coscienza “materiale”, allora essa è a tutti gli effetti concepibile nei termini di un comportamento (nel senso, ad esempio, in cui quantisticamente una particella ha un comportamento), un’attività vincolata ad un mondo-ambiente. L’espressione percettiva non è un atto puro, ma una prassi “situata” in uno “sfondo” di passività. Il richiamo è qui alla Gestaltpsychologie, che Merleau-Ponty aveva studiato attentamente nel libro del 1942 (e che nel corso affronta tra la settima e la nona lezione). Ogni coscienza percettiva è una figura (Gestalt) che emerge da uno sfondo e «vi è sempre qualcosa di inarticolato e di sottinteso in ciò di cui vi è coscienza» (p. 67). Lungi dall’essere un’astratta sensazione senza soggetto, l’espressione sensibile è un processo di figurazione (Gestaltung) e la coscienza percettiva è una figura o forma materiale. La coscienza percettiva non è un cogito ma un corpo, non un’anima che emerge e s’innalza dalla materia, ma l’individuazione, l’attività immanente, la configurazione sensibile e materiale di un corpo. Il primato della percezione è il primato del corpo sull’anima, non nel senso “empiristico-naturalistico” di un primato dell’esteso sull’inesteso, ma di una indiscernibilità tra il mondo sensibile della corporeità e la sua espressione animale.
Allora fenomenologia diviene sinonimo di strutturazione ontologica — «non vi è differenza tra ontologia e fenomenologia» (p. 61) — e il primato della percezione conduce a una ontologia dinamica e processuale (Vanzago, 2001). Il mondo dell’espressione non è riducibile a un mondo formale, ha una sua materialità; il sensibile non è inerte o passivo. C’è espressività sensibile tanto quanto vi è sensibilità “spirituale”. Né inerte né formale: l’espressività del sensibile è movimento e la fenomenologia della percezione è manifestazione non richiudibile negli steccati formali dell’estetica trascendentale, poiché non vi è più un primato del formale estetico (dello spazio e del tempo formali). Si avvia qui quello che con Husserl (1991) potremmo chiamare rovesciamento della rivoluzione copernicana: è il movimento a determinare le forme del tempo e dello spazio, non il contrario. Anzi: spazio e tempo non sono più forme, ma figure (Gestalten). Il movimento (si veda in particolare la sesta lezione) è il fenomeno espressivo per eccellenza, tutt’altro dunque che l’esito di una rappresentazione soggettiva. Come la percezione, esso non è l’oggetto di un sapere né l’attributo di un cogito (p. 99), ma è qualcosa che può essere solo sentito, in cui si manifesta il movente. Non è neppure un mero accidente che capita a un oggetto empirico, non è, cioè, la variazione di luogo nel tempo di una “cosa” (Sache), ma il fenomeno per il quale “qualcosa” (Ding) si esprime, emerge spazialmente e temporalmente (geograficamente e storicamente) in quanto figura su sfondo.
Il movimento espressivo è l’installazione sensibile di una coscienza percettiva nel cuore dello spazio e del tempo, il suo modo di abitare lo spazio e il tempo (p. 103), i quali non sono relazioni formali né empiriche, bensì modali. C’è movimento, ovvero qualche cosa appare, c’è della percezione, c’è del comportamento, c’è della coscienza, c’è figurazione: espressione di un’immagine materiale. Il movimento espressivo (siamo alla quarta lezione del corso) è «spirito che si fa corpo e corpo che si fa spirito […] una logica del funzionamento percettivo» (p. 105). Rovesciamento della fenomenologia hegeliana: fenomenologia e logica della percezione; il corpo è lo spirito, il mondo sensibile esprime il mondo spirituale; l’unione non è sintesi assoluta, ma l’affinità trascendentale (p. 107) dello spirito col sensibile in sopravanzamento (overlapping) l’uno sull’altro, «sintesi di enjambement» (p. 109).
Il movimento espressivo è la sintesi senza concetto di spazio e tempo. La mente va a Bergson che più di chiunque altro nel Novecento si è sforzato di pensare il soggetto implicato nel movimento (pp. 119-125). Dopo aver esposto, all’inizio della sesta lezione, gli «argomenti di Zenone» (p. 118) sull’impossibilità ontologica del movimento, Merleau-Ponty vi si richiama: «Per lui quello che rende impossibile il movimento nel pensiero di Zenone è la divisione infinita e attuale del tempo e dello spazio, […] per rendere possibile il movimento occorre che il tempo e lo spazio siano divisibili, ma non divisi, che, posti a partire dal tutto, ammettano uno spazio “tra” le posizioni e gli istanti, cosa che non è possibile nell’in sé. È quindi necessario che il movimento , che è fatto del mondo, sconfini su di me come durata, sia anche fatto di coscienza» (p. 119). Tuttavia, Bergson nel cercare un tout indivisé del movimento è ancora troppo intellettualista, «resta coscienziale» (p. 121). Occorre essere, si legge tra le righe delle note di lavoro, più bergsoniani di Bergson, il quale «trionfa su Zenone mostrando che il tempo non è fatto di istanti né lo spazio di limiti di spazio, ed è vero. Ma resta da esplicitare la conseguenza […] crede che il problema sia concluso» (p. 239). Diventa necessaria «una teoria del corpo percipiente» (p. 240), un paradigma del corpo (Iofrida 2019) che troviamo tra l’undicesima e la tredicesima lezione (nel cuore, dunque, del corso): il movimento è sì un dato immediato della coscienza, ma di una coscienza percettiva, una coscienza-immagine che sia la sintesi esistenziale (materiale) della durata, la quale viene così reinterpretata come espressione sensibile, immagine-spaziotempo, figurazione espressiva.
La durata bergsoniana è “astratta” e manca, agli occhi di Merleau-Ponty, la “e”tra sensibilità ed espressività, una unità (dodicesima lezione) non teoretica, ma pratica, «unità dello schema corporeo […] unità di un’azione sul mondo, di una prassi» (p. 187), non nel senso di un pragmatismo utilitaristico (che per Merleau-Ponty manterrebbe la sussunzione dell’azione sensibile a uno scopo sovrasensibile), ma come attività passiva di creazione di immagini, una prassi che «comporta una teoria [Theoria] o gnosis che ne è lo sfondo, che essa modifica e che a sua volta la modifica» (ibidem). La durata espressiva è unità di teoria e di prassi, una praktognosia che non è un pragmatismo — esiste una materialità dei valori — né un empirismo — c’è, come rileva Dalmasso, una intenzionalità del sensibile (pp. 46-52). La durata come congiunzione del mondo sensibile e del mondo dell’espressione, una unità che si può a buon diritto definire estetica (se con Kant intendiamo “estetica” l’unità senza concetto, pre-logica).
Non è un caso che i corsi del ’53 si chiudano (quattordicesima lezione) con delle considerazioni sull’Arte in generale, e sul cinema in particolare. Le considerazioni estetiche di Merleau-Ponty sul cinema meriterebbero ben altre analisi (si rimanda ai lavori di Carbone e di Dalmasso), qui ci limitiamo solo a trarre una brevissima conclusione. Il cinema è la “prova ontologica” del primato della percezione e del movimento espressivo. Esso è una ritmologia della durata dell’immagine, un contrappunto di punti di vista, di immagini che sopravanzano l’una sull’altra. Nell’arte cinematografica si realizza l’unità di sensibile ed espressione, il vinculum substantiale di una molteplicità di immagini sensibili senza sussunzione entro i decreti formali dell’intelletto trascendentale. Nel movimento cinematografico appare una vera e propria monadologia sensibile (p. 64) che si insinua nel mezzo dei due mondi, che sono “separabili” ma non separati e nelle cui pieghe emergono molteplici mondi intermedi. Come scrive Carbone, nel cinema «si celebra il venire ad espressione […] del mondo sensibile» (p. 16).
Questi mondi intermedi sono il legame tra mondo sensibile e mondo dell’espressione e costituiscono l’ambiente originario nel quale la nostra capacità creativa di corpi animali o anime materiali riesce a trovare spazio per esprimersi e manifestarsi attraverso un’inaspettata fenomenologia dello spirito-carne che solo un primato della percezione può rendere visibile. Già solo questa breve conclusione a cui perviene Merleau-Ponty nei corsi dedicati alla duplicità sensibile/espressione, forse, vale da sola lo studio attento di questo volume.
di Gianluca De Fazio
[1] L’editore continua ancora oggi il suo lavoro di pubblicazione dei corsi al Collège de France di Merleau-Ponty. Si segnala il numero monografico dedicato al Mondo sensibile e mondo dell’espressione della rivista Chiasmi International (n. s. 12-2010).
Bibliografia
Baumgartem, A.G. (1993), Progetto dell’estetica, in A.G. Baumgarten, I. Kant, Il battesimo dell’estetica, a cura di L. Amoroso, ETS, Pisa.
Descola, P. (2005), Par-delà nature et culture, Gallimard, Paris.
Husserl, E. (1991), Rovesciamento della dottrina copernicana della corrente visione del mondo, «Aut-Aut», 245, pp. 3-18.
Iofrida, M. (2019), Per un paradigma del corpo: una rifondazione filosofica dell’ecologia, Quodlibet, Macerata.
Lanfredini, R. (2011, a cura di), Divenire di Merleau-Ponty. Filosofia di un soggetto incarnato, Guerini, Milano.
Lévi-Strauss, C. (1969), La struttura elementare della parentela, a cura di A.M. Cirese, Feltrinelli, Milano.
Ménasé, S. (2003), Passivité et création. Merleau-Ponty et l’art moderne, PUF, Paris.
Merleau-Ponty, M. (2004), Il primato della percezione e le sue conseguenze filosofiche, a cura di R. Prezzo, F. Negri Medusa, Milano.
Merleau-Ponty, M. (2008), Elogio della filosofia, a cura di C. Sini, SE, Milano.
Ruyer, R. (2018), Neofinalismo, a cura di U. Ugazio, V. Cavedagna, G. Vissio, Mimesis, Milano-Udine.
Simondon, G. (2011), L’individuazione alla luce delle nozioni di forma e d’informazione, a cura di G. Carrozzini, Mimesis, Milano-Udine.
Vanzago, L. (2001), Modi del tempo: simultaneità, processualità e relazionalità tra Whitehead e Merleau-Ponty, Mimesis, Milano-Udine.
Vuillerod, J.B. (2018), Merleau-Ponty hégélien?, «Chiasmi International», n.s. 19, pp. 101-114.
-
Tim Ingold – Making. Una ecologia del produrre
Recensioni / Maggio 2019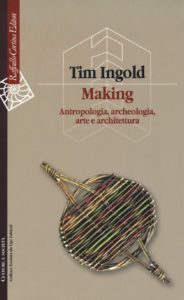 Potremmo pensare che filosofi e artigiani facciano due mestieri molto diversi, che hanno davvero poco a che vedere l’uno con l’altro: il primo infatti pensa, scrive e parla mentre il secondo fa, produce e manipola. Forse proprio per questo è poco usuale, per i filosofi, interrogarsi sul nesso tra la loro attività abituale, il pensiero, e il fare che segna tanto il lavoro dell’artigiano quanto la più comune prassi quotidiana. Ed è forse altrettanto poco usuale per un operaio o un artigiano chiedersi in che modo, nella sua attività di produzione, egli stia anche pensando. Eppure si tratta di una questione straordinariamente feconda, ci insegna Tim Ingold nel suo Making, prima opera dell’autore ad essere interamente tradotta in italiano a cura di Gesualdo Busacca per Raffaello Cortina (Milano, 2019, pp. 262). Il testo scaturisce dall’esperienza di un corso universitario tenuto da Ingold a partire dal 2004 nella facoltà di Antropologia dell’università di Aberdeen, intitolato: Le quattro A: Antropologia, Archeologia, Arte e Architettura. Più volte ripreso e messo da parte nel corso degli anni, Making esce per la prima volta nel 2013 e riprende l’ossatura teorica di Being alive (2011), la raccolta di saggi in cui si sviluppa un originale percorso teorico mosso dall’esigenza di riavvicinare l’antropologia alla vita. Ciò che però contraddistingue Making, rispetto a questa raccolta, è l’intimo legame che la riflessione intrattiene con l’esperienza al contempo didattica e di ricerca dell’insegnamento universitario. Ingold intende spingersi ben oltre la trasmissione di nozioni ridotte a rappresentazioni astratte, ferme e chiuse; è piuttosto interessato a coinvolgere i suoi studenti in percorsi di movimento nell’ambiente che aprano ad esso in un atteggiamento di ascolto ed esplorazione. Il gruppo si educa così a una forma di attenzione percettiva che permette di porsi sulle tracce delle cose che abitano il mondo tramite una paziente e scrupolosa raccolta di indizi. Gli studenti, infatti, erano chiamati non solo a seguire lezioni frontali, ma soprattutto a cimentarsi in esperienze di manipolazione di materiali e costruzione di oggetti nel corso di esperimenti e laboratori collettivi sempre accompagnati da momenti di restituzione e discussione. Le quattro A intrecciava dunque attività di produzione ed elaborazione riflessiva, facendole scaturire come momenti di una conoscenza trasformativa che si innesta sui percorsi vitali delle cose e si sviluppa con essi. Questo lavoro dà origine alla pratica di formazione collettiva nella quale prendono corpo le idee che animano il libro. Nell’ambito di un corso universitario, volto comunemente a produrre tramite il pensiero, Ingold e i suoi studenti imparano ad imparare in un altro modo, ossia a pensare tramite il produrre.
Potremmo pensare che filosofi e artigiani facciano due mestieri molto diversi, che hanno davvero poco a che vedere l’uno con l’altro: il primo infatti pensa, scrive e parla mentre il secondo fa, produce e manipola. Forse proprio per questo è poco usuale, per i filosofi, interrogarsi sul nesso tra la loro attività abituale, il pensiero, e il fare che segna tanto il lavoro dell’artigiano quanto la più comune prassi quotidiana. Ed è forse altrettanto poco usuale per un operaio o un artigiano chiedersi in che modo, nella sua attività di produzione, egli stia anche pensando. Eppure si tratta di una questione straordinariamente feconda, ci insegna Tim Ingold nel suo Making, prima opera dell’autore ad essere interamente tradotta in italiano a cura di Gesualdo Busacca per Raffaello Cortina (Milano, 2019, pp. 262). Il testo scaturisce dall’esperienza di un corso universitario tenuto da Ingold a partire dal 2004 nella facoltà di Antropologia dell’università di Aberdeen, intitolato: Le quattro A: Antropologia, Archeologia, Arte e Architettura. Più volte ripreso e messo da parte nel corso degli anni, Making esce per la prima volta nel 2013 e riprende l’ossatura teorica di Being alive (2011), la raccolta di saggi in cui si sviluppa un originale percorso teorico mosso dall’esigenza di riavvicinare l’antropologia alla vita. Ciò che però contraddistingue Making, rispetto a questa raccolta, è l’intimo legame che la riflessione intrattiene con l’esperienza al contempo didattica e di ricerca dell’insegnamento universitario. Ingold intende spingersi ben oltre la trasmissione di nozioni ridotte a rappresentazioni astratte, ferme e chiuse; è piuttosto interessato a coinvolgere i suoi studenti in percorsi di movimento nell’ambiente che aprano ad esso in un atteggiamento di ascolto ed esplorazione. Il gruppo si educa così a una forma di attenzione percettiva che permette di porsi sulle tracce delle cose che abitano il mondo tramite una paziente e scrupolosa raccolta di indizi. Gli studenti, infatti, erano chiamati non solo a seguire lezioni frontali, ma soprattutto a cimentarsi in esperienze di manipolazione di materiali e costruzione di oggetti nel corso di esperimenti e laboratori collettivi sempre accompagnati da momenti di restituzione e discussione. Le quattro A intrecciava dunque attività di produzione ed elaborazione riflessiva, facendole scaturire come momenti di una conoscenza trasformativa che si innesta sui percorsi vitali delle cose e si sviluppa con essi. Questo lavoro dà origine alla pratica di formazione collettiva nella quale prendono corpo le idee che animano il libro. Nell’ambito di un corso universitario, volto comunemente a produrre tramite il pensiero, Ingold e i suoi studenti imparano ad imparare in un altro modo, ossia a pensare tramite il produrre. -
Fare l’immagine. Deleuze su Beckett
Sconfinamenti, Serial / Febbraio 2016 Uno degli scrittori più presenti nel lavoro di Gilles Deleuze è senz’altro Samuel Beckett. È vero che il filosofo non gli ha dedicato un volume monografico – cosa che ha fatto invece per altri due grandi della letteratura, Proust e Kafka –, ma all’interno dei suoi libri troviamo un elevato numero di riferimenti all’autore irlandese, che mostrano quale importanza particolare egli gli attribuisca. Esistono inoltre due testi (uno breve, l’altro più ampio) esplicitamente destinati a commentare opere beckettiane, e proprio a essi rivolgeremo l’attenzione... Scarica il PDF
Uno degli scrittori più presenti nel lavoro di Gilles Deleuze è senz’altro Samuel Beckett. È vero che il filosofo non gli ha dedicato un volume monografico – cosa che ha fatto invece per altri due grandi della letteratura, Proust e Kafka –, ma all’interno dei suoi libri troviamo un elevato numero di riferimenti all’autore irlandese, che mostrano quale importanza particolare egli gli attribuisca. Esistono inoltre due testi (uno breve, l’altro più ampio) esplicitamente destinati a commentare opere beckettiane, e proprio a essi rivolgeremo l’attenzione... Scarica il PDFA cura di:
Giuseppe Zuccarino è critico e traduttore. Ha pubblicato vari saggi: La scrittura impossibile, Genova, Graphos, 1995; L’immagine e l’enigma, ivi, 1998; Critica e commento. Benjamin, Foucault, Derrida, ivi, 2000; Percorsi anomali, Udine, Campanotto, 2002; Il desiderio, la follia, la morte, ivi, 2005; Il dialogo e il silenzio, ivi, 2008; Da un’arte all’altra, Novi Ligure, Joker, 2009; Note al palinsesto, ivi, 2012; Il farsi della scrittura, Milano-Udine, Mimesis, 2012. Tra i libri da lui tradotti figurano opere di Mallarmé, Bataille, Klossowski, Blanchot, Caillois e Barthes.
-
Ancora troppo umani. Il postumano di Giovanni Leghissa
Recensioni / Ottobre 2015 Nel suo saggio Postumani per scelta. Verso un’ecosofia dei collettivi, ospite della collana “Spiritualità senza Dio?” diretta da Luigi Berzano, Giovanni Leghissa dà unitarietà a un tema che ormai lo vede occupato da alcuni anni (La fondazione, la fondazione dell’umano, il post-umano, 2013; Il postumano: un nuovo paradigma?, 2013; curatela di aut aut, La condizione postumana, 2014). Nonostante la brevità del saggio, l’autore si propone di soddisfare la duplice esigenza teorica di inquadrare da più vicino lo sfuggente dibattito sulla questione postumana e, insieme, di estrarne una possibile interpretazione critica. Così, alla messa in ordine di linee guida di una discussione spesso frammentaria, si affianca l’argomentazione di una tesi, frutto dell’incontro di assi di ricerca eterogenei ma convergenti. Le fonti e le questioni interpellate sono infatti numerose e provenienti dalle più disparate aree del sapere filosofico. Tra i “maestri” e le tradizioni di pensiero che vediamo avvicendarsi figurano l’illuminismo, l’evoluzionismo, la filosofia francese del dopoguerra, l’epistemologia, la fenomenologia husserliana, l’idea di un sapere enciclopedico alla Enzo Paci, la decostruzione e l’antropologia filosofica di Hans Blumenberg. Come dichiara l’autore, si tratterà allora di seguire questi molteplici stimoli nell’intento di definire la condizione postumana in termini filosofici, individuando e descrivendo schematicamente gli atteggiamenti caratteristici del suo approccio.
Nel suo saggio Postumani per scelta. Verso un’ecosofia dei collettivi, ospite della collana “Spiritualità senza Dio?” diretta da Luigi Berzano, Giovanni Leghissa dà unitarietà a un tema che ormai lo vede occupato da alcuni anni (La fondazione, la fondazione dell’umano, il post-umano, 2013; Il postumano: un nuovo paradigma?, 2013; curatela di aut aut, La condizione postumana, 2014). Nonostante la brevità del saggio, l’autore si propone di soddisfare la duplice esigenza teorica di inquadrare da più vicino lo sfuggente dibattito sulla questione postumana e, insieme, di estrarne una possibile interpretazione critica. Così, alla messa in ordine di linee guida di una discussione spesso frammentaria, si affianca l’argomentazione di una tesi, frutto dell’incontro di assi di ricerca eterogenei ma convergenti. Le fonti e le questioni interpellate sono infatti numerose e provenienti dalle più disparate aree del sapere filosofico. Tra i “maestri” e le tradizioni di pensiero che vediamo avvicendarsi figurano l’illuminismo, l’evoluzionismo, la filosofia francese del dopoguerra, l’epistemologia, la fenomenologia husserliana, l’idea di un sapere enciclopedico alla Enzo Paci, la decostruzione e l’antropologia filosofica di Hans Blumenberg. Come dichiara l’autore, si tratterà allora di seguire questi molteplici stimoli nell’intento di definire la condizione postumana in termini filosofici, individuando e descrivendo schematicamente gli atteggiamenti caratteristici del suo approccio. -
Che cosa può motivare la scelta di dedicare un libro al problema del «precategoriale» in
 Husserl? Il libro di Federica Buongiorno, Logica delle forme sensibili. Sul precategoriale nel primo Husserl, è motivato dalla convinzione che il problema del precategoriale sia un tema inaggirabile della fenomenologia di Husserl, un problema del quale la fenomenologia husserliana può e deve rispondere. In un passo molto chiaro Buongiorno afferma che il «compito della fenomenologia […] è appunto quello di condurre l’anonimo (l’implicito) al categoriale e ricondurre poi quest’ultimo […] alle radici pre-categoriali» (p. 184). La difficoltà – a ragione valorizzata in questo libro – risiede nel fatto che la precedenza del precategoriale non rappresenta il momento iniziale di un processo conoscitivo, bensì quel tratto costitutivamente «anonimo» e «non tematico» dell’«esperienza fondante» (p. XVII). L’Autrice, dunque, evidenzia sin dall’inizio come la differenza tra «categoriale» e «precategoriale» non vada intesa, per così dire, in maniera lineare, cioè come una differenza tra due momenti di un medesimo processo conoscitivo, ma come il problematico opporsi di due livelli irriducibilmente distinti: il «tematico» e il «non tematico». Il precategoriale è un fenomeno rilevante proprio in quanto costituisce quella «esperienza fondante» che si sottrae alla tematizzazione e alla conoscenza tradizionale, e che impegna la fenomenologia nella sua specificità.
Husserl? Il libro di Federica Buongiorno, Logica delle forme sensibili. Sul precategoriale nel primo Husserl, è motivato dalla convinzione che il problema del precategoriale sia un tema inaggirabile della fenomenologia di Husserl, un problema del quale la fenomenologia husserliana può e deve rispondere. In un passo molto chiaro Buongiorno afferma che il «compito della fenomenologia […] è appunto quello di condurre l’anonimo (l’implicito) al categoriale e ricondurre poi quest’ultimo […] alle radici pre-categoriali» (p. 184). La difficoltà – a ragione valorizzata in questo libro – risiede nel fatto che la precedenza del precategoriale non rappresenta il momento iniziale di un processo conoscitivo, bensì quel tratto costitutivamente «anonimo» e «non tematico» dell’«esperienza fondante» (p. XVII). L’Autrice, dunque, evidenzia sin dall’inizio come la differenza tra «categoriale» e «precategoriale» non vada intesa, per così dire, in maniera lineare, cioè come una differenza tra due momenti di un medesimo processo conoscitivo, ma come il problematico opporsi di due livelli irriducibilmente distinti: il «tematico» e il «non tematico». Il precategoriale è un fenomeno rilevante proprio in quanto costituisce quella «esperienza fondante» che si sottrae alla tematizzazione e alla conoscenza tradizionale, e che impegna la fenomenologia nella sua specificità.Ma non è questo il tema specifico del libro, che tratta, come esplicita il sottotitolo, del precategoriale «nel primo Husserl». Questa restrizione tematica rende ancor più ambiziosa la sfida di questo testo. Mettere a tema il precategoriale nel primo Husserl significa infatti individuare e discutere tale questione al livello metodologico e problematico delle Ricerche Logiche, quindi, prima della «riduzione fenomenologica» delle Idee, prima delle analisi genetiche e prima che Husserl, nella Crisi delle scienze europee, affronti esplicitamente il problema del «mondo della vita». Ma è proprio questa la sfida del libro di Federica Buongiorno, che – sempre consapevole di queste difficoltà – cerca di pensare il precategoriale con Husserl (nello specifico, con il primo Husserl) ma anche oltre Husserl. Per ragioni di spazio, in questa recensione mi concentro su questi due aspetti principali del libro, sebbene esso affronti con precisione filologica moltissime altre questioni; mi limito a ricordare il rapporto con Brentano (cap. I), l’influenza di Bolzano (cap. II) e il confronto con Kant, che l’Autrice valorizza costantemente.
Innanzitutto, vorrei richiamare l’attenzione sul titolo del testo. Che il problema del precategoriale abbia a che fare con qualcosa come una «logica delle forme sensibili» può sembrare, soprattutto per lo studioso di fenomenologia, una cosa ovvia. In realtà questo legame, tutt’altro che pacifico, tra il precategoriale e la logica delle forme sensibili sintetizza la tesi centrale di questo libro. Si tratta dell’idea – lo dico con parole mie – che il problema del precategoriale conduca all’elaborazione di una radicale “logica del sensibile”, a una “logica” che, in quanto “dedotta” dalla sensibilità stessa, di “logico” in senso tradizionale conserva ben poco. Ci si deve innanzitutto chiedere in che misura il primo Husserl ci offra la possibilità di pensare questa “logica del sensibile”, e in che misura questa “logica” sia capace di restituire, nella sua ricchezza e originarietà, il fenomeno del precategoriale.
Nell’“Introduzione”, in un passo molto significativo sul quale tornerò in chiusura, si dice che il carattere «costitutivamente problematico» del precategoriale introduce una «tensione di carattere fondazionale all’interno della teoria husserliana». Il punto è che questa tensione non può «essere risolta richiamandosi alla predelineazione del categoriale nel suo fondamento ante-predicativo, sebbene sia questo il ragionevole orizzonte interpretativo nel quale disporre il problema» (p. XII, corsivo mio). Il problema del precategoriale comporta infatti una strutturale eccedenza rispetto a una certa idea di precategoriale, una idea già attiva a livello delle Ricerche Logiche e definibile come una «predelineazione del categoriale» nella sensibilità. Questa “eccedenza” rappresenta a mio avviso qualcosa di decisivo per questo libro, nel quale l’analisi filologica del testo husserliano, volta a individuare la presenza del precategoriale nel primo Husserl, è costantemente ravvivata dalla consapevolezza della portata filosofica e teoretica del problema. La discussione del problema del precategoriale nel primo Husserl trova il proprio centro nel concetto di «intuizione categoriale», di cui Federica Buongiorno rintraccia le origini (cap. III. 1,2) e di cui ricostruisce – inquadrando la nozione all’interno delle Ricerche Logiche – il contesto problematico (cap. III. 3), per offrirne poi una analisi mirata nella parte finale del libro (cap. IV).
A un primo livello si può dire che la rilevanza dell’intuizione categoriale per il problema del precategoriale risiede nel fatto che, come è noto, attraverso questa nozione diventa possibile pensare il categoriale come dato. Questa nozione – ecco la sfida lanciata a Kant – implica una «profonda riconsiderazione dei rapporti tra sensibilità e intelletto, tra base estetica (precategoriale) e operazioni logico-discorsive» (p. 148). Ma, a mio avviso, Buongiorno coglie un punto fondamentale quando parla di una «duplice vettorialità» dell’intuizione categoriale (p. 136). Questa espressione dà voce al duplice aspetto dell’intuizione categoriale, come atto fondato sull’intuizione sensibile e come atto che offre al tempo stesso un nuovo tipo di oggettualità, una oggettualità eccedente rispetto all’intuizione sensibile. È forse proprio questa duplice vettorialità dell’intuizione categoriale ciò che permette di preservare il carattere originario, sensibile e intuitivo del precategoriale, senza tuttavia ridurre la sensibilità (per dirla con Kant) a una “intuizione cieca”, o (con le parole dell’Autrice) a una “mera sensibilità”, con cui il precategoriale, come giustamente viene precisato, non deve essere mai confuso (p. XVII). È sempre in quest’ottica che nel testo ci si confronta con il concetto fenomenologico di intuizione «in senso ampio». L’intuizione categoriale – l’esempio della copula è emblematico – presuppone proprio la possibilità di intuire (in senso ampio) qualcosa di radicalmente non intuibile (in senso stretto). Come rileva Buongiorno, l’allargamento fenomenologico del concetto di intuizione va di pari passo con l’«ampliamento dell’esistenza alla sfera logico-ideale» (p. 115).
L’insistenza su questa duplice vettorialità dell’intuizione categoriale è inoltre coerente con una prima importante scelta metodologica del testo. Buongiorno individua infatti nella rielaborazione husserliana della teoria brentaniana delle «rappresentazioni improprie» una chiave di lettura per comprendere la specificità della concezione fenomenologica del rapporto tra «intuizione (riempimento)» e «intelletto (intenzione
 significante)». Se per Brentano «le rappresentazioni improprie e i giudizi su di esse fondati avevano carattere “pseudo-conoscitivo”, […] per Husserl è possibile cogliere intuitivamente gli oggetti ideali» (p. 52). L’Autrice mette in luce il fatto che le rappresentazioni simboliche (intese come rappresentazioni improprie) contengono in sé un rinvio al «pre-logico». È proprio in virtù di questo «presupposto pre-logico» che il rappresentare simbolico, sebbene improprio, non si vede precluso un orizzonte di possibile datità. L’intuizione categoriale viene poi tematizzata in maniera analitica nell’ultimo capitolo del libro, di cui posso ricordare solo alcune pagine. L’Autrice, richiamandosi a Lohmar, distingue tre diversi livelli dell’intuizione categoriale (p. 173). In primis, la percezione semplice o «percezione complessiva» (Gesamtwahrnehmung), che offre un oggetto sensibile «unitario» (per esempio una porta rossa). Successivamente, la «percezione specifica» o «intenzione esplicitante», che è «ancora percezione, dunque un atto semplice», anche se «non ha più un carattere complessivo»; a questo livello «l’atto non è ancora mutato: ci limitiamo a concentrare il nostro interesse percettivo su un momento dell’intero» (nell’esempio, il rosso della porta). Infine, l’intuizione categoriale, dove «le parti esplicitate della Sonderwahrnehmung vengono ricombinate e connesse da un atto categoriale e sintetico» (l’esser-rossa-della-porta, il giudizio ‘la porta è rossa’). Secondo l’Autrice – e qui veniamo a uno snodo fondamentale del testo – il «fenomeno decisivo, sul piano categoriale, avviene già nel passaggio dalla Gesamtwahrnehmung alla Sonderwahrnhemung, le quali rientrano ancora nella modalità intuitiva semplice, sensibile». In questo livello intermedio si mostrerebbe dunque una strutturale e positiva ambiguità dell’intuizione: il momento esplicitante si configura come una «sintesi della coincidenza» che «non è ancora una formazione categoriale, ma non è neppure più o soltanto un contenuto sensibile. […] È proprio in questo discrimine interno alla sensibilità ma già aperto sul categoriale, in questo tratto di scivolosa commistione tra intuizione primaria e secondaria che il precategoriale fa valere il proprio impatto problematico all’interno della Sesta Ricerca» (pp. 175-176, corsivo mio).
significante)». Se per Brentano «le rappresentazioni improprie e i giudizi su di esse fondati avevano carattere “pseudo-conoscitivo”, […] per Husserl è possibile cogliere intuitivamente gli oggetti ideali» (p. 52). L’Autrice mette in luce il fatto che le rappresentazioni simboliche (intese come rappresentazioni improprie) contengono in sé un rinvio al «pre-logico». È proprio in virtù di questo «presupposto pre-logico» che il rappresentare simbolico, sebbene improprio, non si vede precluso un orizzonte di possibile datità. L’intuizione categoriale viene poi tematizzata in maniera analitica nell’ultimo capitolo del libro, di cui posso ricordare solo alcune pagine. L’Autrice, richiamandosi a Lohmar, distingue tre diversi livelli dell’intuizione categoriale (p. 173). In primis, la percezione semplice o «percezione complessiva» (Gesamtwahrnehmung), che offre un oggetto sensibile «unitario» (per esempio una porta rossa). Successivamente, la «percezione specifica» o «intenzione esplicitante», che è «ancora percezione, dunque un atto semplice», anche se «non ha più un carattere complessivo»; a questo livello «l’atto non è ancora mutato: ci limitiamo a concentrare il nostro interesse percettivo su un momento dell’intero» (nell’esempio, il rosso della porta). Infine, l’intuizione categoriale, dove «le parti esplicitate della Sonderwahrnehmung vengono ricombinate e connesse da un atto categoriale e sintetico» (l’esser-rossa-della-porta, il giudizio ‘la porta è rossa’). Secondo l’Autrice – e qui veniamo a uno snodo fondamentale del testo – il «fenomeno decisivo, sul piano categoriale, avviene già nel passaggio dalla Gesamtwahrnehmung alla Sonderwahrnhemung, le quali rientrano ancora nella modalità intuitiva semplice, sensibile». In questo livello intermedio si mostrerebbe dunque una strutturale e positiva ambiguità dell’intuizione: il momento esplicitante si configura come una «sintesi della coincidenza» che «non è ancora una formazione categoriale, ma non è neppure più o soltanto un contenuto sensibile. […] È proprio in questo discrimine interno alla sensibilità ma già aperto sul categoriale, in questo tratto di scivolosa commistione tra intuizione primaria e secondaria che il precategoriale fa valere il proprio impatto problematico all’interno della Sesta Ricerca» (pp. 175-176, corsivo mio).Federica Buongiorno può dunque affermare che il precategoriale, costituendo la “radice sensibile” dell’intuizione categoriale, è implicitamente presente nella Sesta Ricerca. Questa tesi non è affatto ovvia. L’Autrice, infatti, riconosce con Lohmar che a livello di quest’opera (nelle quale le analisi genetiche sono lasciate da parte) la percezione è assunta «a-problematicamente». Del resto, già nell’“Introduzione” si legge che il tentativo di tematizzare il precategoriale nel primo Husserl si scontra con un dato innegabile: il carattere statico e non genetico delle analisi delle Ricerche Logiche. Eppure il problema può e deve essere posto, perché tanto il carattere «complessivo» della percezione quanto la «sintesi della coincidenza» risulterebbero difficilmente spiegabili senza presupporre questo riferimento al precategoriale. Ci si può infatti chiedere: «come fa la percezione ad afferrare A come un intero?» (p. 206). È per rispondere a domande come questa che l’Autrice richiama, come «supplemento concettuale indispensabile» (p. 180), la nozione di Typus, che Husserl guadagnerà successivamente, nella quale è possibile individuare quella forma di «schematismo fenomenologico» che costituisce un presupposto implicito dell’intuizione categoriale. Proprio a partire da questo schematismo fenomenologico si rende inoltre apprezzabile la differenza tra Husserl e Kant, sulla quale l’Autrice insiste in vari luoghi ma che emerge molto incisivamente dalla considerazione della Terza ricerca. La «riconsiderazione dei rapporti tra sfera analitica e sintetica» – rendendo pensabile un rapporto che ha carattere essenziale e analitico, pur implicando una sintesi (è il caso del legame essenziale tra qualità e intensità) – permette ad Husserl di «fondare esteticamente l’apriori» (p. 120). Attraverso l’apriori materiale Husserl riferisce la forma «“alle cose stesse”» (p. 125), «sono gli oggetti a fornire il Leitfaden della conoscenza» (p. 127).
Il radicamento dell’intuizione categoriale in una sensibilità “ibrida” e “già aperta al categoriale”, e così l’idea secondo la quale la sensibilità racchiude una “logica degli oggetti”, sono aspetti particolarmente emblematici del modo in cui il primo Husserl pensa il precategoriale. Ma è forse proprio in questa logica degli oggetti che il tentativo husserliano sembra essere attraversato da quella problematicità che rappresenta un aspetto essenziale del fenomeno del precategoriale, il contrassegno della sua “eccedenza” rispetto al categoriale. Si può infatti dire che se da un lato l’intuizione categoriale, esibendo il necessario radicamento del categoriale nella sensibilità, è una condizione per porre il problema del precategoriale, dall’altro si ha l’impressione che in Husserl l’“anteriorità originaria” del precategoriale rimanga limitata a questa predelineazione delle categorie nella sensibilità. Ciò è del resto riconosciuto dall’Autrice in un passo dell’“Introduzione” che ho già citato, ma che voglio richiamare di nuovo. Vi si dice, per l’appunto, che la «tensione» provocata dal precategoriale non può «essere risolta richiamandosi alla predelineazione del categoriale nel suo fondamento ante-predicativo, sebbene sia questo il ragionevole orizzonte interpretativo nel quale disporre il problema» (corsivo mio). Per questo motivo il libro di Federica Buongiorno suggerisce la necessità di pensare il precategoriale non solo «con» Husserl, ma anche «oltre» Husserl.
A mio avviso, le ultime pagine di questo testo possono essere lette come una ripresa e una radicalizzazione della situazione problematica presentata nell’“Introduzione”, dove il precategoriale è indicato come un fenomeno situato «nello scivoloso discrimine tra originarietà e descrittività» (p. XII). Questa radicalizzazione è operata facendo riferimento alla «paradossalità» fenomenologica del soggetto (come soggetto e come oggetto, come costituente e costituito), che rappresenta secondo l’Autrice «la cifra stessa della fenomenologia». In effetti, lo statuto paradossale del soggetto comporta una difficoltà teoretica analoga alla più volte segnalata “problematica anteriorità” del precategoriale. Ma in che senso si può dire che la domanda sul soggetto costituisce una radicalizzazione della domanda sul precategoriale? Leggendo queste ultime pagine la risposta sembra essere la seguente: la commistione tra «passività» e «attività» oppure tra «intuizione» e «pensiero», fin qui affrontata in stretto rapporto all’intuizione categoriale, viene ora pensata come essenzialmente appartenente alla struttura del soggetto. Da questo punto di vista, a essere ambigua non è innanzitutto la sensibilità, come mostra l’analisi dell’intuizione categoriale, ma la stessa soggettività umana. La questione del precategoriale, dunque, comporta non soltanto un abbandono del presupposto antropologico kantiano (la divisione della capacità conoscitiva in sensibilità e intelletto) ma mette la fenomenologia di fronte alla domanda «come è l’uomo?», domanda che secondo l’Autrice è presente nel pensiero di Husserl, pur restando «difficilmente dipanabile» al suo interno.
Per concludere, questo libro, nel suo lato più strettamente husserliano, mostra in maniera filologicamente dettagliata come il problema del precategoriale conduca all’elaborazione di una logica delle forme sensibili che trova – diversamente che in Kant – negli oggetti stessi il proprio filo guida. D’altro canto, le ultime pagine di questo testo, rivendicando una aspirazione teoretica che va oltre il testo husserliano, indicano nella domanda antropologica «come è l’uomo?» una via più radicale per pensare il precategoriale.
di Fabio Pellizzer
-
Variante 200 – Corso Grosseto #1
Serial / Febbraio 2015Il parco e le sue paratie verde mimetico sono oramai alle nostre spalle e cerchiamo di raggiungere Piazza Rebaudengo, proprio dall'altra parte del cantiere. Quando incontriamo Corso Grosseto, nel punto in cui si interseca con la bretella della tangenziale, le automobili sfrecciano veloci. Ecco che subitaneamente cambia la percezione dello spazio; lasciata indietro quell'impressione di immobilità che permeava la zona adiacente, ci troviamo ora nel luogo del puro scorrere dove i viali diventano ampi e impossibili da attraversare a piedi, dove i percorsi pedonali sono interrotti da guardrail da scavalcare.

«La moderna fine del mondo si compirà in questo modo: in occasione dell'ultimo perfezionamento delle macchine si dichiarerà la incapacità a circolare degli uomini» Karl Krauss
Ci si abitua oggi, presto e quasi in maniera indolore, a questa costruzione dell'esperienza basata sullo shock. Spesso, ci diciamo, saremmo curiosi di ritornare all'emozione provata da chi quel giorno vedendo il film dei fratelli Loumière scappò dal primo cinema, da quella sequenza di fotografie del treno che terrorizzò i primi spettatori, per capire quanta educazione dello sguardo si nasconda dietro alla nostra cognizione del movimento.
Ma sono parole brevi e veloci scambiate distrattamente mentre con attenzione e passo svelto attraversiamo lo svincolo e ci ritroviamo a dover passare su un ponte proprio sopra l'autostrada. Ci attardiamo un attimo a contemplare da questo punto di vista privilegiato i nuovi assetti della città mentre alle nostre spalle le macchine sfrecciano veloci, sotto di noi pure. Questa posizione leggermente rialzata e distante dal groviglio urbano, ci sbatte in faccia un' inaspettata cartolina di Torino: la città appare come ritrarsi gradualmente col dilagare del cantiere, il quale sembra non interrompersi ai soli lavori intorno alla stazione ma continuare lungo una corrente che parte dal nuovissimo grattacielo della San Paolo in Corso Inghilterra.

«Bello, quando sul mare si scontrano i venti/E la cupa vastità delle acque si turba,/guardare da terra il naufragio lontano:/non ti rallegra lo spettacolo dell’altrui rovina,/ma la distanza da una simile sorte» Lucrezio
È nuovamente la geografia urbana a sorprenderci con il suo gioco tridimensionale: di sovrapposizioni di scorci, di differenziali di velocità che destabilizzano le coordinate spaziali; è anche a questo shock, che era così efficacemente sublimato dai sipari haussmaniani, che l'occhio contemporaneo deve saper adattarsi.
Ci sbagliavamo poco fa a credere che fosse la stazione l'epicentro di questa marea polverosa, perché è piuttosto l'edificio tributo al capitale cittadino, il grattacielo, a essere l'occhio del ciclone al centro de “la bufera del progresso”. Lontano eppur così borioso anche da qui, dalla periferia da cui, per visuale d'insieme, sembra un monumentale dito medio che si erge monopolizzando l'attenzione visiva, andando a costituire il punto di fuga di questo quadro dell'oggi. A ben guardare, all'orizzonte cresce lesto anche quello della Regione Piemonte, leggermente sulla sinistra rispetto al primo. Da qui non si vede altro: autostrada, cantiere e le vette del dominio. A cosa si riduce la città che è ora sotto il nostro sguardo? È solo una topica estetica o una prospettiva simbolica questa? Impossibile non chiederselo con quell'inquietudine calmierata dello spettatore che guarda il naufragio da un approdo tanto momentaneo quanto fittizio.

«Non c'è nessun oceano, John. Non c'è niente oltre la città. L'unico posto in cui esiste casa è il tuo cervello» Dark City
C'è tuttavia il ronzio dei motori a distrarci continuamente, insistendo nel volerci palesare la superbia del crederci distanti e separati dall'oggetto della nostra osservazione. Ma il corpo urbano non può essere carpito con un singolo sguardo e ancor meno si può ridurre a una sola inquadratura. Esso è ciò in cui siamo immersi, una modalità di vita, l'habitus di cui non si ha più percezione. E seppur è vero che una finzione ipotetica è necessaria per l'avvio di ogni teoria, non è detto che l'unica possibile sia quella dello spettatore. C'è infatti un ritmo provocato dal passaggio degli autoveicoli sui giunti d'espansione del ponte che ci ricorda la nostra immersione completa nei flussi urbani. Ed è proprio la cadenza sonora, la sua frequenza e le sue pause, a suggerirci che l'urbano è soprattutto ingegneria della certezza. Essa segue tempi precisi: in questo caso regolati da semafori, segnaletica e, come substrato, da un florilegio di norme stradali. Quello che a livello percettivo veniva associato al caos, segue in realtà un cronometro preciso. Ora anche la nitidezza prospettica sulla città non sembra più in contrasto con la confusione sonora alle nostre spalle.
«Vauban preconizzerà vivamente questa maniera di evitare la carneficina e di dissolvere il nemico per mezzo della semplice costruzione di un universo topologicamente costituito "di un insieme di meccanismi capaci di ricevere una forma definita di energia- all'occorrenza quella della massa mobile degli assalitori- di trasformarla e di restituirla alla fine sotto una forma più appropriata»
Ebbene, alla fin fine, pare non esserci nessuna topica estetica, tanto meno una prospettiva simbolica. Nella comprensione della città il punto non sta tanto nel descrivere minuziosamente un luogo da una supposta ubicazione d'eccezione, come fosse uno scenario, quanto piuttosto comprenderlo come un rapporto tra la costituzione fisica e la massa mobile che da essa è informata.

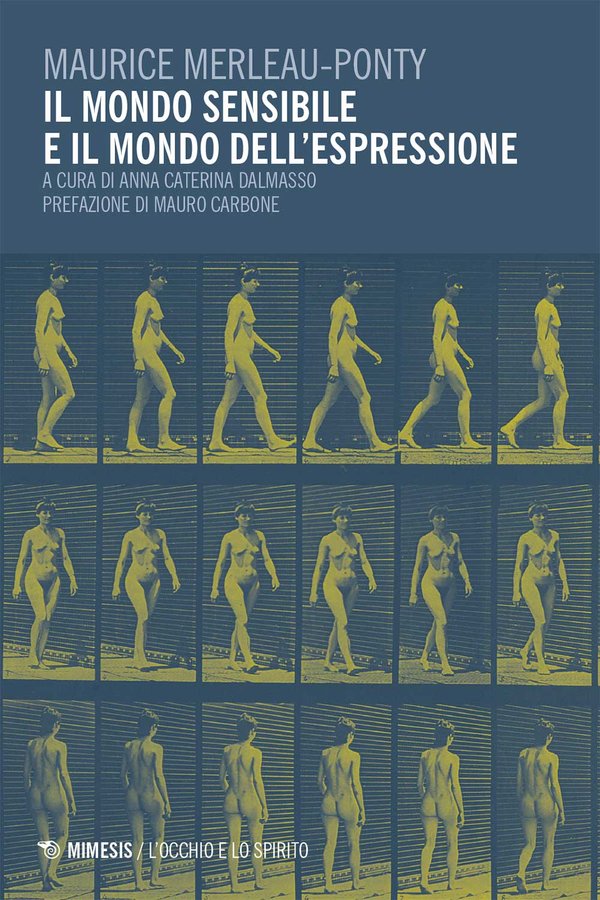




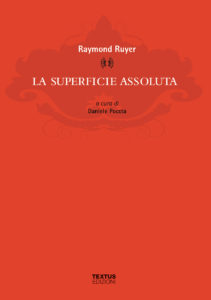

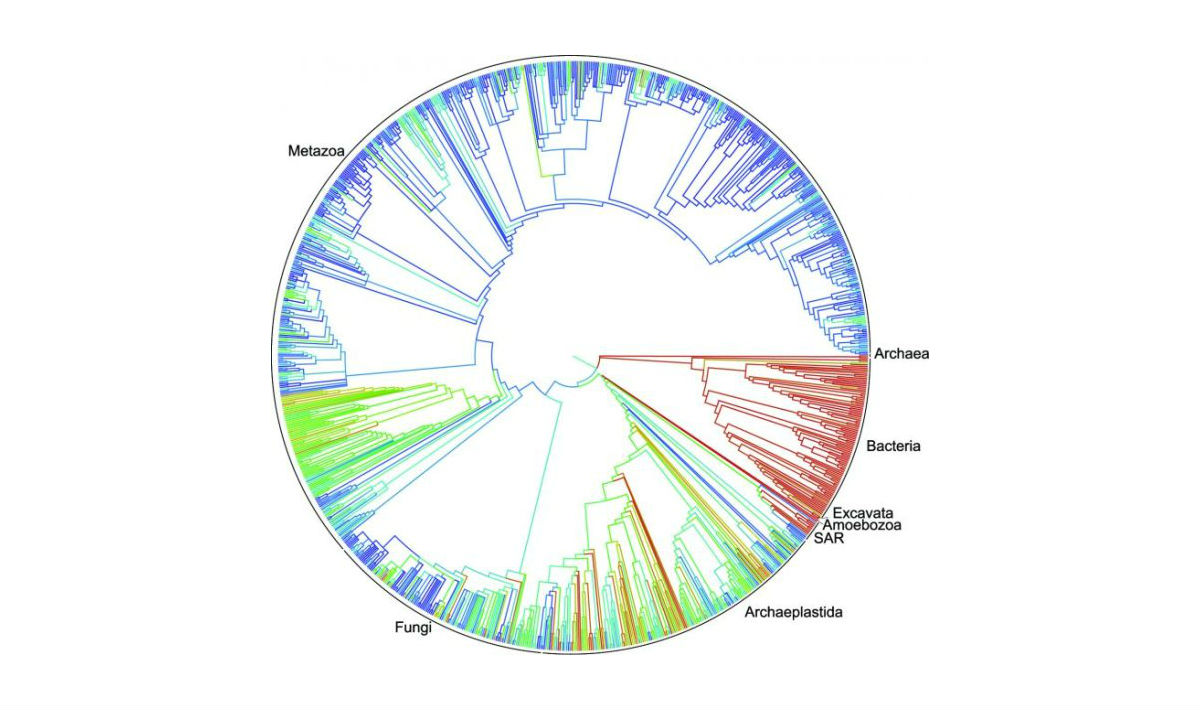


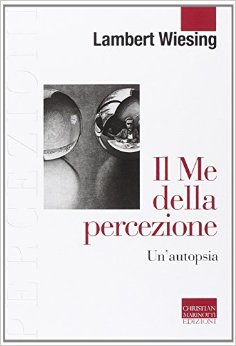

 zione ridisegnata da Wiesing, il trittico soggetto/oggetto/percezione si riconfigura, portando in primo piano la percezione come suo centro propulsore, in maniera non dissimile da quanto portato avanti, in un altro contesto, da Gilbert Simondon prima e da Bernard Stiegler oggi: nel passaggio all’individuazione non bisogna concentrarsi né sull’origine né sul termine, ma sul processo trasduttivo e relazionale in grado di articolare i due momenti. Al di qua della sclerotizzazione tra un soggettivismo autoreferenziale e un oggettivismo semplicistico, Simondon, Stiegler e Wiesing, in modi ovviamente differenti, propongono uno sguardo “terzo”, bergsonianamente orientato sui movimenti che riconfigurano le essenze statiche in poli di un processo.
zione ridisegnata da Wiesing, il trittico soggetto/oggetto/percezione si riconfigura, portando in primo piano la percezione come suo centro propulsore, in maniera non dissimile da quanto portato avanti, in un altro contesto, da Gilbert Simondon prima e da Bernard Stiegler oggi: nel passaggio all’individuazione non bisogna concentrarsi né sull’origine né sul termine, ma sul processo trasduttivo e relazionale in grado di articolare i due momenti. Al di qua della sclerotizzazione tra un soggettivismo autoreferenziale e un oggettivismo semplicistico, Simondon, Stiegler e Wiesing, in modi ovviamente differenti, propongono uno sguardo “terzo”, bergsonianamente orientato sui movimenti che riconfigurano le essenze statiche in poli di un processo.