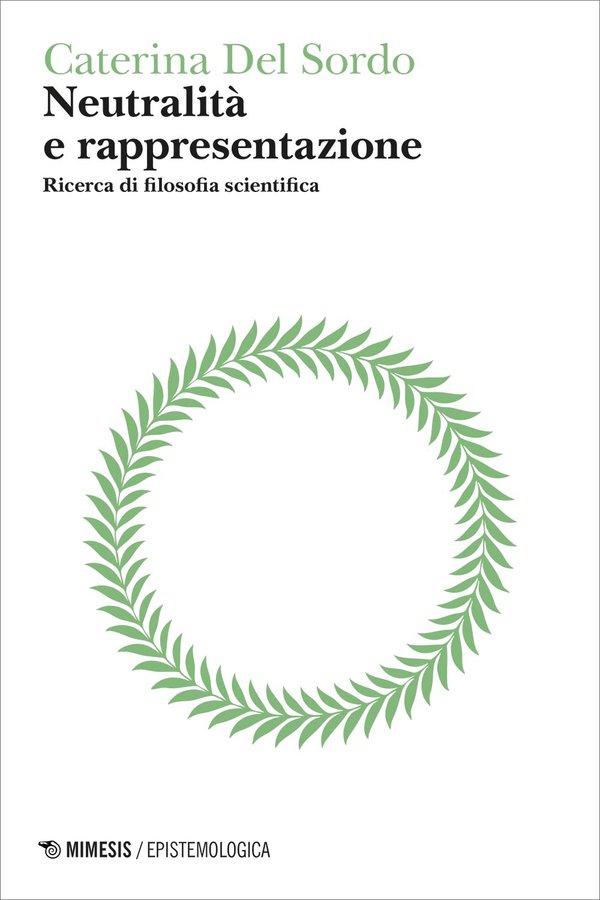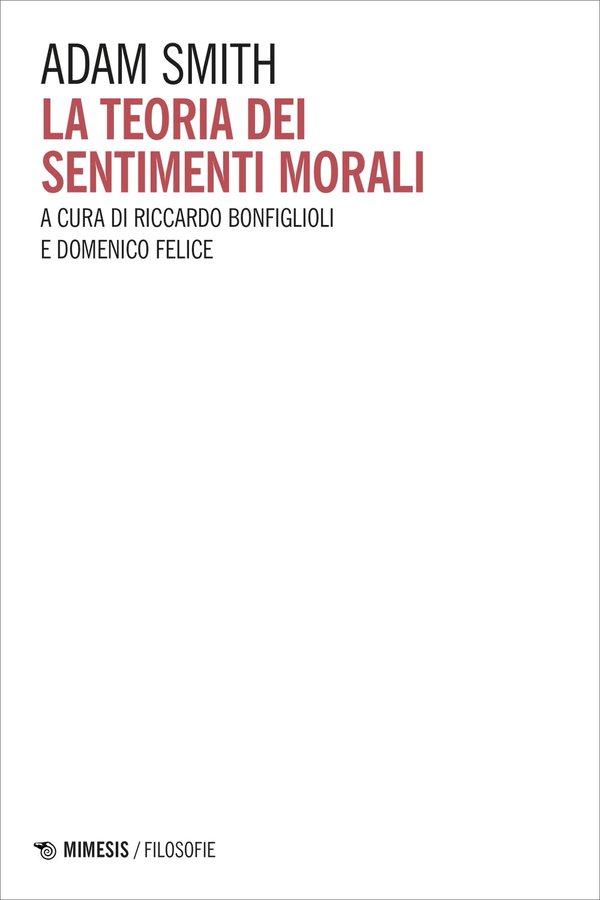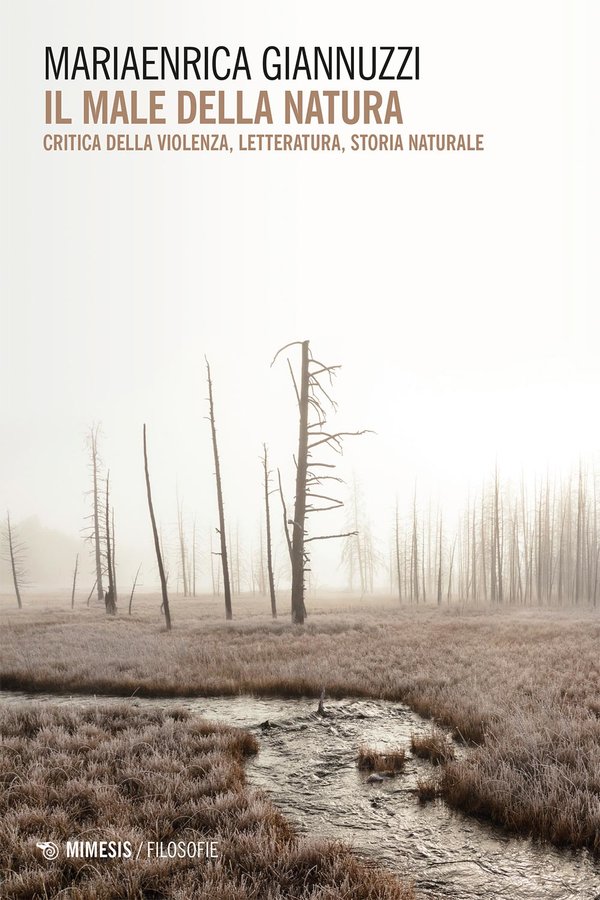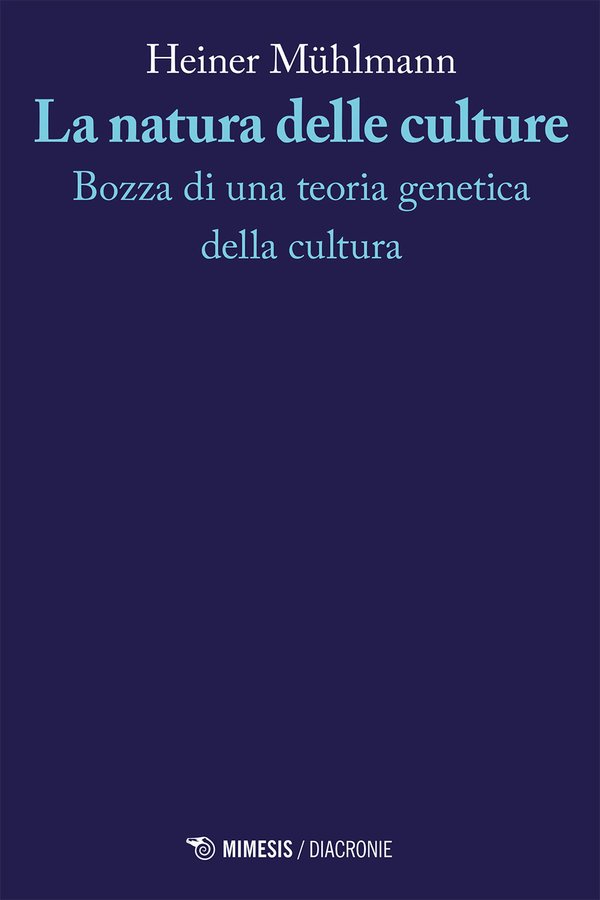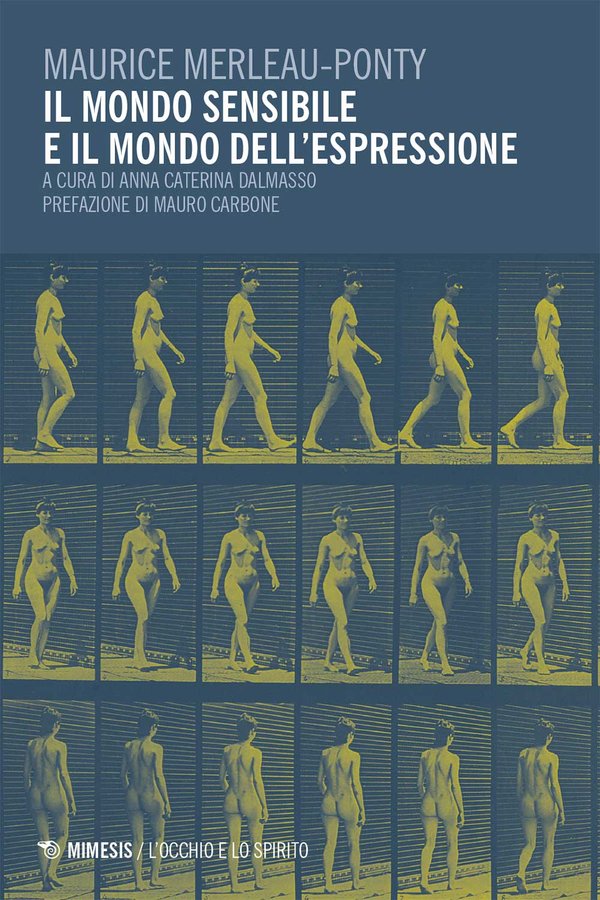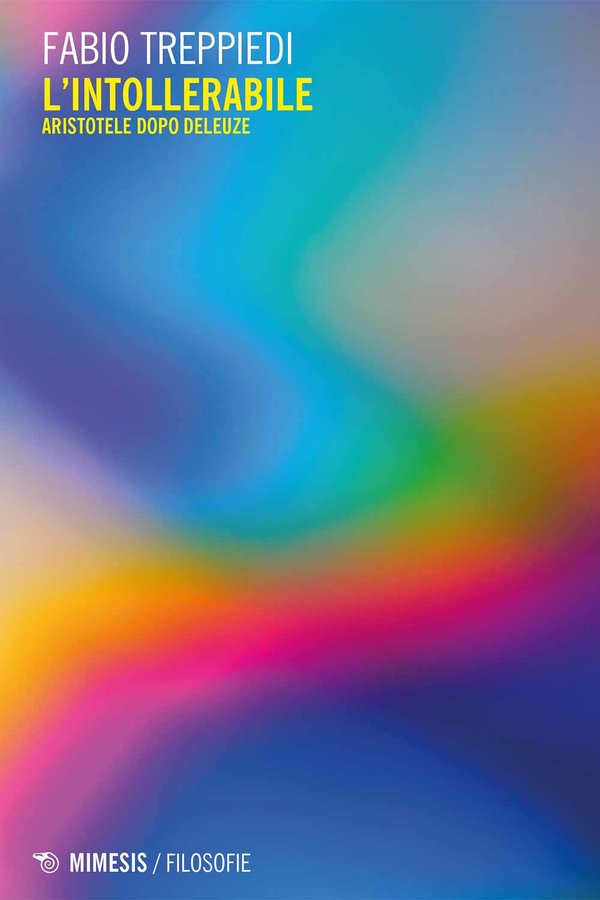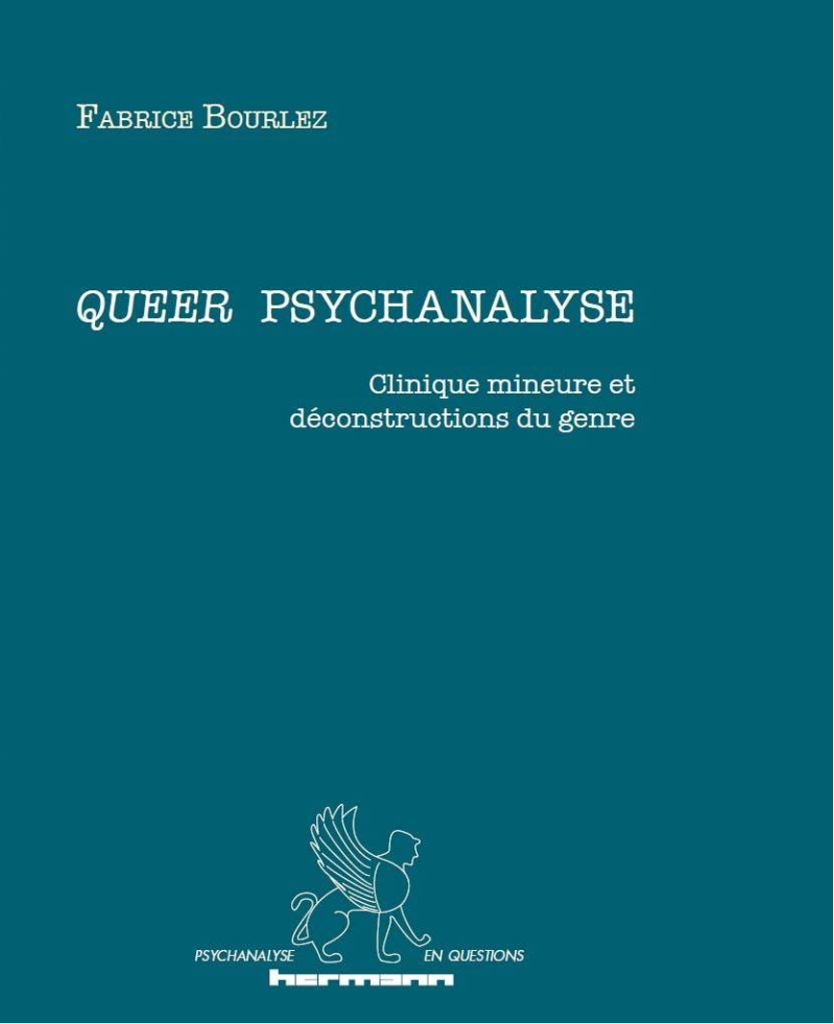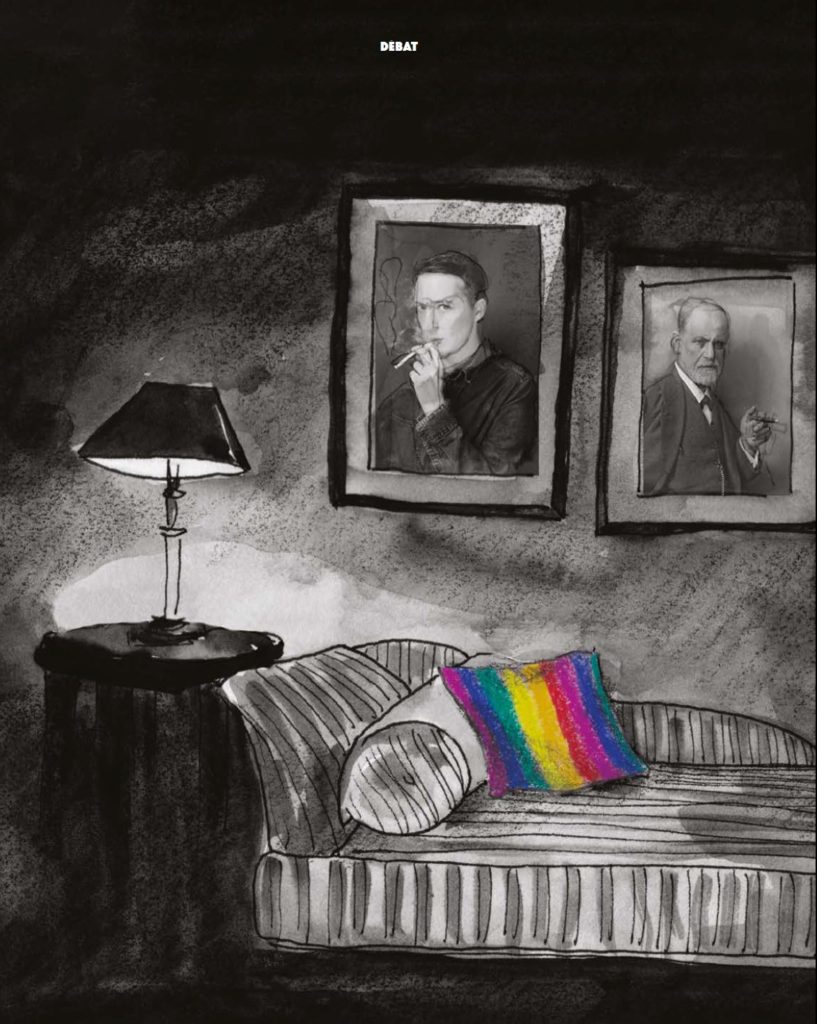-
-
La collana Epistemologica dell’editore Mimesis rappresenta da molti anni una preziosa risorsa per le ricerche in ambito sociologico, filosofico ed epistemologico. Neutralità e rappresentazione. Ricerca di filosofia scientifica, scritto da Caterina Del Sordo, è un’aggiunta particolarmente interessante; l’autrice svolge ricerche nel campo dell’empirismo logico, del monismo neutrale e della fenomenologia, con particolare attenzione al lavoro scientifico e filosofico di Rudolf Carnap. Le riflessioni del membro del Circolo di Vienna sono l’argomento principale di questo saggio, in cui Del Sordo intende rivalutare il pensiero carnapiano per una nuova proposta di filosofia scientifica. Oggi, tale visione della filosofia non può essere ricondotta né alla Wissenschaftliche Weltauffassung Der Wiener Kreis né a un’idea di scienza naturalizzata. Una prova di questo fatto è la scelta editoriale fatta da Hannes Leitgeb, direttore della rivista Erkenntnis che, nel 2013, ne ha cambiato il sottotitolo da International Journal of Analytic Philosophy a International Journal of Scientific Philosophy: tale modifica sottolinea la volontà di conferire «legittimità teorica ai problemi filosofici tradizionali promulgandone la trattazione attraverso metodi, in particolare matematici, ma anche computazionali e sperimentali, prominenti nella scienza medesima» (p. 24). La proposta avanzata da Del Sordo è quindi quella di una filosofia scientifica pragmatica, basata essenzialmente su tre vocaboli: “Non-residualità”, “Termine medio” e “Trasformazione”.
La filosofia scientifica adotta due atteggiamenti: il primo – mutuando i termini dalla fenomenologia husserliana (Husserl, 2003) – può definirsi “statico”, in cui «si rendono strumentali le tesi che derivano dai tentativi di risolvere problemi contestuali» (p. 55); il secondo è l’atteggiamento “genetico”, dove «le tesi [sono considerate] come nodi inseparabili di un[a] rete di assunzioni implicite o esplicite» (p. 56). Nei due atteggiamenti si delineano due diversi metodi: il primo utilizza un approccio analitico, il secondo, invece, usa norme di tipo sintetico. Questi metodi non sono necessariamente in antitesi tra loro: come suggerisce Del Sordo – rifacendosi al testo Discourse on a New Method. Reinvigorating the Marriage of History and Philosophy of Science curato da Mary Domsky e Michael Dickson (Domsky e Dickson, 2010) –, «L’obiettivo dell’analisi non è quello di scomporre un oggetto in frammenti, quanto piuttosto quello di entrare nella profondità e opacità dello stesso […]. La sintesi, dall’altra parte, non ammonta a una connessione eterogenea o arbitraria di elementi tra loro irrelati […]. Essa serve piuttosto ad articolare la già data connessione tra A e B, nonché a renderla intelligibile, rendendone ragione, motivandola o giustificandola»(p. 58). Tale metodologia, che interseca la riflessione filosofica con il contesto storico in cui essa si sviluppa, «è molto specifica. Non si tratta infatti di trovare le “big pictures” che collegano ad esempio la figura di Cartesio al passaggio dalla filosofia della natura aristotelico-scolastica a quella meccanica o lo sviluppo della computer science a quello di varie teorie della mente. Si tratta piuttosto di rintracciare questioni più sottili che collegano ad esempio le leggi della meccanica newtoniana al tentativo kantiano di ricercare le condizioni che rendono possibili conoscenze sintetiche a priori […] (p. 60).
Del Sordo segue questa strada per indagare i rapporti tra Carnap e il monismo neutrale. Questa classe di teorie metafisiche, che trova la sua massima espressione negli scritti di Ernst Mach, William James e Bertrand Russell, intende superare sia il materialismo legato alla concezione galileiana del mondo fisico, sia lo spiritualismo che fa riferimento alla res cogitans cartesiana attraverso una visione unitaria del reale. Autorevoli studiosi come Erik Banks hanno escluso qualsiasi tipo di legame tra il monismo neutrale e la filosofia di Carnap, facendo leva sulla visione deflazionata dell’ontologia tipica del Circolo di Vienna (Banks, 2014). Tuttavia, Del Sordo esprime un’altra convinzione: facendo riferimento al manoscritto inedito Vom Chaos zur Wirklichkeit (Carnap, 1922), l’autrice mette in evidenza come, per Carnap, «La realtà [sia] costruita da un onnicomprensivo will-to-order da cui lo stesso intelletto dell’epistemologo viene giocato, costituito o determinato» (p. 87); tale idea è in accordo con la visione sostanziale dell’ontologia esposta da Mach, secondo cui la conoscenza della realtà dipende dalla scoperta di nuove relazioni tra i fenomeni (Guidetti, 2021, p. 27).
Proprio la natura relazionale della realtà è l’aspetto su cui poggia la proposta di filosofia scientifica di Del Sordo: le relazioni tra diversi elementi comportano la creazione di strutture, nozione fondamentale sia nella filosofia sia nelle scienze. Nel terzo capitolo, infatti, Del Sordo mostra al lettore alcuni risultati della sua collaborazione con il filosofo e matematico Thomas Mormann. L’uso di costruzioni concettuali strutturali – come, ad esempio, il teorema M3 – N5 – è una pratica basilare nella costruzione del sapere, sia esso filosofico o scientifico. Le criticità emergono quando si passa dal piano concettuale a quello empirico: in questo passaggio, infatti, si creano variazioni e ambiguità. Questo fatto, che in apparenza sembra invalidare il lavoro di Carnap, è, in realtà, pienamente consonante con il contenuto de La costruzione logica del mondo (Carnap, 1997), dove si distingue tra un approccio sistematico di carattere logico-epistemologico e un approccio sistemico di carattere pratico-operativo. Le strutture, dunque, non sono delle mere costruzioni logiche, bensì delle operazioni che fanno emergere la pragmaticità di determinate conoscenze; esse colgono la dinamicità del reale, sia nelle sue declinazioni teoretiche sia nei suoi risvolti pratici. Quest’ottica relazionale-strutturale permette a Del Sordo di praticare un’interessante operazione di ingegneria concettuale: partendo dalle classiche coppie «realtà metafisica / realtà empirica; ontico / ontologico; realismo empirico / realismo metafisico», l’autrice elabora le terne «realtà profonda / realtà empirica / realtà metafisica; ontale / ontico / ontologico; realismo profondo / realismo empirico / realismo metafisico» (p. 124). Così facendo, Del Sordo apre nuovi scenari di ricerca, non solo per gli studi su Carnap, ma anche per l’indagine filosofico-scientifica in generale.
Come detto in precedenza, il libro di Del Sordo è un’aggiunta molto interessante agli studi in ambito epistemologico. Oltre a fornire una rilettura significativa dell’opera di Carnap, il testo solleva altre due questioni di notevole spessore: la prima riguarda il rapporto tra universale e particolare, analizzato in ambito politico già da Jean-Jacques Rousseau (Rousseau, 2003), affrontato in un’ottica geo-culturale da Dipesh Chackrabarty (Chakrabarty, 2004) e indagato ottimamente nei suoi legami con il digitale da Mauro Barberis (Barberis, 2024); la seconda, invece, concerne le infinite potenzialità dell’ermeneutica, ampiamente discusse da Hans-Georg Gadamer (Gadamer, 2000). In Del Sordo, queste due questioni convergono nella sfera epistemologica; come scrive l’autrice stessa: «Se qualcosa nasce, si sviluppa e muore, può dirsi avere una vita. In questo senso, hanno una vita non solo gli organismi animali o vegetali, ma anche i prodotti della cultura o del pensiero, che si originano e si sviluppano per poi morire o decadere» (p. 21). La metafora del ciclo vitale è particolarmente calzante: nel corso del loro vissuto, gli animali e i vegetali si trovano in una fitta rete di interconnessioni che modificano continuamente i soggetti coinvolti; lo stesso accade per i prodotti culturali, sempre suscettibili alla relazione e alla ridiscussione. Del Sordo ci guida in un percorso che dimostra chiaramente questa connessione tra pensiero e vita.
Efrem Trevisan
Bibliografia
Banks, E. (2014). The Realistic Empiricism of Mach, James and Russell. Neutral Monism Reconsidered, Cambridge University Press, Cambridge.
Barberis, M. (2024). L’incanto del mondo. Un’introduzione al pluralismo, Meltemi, Milano.
Carnap, R. (1922). Vom Chaos zur Wirklichkeit, Document RC 081-05-01, Archives of Scientific Philosophy, Hillman Library, Pittsburgh University.
Carnap, R. (1997). La costruzione logica del mondo. Pseudoproblemi nella filosofia, UTET, Torino.
Chakrabarty, D. (2004). Provincializzare l’Europa, Meltemi, Roma.
Domsky, M., Dickson, M. (ed.). (2010). Discourse on a New Method. Reinvigorating the Marriage of History and Philosophy of Science, Open Court, Chicago and La Salle.
Gadamer, H.-G. (2000). Verità e metodo, Bompiani, Milano.
Guidetti, L. (2021). Gli elementi dell’esperienza. Studi su Ernst Mach, Quodlibet, Macerata.
Husserl, E. (2003). Metodo fenomenologico statico e genetico, Il Saggiatore, Milano.
Rousseau J.-J. (2003). Il contratto sociale, Feltrinelli, Milano.
-
«Che cos’è il digitale e come può essere definito? Cos’ha da dire la tradizione fenomenologica, sviluppatasi più di un secolo fa, su tale questione? Come percepiamo e come entriamo in relazione con oggetti, eventi e ambienti nell’era digitale? Come viviamo il nostro corpo e come questo si modifica in ambienti diversi da quello analogico, per esempio nella realtà virtuale o nella realtà aumentata?» (p. 11). Sono queste le domande alla base del testo "Fenomenologia del digitale. Corpi e dimensioni al tempo dell’intelligenza artificiale" (Mimesis, 2024) scritto da Floriana Ferro. L’autrice studia da anni la tradizione fenomenologica e, nell’opera, utilizza questo approccio per indagare il rapporto tra l’umano e le nuove tecnologie digitali, fino a giungere a una proposta originale su come dovremmo vivere tale rapporto.
L’autore che guida la trattazione di Ferro è Maurice Merleau-Ponty. Nel libro si fa costante riferimento al concetto di “carne”, che il filosofo francese elabora nella tarda fase del suo pensiero. Tale concetto nasce dall’esigenza di superare il dualismo ancora presente nella Fenomenologia della percezione (1945) in favore di un monismo che annulli la distinzione tra Leib e Körper. Ne Il visibile e l’invisibile (1964), Merleau-Ponty scrive:
Ciò che chiamiamo carne, questa massa interiormente travagliata, non ha nome in nessuna filosofia. Medium formatore dell’oggetto e del soggetto, essa non è l’atomo d’essere, l’in sé duro che risiede in un luogo e in un momento unici […]. Si deve pensare la carne non già a partire dalle sostanze, […] ma, dicevamo, come elemento, emblema concreto di un modo d’essere generale (Merleau-Ponty, 2003, p. 163).
Il concetto di “carne” mostra, dunque, una realtà viva e dinamica, in cui i vari elementi interagiscono tra loro grazie a un comune modo d’essere. La figura che rappresenta al meglio questa situazione è quella del chiasma, caratterizzata «da un intreccio dinamico tra polarità divergenti. Nella x e nella χ vengono raffigurate due linee che partono da due punti diversi, si incontrano in un punto e poi seguono direzioni opposte» (p. 36). In questo movimento dialettico – da intendere in senso schellinghiano e non hegeliano – si considera la realtà nella sua pluralità di rapporti, tutti essenziali per comprendere la complessità e la ricchezza del mondo in cui viviamo.
Partendo dalla prospettiva merleau-pontiana, Ferro esamina la relazione che si instaura tra noi e gli ambienti digitali. La realtà virtuale e la realtà aumentata, infatti, sono presenze sempre più familiari e la loro natura e funzione chiamano in causa anche la riflessione filosofica. Una delle tesi presenti nel libro è che gli ambienti analogici e digitali non siano in un rapporto antitetico, bensì esista un continuum tra loro. Per sostenere tale posizione, l’autrice fa riferimento all’idea di Umwelt, esposta da filosofi come Edmund Husserl e lo stesso Merleau-Ponty, ma anche da scienziati come Jakob von Uexküll. L’interconnessione tra il soggetto e l’ambiente circostante applicata alle nuove tecnologie digitali e lo sviluppo dialettico della realtà legato alla “carne” consentono a Ferro di proporre una nuova versione della realtà, che si differenzia sia da quella di Milgram, Kishino e altri del 1994, sia da quella più recente di Skarbez e altri, elaborata nel 2021. Se le prime due versioni individuano nel reale e nel virtuale i due poli della realtà, Ferro – richiamando le polarità ontologiche “possibile-reale” e “virtuale-attuale” formulate da Pierre Lévy nella sua rilettura della filosofia di Gilles Deleuze – esprime una convinzione diversa:
[…] il virtuale non è da considerarsi in contrapposizione al reale, ma come una caratteristica del suo movimento dialettico. I due elementi che costituiscono il reale sono, invece, l’analogico e il digitale, che consistono in due diversi poli della carne, l’elemento comune della realtà. Questi due poli si relazionano dinamicamente in maniera chiasmatica, incontrandosi senza mai sovrapporsi o rischiare di annichilire l’altro polo (p. 77).
Cosa rende possibile l’esperienza del continuum analogico-digitale? Per rispondere a questo quesito, Ferro usa il concetto di “analogia”, declinandolo in chiave fenomenologica. L’esperienza in ambienti diversi presenta comunque dei punti di continuità, poiché tutti partecipano a questo modo di essere che caratterizza la “carne”, consentendo di parlare di analogia transdimensionale. «[…] le relazioni percettive [s]i possono quindi considerare come soggette ad analogie applicabili a dimensioni differenti. L’oggetto è quindi ”analogo”: ciò significa che non rimane del tutto uguale, né cambia totalmente al mutare della dimensione» (p. 126).
Meritevole di particolare attenzione è il quarto capitolo, in cui si analizza il complesso rapporto tra i corpi umani e quelli artificiali. In questo contesto, Ferro dimostra le connessioni che sussistono tra la filosofia e l’ingegneria robotica: l’interazione tra gli umani e i robot è un campo di studio in grande crescita, guidato soprattutto dagli sviluppi dell’IA. La Human Robot Interaction (HRI) porta all’attenzione la questione dell’empatia, ampiamente discussa dalla filosofia e, in particolar modo, dalla fenomenologia. Per comprendere empaticamente l’altro dobbiamo porre uguale attenzione sui due termini dell’espressione alter ego: in primo luogo, devo riconoscerlo come ego in grado di esercitare un comportamento analogo al mio (come avviene nell’associazione appaiante di Husserl); in secondo luogo, devo anche essere consapevole delle differenze tra il mio vissuto e il suo (elemento base dell’empatia descritta da Edith Stein). Numerosi esperimenti dimostrano come gli umani, pur interagendo con degli umanoidi artificiali, esperiscano il doppio movimento appena delineato, riuscendo a provare empatia verso i robot. Secondo Ferro questo è possibile grazie a una comune esperienza del corpo e della “carne” che, come fatto in precedenza, permette di parlare di un’analogia transcorporea.
L’analogia transdimensionale e l’analogia transcorporea conducono alla proposta di un’ontologia piatta (flat ontology). Come sottolinea l’autrice, il termine “piatto” non deve essere interpretato come mancanza di stratificazione della realtà; infatti, «Il concetto di ontologia piatta, inteso in senso fenomenologico, non implica una realtà priva di profondità, bensì la mancanza di una struttura gerarchica degli enti» (p. 169). Quest’ottica, tipica del postumano, viene qui usata per reinterpretare il tardo pensiero merleau-pontiano, evidenziando le infinite interconnessioni tra entità umane e non umane, accumunate da un’unica modalità di esistenza che, però, non annulla mai le loro peculiarità. A conclusione del capitolo, Ferro amplia la prospettiva, includendo nella sua analisi tre esempi di ontologia piatta tratti da autori contemporanei: la Actor-Network Theory (ANT) di Bruno Latour, la Object-Oriented Ontology (OOO) di Graham Harman e l’onticologia di Levi Bryant. Queste proposte – pur nelle loro differenze, messe ben in luce dall’autrice – hanno il pregio di guardare la realtà in modo non antropocentrico, valorizzando lo statuto ontologico degli enti che spesso vengono esclusi dalla riflessione filosofica e scientifica.
Nella sua critica alla metafisica classica di stampo aristotelico-tomista, Deleuze si ispira all’ontologia dell’univocità promossa da Duns Scoto, secondo cui gli enti non differiscono in virtù di un maggior o minor grado di partecipazione all’essere; «Le differenze ci sono, ma l’essere si distribuisce in maniera equa: si predica allo stesso modo per tutte le modalità individuanti, malgrado queste siano diverse l’una rispetto all’altra» (p. 185). In Differenza e ripetizione (1968), il filosofo francese oppone all’immagine di un nómos sedentario, che non coglie la dinamicità del reale, quella di un nómos nomade, capace di comprendere la natura della differenza. La proposta di Ferro segue quest’ultimo (valorizzando, però, anche la verticalità dell’essere), offrendo un’ottima introduzione alla fenomenologia del digitale, ricca di riferimenti bibliografici e feconda di spunti da poter sviluppare: nel libro, infatti, si trovano rimandi (per citarne alcuni) anche alla postfenomenologia, alla teoria ecologica e alla Gestaltpsychologie.
Discutere il nostro rapporto con il digitale è un problema sempre più impellente, nonché un dovere per noi esseri umani: come affermava già Martin Heidegger nella conferenza La questione della tecnica (1953), l’umano è homo technicus, ovvero capace di disvelare l’essere tramite la sua attività produttiva; ma, contemporaneamente, egli è anche homo technologicus, in grado, cioè, di pensare e discutere il suo essere tecnico. Fenomenologia del digitale. Corpi e dimensioni al tempo dell’intelligenza artificiale è un prezioso strumento per iniziare questa discussione.
Efrem Trevisan
Bibliografia
Deleuze, G. (1997). Differenza e ripetizione, Raffaello Cortina, Milano.
Heidegger, M. (1991). La questione della tecnica, in Saggi e discorsi, Mursia, Milano.
Merleau-Ponty, M. (2003). Fenomenologia della percezione, Bompiani, Milano.
Merleau-Ponty, M. (2003). Il visibile e l’invisibile, Bompiani, Milano.
-
Sul razzismo di Fabio Ciracì
Recensioni / Dicembre 2024Non sono prigioniero della Storia. Non devo ricercarvi il senso del mio destino. Devo ricordarmi in ogni momento che il vero e proprio salto consiste nell’introdurre l’invenzione nell’esistenza. (F. Fanon, Pelle nera, maschere bianche) [1]
....
L’attualità di Sul razzismo. Strutture logiche e paradigmi storico-filosofici di Fabio Ciracì è, per limitarsi a un aggettivo, disturbante. Non che l’attualità di per sé sia un criterio per misurare la tenuta filosofica di una proposta teorica, ma in questo caso colpisce il fatto che la fucina di ideazione e lavorazione del volume, ossia la constatazione della legittimazione di fatto e di diritto della violenza xenofoba in seguito al risultato delle elezioni politiche americane del 2016 si ritrovi pressocché identica a se stessa otto anni dopo, e che il libro venga dato alle stampe mentre Trump e la destra conservatrice si confermano ai vertici del potere.
Assistiamo oggi al trionfo di quell’incubatrice ideologica all’interno della quale l’uso massiccio di un linguaggio esplicitamente xenofobo irrobustisce le proprie gambe fino ad abbandonare il nido, pericoloso ma apparentemente circoscritto, della retorica politica, nell’attesa della prossima Charlottesville e del prossimo Georges Floyd. Se la sensazione di déjà-vu si accompagna inevitabilmente a un certo modo di indugiare nello sconforto, l’analisi di Ciracì non autorizza ad attardarsi sul territorio arido dell’autocommiserazione, ma avanza ponendo la questione intorno alle ragioni profonde della rinnovata riuscita di un clamoroso Trump-l’œil. Sul piano speculativo, egli non ritiene più sufficiente nemmeno impegnarsi nel mostrare, con clamore o con pacatezza, come scriveva Fanon, che «ci sono troppi imbecilli su questa terra» [2]; piuttosto, occorre fare un passo indietro, guadagnando così quella distanza filosofico-ermeneutica grazie alla quale il fragore dell’incrocio tra spade si attenua, permettendo alle strutture logico-concettuali dalle quali il conflitto trae alimento di emergere nei propri tratti costitutivi. La presa di discorso all’interno di questo spazio ha una intenzione molto chiara, che può essere espressa con le parole di Machiavelli: «voi piangerete anchora, et sanza fructo, se non vi mutate di opinione; perché io vi dico che la Fortuna non muta sententia, dove non si muta ordine; né e cieli vogliono o possono sostenere una cosa che voglia ruinare ad ogni modo» [3]. L’orizzonte di riferimento è quindi – e non potrebbe essere diversamente – quello etico: la proposta sulla quale si apre e conclude il volume è il dischiudersi di una «etica solidaristica» (p. 404), cantiere di lavoro di oggi per l’avvenire. Per tenere insieme queste due dimensioni senza cadere nella forma sclerotizzata del manuale o del breviario, Ciracì si situa con decisione nel solco metodologico della teoria critica. Ben radicato nella storia materiale delle idee, l’autore si impegna nel sovraesporre, come in una camera oscura, il passaggio del razzismo da visione del mondo a ideologia, fino a fare emergere gli strumenti categoriali scomodati nel processo di razionalizzazione sistematica della discriminazione, il cui fine «è fissare posizioni di privilegio – rispetto alla gestione e l’allocazione delle risorse disponibili o allo status di riconoscimento sociale – di una certa classe di individui all’interno della società, a discapito di individui subalterni» (pp. 20-21). Dopo aver specificato che le pulsioni identitarie e gli istinti aggressivi su cui il razzismo fa leva sono precategoriali, e non coincidono quindi con i valori morali che le costruzioni culturali associano loro, Ciracì fa emergere un elemento fondamentale del discorso razzista, che ritorna come un Leitmotiv lungo le due macro sezioni del volume: la sua legittimazione passa attraverso la costruzione dell’altro. Questo esercizio creativo del razzismo si è affinato nel tempo: da un modo ingenuo e rudimentale di sfruttamento della paura in funzione xenofoba a elaborate pretese ontologico-ritrattistiche (si pensi all’hitleriano «Wer Jude ist, das bestimme ich»). La complessità del fenomeno costringe a procedere lungo un doppio binario: se la prima parte del volume si interroga sugli strumenti categoriali che definiscono il razzismo, come essenza, identità, alterità, purezza, parallelismo fisico-psichico, deumanizzazione e tradizione dell’odio, nonché su quelle due categorie storico-ermeneutiche che sono l’evoluzione e la degenerazione, la seconda parte si concentra sui profili storico-filosofici dell’alterità, dallo xénos greco al mito del buon selvaggio, attraverso i quali emerge la genealogia del concetto di razza. Questo lavoro di scavo permette una interrogazione stratificata dei paradigmi interpretativi del fenomeno razziale, come il colore della pelle, la purezza del sangue, il tema del suolo natìo, le caratteristiche fisiche teorizzate dalla fisiognomica e della frenologia, fino ad arrivare all’iperrazzismo. Attraverso questa griglia complessa è possibile mettere in tensione le specificità delle diverse forme storiche del razzismo (religioso, fenotipico, naturalistico, ariano, nero, sovranista, …) su un ordito di invarianza. E se a definizione univoca non corrisponde un oggetto molare, bensì una realtà molecolare, l’assalto frontale monodirezionato come strategia d’attacco deve cedere il posto a una forma di guerriglia organizzata. Attraverso incursioni mirate, Ciracì mostra come dietro a ogni supposto ritratto si celi una maldestra caricatura, inevitabilmente contraddittoria. Per quanto possa suonare anti-intuitivo infatti, il tema del mascheramento fa parte sin dalla grecità del discorso intorno allo straniero, e può forse fornire una traccia di lettura non del tutto oziosa per attraversare alcuni passaggi di Sul razzismo. Il suo contraltare teorico, ossia la più immediata capacità di riconoscere “a occhio nudo” il diverso, potrebbe allora essere pensato non come il momento in cui la maschera cade, ma al contrario come il portato fondamentale della maschera stessa. Ma procediamo per punti. Scrive Ciracì in apertura alla seconda sezione del volume:
Xénos è anche la maschera ritrovata in mare da alcuni pescatori dell’isola di Lesbo, interpretata come epifania proprio di Dioniso. Quindi, il dio delle maschere è il dio straniero (tracio) perché, coprendosi il volto, non può essere identificato, rimane celato. La maschera però è sia lo strumento che copre il vero volto, per proteggerlo, sia l’immagine che rivela il personaggio, dal latino persona, ovvero la maschera attoriale, che porta con sé un universo simbolico e identitario complesso, il tramite della relazione sociale. (p. 152)
La maschera è dunque un modo dell’ambiguità tra nascondimento e svelamento, e non necessariamente un correlato del pensiero dell’essenzializzazione, ossia di quel binarismo teorico-psicologico che Ciracì aggredisce in ogni pagina del volume. Ora, la peculiarità di questo strumento teorico è che non appena la maschera viene appiattita lungo una delle due direzioni perde, insieme alla sua capacità di mettere in sospeso, il proprio potenziale critico, e cade a servizio dell’ideologia. Per questa ragione il suo utilizzo fa gioco e controgioco al discorso razzista, e se da una parte lo afferma e lo rinforza, dall’altro gli sottrae terreno. La razza, «simulacro di un’essenza, un feticcio ideologico […] deve per definizione essere immutabile e pura» (p. 95), e può esprimersi direttamente sul corpo del soggetto (colore della pelle, naso aquilino, labbra sporgenti, bozzi sul cranio, occhi bovini, mostruosità di sorta), oppure manifestarsi nel suo comportamento intellettivo-morale (esseri incolti, grado zero della civilizzazione, criminali e figure paradigmatiche dell’immoralità, viziosi, parassiti della società). Ad ogni incrocio tra questi due piani si trova una maschera, fissa e necessaria, con pretese ontologiche: la sensazione che si ha è allora quella di procedere lungo una galleria fotografica, alle cui pareti sono affisse caricature e bozzetti che si spacciano per ritratti, un museo di feticci ideologici le cui specificità traggono le mosse, di volta in volta, dalla contingenza storica. Sul crinale della corrispondenza biunivoca tra interiorità e fattezze estetiche troviamo il primato del “colpo d’occhio”, che può essere più o meno specialistico, e che è il grado zero della maschera: il corpo disarmonico o brutto, il volto segnato come quello di Caino, il razzismo della pelle e le categorie fisiognomiche più elementari fino alla silhouette di Lavater, passando per le tassonomie naturaliste, sono alla portata di tutti, mentre l’indice cefalico di André Retzius o le dimensioni del cranio descritte da Blumenbach hanno bisogno di strumenti tecnici di misurazione. Ma se la pelle nera è «una sorta di stigma visibile del male» (p. 171), occorre anche correggere la storia laddove rischia di smentire la coincidenza tra caratteristiche fisiche e qualità morali. Tra i diversi casi di manipolazione storica affrontati da Ciracì, tra cui Winckelmann che, lavando via dalle statue greche gli ultimi residui di colore, «inventa, con l’olio di gomito delle brave massaie, la classicità bianca e abbagliante che ammiriamo oggi nelle collezioni d’arte di tutto il mondo» [4], vale senz’altro la pena ricordare la lattizzazione di Sant’Agostino, di colore nelle rappresentazioni del XIV secolo, ma sbiancato mille anni dopo la sua nascita per assurgere a padre della chiesa cattolica occidentale. Maschere bianche, insomma. Ma la maschera è anche un rischio per il razzista, che prova a difendersi con argomenti come la «purezza del sangue» (p. 171). Preoccupazione di Ferdinando II d’Aragona e di Isabella di Castiglia era infatti che la conversione degli ebrei al cattolicesimo potesse essere una conversione “di facciata”, una maschera da aggirare attraverso il riferimento del decreto del 1492 alla purezza del sangue. In questi casi al razzista non basta allora il colpo d’occhio, egli deve scovare, ricercare, farsi più astuto dell’infido che rincorre, mappare, rintracciare le coordinate che inchiodano il subalterno al proprio stato. Lungo l’asse dello svelamento un esempio particolarmente interessante che Ciracì affronta in questo volume è il fenomeno dell’iperrazzismo, dunque di un razzismo in cui al criterio genetico fenotipicamente espresso occorre aggiungere un principio di selezione territoriale. Se la vitalità di un conquistador nato in terra straniera era già ritenuta inferiore a quella di un figlio della corona nato in Spagna, questo principio ritorna nel Blut und Boden ariano e nel razzismo antisemita di Julius Evola. La questione non è pacifica perché, come Ciracì non manca di sottolineare, il cosiddetto principio di Anteo mal si coniuga alla Machtpolitik, perché la terra conquistata è e rimane straniera, inadatta ad alimentare le forze vitali dei non autoctoni. È a questa altezza che Ciracì infligge un colpo teorico di un certo spessore:
Il confine di questa posizione è il limite negativo del concetto di razza, ovvero il pericolo del meticciato, che può giungere all’ideazione di una non-razza, come l’ebreo di Evola che sfugge finanche alla classificazione razziale altrui. Da qui si evince l’arbitrarietà della definizione di altro e la sua strumentalità politica e sociale. E anche la capacità del potere di soggettivizzare i sottomessi e i subalterni. (p. 306)
Fuori dall’essenzialismo, l’altro si riappropria della propria dimensione ambigua e inafferrabile, riafferma quel connotato già presente nello xénos greco e antagonista alla logica razzista, permettendo a sua volta a quell’io che lo definisce come altro da sé di strapparsi di dosso le effigie del binarismo identitario. In conclusione al volume, Ciracì prende posizione all’interno del dibattito contemporaneo sull’antirazzismo: se l’antirazzismo è, con Traverso, una battaglia per la memoria, occorre interrogare la cancel cultur come pratica per non cadere nel rischio di farne l’ultima maschera del razzismo:
Si tratta […] di operare una risignificazione culturale, un processo di destrutturazione del potere: decolonizzare la storia. Tale processo non ha solo una pars destruens, ma anche una pars construens, ovvero una riappropriazione di un passato obliterato dal potere (pp. 388-389).
L’invito di Ciracì è allora a risemantizzare, ovvero a ricollocare il significato del fatto storico, e di conseguenza dei modi in cui se ne preserva la memoria, all’interno di un contesto culturale e sociale. Si tratta di una vera e propria ritenzione terziaria, il cui esempio preso qui in esame è la risposta di Banksy alla proposta di reinserire la statua di Edward Colston, commerciante di schiavi nella rotta atlantica, sul suo piedistallo in un parco di Bristol, dopo che i manifestanti antirazzisti l’hanno abbattuta nel 2020. La proposta dell’artista è quella di rimettere la statua al suo posto, aggiungendo però alla sua prima versione il ricordo della sua contestazione: l’aggiunta dei manifestanti a grandezza reale che, armati di corde, la trascinano giù, potrebbe allora rappresentare una scelta percorribile a difesa di una pluralità di senso. La risemantizzazione auspicata da Ciracì non lascia indenne il diritto: allo stesso modo occorre, per il filosofo, riformulare l’articolo 3 della Costituzione italiana, nel quale compare l’espressione “razza”. Coerentemente a quanto espresso, non si tratta di elidere il termine, ma di scardinare il vocabolario essenzialista al quale ammicca, per farla finita, una volta per tutte, con il dog-whistling e con ogni forma di compiacenza al razzismo.
Emilia Marra
[1] F. Fanon, Pelle nera, maschere bianche, tr. it. di S. Chiletti, ETS, Pisa 2015, p. 206.
[2] Ivi, p. 25.
[3] Cfr. Machiavelli, Parole da dirle sopra la provisione del danaio, in Id., “Opere di Niccolò Machiavelli”, a cura di E. Raimondi, Mursia, Milano 1966.
[4] R. Falcinelli, Cromorama, Einaudi, Torino 2017, pp. 303-304.
-
Adam Smith e la Theory of Moral Sentiments
Recensioni / Maggio 2024La Theory of Moral Sentiments (1759/1790) di Adam Smith (1723-1790) rappresenta una delle perle dell’Illuminismo scozzese. Opera di ampio respiro, essa riflette l’eccezionale estensione teorica dei corsi universitari di filosofia morale tenuti dall’autore presso l’Università di Glasgow a partire dal 1752, nel seno dei quali questo lavoro venne alla luce. Essa si articola intorno all’intento principale di una descrizione della vita morale umana (la genesi del giudizio morale, lo spettro delle virtù, l’interazione tra le diverse passioni), fornendo allo stesso tempo interessanti spunti di riflessione in materia di etica normativa, filosofia politica, epistemologia, estetica e teologia naturale. Smith raccoglie e rielabora criticamente gli stimoli dei grandi teorici britannici della natura umana (Hobbes, Cudworth, Shaftesbury, Mandeville, Hutcheson, Butler e Hume), contribuendo al dibattito intorno alla naturale socievolezza dell’uomo con un’originale interpretazione del ruolo della spettatorialità (spettatore interno, pubblico esterno) e della comunicazione affettiva (simpatia). Il progetto di Smith è sviluppato in maniera ordinata e didascalica, e in ciò risiede uno dei grandi meriti di quest’opera: non solo l’argomentazione ricerca pazientemente – seppur non sempre con successo – la chiarezza, bensì essa si accompagna di innumerevoli esempi volti a illustrare le diverse declinazioni e sfumature dei propri concetti chiave.
La Theory of Moral Sentiments fu probabilmente l’opera più cara al filosofo scozzese, il quale non ne abbandonò mai il lavoro di revisione. Sei sono le edizioni che videro la luce durante la vita di Smith: 1759, 1761, 1767, 1774, 1781, 1790 – quest’ultima appena poche settimane prima della morte dell’autore. Sin dalla prima pubblicazione, essa rese celebre il professore scozzese in tutta Europa, consacrandolo al pantheon della filosofia occidentale. La fama di Smith fu destinata a crescere a dismisura, anche oltreoceano, con la prima pubblicazione di An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (WN) nel 1776, la quale tuttavia sancì il graduale oblio della prima opera presso il pubblico. Mentre in ambito anglosassone la Theory of Moral Sentiments continuò a suscitare un qualche interesse, nel Continente essa venne perlopiù negletta per tutto il corso del XIX secolo. In Germania bisognerà aspettare più di centotrent’anni per una nuova traduzione [1]; in Italia, essendo mancata una pronta traduzione integrale, si dovrà aspettare addirittura il 1991, anno in cui apparve l’edizione di Adelino Zanini, con la traduzione di Cesare Cozzo, per i tipi dell’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Treccani [2].
Il tardo ‘900 vide una vera e propria rinascita dell’interesse per la teoria morale di Smith. Non sorprende che questo avvenne, in una certa misura, proprio tramite WN. Fu infatti per il bicentenario di quest’ultima che si avviarono i lavori per una nuova edizione critica delle opere del filosofo scozzese: la Glasgow Edition of the Works and Correspondence of Adam Smith (Oxford, Oxford University Press, 1976-1987). E fu sulla base della nuova edizione critica di Theory of Moral Sentiments curata da David D. Raphael e Alec L. Macfie che furono redatte le traduzioni italiane integrali oggi disponibili: la già citata edizione di Zanini (1991), quella di Eugenio Lecaldano (trad. it. S. Di Pietro, Milano, BUR, 1995) e la presente di Riccardo Bonfiglioli e Domenico Felice (2024).
Sebbene l’edizione di Lecaldano rimanga sotto diversi rispetti insuperata, la nuova edizione Mimesis ha il merito e il vantaggio di fornire allo studioso italiano una bibliografia aggiornata degli studi sul pensiero smithiano svolti negli ultimi anni (pp. 510-527) – una letteratura in crescita esponenziale non solo a seguito della “Glasgow edition”, bensì anche del duecentocinquantenario della prima pubblicazione di Theory of Moral Sentiments (2009) e del tricentenario della nascita dell’autore (2023). Per ciò che riguarda la generale impostazione editoriale del testo di Smith, va apprezzata la numerazione dei capoversi seguendo l’edizione critica inglese (una scelta già operata da Lecaldano ma non da Zanini).
Vanno tuttavia segnalate due mancanze. La prima, comune a tutte le edizioni italiane di Theory of Moral Sentiments, riguarda l’espunzione delle Considerations concering the first formation of languages, And the different genius of original and compounded languages, testo del 1761 che l’autore volle annettere a Theory of Moral Sentiments a partire dalla terza edizione (1767), per preservarlo sino all’ultima edizione da lui stesso curata (1790). L’assenza di tale saggio in appendice è da imputare all’adozione dell’edizione Glasgow del 1976 quale testo di riferimento (anche per gli apparati critici), nella quale esso è altresì omesso [3]. Sebbene si possa discutere sulla rilevanza di tale saggio per una lettura informata di Theory of Moral Sentiments, la sua eliminazione tradisce le indicazioni dello stesso Smith [4]. La seconda mancanza, propria dell’edizione Mimesis, concerne l’assenza di un indice degli argomenti, strumento utile allo studioso che tenti di ricostruire la trama di alcuni concetti chiave dell’opera. Al lettore, che per tali questioni è costretto a tornare alle edizioni Glasgow, Zanini o Lecaldano, è fornito il solo Indice dei nomi (pp. 529-532).
L’Introduzione di Bonfiglioli, seppur non altrettanto ricca quanto quella delle edizioni precedenti, è ben organizzata secondo alcuni punti chiave per l’interpretazione del testo smithiano. In generale, si osserva il tentativo di concentrarsi su Smith senza digredire sui prestiti e sulle critiche nei confronti di autori quali Hume. Da un lato, tale scelta è apprezzabile nella misura in cui suggerisce l’originalità del pensiero di Smith; dall’altro, al lettore italiano potrebbe giovare una maggiore attenzione alla ricezione smithiana dei testi di Hume per ciò che concerne i temi dell’immaginazione, della simpatia e della spettatorialità. L’Introduzione si apre con alcuni cenni biografici (§1), cui segue un’esposizione del contesto storico-culturale della Scozia del XVIII secolo (§2) – un denso paragrafo ricco di risorse bibliografiche che restituisce una buona immagine dei fermenti politici, religiosi e culturali dell’epoca. I paragrafi 3 (Caratteri generali de La teoria dei sentimenti morali), 4 (Sullo stile dell’opera) e 5 (Fonti teoriche della teoria morale di Smith) presentano lo spirito di Theory of moral sentiments nei suoi tratti generali. Apprezzato è il ricorso al sottotitolo dell’opera (“An essay towards an analysis of the principles by which men naturally judge concerning the conduct and character, first of their neighbours, and afterwards of themselves”) per introdurne i contenuti, sebbene tale sottotitolo non venga poi riportato nel frontespizio del testo smithiano [5]. Bonfiglioli rimarca la grande attenzione lessicale, gli intenti illustrativi e l’apertura al dialogo di Smith, quale buon filosofo e paziente professore, nei confronti dei pensatori di cui si fa interlocutore; inoltre, egli descrive correttamente la posizione di Theory of Moral Sentiments all’interno del processo di naturalizzazione della morale che caratterizza il ‘700 e che trova i propri antecedenti nella tradizione del diritto naturale seicentesca. Infine, i paragrafi 6-9, di carattere interpretativo, intendono introdurre il lettore ai concetti chiave della riflessione morale di Smith. A un paragrafo dedicato all’immaginazione (§6), forse troppo conciso ed eccessivamente silente nei confronti del retaggio humeano, segue una buona esposizione della complessità e dell’originalità dell’utilizzo smithiano della nozione di simpatia (§7). Tali tematiche sfociano naturalmente nella trattazione della spettatorialità (§8). Bonfiglioli schematizza brevemente ma in maniera sufficientemente efficace la pluralità, la fluidità e l’intreccio tra i diversi tipi di spettori coinvolti nella riflessione morale del singolo: gli spettatori esterni e lo spettatore interno (tendente all’imparzialità ma di fatto influenzato dagli interessi del singolo e dallo sguardo del pubblico esterno). Tuttavia, non ci troviamo d’accordo con l’identificazione dello spettatore esterno con lo spettatore “reale” tout court, che sorvola la questione degli spettatori esterni “possibili” (i.e. la profonda radicazione dell’occhio pubblico nella quotidianità del singolo, quella tendenza a comportarsi comunque, anche in solitudine, come se si fosse visti e giudicati – non solo appunto dallo spettatore interno ma anche e soprattutto dagli altri nostri simili), che costituisce uno dei più interessanti terreni di scontro tra i moralisti del sentimento e i teorici della morale egoista. L’Introduzione si conclude con un paragrafo dedicato alla filosofia della storia. Per quanto interessante, si tratta di una tematica non specifica a Theory of Moral Sentiments, bensì trasversale a tutti gli scritti dell’autore. Per tale ragione, accanto alle pur importanti indicazioni bibliografiche, si sarebbe apprezzato un qualche riferimento – qui assente – alle opere di Smith.
Da ultimo, per ciò che riguarda la traduzione, osserviamo la scelta di aderire, fin dove possibile, alla sintattica e alle particolarità lessicali del testo originale. Ciò comporta il vantaggio di sollecitare il lettore all’adozione di schemi di pensiero possibilmente più prossimi alle originarie intenzioni dell’autore, ma rende la lettura talvolta meno agevole e non altrettanto gradevole quanto nella versione inglese. Inoltre, le traduzioni di Cozzo (per l’edizione di Zanini del ’91) e di Di Pietro (per l’edizione di Lecaldano del ’95) paiono in generale più attente, come emerge dalle differenti scelte operate per la resa del verbo “saw” (terza persona singolare) all’interno del periodo ipotetico «A stranger to human nature, who saw the indifference of men about the misery of their inferiors, and the regret and indignation which they feel for the misfortunes and sufferings of those above them, would be apt to imagine, that pain must be more agonizing, and the convulsions of death more terrible to persons of higher rank, than to those of meaner stations» (TMS, I.iii.2.2): Cozzo adotta il congiuntivo imperfetto “che vedesse” (p. 68 della rispettiva edizione), Di Pietro il gerundio “vedendo” (p. 153), mentre Bonfiglioli opta per un erroneo imperfetto (“vedeva”, p. 109).
In conclusione, riteniamo la nuova edizione di Theory of Moral Sentiments per Mimesis una buona risorsa per lo studioso italiano del pensiero di Smith, seppur questa non eguagli ancora, nella traduzione e e negli apparati critici, un’edizione come quella di Lecaldano, che rimane un imprescindibile punto di riferimento.
Michele Vinai
Note
[1] La prima traduzione tedesca del testo della sesta edizione avvenne ad opera di Ludwig Theobul Kosegarten, il quale pubblicò una Theorie der sittlichen Gefühle in due volumi (il primo nel 1791, redatto su di un’edizione precedente la sesta; il secondo nel 1795, contente le aggiunte presenti nell’ultima versione smithiana). Nel 1926, Walther Eckstein pubblicò una nuova traduzione accompagnata da un ricco apparato critico (Smith, Adam, Theorie der ethischen Gefühle, nach der Ausgabe letzter Hand übersetzt und mit Einleitung, Anmerkungen und Registern herausgegeben von Walther Eckstein, 2 Bande, Leipzig 1926). Per ulteriori informazioni, si veda l’Introduzione degli editori della Glasgow Edition (Smith, Adam, The Theory of Moral Sentiments, 1759/1790, a cura di D. D. Raphael e A. L. Macfie, Oxford, Oxford University Press, 1976).
[2] Smith, Adam, Teoria dei sentimenti morali, 1759/1790, a cura di A. Zanini, trad. it. C. Cozzo, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1991.
[3] Gli editori della “Glasgow edition” inseriscono le Considerations nel volume IV (Lectures on Rhetoric and Belles Lettres, a cura di J. C. Bryce, Oxford, Oxford University Press, 1983). Una traduzione italiana del saggio è annessa alla traduzione degli Essays on Philosophical Subjects (a cura di W. P. D. Wightman e J. C. Bryce, Oxford, Oxford University Press, 1980) curata da Paolo Berlanda: Smith, Adam, Saggi filosofici,a cura di P. Berlanda, Milano, Franco Angeli, 1984).
[4] «The Dissertation upon the Origin of Languages [viz. le Considerations]is to be printed at the end of the Theory» (Adam Smith a William Strahan, Londra, inverno 1766/67, The Correspondence of Adam Smith, a cura di E. C. Mossner e I. S. Ross, Oxford, Oxford University Press, 1987, cit. lettera 100, p. 122). Poche sono le edizioni inglesi che allegano le Considerations a TMS. Tra queste, si ricorda l’accessibile e ottima edizione di Amartya Sen e Ryan P. Hanley per Penguin Books (Londra, 2009).
[5] Questa omissione accomuna tutte le edizioni italiane, ancora una volta sulla scorta delle scelte (in questo caso inspiegabili e inspiegate) degli editori di Glasgow. Tale sottotitolo fu aggiungo nella quarta edizione (1774) e conservato in tutte le seguenti edizioni supervisionate dall’autore (1781, 1790). Cfr. Raphael, David D. & Macfie, Alec L., Introduction, in Smith, Adam, TMS, a cura di D. D. Raphael e A. L. Macfie, Oxford, Oxford University Press, 1976, p. 40.
Bibliografia
Mossner, Ernest C. & Ross, Ian S. (a cura di), The Correspondence of Adam Smith, Oxford, Oxford University Press, 1987.
Smith, Adam, Essays on Philosophical Subjects, a cura di W. P. D. Wightman e J. C. Bryce, Oxford, Oxford University Press, 1980; trad. it. Smith, Adam, Saggi filosofici, a cura di P. Berlanda, Milano, Franco Angeli, 1984.
Smith, Adam, Lectures on Rhetoric and Belles Lettres, a cura di J. C. Bryce, Oxford, Oxford University Press, 1983.Smith, Adam, The theory of Moral Sentiments, 1759/1790, a cura di D. D. Raphael e A. L. Macfie, Oxford, Oxford University Press, 1976. Edizione inglese altresì menzionata: Smith, Adam, The Theory of Moral Sentiments, 1759/1790, a cura di A. Sen e R. P. Hanley, Londra, Penguin, 2009. Edizioni italiane: Smith, Adam, Teoria dei sentimenti morali, 1759/1790, a cura di A. Zanini, trad. it. C. Cozzo, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1991; Smith, Adam, Teoria dei sentimenti morali, 1759/1790, a cura di E. Lecaldano, trad. it. S. Di Pietro, Milano, BUR, 1995; Smith, Adam, La teoria dei sentimenti morali, a cura di R. Bonfiglioli e D. Felice, trad. it. R. Bonfiglioli, Milano-Udine, Mimesis, 2024.
-
STORIE SEGRETE DELLA SCIENZA
Recensioni / Aprile 2024Pubblicata per la prima volta nel 1995 con il titolo Hidden Histories of Science, l’editore Mimesis ripropone questa raccolta di saggi inerenti ad aspetti poco considerati dell’attività scientifica. Il volume Storie segrete della scienza. Accelerazioni, battute d’arresto e serendipità – che raccoglie contributi di Oliver Sacks (1933-2015), Stephen Jay Gould (1941-2002), Jonathan Miller (1934-2019), Daniel J. Kevles (1939-) e Richard C. Lewontin (1929-2021) – si inserisce nell’ambito degli STS Studies, branca della sociologia volta a riconsiderare la pratica scientifica non come un’attività astratta ma come un sapere situato e, in quanto tale, soggetto a errori. Il rischio che si corre quando si parla di “scienza” è infatti quello di pensare a un processo lineare, costellato da continui successi e miglioramenti; la realtà dei fatti è assai diversa: la storia della scienza è caratterizzata – per riprendere il titolo di questo libro – da continue accelerazioni ma anche da altrettante battute d’arresto che mostrano il suo carattere fallibile. L’incertezza quando parliamo di scienza non è necessariamente un difetto, significa semplicemente «rifiutare le risposte facili: le risposte facili che pretendono di essere definitive metteranno a tacere per un po’ le nostre paure, lasciandoci nei guai più di prima. […] Quando una star indiscussa della fisica teorica del Novecento come Feynman racconta di sé e del proprio mestiere, lo fa dalla parte della scienza, ma senza alimentare miti, semmai invitandoci ad accettare la sfida di convivere con l’incertezza per osare sempre un po’ di più nella conoscenza» (Govoni, 2019, p. 21).
La volontà di non accontentarsi delle risposte ovvie è il tema del saggio di Miller, intitolato Perdere conoscenza. Analizzando gli studi di James Braid, Miller mostra come l’avanzamento della scienza (in questo caso medica) possa avvenire anche quando si va contro le massime autorità di un determinato settore. Il chirurgo scozzese – dopo aver assistito a una dimostrazione di “magnetismo animale” ad opera di Lafontaine il 13 novembre 1841 – si convinse dell’infondatezza di questa pratica. Il “sonno nervoso” non veniva causato – come suggeriva il filosofo e medico tedesco Franz Anton Mesmer – dall’influenza della gravità celeste veicolata dalla sostanza eterea che il medico esercitava sul paziente, ma da fattori biologici che il cervello sovraccaricato sperimenta. Questo azzardo di Braid – in contrasto con le popolari teorie mesmeriane – gettò le basi per la psicoanalisi freudiana e le moderne teorie di ipnosi.
Possiamo quindi definire la ricerca scientifica come un’impresa che richiede coraggio e, molte volte, il saper prendere dei rischi. Nel saggio Sfida all’impopolarità: una storia di coraggio, virus e cancro, lo storico della scienza Kevles narra alcune tappe fondamentali della lotta ai tumori. Figure chiave della biologia come Gross, Rous, Bittner e Klein seppero tutte dare dei contributi essenziali alla ricerca di una cura contro il cancro. Nel lavoro di Kevles emerge il carattere storico, ma anche cumulativo, della ricerca scientifica; come scrive l’autore di questo saggio: «I meccanismi del cancro umano verranno svelati da quel genere di progresso, graduale e spesso tortuoso, legato alla ricerca sugli organismi umani e non umani, che è stato ottenuto fino a oggi – quel tipo di progresso che ci permette di affermare, diversamente da Samuel Gross più di un secolo fa, che sappiamo alcune cose sul cancro; e che probabilmente ne sapremo molte di più tra un secolo» (p. 129).
Una sintesi degli aspetti nominati finora si trova in Scotoma: oblio e omissione nella scienza, scritto di Sacks in cui si analizza la scotoma in una prospettiva diacronica. Gli studi su questa problematica legata alla vista hanno vissuto una storia particolare: le prime ricerche sulla scotoma erano ancora legate a un’immagine meccanicistica del mondo, escludendo ogni forma di plasticità da parte degli organismi; tutto ciò si tradusse in una visione riduzionista di questo fenomeno biologico. Tale approccio venne messo in discussione da Elkhonon Goldberg, che propose l’ipotesi dei gradienti corticali, secondo cui nelle aree del cervello associate all’apprendimento si sviluppano «dalle particolarità delle esperienze di vita» (p. 215). Questa proposta – in completa antitesi con il meccanicismo – venne subito scartata dalla comunità scientifica; tuttavia, con lo sviluppo delle teorie neurologiche, la visione del mondo inter-attiva proposta da Goldberg – ma anche da Gerald Edelman con la sua teoria della selezione dei gruppi neuronali – si rivelò assai efficace nel descrivere il fenomeno della scotoma, permettendo di comprendere e analizzare meglio tale problematica.
Sacks mostra come la scienza sia sempre legata a un determinato contesto socio-culturale; essa fa riferimento – come afferma Kuhn – a specifici paradigmi (Kuhn, 2009). Questa tesi viene ribadita da Gould. In Scale e coni: l’evoluzione ingabbiata dalle immagini canoniche, il biologo statunitense scrive di come – molto spesso – la scienza sia alimentata da pregiudizi: un tipico esempio riportato da Gould è l’immagine che rappresenta l’evoluzione dalla scimmia all’uomo. Questa rappresentazione – che mostra una linearità nel processo evolutivo – è fuorviante: molteplici studi paleografici e antropologici hanno dimostrato come il processo evolutivo si sia sviluppato attraverso vari percorsi e direzioni, a volte progredendo, altre regredendo. La linearità evolutiva promossa da Darwin era ancora legata a quel paradigma antropocentrico che vedeva nell’essere umano un costante miglioramento, ignorando totalmente le contingenze che gli esseri viventi incontrano nel loro sviluppo. All’immagine della scala che designa un processo unilineare, Gould contrappone quella del cono: in esso, infatti, «la storia di una discendenza inizia con un unico tronco (l’antenato comune) e poi procede – gradualmente, dolcemente e in maniera continua – verso l’alto e verso l’esterno, occupando sempre più spazio man mano che il numero dei rami (la specie) cresce» (p. 77). L’uomo, dunque, non è un animale speciale ma deriva da un antenato comune con altri primati, i quali hanno semplicemente seguito un percorso evolutivo diverso.
Approcciarsi alle tematiche scientifiche con atteggiamento critico è utile anche per affrontare determinate problematiche senza retorica. In Geni, ambienti e organismi, Lewontin tratta il tema dell’impatto dell’uomo sull’ambiente. Il genetista statunitense osserva come la modificazione dell’ambiente circostante sia una caratteristica intrinseca degli esseri viventi; ogni forma di vita – dai grandi mammiferi ai batteri e ai virus – deve creare un luogo favorevole in cui poter vivere secondo le proprie necessità. Partendo da queste osservazioni di carattere storico-biologico, Lewontin può concludere che «La visione costruzionista di organismo e ambiente riveste una certa importanza per l’azione umana. Un movimento ambientalista razionale non può essere costruito sulla richiesta di salvare l’ambiente, che, in ogni caso, non esiste. Chiaramente nessuno desidera vivere in un mondo che abbia un aspetto e un odore peggiori di quello attuale, in cui la vita sia ancora più solitaria, misera, pericolosa, brutale e breve di quella dei giorni nostri. Ma questo desiderio non può essere realizzato dall’impossibile richiesta che gli uomini smettano di modificare il mondo» (p. 160). Ancora una volta, seguire la strada degli STS Studies si rivela proficuo per ragionare su un tema che, oltre all’aspetto scientifico, non può prescindere dall’importanza della società e della politica.
Nonostante sia stata pubblicata per la prima volta quasi trent’anni fa, questa raccolta di saggi risulta interessante anche negli anni ‘20 del XXI secolo. I vari autori ci permettono – adottando prospettive diverse – di riconsiderare alcune tematiche scientifiche sotto una luce nuova: lo scienziato e le sue attività sono sempre stati legati al contesto storico, politico e culturale; l’immagine di una scienza astratta dal contesto in cui agisce è inadeguata e questo libro lo dimostra chiaramente. Il lettore – oltre agli elementi descritti finora – avrà anche modo di osservare come le discipline scientifiche siano connesse con le riflessioni di carattere umanistico: il libro contiene infatti diversi riferimenti alla letteratura e alla filosofia, dando un esempio di quel grande tema che è l’interdisciplinarità (Corvi, 2023). In conclusione possiamo dire che, nonostante non sia un’opera recente, il presente volume può aiutarci a riflettere sul mondo contemporaneo e capire che
La scienza a volte considera sé stessa un’attività impersonale, un “pensiero puro”, indipendente dalle proprie origini umane e storiche. Spesso si pensa che sia davvero così. Ma la scienza è un’impresa interamente umana, una crescita, organica e in continua evoluzione, con improvvise accelerazioni e bruschi arresti, soggetta a strane deviazioni. Sgorga dal suo stesso passato, ma non se ne distacca mai completamente, non più di quanto noi stessi ci distacchiamo dalla nostra infanzia (p. 8).
Efrem Trevisan
Bibliografia
Corvi, R. (2023). Frontiere aperte. Verso un’epistemologia transdisciplinare, Morcelliana, Milano.
Govoni, P. (2019). Che cos’è la storia della scienza, Carocci, Milano.
Kuhn, T. S. (2009). La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi, Torino.
-
L’ultimo libro di Giorgio Derossi, intitolato L’intravisibile. Saggi di filosofia sperimentale: analisi fenomenoscopiche (Mimesis 2023), è un testo sugli esperimenti mentali. Derossi, che è stato professore ordinario in Filosofia teoretica all’Università di Trieste, analizza sia i procedimenti idealizzanti delle scienze dure, sia i procedimenti sperimentali adottati in psicologia e in filosofia. Portando alla luce l’idealizzazione presente nei saperi comunemente considerati sperimentali (STEM) e la sperimentazione nelle discipline umanistiche, di solito basate sulla teoria, Derossi evidenzia “l’altra faccia” delle ontologie regionali, come direbbe Husserl. Derossi si ispira qui alla fenomenologia sperimentale di matrice gestaltista (Taddio, 2011), che coniuga il sapere filosofico husserliano e merleau-pontiano con le ricerche sviluppate dalla scuola triestina di psicologia della Gestalt, rappresentata da autori come Gaetano Kanizsa, Paolo Bozzi e Giovanni Bruno Vicario (p. 14).
Il muoversi tra filosofia, psicologia e fisica rende questo libro di Derossi particolarmente affascinante, insieme alla sua trattazione degli esperimenti mentali. Questi ultimi sono essenziali sia nelle discipline umanistiche, sia in quelle scientifiche: quando un fenomeno non è sperimentabile empiricamente o si presta a delle evidenti limitazioni, l’esperimento mentale è uno strumento irrinunciabile. Derossi si pone l’obiettivo di verificarne la valenza dimostrativa, possibile solo grazie allo svolgimento di debite analisi “fenomenoscopiche”. Queste analisi si muovono alla ricerca dell’intravisibile, che non coincide con l’invisibile: da qui la critica al tardo pensiero di Merleau-Ponty (1993). Per Derossi l’invisibile è ormai ridotto «al verso del foglio del visibile, rinsecchito duplicato dello “spirito” o degli “spiriti”: tanto che questo incessante, reversibile camuffamento si palesa come una vera e propria sindrome d’una malattia tipica del “moderno” o “postmoderno”, anzi come un’inarrestabile pandemia, il cui sintomo più evidente e inquietante è costituito dalla dominanza e contaminazione dei segni» (p. 20). La profonda conoscenza e, al contempo, la critica della concezione saussuriana dei segni spingono Derossi ad andare oltre i significanti e i significati, alla ricerca dei referenti dei segni, della realtà extralinguistica ed extrasegnica (p. 21). Questo non significa negare l’importanza dei segni, ma dare loro una validità fuori dall’universo segnico. Si tratta di una validità che si fonda sull’intravisibile, definito come il visibile “a portata di mano”, inteso in senso trascendentale: «ciò che fa sì che il visibile appaia come appare e sia quel che è» (p. 24). Oltre alla visione diretta del visibile, Derossi teorizza l’esistenza di una “visivazione” in grado di far vedere l’intravisibile, che porta alla luce le forme soggettive e oggettive della percezione, ciò che è empirico e ciò che è ontico (p. 27). In particolare, se la visualizzazione si applica al significato fisico dei fenomeni, la visivazione serve a coglierne il significato fenomenico.
Alla luce di questo intento programmatico, Derossi evidenzia quanto sia importante la consapevolezza dei nostri pregiudizi. Bisogna evitare quello che gli psicologi della Gestalt, sulla scia degli esperimenti di Titchener, chiamano “errore dello stimolo” (Titchener, 1905; Köhler, 1998), ovvero il confondere la nostra conoscenza delle condizioni fisiche dell’esperienza con l’esperienza stessa. Saper osservare significa lasciare che il percepito si mostri al percipiente, in modo che quest’ultimo non possa «imporre o sovrapporre i propri preconcetti o pregiudizi al percepito in modo da vederlo in maniera diversa da come esso ci obbliga a vederlo» (p. 40). Solo così è possibile una vera e propria “fenomenoscopia”, che consiste nell’analizzare l’apparire dei fenomeni attraverso opportune tecniche di “visibilizzazione”. Derossi evidenzia come tali tecniche non coincidano con quelle di visualizzazione, ovvero con la semplice rappresentazione visiva dei concetti. La visibilizzazione ha lo scopo di andare il profondità, consentendo di conoscere non tanto l’essenza o il significato dei fenomeni (conoscenza a cui mirano, seppur in maniera diversa, la fenomenologia husserliana e la teoria di Saussure), quanto la realtà extrasegnica che si rivela nell’intravisibile (pp. 49-51). Bisogna dunque distinguere, sulla scia di quanto afferma Kanizsa (1991), tra la “logica del vedere” e la “logica del pensare”.
Il metodo fenomenoscopico viene così applicato ad alcuni esperimenti mentali realizzati nella storia della filosofia e della scienza. Derossi inizia con gli argomenti di Zenone contro il movimento, in particolare Achille e lo Stadio. Il primo anticipa, seppur in maniera embrionale, il calcolo infinitesimale scoperto da Leibniz e Newton, mentre il secondo si riferisce alla relatività della velocità e del tempo teorizzati da Einstein. Dopo aver esposto e sottoposto a critica le analisi linguistiche di Black e Ryle, Derossi si volge all’analisi matematica di Frajese, che non riesce ad andare oltre il livello concettuale. Attraverso tutta una serie di passaggi su cui il lettore avrà il piacere di soffermarsi, l’autore propone di “visibilizzare”, attraverso un’ipotetica «macchina di finità» (p. 95), il percorso di Achille (A) in relazione alla tartaruga (T), oscurando quello visibile in relazione alla pista (P). Questo è possibile attraverso l’emergere dell’«intravisibile fattore-tempo integrato nella velocità di A relativa a T» (p. 96). Derossi dimostra così l’inefficacia dell’argomento di Zenone, che pecca di incompatibilità non solo con il visibile (vediamo infatti Achille raggiungere e poi superare la tartaruga), ma anche con l’intravisibile, dunque con la realtà fenomenica nella sua completezza.
Derossi si volge poi a Mach, che in Conoscenza ed errore (Mach, 2017), espone la sua teoria dell’esperimento mentale. Quest’ultimo ha un valore rilevante in ambito scientifico: esso si distingue dall’esperimento poetico o fantastico, poiché aderisce alla realtà dei fatti. A differenza dell’esperimento in laboratorio, quello mentale consente di passare in rassegna tutti i casi possibili, immaginando una continua variazione delle circostanze che influiscono su un risultato (p. 101). Ciò è possibile, come nel caso del principio di inerzia scoperto da Galileo, attraverso processi di idealizzazione o astrazione. Questi tuttavia, se non sono ben condotti, possono allontanarsi dal reale. Derossi nota che Mach arricchisce l’esperimento mentale di Galileo sul moto rettilineo uniforme con una serie decrescente di piani inclinati e un passaggio al limite al piano orizzontale, allo scopo di erschauen (“scorgere”) l’inatteso, ovvero il principio di inerzia. In particolare, l’erschauen di Mach consiste proprio nel «saper osservare che consente di scorgere il fenomeno non solo nel suo essere bensì anche e soprattutto nella sua ragion d’essere, che ne è il fondamento» (p. 116). Nonostante il meritorio lavoro di Mach, Derossi ne contesta il passaggio al limite: il moto sull’ultimo piano non inclinato non è osservabile, poiché non è percepibile (p. 126).
La questione del passaggio al limite torna successivamente nel testo di Derossi, in particolare nella sua critica alla fenomenologia husserliana. L’autore non concorda con Husserl sul fatto che basti l’evidenza per far apparire l’oggetto in sé, né sulla ricerca dell’oggetto ideale, l’eidos di ciò che a noi appare. Derossi nota che, sebbene Husserl critichi apertamente l’idealizzazione tipica degli scienziati (Husserl, 2015), sembra ricadere nello stesso errore quando cerca l’essenza degli oggetti. È un approccio di questo tipo a guidare l’utilizzo del passaggio al limite, passaggio per Derossi valido a livello matematico, ma problematico a livello fenomenico. In particolare, riferendosi alla linea retta e al suo tradursi dall’esperienza al concetto, l’autore afferma che il passaggio al limite «rischia di essere onticamente un “salto mortale”» (p. 227). Derossi è tuttavia consapevole che l’eidos husserliana non è frutto di astrazione e che attinge alla sfera sensibile. Per esempio, nel caso degli enti geometrici, Husserl si serve dell’intuizione spaziale, che esplicita strutture e forme già date sul piano delle sintesi passive (Husserl, 2016).
Il problema dell’idealizzazione si presenta anche nel caso degli esperimenti mentali adottati da Einstein per dimostrare la teoria della relatività ristretta. Si tratta di esperimenti cruciali, poiché la visualizzazione fisica della relatività dello spazio consente anche di intravedere la relatività del tempo, che è l’obiettivo da raggiungere. Secondo Derossi, nella teoria di Einstein è presente il rapporto sia funzionale che strutturale tra significati e riferiti, tra concetti e fenomeni (p. 157). Nonostante ciò, Einstein non riesce nel suo intento: la sua visualizzazione rappresenta efficacemente il significato fisico della relatività ristretta, ma non è altrettanto capace di connettersi al reale a cui si riferisce. L’unico modo per cui questo accada è il ricorso a una verifica sperimentale, possibile solo se «le condizioni spazio-temporali che la rendono possibile (rendendo possibile la detta “visione”) sono a loro volta verificate (ossia esse pure visibili)» (p. 170). Einstein non si rende conto che l’accadere dell’evento e della sua visione non sono simultanee, poiché sostituisce la verifica sperimentale sul campo con la semplice visualizzazione atemporale e aspaziale di un diagramma (p. 174). L’obiettivo dello scienziato non deve essere soltanto il significato fisico di ciò che vuole dimostrare, né quello filosofico inteso come “essenza” alla maniera husserliana, bensì la visione della forma intesa in senso gestaltico, costituita dai fattori generativi delle configurazioni percepite in oggetti e fenomeni. Questo discorso si estende, nella Parte Quarta del testo, all’esperimento mentale sui muoni e sulla dilatazione temporale.
Di particolare interesse per comprendere la questione delle configurazioni in senso gestaltico è la Parte Quinta, in cui vengono analizzati dei fenomeni visivi molto noti: l’illusione di Müller-Lyer, il triangolo di Kanizsa e la percezione del cubo. In particolare, è possibile capire meglio cosa accade in ciascuno di questi fenomeni, nel momento in cui si compiono delle operazioni atte a far emergere l’intravisibile. Nell’illusione di Müller-Lyer viene aggiunto un piccolo intervallo vuoto tra la parte superiore e quella inferiore dei due segmenti; nel triangolo di Kanizsa si tracciano i lati completi del triangolo con i bordi neri, per fare scomparire il triangolo bianco e comprendere come avviene la sua visivazione; nel caso del cubo, si nota che questo appare anche come “figura impossibile” e che, per non percepirlo, bisogna che esso si mostri solo come quadrato. Come Derossi approfondisce nella Parte Sesta, è la tridimensionalità che caratterizza il cubo, anche quando, come avviene nella nostra percezione, ne vediamo solo due o tre facce (pp. 237-239).
Derossi, malgrado la critica alla fenomenologia husserliana, ne riprende il concetto di Sinngebung, ovvero di donazione di senso (per quanto non lo citi esplicitamente), e aggiunge le osservazioni di Merleau-Ponty presenti nella Struttura del comportamento (Merleau-Ponty, 2019). Derossi, sulla scia merleau-pontiana, nota che solo la percezione può assicurare sia la visibilità che la pensabilità degli oggetti (p. 242), rispondendo così alle obiezioni di Russell. Questo ritorno alla fenomenologia e alla validità della percezione consente a Derossi di confutare la mera visualizzazione, che manca appunto di ancoraggi al sensibile. Ogni buon esperimento mentale deve essere, dunque, caratterizzato da una verifica che non sia solo concettuale: «una simile “verifica” è veramente e proficuamente sperimentale soltanto se è concretamente visiva e non astrattamente mentale – e l’autentica “verifica” di una “teoria” è procurata dalla visione non della “pura” essenza, ma dell’essenza visibilizzata» (p. 282). Concludendo, il testo di Derossi ha il grande pregio di indicare chiaramente al lettore l’importanza della percezione visiva e il suo ruolo irrinunciabile nella sperimentazione scientifica, sia essa empirica o mentale.
Floriana Ferro, Università degli Studi di Udine
Bibliografia
Husserl, E. (2015). La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, a cura di E. Filippini, Il Saggiatore, Milano.
Husserl, E. (2016). Lezioni sulla sintesi passiva, a cura di V. Costa, La Scuola, Brescia.
Kanizsa, G. (1991). Vedere e pensare. Il Mulino, Bologna.
Köhler, W. (1998). La psicologia della Gestalt, a cura di G.A. De Toni, Feltrinelli, Milano.
Mach, E. (2017). Conoscenza ed errore. Abbozzi per una psicologia della ricerca, Mimesis, Milano-Udine.
Merleau-Ponty, M. (1993). Il visibile e l’invisibile, a cura di M. Carbone, Bompiani, Milano.
Merleau-Ponty, M. (2019). La struttura del comportamento, a cura di A. Scotti, Mimesis, Milano-Udine.
Taddio, L. (2011). Fenomenologia eretica. Saggio sull’esperienza immediata della cosa, Mimesis, Milano-Udine.
Titchener, E.B. (1905). Experimental Psychology: A Manual of Laboratory Practice, Macmillan, New York.
-
Il male della natura
Recensioni / Dicembre 2023«Un errore fatale ha fatto credere al deputato Menenio che dalla bocca dei plebei uscissero parole, laddove poteva logicamente uscire solo rumore […] Prima di essere un traditore della sua classe, il deputato Menenio, convinto di aver sentito i plebei parlare, è vittima di un’illusione dei sensi» (2007, p. 43). Così ne Il disaccordo Jacques Rancière commenta un episodio risalente al periodo delle secessioni a Roma in cui si palesa lo scandalo estetico di cui è capace la parola politica. L’azione performativa dei plebei «senza-nome» che si arrogano il diritto di parlare consiste nella «ripetizione» rivoluzionaria dell’ordine stabilito della città. Parlando come i patrizi, ripetendo le loro parole, i plebei mettono in scena una ripetizione impossibile che, nel momento stesso in cui si realizza, destituisce l’ordine dato e apre uno spazio di indeterminatezza linguistica e giuridica, politica ed estetica.
Nel solco di Rancière, non potrebbe emergere con più forza lo statuto “politico” della poesia di Paul Celan, secondo l’interpretazione che ne offre Mariaenrica Giannuzzi: Il male della natura. Critica della violenza, letteratura, storia naturale (Mimesis, 2023) è uno studio critico dal respiro militante, che restituisce alla produzione del poeta sopravvissuto allo sterminio nazista tutta la portata radicale di un progetto culturale, personale e politico che trova nella destituzione dell’ordine stabilito e nell’apertura di uno spazio di libertà linguistica l’unica alternativa alla distruzione urbana, fisica e morale cui la Germania assiste nel corso del Dopoguerra. Si tratta della ricostruzione minuziosa e appassionata del progetto di una vera e propria filosofia della natura che non può che essere simultaneamente filosofia politica, di un pensiero politico della distruzione che a sua volta non può che essere compiutamente linguaggio della natura: questo il principio primo di ogni autentica «storia naturale», modello estetico-politico del reale in cui rappresentazione e progetto politico sono due facce della stessa medaglia. Fin dalle prime battute del saggio, l’autrice ci richiama alla specificità del paradigma storico-naturalistico messo in atto dalla poesia di Celan: sarebbe del tutto fuorviante confondere l’esistenza di una tradizione filosofica ben definita che si fonda sulla storia naturale – tradizione di cui Giannuzzi ricostruisce a intermittenza coordinate e personaggi – con la possibilità di individuare un paradigma concettuale univoco. Se è necessario piuttosto parlare di «storie naturali», l’impegno dell’autrice sarà proprio quello di delineare la peculiare «struttura latente ma concretissima» (p. 12) che tiene insieme lingua, storia, tempo e natura nella riflessione poetica di Celan, quella trama concettuale e linguistica con cui la poesia tenta di elaborare la «dispersione dei tempi tipica del ricordo traumatico» (p.14) e di dare forma nuova a un’esperienza segnata da una frattura storica e biografica, dramma individuale e collettivo. Mostrando rigore critico e lucidità estrema nell’evidenziare meriti e storture della critica tradizionale, Giannuzzi intraprende dunque un intenso percorso attraverso la lirica di Celan, in un confronto serrato con il pensiero di autori tra cui W.G. Sebald, T.W. Adorno, Peter Szondi, Osip Mandel'štam e, interlocutore costante, Walter Benjamin. Il raffronto con i contemporanei permette al lettore non solo di riconoscere radici e influenze teoriche pluridirezionali nell’opera celaniana, ma anche di percepire un tessuto latente di inquietudini e motivi ricorrenti che rimandano agli scenari desolati e disincantati dei campi di sterminio e delle distruzioni della bomba atomica, di un’epoca in cui, secondo una nota sentenza di Adorno stesso, nessuna poesia sarebbe più stata possibile. Come narrare questo paesaggio, come ricomporlo a partire dalla narrazione: sulla specificità di questo come si gioca tutta l’originalità della poetica filosofica di Celan, secondo l’autrice, e dunque la distanza sostanziale da parte della tradizione di cui pure fa parte. Se Sebald, ad esempio, affida la ricomposizione del paesaggio distrutto all’oggettività di un modello di narrazione documentaristico capace di testimoniare scientificamente gli eventi storici, se altrove la ricostruzione può avvenire in una forma di redenzione mitica o religiosa – questo il caso di autori menzionati nel corso del primo capitolo, tra cui Gottfried Benn –, a ogni forma di oggettività o escatologia rinuncia la riflessione di Celan: riecheggiano forte qui la critica alla «bufera del progresso» portata avanti nelle Tesi (1942) di Benjamin, citate più volte dall’autrice, la scelta per una messa in discussione di dogmi inamovibili, il rifiuto di un’idea di speranza nel futuro in quanto orizzonte di crescita e miglioramento, e la rottura con l’illusione che la «catastrofe» delle vicende umane sia un tassello che possa essere riassorbito nell’ottica dell’intero e dell’ordine cosmico. Dell’opera di Celan l’autrice rivendica la scelta, al contrario, più che radicale di un’azione politica di attraversamento delle rovine che non cerca consolazione in protesi teologiche, che si fa con e attraverso la parola laica: non il Verbo, parola che dice l’origine e la fonda, parola salvatrice e redenzione, ma parola che dice l’impossibilità di un inizio, che impone al contrario la rinuncia a ogni mito dell’origine. Ma se non c’è inizio, se dunque non c’è apocatastasi alcuna, come la poesia di Celan si fa carico di una ricomposizione delle macerie?
Ed è qui che il saggio mostra a sua volta la propria originalità: pur non rinunciando ad un’ossatura argomentativa di tipo scientifico, che può contare sulla documentazione accumulata in anni di ricerca bibliografica e archivistica, Giannuzzi decide infatti di portarci dentro la lingua di Celan, di farci attraversare come in una galleria le «figure» in cui storia e natura si fanno tutt’uno.
«Una figura non è una metafora, né simbolo, né allegoria. Immaginando le figure come strumenti ottici, esse permettono d’individuare un “angolo d’incidenza” per rifrangere il tempo pluriverso di una espressione, la parola iniziale. Gli oggetti naturali ne sono colpiti come facendo con questi raggi, filamenti, direzioni temporali, forme linguistiche nuove, vacanti, che intagliano vuoti nella lingua, e significano sintesi concrete di oggetto naturale e intensità esistenziale» (p. 65).
Tramite l’esposizione di queste figure l’autrice dunque fa vedere, più che raccontare, mostra più che spiegare, la possibilità concreta di uno spazio alternativo di libertà. Ci mostra, cioè, come nello spostamento semantico operato dalla lingua di Celan sia possibile fuoriuscire dalla necessità binaria del rimando tra significante e significato, specchio linguistico dalla divisione del mondo in atomi e vuoto della fisica democritea. La rilettura etica del Leere di Democrito da parte di Celan, che insieme alla ripresa della nozione di “allegoria” del Dramma barocco tedesco di Benjamin rappresenta uno dei momenti-chiave nella proposta interpretativa di Giannuzzi, rimanda ancora una volta al valore politico della storia naturale: la poesia è politica perché nella figura della paradossale ma concretissima compenetrazione tra natura e storia, tra spazio e tempo, incarna la possibilità di una combinazione inedita, di una riconfigurazione del materiale dato. Questo è ciò che l’autrice definisce, rifacendosi alla rilettura della Destruktion benjaminiana di Gentili, l’«intenzione destruttiva» delle composizioni di Celan.
«L’importanza di questa nozione benjaminiana per comprendere la tendenza, che potremmo definire con Anne Carson tendenza de-creativa della scrittura di Celan, sta nel fatto che il carattere destruttivo segna la differenza tra, da un lato, una forma nichilistica della distruzione, cioè un annientamento matematico, apollineo, che non lascia tracce, come un’estrazione di radice quadrata; e dall’altro, un concetto della distruzione che per Benjamin sarebbe, invece, riverente verso il creato» (p. 161).
Nel quadro del capitolo sull’attualità della storia, l’autrice lavora dunque con insistenza sulla categoria della “distruzione”, concetto-motore del saggio che, ripreso nel corso di tutta la trattazione, può essere problematizzato nelle sue varie accezioni a partire da un confronto puntuale con la lingua tedesca, che permette di distinguere tra gli effetti della distruzione militare (Zerstörung) e l’annientamento dello spazio pubblico (Vernichtung), così come ricostruito da Arendt nelle Origini del Totalitarismo (1951). L’approdo di questa analisi è, come si è visto, l’idea di quella, ben’altra, forma di distruzione di cui sono capaci le composizioni di Celan: non totalitarismo, ma atto rivoluzionario in grado di «operare una destrutturazione del linguaggio costituito come norma» (p. 163), capace cioè di creare degli spazi vuoti in cui la lingua si apre alla variabilità semantica. In questa vocazione alla moltiplicazione dinamica, secondo la ricostruzione di Giannuzzi, la poesia di Celan è figlia della geologia, il cui modello si concretizza nella figura del fossile.
«Se il modello relazionale del simbolo come moneta, conio, calco è tradizionalmente legato alla divisione in due parti e a una rappresentazione binaria del pensiero, ricordando lo specchio, il dialogo e il pegno di un contratto, il fossile presenta una morfologia che solo indirettamente descrive due parti. Se queste sono complementari, la loro complementarità è però funzionale a una forma mancante racchiusa nella pietra. […] Per queste ragioni, il fossile, resta […] un modello relazionale adatto alla poetica di Celan, alla sua anti-parola, soprattutto, un modello capace di rinnovare l’interpretazione di questa scrittura non simbolica, che tende all’emblema e al segno, pochissimo alla metafora» (p. 114).
Lo sforzo di Giannuzzi allora è mostrare al lettore, ancora una volta a partire da un incontro diretto con le parole della natura – parole che finiscono con il contaminare lo stile stesso di chi scrive – il modo in cui questo modello si celi dietro le scelte linguistiche e le strutture delle composizioni di Celan, da Von Schwelle zu Schwelle (1955) a Die Niemandrose (1963), passando per Sprachgitter (1959), a cui l’autrice riserva un’attenzione particolare: è qui che riesce infatti a mostrare la dissoluzione definitiva del mito dell’intero originario, a partire dalla non corrispondenza tra storia della Terra e storia individuale.
«L’interno della Terra non significa l’interno del corpo, la sua interiorità “profonda” come nell’immaginario romantico della Tiefe. Anzi, è disattivata la stessa idea di un interno umano che si esprime nel linguaggio, poiché il tempo è sempre rimesso al quadro di un Raumgitter, di un reticolo morfologico» (p. 164).
Nell’insistere sulla centralità della creatività linguistica (e politica!) della poesia geologica di Celan, Giannuzzi arriva a definire allora alcune posizioni teoriche e interpretative fondamentali. La prima ha a che fare con l’idea di tempo ciclico che si delinea nella filosofia della natura di Celan. Contro una visione del tempo della natura inteso quale cieco ripetersi del sempre uguale, il poeta farebbe spazio ad un tempo della natura quale susseguirsi di ere geologiche, in cui la sedimentazione è variabilità dinamica e la temporalità è multiforme direzionalità. Radicale è, qui, la distanza da autori lontani dall’oggetto di discussione del saggio, che pure si confrontano con la catastrofe postbellica e che, contrariamente, risolvono in una nuova opposizione tra natura e cultura il superamento della distruzione – si pensi alla concezione della “cieca ripetizione della natura” di de Martino che in Italia rielabora gli scenari apocalittici del Dopoguerra negli appunti de La fine del mondo (1977). Lo stesso de Martino che in Morte e pianto rituale (1958) oppone alla ripetizione opprimente e meccanicistica della natura, segnata dalla mortalità, quella forma di ripetizione significativa che costituisce il cuore del rito collettivo funebre, mediatore di un ritorno alla libertà.
Se la «ripetizione» della natura assume un ruolo nella ricostruzione di Giannuzzi della riflessione di Celan, è in senso diametralmente opposto: la ripetizione geologica sembra più aver a che fare con quella “ripetizione impossibile” che poco fa connettevamo al dispiegarsi di possibili variazioni: qui è la ripetizione naturale a favorire, più che inibire, una chance di libertà. È in parte l’insistenza su questa specifica idea di ripetizione geologica a determinare la distanza di Giannuzzi dalla nota interpretazione di Uta Werner che, invece, associa la poesia naturalistica di Celan ai riti funebri della “seconda morte”. Come è possibile, sostiene Giannuzzi, conciliare la questione della «variabilità dinamica del processo sedimentario» (p. 96), la dissoluzione dei corpi nel paesaggio, con la necessità che quei resti biologici assolvano alla funzione sociale di mediazione della memoria? Se i morti ci sono, e ci sono, nella poesia di Celan sono «Singbarer Rest» (“resti cantabili”), voci disperse, frammentate, più che raccolte – scrive Giannuzzi – reintegrate in una forma che è pietra, unità di tempo e spazio che storicizza e, quindi, cristallizza, rimane e rende più stabile, ma che non ha nulla a che fare con la soggettività del ricordo. È questo, forse, il paradosso di cui parla l’autrice quando scrive che «il tempo presente è fatto di discorsi e tracce d’acqua freatica: un paradosso, perché in geologia le tracce riguardano il passaggio di una forma di vita, e l’acqua le rimuove» (p. 178). Eppure non è forse l’acqua che cancella la memoria, l’acqua del Lete, che pure apre l’aldilà alle ombre dei morti?
È una trattazione delle ombre come cifra del vero nella poesia di Celan, nel loro significato «non rituale e tantomeno spettrale, ma gnoseologico» che introduce nella parte finale del saggio a quell’estetica del silenzio che trova in Susan Sontag celebre riferimento e che è, ancora una volta radicale, richiamo alla negazione di un’eternità possibile, ma anche affermazione del desiderio di un lutto taciuto, di una commemorazione impossibile, che accetta di limitarsi a cantare silenziosamente le tracce: SINGBARER REST – der Umriß / dessen, der durch / die Sichelschrift lautos indurchbrach, / abseits, am Schneeort // Quirlend / unter Kometen- / brauen / die Blickmasse, auf / die ver venfisterte winzige / Herztrabant zutreib / mit dem / draußen erjagten Funken. // – Entmündigte Lippe, melde, daß etwas geschiet, noch immer, unweit von dir. [RESTO CANTABILE – il contorno / di chi, attraverso / la scrittura a falce senza rumore aprì il varco / in disparte, al posto della neve. // Vorticante / sotto fabbricare – / Comete / la massa visiva, sospinge a / l’oscurato minuscolo / cuore satellite / con la / scintilla fuori conquistata. // – Labbra interdette, avvisate, / che qualcosa accade, ancor sempre / non lontano da te.]
Maria Serafini
BIBLIOGRAFIA
Adorno T. W., Prismi. Saggi sulla critica della società, Einaudi, Torino 2018.
Arendt H., Le origini del totalitarismo, Einaudi, Torino 2009.
Benjamin W., Sul concetto di storia, Einaudi, Torino 1997.
Benjamin W., Il dramma barocco tedesco, Einaudi, Torino 1999.
Cacciapaglia G. (a cura di), Poesia tedesca contemporanea. Dal 1945 a oggi, Newton Compton Editori, Roma 1980.
Celan P., Poesie, a cura di Giuseppe Bevilacqua, Mondadori, Milano 2023.
De Martino E., Morte e pianto rituale, Einaudi, Torino 2021.
De Martino E., La fine del mondo, Einaudi, Torino 2019.
Moroncini B., Il lavoro del lutto. Materialismo, politica e rivoluzione in Walter Benjamin, Mimesis, Milano 2012.
Szondi P., L’ora che non ha più sorelle. Studi su Paul Celan, Gallio Editori, Ferrara 1990.
Rancière J., Il disaccordo, Meltemi, Roma 2007. -
La natura delle culture: perché Mühlmann oggi?
Recensioni / Novembre 2023La traduzione di un testo filosofico è indubbiamente un atto non neutrale né irrilevante, soprattutto se, come nel caso della recentissima pubblicazione di La natura delle culture. Bozza di una teoria genetica della cultura (Mimesis 2023), consente a un pubblico di specialisti e non un più agevole accesso alla prosa ostica e rigorosa di un autore – Heiner Mühlmann – generalmente poco tradotto e ancor meno recepito, senza doversi necessariamente scontrare con lo scoglio della conoscenza della lingua originale. In questo senso, si tratta di un’operazione che costituisce lo spunto per un effettivo ampliamento della conoscenza e per un auspicabile estensione del dibattito, a partire dalle tesi che l’autore ha avanzato. E lo è ancor di più se, come nel caso in questione, la traduzione – opera congiunta di Matteo Caparrini e Silvia Rodeschini, con la curatela di Gianluca Bonaiuti – è accompagnata da una preziosa postfazione, realizzata da Antonio Lucci e dallo stesso Bonaiuti, che consente di contestualizzare il collocamento di un autore – come è stato sottolineato – volutamente schivo, deliberatamente lontano dal suscitare polemiche e scandali intellettuali, ma sempre tagliente e netto nell’esporre le proprie ragionate posizioni, stando a quanto è possibile evincere dalle sue rare apparizioni pubbliche e mediatiche (pp. 216-223).
Una postfazione che, oltretutto, non si arresta davanti al compito di sollevare una questione cruciale: quali sono le potenzialità, i limiti e persino gli eventuali pericoli che possono derivare da una lettura della kulturgenetische Theorie proposta da Mühlmann? Domanda ineludibile che viene affrontata a partire dalla contrapposizione tra due letture antitetiche: l’appropriazione in salsa identitaria operata da Marc Jongen, ideologo del partito di estrema destra di Alternative für Deutschland (nonché ex assistente, ripudiato, di Peter Sloterdijk), e la rilettura espansiva e in chiave timotica proposta dallo stesso Sloterdijk in testi come Ira e tempo e Stress e libertà. Il primo, infatti, interpretando in modo puramente difensivo la dinamica di formazione delle culture come reazione ad eventi di stress massimale e ignorando il ruolo del decorum prodotto dalla fase di assestamento post-stressale, presenta una versione caricaturale del modello descrittivo sviluppato da Mühlmann che riduce tanto le culture a «gruppi di mammiferi della specie-sapiens uniti per far fronte ad aggressioni esterne», quanto lo stesso autore a una sorta di «Carl Schmitt 2.0 senza fronzoli teologici» (p. 230), con il solo intento di giustificare teoreticamente la legittimità di una politica xenofoba. Il secondo, al contrario, facendo proprie le tesi di Mühlmann sul ruolo fondamentale dello stress nella formazione dei gruppi umani, senza però trascurare il peso fondamentale del decorum, della formazione di set di regole ereditabili che costituiscono l’orizzonte di fitness e di sopravvivenza di una cultura, effettua, attraverso il loro inserimento nel rilancio dell’antico concetto greco di thymos, una vera e propria pulsionalizzazione di una dinamica che in Mühlmann è meramente fisiologica. Gesto che permette a Sloterdijk di ritagliare «uno spazio di possibilità per non pensare il thymos come unicamente votato all’esplosione polemogena», sottolineando gli effetti civilizzatori del differimento delle energie timotiche e lo stesso carattere generativo e non necessariamente distruttivo del thymos (desiderio di riconoscimento, di rivalsa, di affermazione, odio, invidia, ambizione, ira ecc.), rimanendo, come suggeriscono Lucci e Bonaiuti, «più fedele alle idee originali di Mühlmann di Mühlmann stesso» (p. 230).
Ora, sembra opportuno chiedersi, a fronte della presente traduzione – perché leggere Mühlmann? Perché tradurlo? E perché proprio oggi, in un momento storico caratterizzato dall’insorgenza di conflitti sempre più intensi e ravvicinati che, come mostrato dall'invasione russa dell’Ucraina e dalla ancor più recente recrudescenza del conflitto israeliano-palestinese, nonché dal profilarsi all’orizzonte di un possibile scontro Stati Uniti-Cina sulla questione territoriale di Taiwan, giungono a lambire sempre di più i confini dello spazio europeo e a infrangere la falsa sicurezza, l’illusione che il mondo occidentale non sia più destinato a fare i conti con guerre guerreggiate di ampia portata?
Il saggio di Mühlmann, innanzitutto, forte del suo approccio radicalmente antiumanista, costituisce per il lettore ben disposto una vaccinazione contro qualsiasi forma di naïveté. Davanti a ogni stupore nei confronti della guerra, davanti a ogni appello al presunto influsso benefico e al potere civilizzante di ciò che nei ministeri della cultura, nelle accademie, nelle redazioni dei giornali e dei periodici culturali viene definito «cultura», davanti alla cecità sistematica dell’«umanesimo filosofico» (p. 23) circa l’essenza fondamentalmente bellica della propria cultura e alla sua connivenza con essa, Mühlmann invita a pensare che quell’insieme di pratiche, di regole, di processi a cui ci riferiamo più o meno confusamente con il termine «cultura» sia non tanto un sistema contemplativo, un corpus stabile di valori eterni, autonomi e indipendenti tramandato di generazione in generazione, quanto piuttosto un sistema attivo «che genera guerra ed è generato attraverso la guerra» (p. 7). E in cui, di conseguenza, gli «artefatti mediali», come la retorica, il teatro, l’architettura, la musica, la pittura…non possono essere concepiti soltanto come oggetti di pura contemplazione estetica, rappresentando invece interconnesse «unità comunicative […] del sistema bellico “cultura”» (ibidem).
Il grande merito del modello elaborato da Mühlmann, infatti, consiste nell’invito a pensare la cultura non tanto come uno stato, quanto piuttosto come una dinamica iterativa, come un «oggetto dinamico collocato in un campo di iterazioni energetiche e iterazioni ereditarie» (p. 165): le culture sono pensabili, in questi termini, come esseri viventi, animali selvaggi «il cui comportamento è sottratto all’influenza diretta degli esseri umani» (p. 20), macrorganismi e sistemi autopoietici sottoposti alle condizioni della teoria termodinamica dell’auto-organizzazione messa a punto da Ilya Prigogine. In altri termini: sistemi che creano spontaneamente ordine, contrastando così la generale tendenza all’entropia descritta dalla seconda legge della termodinamica, attraverso un costante afflusso di energia dall’esterno e uno scarico di entropia sull’ambiente.
Le culture sono allora, nell’ottica di Mühlmann, quei sistemi in cui si è prodotto con successo un adeguamento globale di regole locali, stimolato da un adeguato flusso di energia – gli eventi di Maximal Stress Cooperation (leggi: situazioni di stress «per la vita e per la morte») –, e trasmesso non soltanto a livello orizzontale, infragenerazionale, ma soprattutto ereditato in verticale, nel passaggio da una generazione all’altra. Come si esprime altrove Mühlmann: «cultura altro non è che stabilità della memoria transgenerazionale» (2005, p. 6).
In questo senso si spiega la dinamica di evoluzione ed ereditarietà culturale, suddivisa in cinque fasi, che Die Natur der Kulturen si impegna ad analizzare. Alla prima fase, quella delle «regole locali», nella quale si assiste alla comparsa spontanea e individuale di caratteri tecnici e tratti culturali e alla loro preliminare selezione e trasmissione mediante i fenomeni aggreganti della cooperazione e dell’allelopatia, segue, posta la legittimità dell’estensione della neurofisiologia dello stress individuale alla dimensione dei soggetti collettivi, una fase di intensificazione della cooperazione indotta da quell’interruttore di energia biologica che è lo stress massimale. Si dà infatti un rapporto circolare e retroattivo tra la sensibilità di una popolazione allo stress e le dinamiche in-group/out-group che l’autore descrive in termini di «potenziale discriminante», assimilabili alla «differenza di pressione» tra il lato interno e il lato esterno di una membrana, dalla quale sorge – che sia reale o frutto di una proiezione paranoica – lo stressore esterno.
A seguito dell’evento MSC, di cui la guerra è massima espressione, si dà poi una fase di «rilassamento e adeguamento post-stressale», nella quale le regole precedentemente invalse vengono riclassificate e gerarchizzate alla luce della valutazione dell’evento stressante: emerge così un sistema polarizzato di valori, nel quale ciò che ha a che fare con il successo in interazioni MSC assurge al rango più elevato. Ne è un esempio quel sistema di regole che ha avuto corso nella cultura occidentale, grossomodo dall’età greco-romana al XVIII secolo, sotto il nome di decorum, e che Mühlmann indaga con dovizia di particolari attraverso gli strumenti della genetica culturale e degli algoritmi genetici.
Fin qui la formazione di una cultura, cioè l’adeguamento globale di regole locali; ma come si trasmette tutto ciò? È quanto Mühlmann si propone di spiegare nella fase dedicata all’«iterazione»: utilizzando gli strumenti della matematica delle popolazioni, mostra la potenziale tensione che può sorgere tra modalità verticale e orizzontale di trasmissione. Mentre la prima è generalmente vettore di invarianza, fondandosi sui tempi lunghi della riproduzione biologica, la seconda, veicolata soprattutto dall’apprendimento sociale, può costituirsi sia come elemento di stabilità, sia come elemento di instabilità. A partire dal modello di trasmissione culturale proposto da Boyd e Richerson, Mühlmann mostra quanto sia facile il passaggio da un’imitazione di comportamenti legati adattivamente al contesto – l’evento MSC – a un’imitazione decontestualizzata e posta su basi non adattive o addirittura contro-adattive (l’acquisizione e la trasmissione di comportamenti legata, ad esempio, alla moda o al prestigio). Se in ciò si dà in nuce la potenzialità catastrofica a cui è dedicata la quinta fase, quella della «degenerazione» indotta dall’effetto Baldwin e visibile nella progressiva sovrapposizione di una cultura puramente estetica alla precedente cultura del decorum, non bisogna tuttavia dimenticare l’esistenza della possibilità di trasmissione di un carattere «in un unico atto di comunicazione a un individuo ingenuo» grazie a una «scena di elevata intensità comunicativa» (2023, p. 161), vale a dire attraverso la partecipazione a una situazione di cooperazione da stress massimale. Come non comprendere, allora, in tutta la sua sgradevole durezza, l’affermazione: «per creare stabilità in culture di questo tipo, le guerre si devono ripetere»? (p. 164).
Il modello delineato da Mühlmann conduce dunque all’affermazione di un determinismo radicale? Il suo antiumanismo di fondo, nonché il suo tentativo – corroborato da prove sperimentali – di mostrare come buona parte delle funzioni cruciali dell’auto-organizzazione culturale (gli oggetti di studio delle Geisteswissenschaften) sia in un rapporto di dipendenza funzionale con regolarità naturali, sembrano deporre a favore di questa supposizione. Il progetto di una teoria genetica della cultura, tuttavia, pur traducendosi in un «guscio predittivo vuoto» (p. 205) fondato sull’ipotesi dell’iterazione, contiene in sé un nucleo propositivo, una domanda fondamentale: è possibile addomesticare quegli animali selvaggi che sono le culture tramite la costituzione di una civiltà globale? Detto altrimenti: è possibile, facendo leva sul sapere sperimentale accumulato nella kulturgenetische Theorie, manipolare e ottimizzare le culture, ridurre il loro carattere polemogeno, progettare «culture a risparmio energetico» (p. 210), elaborando una sorta di cultural engineering? A questo proposito l’autore si dimostra piuttosto cauto, limitandosi a porre il seguente caveat: se mai si darà una civiltà globale addomesticatrice, dovrà prima sincerarsi di essere una «metacultura» e non la semplice e violenta universalizzazione dei tratti idiosincratici di una cultura particolare. Altrettanto cauto sembra essere anche Sloterdijk, nella conferenza Von der Domestikation des Menschen zur Zivilisierung der Kulturen: l’autoaddomesticamento dell’umanità è una prospettiva plausibile soltanto sul lungo, lunghissimo, termine – presumibilmente «la prima metà del XXI secolo ricorderà gli eccessi del XX» (2016, p. 50).
Ciò detto – perché, allora, leggere Mühlmann oggi? Certo, fare i conti con il carattere intimamente bellico di ogni cultura, riconoscere in esso il grande rimosso di ogni dinamica culturale, non può che essere il primo passo per una sua ipotetica e futura gestione, quale che sia poi la sua effettiva fattibilità. Tuttavia la lettura del testo di Mühlmann, prendendo alla larga la questione del suo tradursi in possibili programmi utopico-politici, contiene in sé il nucleo di una possibile linea di ricerca teorica, messa bene in luce dai curatori nella postfazione (pp. 228-231), che vede nel momento della Regeleinstellung la chiave di volta di un possibile disinnesco della dinamica polemofila delle culture. Le possibilità, in tal senso, sono molte. Non si percorrerebbe forse una strada feconda provando a sviluppare ulteriormente la ricezione sloterdijkiana della teoria della cultura di Mühlmann? Perché che cosa sono, in effetti, le regole locali, i caratteri tecnici globalmente adattati e polarizzati nel confronto con interazioni da stress, se non ciò che Sloterdijk chiama esercizi e antropotecniche? E non riconosce lo stesso Mühlmann, in base ai più recenti esperimenti neuroscientifici, il ruolo cruciale che artefatti e tecniche mediali di generazione delle emozioni, nel loro legame con le tre dimensioni della memoria (procedurale, dichiarativa, emotiva), svolgono nel processo di acculturamento (pp. 209-210)? Del resto è proprio in questo punto, nell’inscrizione psicofisica di routines e automatisimi, che giace, per Sloterdijk (2010, pp. 15-16), la condizione di possibilità del continuum tra natura e cultura, assicurato da una «vasta zona mediana di pratiche installate nel corpo». Se la cultura è un sistema di trasmissione di caratteri culturali, e il processo di acculturamento coincide con il «trasferimento di caratteri culturali nei sistemi biologici di memoria degli individui di una popolazione» (2023, p. 31) – perché dunque non ripartire da qui?
Luca Valsecchi
Bibliografia
Mühlmann, H. (2005). Maximal Stress Cooperation. The driving force of cultures. Wien: Springer-Verlag.
Mühlmann, H. (2023). La natura delle culture. Bozza di una teoria genetica della cultura. Milano: Mimesis.
Sloterdijk, P. (2010) Devi cambiare la tua vita. Sull’antropotecnica. Milano: Raffaello Cortina.
Sloterdijk, P. (2012). Stress e libertà. Milano: Raffaello Cortina.
Sloterdijk, P. (2016). Che cosa è successo nel XX secolo?. Torino: Bollati-Boringhieri.
Sloterdijk, P. (2019). Ira e tempo. Saggio politico-psicologico. Venezia: Marsilio.
-
«Perché alcuni acconsentono a subire la sofferenza, mentre altri acconsentono a infliggere tale sofferenza?» Lavoro e ingiustizia sociale.
L’ingranaggio siamo noi. Lavoro e banalizzazione dell’ingiustizia sociale, edito da Mimesis nel 2021, è la più recente traduzione italiana dell’opera Souffrance en France di Christophe Dejours, edita per la prima volta nel 1998, éditions du Seuil. L’autore, Christophe Dejours, è psichiatra e psicanalista, direttore dell’Insitut de Psychodynamique du Travail (IPDT) di Parigi: la sua ampia produzione sul tema del lavoro parte da ricerche sul campo nell’ambito della psicodinamica del lavoro, ma offre altresì importanti spunti alla riflessione filosofica sul tema, entrando in dialogo con la tradizione critica. Piuttosto noto e presente nel dibattito pubblico in Francia, Dejours risulta invece ancora poco conosciuto in Italia: fra i suoi volumi tradotti in italiano vi sono solo i due testi Lavoro vivo, traduzione di alcuni brani del secondo volume di Travail vivant, e Si può scegliere. Soffrire al lavoro non è una fatalità, traduzione di Le choix Souffrir au travail n’est pas une fatalité. La nuova edizione italiana de L’ingranaggio siamo noi risulta dunque di particolare importanza, in quanto riporta nel panorama italiano un testo che, a distanza di quasi vent’anni dalla sua prima edizione, può fornire ancora spunti fecondi sul mondo del lavoro contemporaneo. Lavoro e ingiustizia sociale
Il testo si articola a partire da una domanda, esplicitata nel primo capitolo del libro: come tollerare l’intollerabile? Ovvero, com’è possibile che si assista oggi non solo all’accettazione della sistematica sofferenza di alcuni, ma anche alla generazione di consenso di questi attorno agli stessi dispositivi che ne causano la sofferenza? Perché, per citare Dejours, la sofferenza non è più percepita come ingiustizia sociale?
Dejours affida al lavoro un ruolo centrale nella spiegazione del fenomeno: le sue indagini si concentrano infatti sulla sofferenza generata al lavoro. In L’ingranaggio siamo noi, l’oggetto della ricerca non sono più tanto i lavoratori operatori sul campo, come era invece in Travail, usure mentale, quanto i quadri collaboratori dei dirigenti d’azienda. L’autore si domanda infatti quali meccanismi dell’organizzazione del lavoro contemporanea siano in grado di coinvolgere a tal punto “brave persone” a collaborare attivamente alla generazione di sofferenza fra altri lavoratori.
Per costruire una risposta a tali quesiti, Dejours parte da considerazioni di psicodinamica del lavoro circa le strategie di difesa mobilitate dai lavoratori per far fronte alla sofferenza. Il legame tra sofferenza e lavoro può essere secondo Dejours di due tipi: da una parte vi è la sofferenza di coloro che non hanno un impiego, dall’altra vi è la sofferenza vissuta da coloro che lavorano, che può assumere forme diverse.
Un primo fattore che determina la difficoltà a reagire alla sofferenza e contribuisce ad aggravarla è la sua negazione, perpetrata secondo Dejours tanto dalle organizzazioni politiche e sindacali che dovrebbero prendersene carico, quanto dai lavoratori stessi che finiscono per delegittimare e non riconoscere la propria stessa sofferenza psichica. In uno scenario di crescente disoccupazione, la battaglia per diminuire la sofferenza a lavoro risulta essere appannaggio dei privilegiati che hanno un impiego, i quali vanno incontro a colpevolizzazione e vergogna di fronte a tutti coloro che sono invece esclusi dal lavoro stesso. A tali fenomeni di inibizione delle rivendicazioni si aggiunge la paura per la precarizzazione, lavorativa e dunque esistenziale, in cui vive la maggior parte dei lavoratori, che accresce l’individualismo e la solitudine.
Tale negazione è alla base nel fenomeno che Dejours chiama «distorsione comunicativa», concetto centrale nella riflessione dell’autore. Tale distorsione è dovuta, secondo l’autore, allo scarto fra due diverse descrizioni del lavoro: quella manageriale e quella soggettiva dei lavoratori. Quest’ultima rende conto del reale del lavoro, ovvero il confronto con gli inevitabili imprevisti a cui tutti i lavoratori devono far fronte nelle loro attività quotidiane, in cui sono mobilitate risorse soggettive di creatività e ingegno non previste dall’attività prescritta. Al contrario, la descrizione manageriale del lavoro prevede secondo Dejours una sistematica e strategica distorsione comunicativa che concorre all’occultamento della sofferenza fra i lavoratori e alla collaborazione zelante dei quadri: la narrazione del lavoro a partire solo dai risultati e non dalle attività che li producono, l’enfasi sui successi e l’omissione di errori e fallimenti diffondono un’immagine che non corrisponde alla realtà (come sintetizzato da Dejours con la descrizione dei dispositivi di dominio manageriale della «valutazione individualizzata delle prestazioni» e dello «standard di qualità totale»).
La distorsione è realizzata grazie all’attiva cooperazione dei quadri: è a questo punto che Dejours introduce un’analisi della specifica forma di sofferenza che affligge questa categoria di lavoratori. Dalle inchieste condotte da Dejours emerge infatti la loro difficile posizione psicologica: costretti a compiere azioni inique con i propri subordinati, «dei quali si finge di ignorare la sofferenza, o con i propri colleghi, verso i quali, per conservare il posto o ottenere avanzamenti di carriera, si è costretti a essere sleali». La collaborazione attiva a tali azioni è possibile secondo Dejours in ragione di due diversi tipi di sofferenza, negata e dissimulata: da una parte vi è la paura di licenziamento e precarizzazione in caso di rifiuto, ma dall’altra vi è una vera e propria «“sofferenza etica”» determinata dall’essere costretti a «perdere la propria dignità» e a «tradire i propri ideali e valori». Per far fronte a questa specifica sofferenza, che non può essere espressa, i quadri mettono in atto strategie individuali e collettive di difesa che Dejours riconduce a un processo di razionalizzazione, intesa in questo caso in senso psichiatrico, come «una difesa psicologica che consiste nel dare a un vissuto, a un comportamento o a dei pensieri riconosciuti dal soggetto stesso come inverosimili (ma ai quali tuttavia egli non può rinunciare) una parvenza di giustificazione». La razionalizzazione si articola secondo l’autore in due processi psicologici: la «strategia collettiva di difesa del “cinismo virile”» e «l’ideologia difensiva del realismo economico». Con la prima l’autore fa riferimento al potere che il movente della virilità può esercitare nel giustificare agli occhi dei quadri scelte che causeranno sofferenza ai lavoratori (dai licenziamenti alla consapevole distorsione comunicativa) e nel creare dinamiche di gruppo a cui il singolo partecipa pur di non sentirsi escluso e di non perdere la propria identità. Dejours descrive a tal proposito veri e propri “rituali” per esorcizzare il rifiuto morale provato dai soggetti per le azioni compiute, come cene fra i quadri in cui dare pubblica dimostrazione di cinismo e disprezzo per le vittime. La seconda fa invece riferimento alla produzione di un discorso di giustificazione del “male necessario” in nome di «interessi sovra-individuali» di natura economica. Proprio la logica economica è al centro del processo di giustificazione e razionalizzazione: non vi è alcuna scelta da compiere, se non quella «tra sopravvivenza e disastro», per cui le scelte di management che comprendono tagli e menzogne, per quanto dolorose, sono inevitabili per salvare l’azienda. È proprio questa narrazione a fare da sfondo al cinismo virile che caratterizza le strategie collettive di difesa dalla sofferenza etica dei quadri.
È a questo punto che Dejours introduce l’interessante analogia fra il processo di razionalizzazione messo in atto a lavoro e il concetto di “banalità del male” di Hannah Arendt, riprendendo la figura di Eichmann. L’autore francese non è l’unico a fornire nuove interpretazioni del concetto di “banalità del male” di Arendt. Altre letture fanno tuttavia riferimento alla «routinizzazione del male» o alla «normalità del male», mentre Dejours attribuisce un significato diverso alla “banalizzazione del male”, in cui il lavoro gioca un ruolo cardine. La deresponsabilizzazione cui si appella Eichmann, in nome di conformismo e obbedienza, è interpretato da Dejours come una strategia difensiva analoga a quella messa in atto dai quadri nel tentativo di proteggersi dalla sofferenza etica e dalla minaccia di «precarizzazione e di esclusione sociale». È così che l’autore finisce per definire la banalizzazione del male come «il processo tramite il quale un comportamento eccezionale, abitualmente inibito dall’azione o dal comportamento della maggioranza, possa essere eretto a norma di condotta, addirittura valore».
L’aspetto di notevole interesse del testo risiede proprio nella complessa analisi psicologica, sociale e politica condotta dall’autore, in cui il lavoro ricopre un ruolo centrale. L’organizzazione manageriale del lavoro in un sistema sempre più tendente al neoliberismo genera infatti precarietà e paura, sofferenza che viene sistematicamente negata. La novità dell’analisi proposta da Dejours risiede nel sottolineare come i quadri stessi, complici del funzionamento dell’organizzazione, siano vittime di un sistema che li costringe al diniego e al misconoscimento della loro sofferenza etica, di fronte alla quale l’unica strada percorribile è innescare strategie di difesa che rafforzano e reiterano non solo la sofferenza subita da altri lavoratori, ma anche l’adesione dei quadri stessi al sistema che ne è causa. Proprio per questo Dejours ritiene possibile ricorrere al concetto di La Boétie di «servitù volontaria», nominata esplicitamente nella Prefazione all’edizione del 2008: «La mia indagine sulla servitù volontaria nel sistema neoliberista rivela che la maggioranza delle persone può essere arruolata al servizio di un sistema del quale pure disapprova profondamente i metodi. E mostra […] che tale mobilitazione può essere ottenuta senza l’uso della forza». Sull’utilizzo della categoria di servitù volontaria in questa chiave non mancano ulteriori spunti.
Una simile interpretazione è ancora feconda per tentare di comprendere il perpetuarsi di fenomeni di ingiustizia sociale che generano disuguaglianza e sofferenza e la difficoltà per molti movimenti a organizzare una forza sociale che promuova una visione alternativa in grado di aggregare consenso. Le indagini di Dejours suggeriscono di spostare l’attenzione sul ruolo centrale svolto dal lavoro nell’adesione alla narrazione dominante, tema sempre più in secondo piano nel dibattito politico, nella convinzione che «se la pubblicazione di quest’analisi è utile, è perché può servire a […] coloro che vogliono pensare non soltanto la resistenza, ma soprattutto delle alternative a quest’evoluzione».
Martina Fang Lu
Bibliografia
H. Arendt, La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme, Feltrinelli, Milano 1964.
S. Benhabib, Hannah Arendt and the Redemptive Power of Narrative, in «Social Research», n°57, 1990.
C. Dejours, Travail, usure mentale. Essai de psychopatologie du travail, Bayard Éditions, 2015 (1980).
C. Dejours, Le facteur humain, PUF, Paris 2018 (1995).
C. Dejours, L’ingranaggio siamo noi. Lavoro e banalizzazione dell’ingiustizia sociale, Mimesis, Milano 2021 (1998).
C. Dejours, Travail Vivant (vol. 1: Sexualité et travail, vol.2: Travail et émancipation), Payot, Paris 2013 (2009).
C. Dejours, Si può scegliere. Soffrire al lavoro non è una fatalità, Moretti & Vitali, Bergamo 2021 (2015).
C. Dejours, J.-P. Deranty, E. Renault e N. H. Smith, The Return of Work in Critical Theory, Columbia University Press, New York 2018.
J.-P. Deranty, Travail et expérience de la domination dans le néolibéralisme contemporain, in «Actuel Marx», 49, 1, 2011, pp. 73-89.
E. Donaggio, Dissonanze del totalitarismo. Banalità del male o servitù volontaria?, in «Psicoterapie e scienze umane», n°2, 2013, pp. 239-254.
E. Donaggio, Souffrance en France en Italie, in « Travailler », 42, 2 2019, pp. 93-101.
C. Emmenegger, F. Gallino, D. Gorgone, Investire se stessi. Capitalismo e servitù volontaria, in E. Donaggio (a cura di), C'è ben altro. Criticare il capitalismo oggi, Mimesis, Milano, 2014, pp. 123-138.
C. Emmenegger, F. Gallino, D. Gorgone, Entre complicité et souffrance. Penser la servitude volontaire dans le monde du travail, in « Travailler », n°42, 2019, pp. 103-118.
S. Forti, I nuovi demoni. Ripensare oggi male e potere, Feltrinelli, Milano, 2012.
É. de La Boétie, Discorso della servitù volontaria, Feltrinelli, Milano 2014.
E. Renault, Souffrances sociales: Philosophie, psychologie et politique, la Découverte, Paris 2008.
E. Renault, Domination et pathologie sociale chez La Boétie, in « Cahiers La Boétie », 3, 2013, pp. 137-151.
-
Non è certo facile restituire la complessità e la densità del volume di Maurice Merleau-Ponty, Il mondo sensibile e il mondo dell’espressione (Mimesis 2021), recentemente tradotto e curato per il pubblico italiano da Anna Caterina Dalmasso, senza dubbio una delle studiose più autorevoli del pensiero del filosofo francese (suo l’importante saggio di Introduzione, pp. 17-52). Non è facile innanzitutto per la stessa natura di questo (non) libro, che raccoglie il materiale del filosofo prodotto in vista del suo primo corso al Collège de France dell’a.a. 1952-53. Il volume contiene tanto l’effettivo materiale utilizzato dal filosofo nelle sue esposizioni orali, quanto appunti che ne ampliano e approfondiscono l’orizzonte teoretico.
L’opportunità per il pubblico italiano di studiare e apprezzare il pensiero di Merleau-Ponty svolto al Collège si amplia così, dopo la traduzione di altri corsi avvenuta a cavallo tra la fine del secolo scorso e l’inizio del millennio: La nature (Seuil, 1995, tr. it. Cortina, 1996) e Notes de Cours 1959-1961 (Gallimard, 1996; tr. it. Cortina, 2003). Quello che qui discuteremo è stato pubblicato nel 2011 dall’editore svizzero MētisPresses[1] sotto la direzione scientifica di E. de Saint Aubert e di S. Kristensen e la traduzione italiana permette di accedere a un materiale teorico molto fecondo, sia per chi si occupa direttamente di Merleau-Ponty sia per chi sia interessato al pensiero francese del Novecento. In queste quattordici lezioni, infatti, si anticipano o si sviluppano in modi originali piste che attraversano, carsicamente a volte, altre in superficie, una tradizione di pensiero gravida ancora oggi di ampi sviluppi teorici. Lungi dall’essere una pubblicazione per soli addetti ai lavori, questo volume può essere di grande aiuto a chi volesse comprendere meglio alcuni intrecci - sia detto solo a titolo di esempio non esaustivo — tra Gestaltpsychologie e filosofia dell’esistenza, tra bergsonismo e fenomenologia, nonché — come segnala la Prefazione di Mauro Carbone (pp. 9-16) foriera di stimolanti riflessioni sull’arte e l’estetica. Insomma, pur non essendo di facile accesso — e tuttavia l’ottimo lavoro di Dalmasso aiuta chi non fosse specialista — il volume non potrà che trovare interesse in molti ambiti degli studi filosofici contemporanei.
Qui ci proponiamo di tracciare una possibile via d’accesso in questo universo filosofico ancora da esplorare anche da parte di chi, da molti anni, vi si dedica con studio attento. Come ogni pista d’accesso, non ne impedisce di altre e non può essere pienamente esaustiva della ricchezza contenuta nelle quasi trecento pagine del volume. Tuttavia, può essere utile a meglio orientarvisi. Come segnala la curatrice, il volume ha il merito di offrire «un punto di vista privilegiato» (p. 17) sul back-office della produzione di Merleau-Ponty, un vero e proprio laboratorio artigianale di concetti situato al fondo del lavoro pubblicato in vita dall’autore.
A differenza degli altri corsi già tradotti per il lettore italiano, la peculiarità de Il mondo sensibile e il mondo dell’espressione consiste nel fatto che esso ci mostra un Merleau-Ponty sul punto di farsi, che non è più quello della Fenomenologia della percezione e non è ancora quello de Le avventure della dialettica, un Merleau-Ponty per così dire “intermedio”, in divenire (Lanfredini 2011): «Le note del corso del ’53 — continua Dalmasso — offrono un insieme di argomentazioni e di fonti in grado di gettare luce su alcuni punti più oscuri o anelli mancanti della riflessione merleau-pontiana successiva» (p. 18). Insomma, il corpus magmatico di questo volume permette, a chi voglia avventurarvisi, di «cogliere “un filosofo al lavoro” e di “accompagnare Merleau-Ponty” nel farsi del suo lavoro» (p. 20). Una vera e propria avventura filosofica che permette al lettore di oggi di risemantizzare molte antinomie che nel nostro presente appaiono ovvi se non addirittura vetusti. Del resto, non siamo noi oggi figli di quella temperie culturale che genericamente potremmo definire post-moderna e che ha fatto della lotta al manicheismo dualistico la sua pars destruens ? È un pensiero non dualistico, senza per questo, vedremo, rinunciare alla duplicità, quello che l’autore — che ovviamente di post-moderno non sapeva nulla — prova a mettere in forma, e che noi abbiamo occasione di studiare proprio nell’atto del suo generarsi.
Mondo sensibile e mondo dell’espressione definiscono un’antinomia che trova le proprie radici, a voler estremizzare, quanto meno nella distinzione platonica tra mondo ideale e mondo sensibile. Se si volessero fissare delle tappe a noi più vicine — come sempre troppo semplicistiche, ma utili a orientarsi — sensibile ed espressione rimandando alle distinzioni moderne di Descartes (quella tra materia estesa e pensiero inesteso) e di Kant (mondo sensibile della natura e mondo intelligibile dei valori) generalizzabile nella distinzione del pensiero antropologico tra natura e cultura (Lévi-Strauss 1969 pp. 39-52; Descola 2005). Già dunque nel tema stesso delle lezioni contenute in questo volume si comprende lo sforzo teorico che le sottende, un lavoro filosofico e fenomenologico che chiama in causa le principali architravi del nostro sensus communis moderno.
Potrebbe essere utile contestualizzare brevemente queste note di corso (si rimanda all’introduzionedella curatrice per i dettagli). L’anno accademico, come detto, è il 1952-53 ed è l’esordio di Merleau-Ponty al Collège de France, dopo che ha già tenuto il suo Elogio della filosofia nella lezione inaugurale (Merleau-Ponty, 2008) e mentre sta aprendo il cammino che lo consacra ai livelli più alti della cultura e della filosofia francese e forse mondiale. Non sono anni facili, gli anni Cinquanta, sia a livello storico (sono gli anni della guerra fredda, delle prime notizie in occidente del regime staliniano, della guerra di Corea, ecc.) sia a livello personale (Merleau-Ponty ha in cantiere La prosa del mondo che resterà incompiuto, sta rivedendo le sue posizioni rispetto all’URSS espresse in Umanismo e terrore del 1948, ma, soprattutto, sta per rompere il grande sodalizio filosofico e affettivo con J.-P. Sartre). Sul piano scientifico ha qualche sassolino nelle scarpe dopo la conferenza del 1946 presso la Société de philosophie dal titolo Il primato della percezione e le sue conseguenze filosofiche (Merleau-Ponty2004) nella quale presentava davanti a un pubblico composto dalle migliori menti filosofiche del tempo i risultati conseguiti con Fenomenologia della percezione. Amici e colleghi (Hyppolite, Bréhier, Lachièze-Rey per citarne alcuni) accolgono in maniera polemica e critica la tesi di fondo di quel libro accusandolo in alcuni casi di sensismo e positivismo. La sensazione di non essere stato compreso si radica nel filosofo e sette anni dopo è proprio da quella discussione che, con certosina attenzione, riparte (p. 61). Il primato della percezione diventa un punto di partenza ottimale per penetrare nel fitto bosco del sensibile e dell’espressione.
Sin dalla prima lezione, quasi un brevissimo compendio di Fenomenologia della percezione, emerge il tema cruciale con un gusto programmatico. Si tratta, cioè, di pensare l’unità del mondo percepito tale che questa unione non sia la “sintesi determinante”, la sintesi intellettuale, cioè, di una molteplicità sensoriale di stimoli empirici. L’unità cercata nella sua opera principale (ma anche in La struttura del comportamento del 1942) non era una sintesi del giudizio, ma di ordine “percettivo”. Si può dunque capire come qui emergano molte ambiguità che il filosofo dovrà in qualche modo dipanare.
Primato della percezione non significa postulare l’esistenza delle cose fuori di me o la corrispondenza oggettiva di mondo e conoscenza né di opporre a una filosofia intellettualista un empirismo sensista à la Hume, bensì di «fare una teoria concreta dello spirito» (p. 59). Il primato della percezione non postula «un primato del sensoriale, del dato naturale» (p. 60), ma è ricerca di un piano originario che non sia né empirico né trascendentale in cui il sensibile e l’espressione possano divenire indiscernibili: è lo statuto stesso della fenomenologia a modificarsi con questo primato. Fenomenologia della percezione non sta ad indicare solo che è possibile trattare la percezione come “noema”, ma che nel farlo si segue il divenire della percezione nel suo stesso attuarsi, ossia che la percezione indica un piano ontologico intermedio tra l’essere oggettivo e l’essere soggettivo. Si può trattare fenomenologicamente la percezione solo se essa non è né l’oggetto di un sapere né il soggetto della sensazione. È questo né né a non essere stato compreso alla Société nel ’46 (pp. 61-62). Il punto è che la percezione non rimanda solo al mondo del sensibile, ma implica anche un carattere espressivo: «Intenderemo qui per espressione o espressività la proprietà che ha un fenomeno, per la sua organizzazione interna, di farne conoscere un altro che non è dato o che non è mai stato dato. […] È in questo […] senso che la percezione è espressione, espressione del mondo» (pp. 62-63).
Fare una fenomenologia della percezione è studiare il farsi del mondo, una fenomenologia che acquista sempre più caratteristiche “hegeliane” (Vuillerod, 2018) risemantizzando il concetto di coscienza. Se c’è percezione, infatti, non è detto che vi sia necessariamente soggetto (nel senso del Cogito trascendentale che accompagna ogni io empirico), ma vi è senz’altro coscienza, che non è il pieno possesso di sé che la tradizione cartesiana e kantiana ci ha consegnato. La coscienza percettiva non è esterna alle cose, si situa tra di esse, ma non è cosa estesa tra cose estese: essa si fa negli scarti, nelle differenze (cromatiche, uditive, sensibili…) tra le cose, è trans-individuale (Ruyer 2018; Simondon 2011), passività creativa (Ménasé 2003). A differenza di quella trascendentale, essa «non ha a che fare con valori […], ma con esseri esistenti» (p. 64). Potremmo dire, cioè, che attraverso il primato della percezione Merleau-Ponty intraveda la possibilità di emancipare la coscienza percettiva dalla sovranità dell’intelletto dell’estetica trascendentale e di riscoprire nella materialità il suo proprio valore/valere.
L’espressività della percezione — il suo “primato” — è dunque ontogenetico, essa non è la facoltà inferiore della coscienza — come all’origine dell’estetica riteneva, ad esempio, A.G. Baumgarten (1993: 41) — ma la sua espressione “sensibile”, è «configurazione, struttura» (p. 65). Ecco un secondo termine fondamentale nel lessico merleau-pontiano che richiama il suo primo grande libro, La struttura del comportamento. Il primato della percezione implica una materialità della coscienza percettiva da intendersi come processo di strutturazione. Se la percezione non è (solo) la passività di un soggetto empirico, ma l’attività — quantunque “passiva” — di una coscienza “materiale”, allora essa è a tutti gli effetti concepibile nei termini di un comportamento (nel senso, ad esempio, in cui quantisticamente una particella ha un comportamento), un’attività vincolata ad un mondo-ambiente. L’espressione percettiva non è un atto puro, ma una prassi “situata” in uno “sfondo” di passività. Il richiamo è qui alla Gestaltpsychologie, che Merleau-Ponty aveva studiato attentamente nel libro del 1942 (e che nel corso affronta tra la settima e la nona lezione). Ogni coscienza percettiva è una figura (Gestalt) che emerge da uno sfondo e «vi è sempre qualcosa di inarticolato e di sottinteso in ciò di cui vi è coscienza» (p. 67). Lungi dall’essere un’astratta sensazione senza soggetto, l’espressione sensibile è un processo di figurazione (Gestaltung) e la coscienza percettiva è una figura o forma materiale. La coscienza percettiva non è un cogito ma un corpo, non un’anima che emerge e s’innalza dalla materia, ma l’individuazione, l’attività immanente, la configurazione sensibile e materiale di un corpo. Il primato della percezione è il primato del corpo sull’anima, non nel senso “empiristico-naturalistico” di un primato dell’esteso sull’inesteso, ma di una indiscernibilità tra il mondo sensibile della corporeità e la sua espressione animale.
Allora fenomenologia diviene sinonimo di strutturazione ontologica — «non vi è differenza tra ontologia e fenomenologia» (p. 61) — e il primato della percezione conduce a una ontologia dinamica e processuale (Vanzago, 2001). Il mondo dell’espressione non è riducibile a un mondo formale, ha una sua materialità; il sensibile non è inerte o passivo. C’è espressività sensibile tanto quanto vi è sensibilità “spirituale”. Né inerte né formale: l’espressività del sensibile è movimento e la fenomenologia della percezione è manifestazione non richiudibile negli steccati formali dell’estetica trascendentale, poiché non vi è più un primato del formale estetico (dello spazio e del tempo formali). Si avvia qui quello che con Husserl (1991) potremmo chiamare rovesciamento della rivoluzione copernicana: è il movimento a determinare le forme del tempo e dello spazio, non il contrario. Anzi: spazio e tempo non sono più forme, ma figure (Gestalten). Il movimento (si veda in particolare la sesta lezione) è il fenomeno espressivo per eccellenza, tutt’altro dunque che l’esito di una rappresentazione soggettiva. Come la percezione, esso non è l’oggetto di un sapere né l’attributo di un cogito (p. 99), ma è qualcosa che può essere solo sentito, in cui si manifesta il movente. Non è neppure un mero accidente che capita a un oggetto empirico, non è, cioè, la variazione di luogo nel tempo di una “cosa” (Sache), ma il fenomeno per il quale “qualcosa” (Ding) si esprime, emerge spazialmente e temporalmente (geograficamente e storicamente) in quanto figura su sfondo.
Il movimento espressivo è l’installazione sensibile di una coscienza percettiva nel cuore dello spazio e del tempo, il suo modo di abitare lo spazio e il tempo (p. 103), i quali non sono relazioni formali né empiriche, bensì modali. C’è movimento, ovvero qualche cosa appare, c’è della percezione, c’è del comportamento, c’è della coscienza, c’è figurazione: espressione di un’immagine materiale. Il movimento espressivo (siamo alla quarta lezione del corso) è «spirito che si fa corpo e corpo che si fa spirito […] una logica del funzionamento percettivo» (p. 105). Rovesciamento della fenomenologia hegeliana: fenomenologia e logica della percezione; il corpo è lo spirito, il mondo sensibile esprime il mondo spirituale; l’unione non è sintesi assoluta, ma l’affinità trascendentale (p. 107) dello spirito col sensibile in sopravanzamento (overlapping) l’uno sull’altro, «sintesi di enjambement» (p. 109).
Il movimento espressivo è la sintesi senza concetto di spazio e tempo. La mente va a Bergson che più di chiunque altro nel Novecento si è sforzato di pensare il soggetto implicato nel movimento (pp. 119-125). Dopo aver esposto, all’inizio della sesta lezione, gli «argomenti di Zenone» (p. 118) sull’impossibilità ontologica del movimento, Merleau-Ponty vi si richiama: «Per lui quello che rende impossibile il movimento nel pensiero di Zenone è la divisione infinita e attuale del tempo e dello spazio, […] per rendere possibile il movimento occorre che il tempo e lo spazio siano divisibili, ma non divisi, che, posti a partire dal tutto, ammettano uno spazio “tra” le posizioni e gli istanti, cosa che non è possibile nell’in sé. È quindi necessario che il movimento , che è fatto del mondo, sconfini su di me come durata, sia anche fatto di coscienza» (p. 119). Tuttavia, Bergson nel cercare un tout indivisé del movimento è ancora troppo intellettualista, «resta coscienziale» (p. 121). Occorre essere, si legge tra le righe delle note di lavoro, più bergsoniani di Bergson, il quale «trionfa su Zenone mostrando che il tempo non è fatto di istanti né lo spazio di limiti di spazio, ed è vero. Ma resta da esplicitare la conseguenza […] crede che il problema sia concluso» (p. 239). Diventa necessaria «una teoria del corpo percipiente» (p. 240), un paradigma del corpo (Iofrida 2019) che troviamo tra l’undicesima e la tredicesima lezione (nel cuore, dunque, del corso): il movimento è sì un dato immediato della coscienza, ma di una coscienza percettiva, una coscienza-immagine che sia la sintesi esistenziale (materiale) della durata, la quale viene così reinterpretata come espressione sensibile, immagine-spaziotempo, figurazione espressiva.
La durata bergsoniana è “astratta” e manca, agli occhi di Merleau-Ponty, la “e”tra sensibilità ed espressività, una unità (dodicesima lezione) non teoretica, ma pratica, «unità dello schema corporeo […] unità di un’azione sul mondo, di una prassi» (p. 187), non nel senso di un pragmatismo utilitaristico (che per Merleau-Ponty manterrebbe la sussunzione dell’azione sensibile a uno scopo sovrasensibile), ma come attività passiva di creazione di immagini, una prassi che «comporta una teoria [Theoria] o gnosis che ne è lo sfondo, che essa modifica e che a sua volta la modifica» (ibidem). La durata espressiva è unità di teoria e di prassi, una praktognosia che non è un pragmatismo — esiste una materialità dei valori — né un empirismo — c’è, come rileva Dalmasso, una intenzionalità del sensibile (pp. 46-52). La durata come congiunzione del mondo sensibile e del mondo dell’espressione, una unità che si può a buon diritto definire estetica (se con Kant intendiamo “estetica” l’unità senza concetto, pre-logica).
Non è un caso che i corsi del ’53 si chiudano (quattordicesima lezione) con delle considerazioni sull’Arte in generale, e sul cinema in particolare. Le considerazioni estetiche di Merleau-Ponty sul cinema meriterebbero ben altre analisi (si rimanda ai lavori di Carbone e di Dalmasso), qui ci limitiamo solo a trarre una brevissima conclusione. Il cinema è la “prova ontologica” del primato della percezione e del movimento espressivo. Esso è una ritmologia della durata dell’immagine, un contrappunto di punti di vista, di immagini che sopravanzano l’una sull’altra. Nell’arte cinematografica si realizza l’unità di sensibile ed espressione, il vinculum substantiale di una molteplicità di immagini sensibili senza sussunzione entro i decreti formali dell’intelletto trascendentale. Nel movimento cinematografico appare una vera e propria monadologia sensibile (p. 64) che si insinua nel mezzo dei due mondi, che sono “separabili” ma non separati e nelle cui pieghe emergono molteplici mondi intermedi. Come scrive Carbone, nel cinema «si celebra il venire ad espressione […] del mondo sensibile» (p. 16).
Questi mondi intermedi sono il legame tra mondo sensibile e mondo dell’espressione e costituiscono l’ambiente originario nel quale la nostra capacità creativa di corpi animali o anime materiali riesce a trovare spazio per esprimersi e manifestarsi attraverso un’inaspettata fenomenologia dello spirito-carne che solo un primato della percezione può rendere visibile. Già solo questa breve conclusione a cui perviene Merleau-Ponty nei corsi dedicati alla duplicità sensibile/espressione, forse, vale da sola lo studio attento di questo volume.
di Gianluca De Fazio
[1] L’editore continua ancora oggi il suo lavoro di pubblicazione dei corsi al Collège de France di Merleau-Ponty. Si segnala il numero monografico dedicato al Mondo sensibile e mondo dell’espressione della rivista Chiasmi International (n. s. 12-2010).
Bibliografia
Baumgartem, A.G. (1993), Progetto dell’estetica, in A.G. Baumgarten, I. Kant, Il battesimo dell’estetica, a cura di L. Amoroso, ETS, Pisa.
Descola, P. (2005), Par-delà nature et culture, Gallimard, Paris.
Husserl, E. (1991), Rovesciamento della dottrina copernicana della corrente visione del mondo, «Aut-Aut», 245, pp. 3-18.
Iofrida, M. (2019), Per un paradigma del corpo: una rifondazione filosofica dell’ecologia, Quodlibet, Macerata.
Lanfredini, R. (2011, a cura di), Divenire di Merleau-Ponty. Filosofia di un soggetto incarnato, Guerini, Milano.
Lévi-Strauss, C. (1969), La struttura elementare della parentela, a cura di A.M. Cirese, Feltrinelli, Milano.
Ménasé, S. (2003), Passivité et création. Merleau-Ponty et l’art moderne, PUF, Paris.
Merleau-Ponty, M. (2004), Il primato della percezione e le sue conseguenze filosofiche, a cura di R. Prezzo, F. Negri Medusa, Milano.
Merleau-Ponty, M. (2008), Elogio della filosofia, a cura di C. Sini, SE, Milano.
Ruyer, R. (2018), Neofinalismo, a cura di U. Ugazio, V. Cavedagna, G. Vissio, Mimesis, Milano-Udine.
Simondon, G. (2011), L’individuazione alla luce delle nozioni di forma e d’informazione, a cura di G. Carrozzini, Mimesis, Milano-Udine.
Vanzago, L. (2001), Modi del tempo: simultaneità, processualità e relazionalità tra Whitehead e Merleau-Ponty, Mimesis, Milano-Udine.
Vuillerod, J.B. (2018), Merleau-Ponty hégélien?, «Chiasmi International», n.s. 19, pp. 101-114.
-
Psicoanalisi Queer Manifesto
Recensioni / Dicembre 2021Nella convinzione che non sia sostenibile una scrittura impersonale e non situata, chi scrive in questa sede lo fa da una posizione di soggettività queer e di adesione a un certo quadro epistemologico, quello di una psicoanalisi queer fin dai suoi quattro concetti fondamentali: l'inconscio, la ripetizione, il transfert e la pulsione.
Che si possa fare una psicoanalisi rigorosa, sia in sede teoretica che clinica, aderendo alla filologia lacaniana (se ce n’è una!) e al contempo attestandone il fondamento queer, lo mostra il saggio Queer Psychanalyse: clinique mineure et déconstructions du genre di Fabrice Bourlez (Éditions Hermann, Paris 2018), in traduzione italiana ad aprile per i tipi di Mimesis. Nella ricezione italiana dell’intersezione tra psicoanalisi e studi di genere, che si approssima al deserto concettuale, la scrittura di Bourlez colma una lacuna che non può persistere oltre. Una lacuna che ha prodotto effetti reali, attestati sia dal silenzio delle Scuole di Psicoanalisi impegnate in querelles lontane dalla causa analitica intesa come causa del desiderio, sia dai disagi soggettivi degli analizzanti che nei cabinets dei propri analisti non trovano risposta alle urgenze della contemporaneità e dei propri corpi.
Aspettando di leggere l’edizione italiana, diamo un occhio allo stato del terreno su cui andrà a installarsi. Da una parte, troviamo la proposta teologica del nostro pastore lacaniano Massimo Recalcati, fondata sul binomio Bibbia-Psicoanalisi, su una solida retorica del sacrificio? e su una speranza di guarigione dal sintomo che si approssima alla grazia divina; il tutto affiancato da una lettura delle tavole della sessuazione (Seminario XX) marcatamente binaria ed etero-patriarcale, poiché la sua intera opera risulta pervasa di dicotomie manichee e attestazione di differenze uomo-donna strutturanti, presuntamente fondate nella logica dell’inconscio: il queer non è chiaramente passato di qui. La carica di potere e autorità di cui gode il controtransfert dell’analista è – non esageriamo – quella di un dio, possibilmente maschio e paternalista, incarnato, e qualsiasi tentativo di rivendicare una psicoanalisi costitutivamente laica nei suoi fondamenti viene “punito” con scomuniche.
Differentemente, lo psicoanalista presentato da Bourlez è una figura etica, nel senso di un essere di desiderio, la cui consistenza non è l’autorità ma l’erratica, fallimentare e sempre eccentrica movenza del desiderio. Un analista che porta dei tacchi, coi quali gioca, cade, gode, performando la propria instabilità. Il tallone d’Achille, ossia la debolezza, il difetto, della psicoanalisi, diventa les talons hautes: i tacchi alti su cui essa svetta, solo a condizione di traballare e di poter cadere da un momento all’altro (pp. 142-44). La clinica di Bourlez ci permette di opporre al pugno duro del soggetto che è supposto sapere perché sa, o perché ha la presunzione di sapere, il tatto di chi abdica alla propria funzione e la decostruisce, limitandosi – eticamente – a occupare una posizione, che è quella del desiderio. Ecco dunque un primo punto per cui Queer Psychanalyse può portare buone notizie al neo-lacanismo italiano, arroccato in una condizione di neo-lacanismo classico, rigidamente milleriano e consacrato all’Uno: l’Uno dell’Unico Lettore (Miller fu così nominato da Lacan), l’Uno de La (Signora) Psicoanalisi, l’Uno del godimento masturbatorio di una pratica che, volendosi una, si vuole sola. Il caposaldo del neo-lacanismo L’Uno-tutto-solo di Jacques-Alain Miller conteneva a sua insaputa una profezia: la solitudine. Ma più che versare lacrime su un neo-lacanismo classico solo e moribondo, dobbiamo condannarne la violenza sistemica, che ha adoperato nella precisa scelta di escludere le psicoanalisi. Le psicoanalisi critiche, cliniche, decostruttive, che lo hanno minacciato con la loro alterità, costitutiva peraltro della sua materia-principe: l’inconscio che è discorso dell’Altro.
Queer Psychanalyse propone dunque non solo una clinica minore, ma minorizzata (minorisée), perché costretta dalla violenza padronale di un’esclusione a esprimersi dal margine. Ricorrendo a una metafora derridiana, possiamo dunque parlare della psicoanalisi diffusa – quasi con atteggiamento coloniale – da Miller come di un neo-lacanismo bianco, laddove “bianco” non (solo) indica il parlante in questione come maschio bianco cisgender eterosessuale ma soprattutto il tentativo di occultare dietro una supposta neutralità del discorso psicoanalitico (che non è mai neutrale, ma immediatamentepolitico) la messa a tacere, colpevole, violenta e intrinsecamente escludente, delle minoranze queer e trans. Bourlez ripristina un uso politico della psicoanalisi sottraendo l’uno-per-uno, l’esercito degli uni-tutti-soli, alla masturbazione paranoica del lettino, e riconsegnandoli alla specificità delle rivendicazioni del loro desiderio, che è passata attraverso il sangue di Stonewall e il “martirio” dei sieropositivi (cfr. pp. 37-38). Altra frontiera che Bourlez apre è il confronto con le teorie femministe, in particolare un urgente Butler con Lacan “Qu’y a-t il entre nous”? La linea che la nostra recensione persegue, riguardo l’imminente ricezione italiana di una psicoanalisi queer, non può che sostare su un fenomeno perlomeno bizzarro che ha colpito il neo-lacanismo: esso consiste nel dare centralità al godimento de la donna millantando un femminismo che non ha rapporto con alcuna delle quattro ondate femministe e che è avulso da rivendicazioni storiche e militanti. Insomma, un “puro” femminismo psicoanalitico, condotto – di nuovo – in solitudine sul lettino, una-per-una, combattendo coi propri fantasmi e accedendo a un godimento tanto singolare quanto innominabile, al di là del fallo: una vera deriva mistica.
La razionalità, il rigore, la logica radicale dell’inconscio – ben illustrata da Matte Blanco nel suo Saggio sulla bi-logica – sembrano rigettare questi accostamenti teologici e mistici, che non solo ridicolizzano l’impresa freudo-lacaniana ma occultano nuovamente la posizione del “chi parla” (né dio, né un al di là di…, ad esempio del fallo). Fortunatamente per noi, Bourlez corregge il tiro ricordandoci che tale godimento singolare (jouissance) può essere pronunciato perché l’esistenza di una comunità militante lgbtqia+ l’ha consentito, e decenni di lotte gay hanno fatto sì che l’innominabile assuma nomi, posizioni e colori di un arcobaleno, attraverso atti di nominazione del suddetto godimento, come il coming out: “sono psicoanalista e gay. L’ho detto, lo ripeto e ci ritornerò. Sarà meglio che vi abituiate” (cfr. p.19, trad. mia). In questo senso, anche l’ascolto (l’Ouïr) dell’analista deve essere un queer-ouïr. Bourlez gioca sulla medesimezza dei due fonemi, a cui aggiungerei jouir, per cui queer ouïr c’est jouir, l’ascolto queer è una forma di godimento: un ascolto in modo sempre già deviante, non coincidente con sé stesso, che diventa-altro e apre da dentro il fuori che rende i quadri clinici non chiudibili, infinitamente eccentrici, per far evolvere in maniera autenticamente critica i concetti fondamentali dell’inconscio. È quel che si intende con psicoanalisi open to revision, aperta alla revisione costante della sua prassi, e in questo senso inclusiva delle minoranze e spazio safe. In Francia i nomi per definirla proliferano: psychanalystes homosexuel.le.s, psylesbiennes, psy gay.e.s, homoanalystes, psy safe inclusif, analystes mineur.e.s, psy queer.
In questi spazi non aleggia il fantasma eteronormativo dell’analista uomo la cui analizzante è donna, con la presunzione maschile da parte del primo che vi sia tra i due un potenziale o un rischio di seduzione.
L’urgenza di far circolare in Italia Queer Psychanalyse di Bourlez deriva anche dall’errato confronto che è stato instaurato tra psicoanalisi lacaniana, femminismi e queer studies allo stato attuale del dibattito: pensiamo a testi come L’essere e il genere. Essere uomo/donna dopo Lacan della filosofa e psicoanalista lacaniana Clotilde Leguil, che ha messo per iscritto qualcosa che non esito a definire come una catastrofe del queer. Il modello di “essere donna” che Leguil propone consiste nel “godere della propria esclusione”, atto che dalla prospettiva di Bourlez sarebbe insostenibile. Per Leguil essere donna, oltre che essere esclusa e, paradossalmente, goderne, significa “confrontarsi con la follia”, e “godere di un’inesistenza per arginare la propria mancanza a essere”. Questi brevi estratti si affiancano a una ricostruzione storica semplicistica e a un’opera permeata, fin dal titolo, di una logica identitaria e binaria. Il binarismo è affermato fin dalla contrapposizione delle due opposte letture del concetto di “gender”, da parte degli studi di genere e della psicoanalisi: per i primi il gender sarebbe un’“artiglieria pesante”, una “gabbia che paralizza l’essere”, da abolire; per la seconda sarebbe il “soffio vitale dell’essere”, la possibilità più propria del soggetto, il quale “rincorre il genere per cogliere e raggiungere qualcosa del suo essere”. Correggere il tiro rispetto a questi quadri teorici fallaci sull’intersezione tra psicoanalisi e gender studies sembra essere per Bourlez un preciso dovere morale: nel suo saggio mostra che attestare l’esistenza di un punto di impossibilità tra La Psicoanalisi e il Queer è un gesto deliberato di occultamento, quello di un pensiero straight, per dirlo à la Wittig, di una precisa matrice eterosessuale che si dà come discorso maggioritario e maggiore: un discorso che silenzia i punti di espressione delle letterature minori, quelle che spingono la lingua al limite facendo tremare la grammatica maggioritaria. Maggiore e minore sono due modi possibili di leggere il testo lacaniano. Bourlez lo mostra anche con le dibattute tavole della sessuazione del Seminario XX, Ancora: uno schema bipartito che distingue il modo di godere fallico da quello femminile, col rischio di creare due universali che governano due logiche differenti, e dunque di riprodurre la differenza dei sessi. Il due è l’unico a priori della sessuazione o possiamo porre, già trascendentalmente, n-sessi, n eccezioni singolari a una legge piena di buchi, che fa acqua da tutte le parti? Attenersi alla binarietà dello schema non ci rende complici di una costruzione culturale ancora intrinsecamente dualista? Leggere le tavole in modo minore significa, invece, sessuare in modo queer, non prima di esser passati da Butler e Fausto-Sterling, intersecando la psicoanalisi con la storia del femminismo e della biologia. Significa intendere i sessi come un continuum e come i colori di un prisma (p. 281), a partire da nient’altro che i corpi (chiaramente significanti e sessuati), dalla loro innata biologia della complessità e della diversità, fino a includerne quel punto tanto imprendibile quanto matematico che è il Reale di ciascuno.
Il saggio di Bourlez ha un andamento decostruttivo: in cinque capitoli, vengono ripensati, in-fondati e reintegrati i fondamenti della pratica analitica. Nel primo, Bourlez sostiene di dover dé-faire l’analyse: e così ri-farla. Per disfare un’analisi, serve scrivere, resistere, fare in un certo senso e a proprio modo coming out (pp. 9-15). Nel secondo, manda in rovina l’Edipo: lo mantiene come osso fondamentale dell’analisi e come contenuto dell’inconscio, ma aprendolo a delle possibilità; ossia che ci siano n-sessi coinvolti nel teatrino edipico e che ci sia un necessario al di là dell’Edipo (pp. 94-98). La sorpresa è che la decostruzione dei generi non viene da un’integrazione, ma da una lettura radicale del testo freudiano stesso.
Bourlez prosegue tematizzando un atto nuovo, quello di performare l’omo-analista: nel terzo capitolo si chiede se i cabinets di Freud e Lacan fossero degli spazi che col lessico di oggi definiremmo safe, o ancora gay-friendly. Perché Dora fugge dopo sole tre settimane di analisi? (pp. 148-153) Perché le diagnosi di isteria spesso celano l’omosessualità femminile dietro la seduzione dell’analizzante per l’analista uomo, investito libidicamente come padre? (p. 147). La migliore sovversione che le isteriche abbiano potuto attuare nel discorso analitico è consistita nell’averlo fatto cessare. Dopo averlo inconsciamente istituito coi propri sintomi, se ne sono sbarazzate. Come? Andandosene. Rispettivamente nel Frammento di un’analisi di isteria (caso Dora) e in Psicogenesi di un caso di omosessualità femminile (caso della giovane omosessuale) “le due donne hanno buttato via il trattamento e le interpretazioni freudiane che lo accompagnano. Le sue manie d'interpretazione del sesso da parte del Padre le hanno fatte inorridire. Sono scappate. Lo hanno lasciato da solo con le sue pipe, le sue statuette e il suo divano” (p. 149).
I successivi capitoli sono dedicati a due precise operazioni politiche: l’inversione dell’etero-sessimo e l’apertura di un al di là della differenza dei sessi (ben diverso dall’al di là del fallo), per smontare le mosse che governano, in ogni nostra terapia individuale, quella che Bourlez definisce la micropolitica dell’atto analitico.
Perché leggere Queer Psychanalyse in Italia e farne, al contempo, il point de départ e il point de capiton del dibattito psicoanalitico contemporaneo? Per farla finita col verbo lacaniano come “sacra scrittura” da riconsegnare alla corretta filologia definitoria, e dunque con le derive teologiche e paranoiche che esso incarna, reiterando il discorso del padrone. Per de-feticizzare la Grande Psicoanalisi intesa come sola e unica soluzione al sintomo, sostituendola con la proliferazione di psicoanalisi queer, transfemministe e decostruttive. Il senso delle psicoanalisi, inteso qui come il loro desiderio, alla luce del saggio di Bourlez, non è l’indagine su un presunto “solo” godimento, ma il re-inquadramento dei modi di godere in un’analisi politica affiancata a un’epistemologia critica della sessuazione. Solo così potremo interrogare preliminarmente la scena eterosessuale, smascherarla nei suoi statuti oppressori e violenti, individuare i modi di vivere maggioritari e incarnare le nostre resistenze soggettive nelle grammatiche che non scegliamo di abitare, aprendo nuove possibilità di sessuazioni queer.
di Sara Fontanelli
Bibliografia
F. Bourlez, Queer Psychanalyse. Clinique mineure et déconstructions du genre, Éditions Hermann, Paris 2018.
J. Derrida, La mitologia bianca (pp. 275-349), in Id., Margini della filosofia (1972), Einaudi, Torino 1997.
J. Lacan, Il Seminario. Libro XX. Ancora (1972-1973), Einaudi, Torino 1983.
C. Leguil, L’essere e il genere. Essere uomo/donna dopo Lacan, Rosenberg & Sellier, Torino 2019.
J.-A. Miller, A. Di Ciaccia, L’Uno-tutto-solo. L’orientamento lacaniano, Astrolabio, Roma 2018.
-
L’automa tra Leibniz e Bergson
Recensioni / Febbraio 2020 In un film di qualche anno fa, Predestination (Australia 2014), i registi e fratelli gemelli Michael e Peter Spierig mettono in scena un vecchio racconto di fantascienza di Robert A. Heinlein, …All You Zombies… (1959), il cui protagonista è, al contempo, maschio e femmina, genitore e figlio/a, amante e amato/a. È la linearità (presunta) delle azioni che si susseguono nel tempo omogeneo a essere così, innanzitutto, radicalmente sovvertita. Una escogitazione narrativa originale, quella di un organismo nato all’interno della possibilità stessa di viaggiare nel tempo, autorizza un gesto che la metafisica si è sempre trattenuta dal compiere fino in fondo: elevare l’esperienza, con la sua radicale imprevedibilità, ad assoluto. Lo spettatore del film, come il suo protagonista (Jane/John), scoprono progressivamente un destino che nessuno ha scritto e che anzi si scrive, in maniera per forza di cose impersonale, attraverso il suo continuo accadere. Se si dovesse perciò trovare un’esemplificazione di quel che Federico Leoni affronta nel suo nuovo libro, L’automa. Leibniz, Bergson (Mimesis 2019), si dovrebbe, con ogni probabilità, fare ricorso a una figura analoga a quella al centro del film degli Spierig.
In un film di qualche anno fa, Predestination (Australia 2014), i registi e fratelli gemelli Michael e Peter Spierig mettono in scena un vecchio racconto di fantascienza di Robert A. Heinlein, …All You Zombies… (1959), il cui protagonista è, al contempo, maschio e femmina, genitore e figlio/a, amante e amato/a. È la linearità (presunta) delle azioni che si susseguono nel tempo omogeneo a essere così, innanzitutto, radicalmente sovvertita. Una escogitazione narrativa originale, quella di un organismo nato all’interno della possibilità stessa di viaggiare nel tempo, autorizza un gesto che la metafisica si è sempre trattenuta dal compiere fino in fondo: elevare l’esperienza, con la sua radicale imprevedibilità, ad assoluto. Lo spettatore del film, come il suo protagonista (Jane/John), scoprono progressivamente un destino che nessuno ha scritto e che anzi si scrive, in maniera per forza di cose impersonale, attraverso il suo continuo accadere. Se si dovesse perciò trovare un’esemplificazione di quel che Federico Leoni affronta nel suo nuovo libro, L’automa. Leibniz, Bergson (Mimesis 2019), si dovrebbe, con ogni probabilità, fare ricorso a una figura analoga a quella al centro del film degli Spierig.Anche l’automa, come la vicenda di Jane/John, è l’emblema di un divenire che si sottrae per definizione a ogni prevedibilità, come a qualsiasi pretesa di sovrana padronanza: che sfugge, in breve, alla calcolabilità dell’algoritmo. In fondo, il tema principale di questo piccolo ma importante libro, risiede nella differenza di natura che l’automa (spirituale o incorporeo, come lo definisce Leibniz) deve poter affermare rispetto alle macchine, e in particolare, in relazione alle molte macchine ‘pensanti’ con le quali oggi si tenta di strappare il divenire delle nostre vite alla sua radicale imprevedibilità. L’automa, insomma, è la figura di un organismo senza confini, di un essere che esiste tutto nel suo trasportarsi attraverso di sé, nel suo raggiungersi alla fine del proprio futuro come al principio del proprio passato, facendo così saltare per aria le paratie con le quali siamo soliti proteggerci dalla fatalità a cui ogni vita dovrebbe accordarsi. Imprevedibilità, in effetti, non significa né contingenza, né necessità, ma, piuttosto, continua ridefinizione del necessario come del possibile. Significa, in una parola, alterazione progressiva e cangiante delle stesse categorie con cui il pensiero tenta – tenta solamente – di irreggimentare l’automa.
L’argomentazione di Leoni prende due strade che, intrecciandosi l’una nell’altra come le due anime di una stessa corda, diventano progressivamente un'unica via. Il saggio, partendo dalla vicenda di Joë Bousquet, il poeta ferito di guerra paraplegico che già Gilles Deleuze eleggeva a simbolo della sua etica dell’evento (etica consistente per intero nel saper essere “all’altezza di ciò che ci accade”), mescola registro soggettivo e registro ontologico, determinando così quella indiscernibilità tra tempi distinti che fa appunto dell’automa la messa fuori gioco reiterata di tutte le opposizioni del pensiero metafisico. Una vita si scrive sempre in uno spazio che sfugge a ogni qualificazione nei termini della logica modale, vera e propria superficie di trascrizione ritmica e dialettica del divenire, allo stesso modo in cui il reale del mondo non si lascia acciuffare dalla scansione metafisica di sostanza e accidente, sostrato e accadere, soggetto e predicato. E viceversa, una vita non è un supporto al quale si aggiungono eventi, come il mondo non risponde alla distinzione di possibile e impossibile, contingenza e necessità. L’automa consiste tutto in questa ritrosia fondamentale, in tale riottosità del reale nei confronti dei nostri, umani troppo umani, schemi concettuali. La macchina, insomma, non è l’automa, perché l’automa è piuttosto la matrice informale e illocalizzabile di ogni macchina. Quel che l’automa, correttamente inteso, rivela è quindi l’impossibilità definitiva di calcolare e padroneggiare tecnicamente il divenire. Attraverso il suo situarsi sempre un passo al di là, o al di qua, di ogni concettualizzazione, come di tutte le prassi di adattamento tecnico del reale ai nostri bisogni, nel mentre che tutte le circoscrive e le include, l’automa offre la manifestazione di un’assoluta e crescente indisponibilità del reale. Reale è qui ciò che, come appunto l’automa, si muove da sé e non tollera quindi alcun genere di ingerenza, senza prima averla riassorbita.

Fritz Lang - Metropolis (1927) Il paradosso di fronte al quale ci mette Leoni è infatti il seguente: il destino esiste solo fin quando vi si acconsente. Ogni manovra diversiva apre per ciò stesso una deviazione, istituisce “nuovo” destino, a sua volta imprevedibile. Leoni propone una sorta di psicoanalisi della metafisica, in cui la struttura nevrotica degli schemi concettuali tràditi diventa l’occasione di un lavoro decostruttivo che non può non essere, altresì, lavoro ricostruttivo. Emerge così qualcosa come una ontologia senza metafisica – un’ontologia della non invarianza dell’ontologia. Un’ontologia della perversione che dà luogo a un’ontologia che si perverte senza sosta. L’utopia, nel senso letterale della parola, è quindi costituire i prodromi di una «scienza del divenire» (p. 13), ovvero di ciò di cui, a detta di Aristotele (e con lui, di tutta l’episteme occidentale), non si dà scienza. Che il divenire sia isomorfo all’individuale è infatti fuor di dubbio: «Non esiste il movimento in generale» (p. 26). Il divenire è sempre singolare – e anzi, il divenire è il singolare. «Se si assume questo schema, scrive Leoni, la filosofia è possibile solo nella forma dell’esplorazione della propria impossibilità, è possibile solo come infinita rivisitazione della propria aporia» (p. 13). Ma la filosofia consiste proprio in questa sfida: occorre saper tramutare una impossibilità, quella della filosofia come scienza del non qualsiasi o del non generico, in effettività. Come fa, d’altronde, ogni creatore. Ogni creatore che si rispetti deve fronteggiarsi infatti con un compito impossibile – trasformare un fraintendimento in una risorsa. Harold Bloom, nel suo celebre L’angoscia dell’influenza, lo ha mostrato in relazione all’emergere di quanto definisce un «poeta forte». Ma il discorso vale vieppiù a proposito della vicenda filosofica. Anche in questo caso ne va della conversione di un travisamento inevitabile in un altrettanto inevitabile progresso, che si legittima à rebours quale correzione di quanto in passato era rimasto disatteso o, soltanto, era stato equivocato. La storia dell’automa coincide quindi con la storia della filosofia, come serie continua di tentativi riusciti proprio perché falliti. L’ontologia che Leoni lascia balenare nella sua istruttoria sull’automa registra questo fatto, elevandolo a cifra stessa del reale – di ciò che nel reale si presenta come l’essere qualsiasi. Paradosso ulteriore, quindi: il modo d’esistenza del singolare, ovvero del non-qualunque, è di essere, appunto, affatto qualsiasi. Di non avere scelta, per dir così.
Ecco allora che, nell’ultimo capitolo, L’inconscio, una storia di fantasmi, l’autore tira le fila del suo discorso con una mossa apparentemente inattesa: l’automa diventa un avatar, a sua volta, del fantasma. Lo scenario è vertiginoso e la batteria di concetti evocati vorticosa. Tutto non è altro che immagine, immagine in sé. Sono le celebri e difficili tesi del primo capitolo del bergsoniano Materia e memoria (1896), portate però qui al loro sviluppo più radicale. L’automa non è una macchina, dicevamo, ma ogni macchina è una forma, o un organo, dell’automatismo dell’automa. Pensare l’automa non significa considerare le connessioni di parti in esteriorità con cui ci si presenta il mondo notomizzato dall’intelligenza pragmatica; non è questione di funzionamenti di oggetti, ricavati dalla giustapposizione di realtà accomodate l’una all’altra secondo il loro profilo materiale. Pensare l’automa è pensare l’intramatura con la quale ogni lacerto di mondo, anche il più insignificante e infinitesimale, si installa e fugge al contempo in e da ogni altro. È vedere il mondo quale ribollio incessante di proliferazioni, di frattali in reciproca e diveniente ristrutturazione. Lo statuto dell’automa è lo statuto dell’esempio, di ciò che, senza scarti di alcun genere – senza la mediazione di una generalità interposta –, è il proprio stesso dover-essere. Di ciò che appunto è singolare: unico nel suo genere. «Ogni cosa è una ragione […] Ogni monade è insieme di un solo elemento, ma quel solo elemento non è un elemento solo, è sempre anche il proprio insieme» (pp. 44 e 74). Nell’atto di leggere Bergson e Leibniz, Leoni si precipita perciò al di là di loro – si spinge oltre il dualismo di tendenze che ancora caratterizza il dettato bergsoniano, come già Deleuze aveva notato, e il contingentismo che Leibniz fatica, malgrado tutto, a ricusare come a giustificare (significativo è che Leoni decida di non tematizzare direttamente la teodicea leibniziana). L’automa si presenta quindi come una meditazione sulla necessità di ontologizzare quanto si sottrae, in apparenza, a questa stessa eventualità: l’immaginazione – quella «funzione senza organo» (Georges Canguilhem) che, secondo il Kant della Critica del giudizio, può guadagnare in alcuni casi le prerogative di un «libero gioco» in cui non è più l’intelletto, con il suo quadro presupposto di categorie, a dettare le condizioni. Ecco che cosa vuol dire pensare una ontologia rescissa dai suoi vincoli metafisici: «E in questo senso ci sono solo nature al plurale, e ogni divisione produce una natura differente, ovvero la natura si divide producendosi in ogni divisione come un altro modo di essere natura, come un altro modo di naturare, un’altra genesi continua di discontinuità. In altre parole, tutto è artificiale, non c’è che artificio» (p. 17).
Il lavoro di Leoni, e non solo in questa occasione, ha come esito, dunque, una definitiva messa in mora della tentazione meccanicista che pure da sempre caratterizza una certa filosofia, intenta a cercare una clavis universalis con cui risolvere una volta per tutte i problemi della conoscenza e della vita. Speranza, d’altronde, dello stesso Leibniz che, con la sua characteristca universalis, immaginava di ridurre ogni controversia a un puro esercizio di calcolo. Fa notare l’Autore: «Ogni macchina contiene un appello alla trascendenza» (p. 51). Si tratta invece di lavorare a un concetto e una prassi conseguente di immanenza integrale. La suddetta chiave, sembra dirci infatti Leoni, semplicemente non esiste, perché deriva, al contrario, da un effetto interno a una potente tecnologia, che fa tutt’uno con quella alfabetica – la grammatica indoeuropea di soggetto e predicato, che struttura notoriamente gran parte della tradizione filosofica occidentale, almeno sino alla soglia del Novecento. Se pensiamo di poter ricostruire l’evento con i risultati della sua analisi (ricostruzione in atto già nella distinzione del flusso linguistico in parti del discorso), finiamo per cadere in una serie di perniciose aporie – tra le quali, e non per ultima, l’idea di un divenire che si aggiunge dall’esterno all’essere senza potersi mai davvero comporre con esso, di una molteplicità che si fa uno o di un’unità che si fa, non si capisce come, molteplice. Quel che va pensato, allora, è qualcosa che è «più di uno e meno di due» (p. 52), che resiste in questo bilico. Occorre solcare il paradosso senza cadere nell’aporia.
Fare filosofia ha sempre significato volersi cimentare con un compito inattuabile: trasformare la vita in un processo automatico. Perché si tratti di alcunché d’irrealizzabile, è presto detto: l’automa è la figura che rende impraticabile questa strada, nella stessa misura in cui la impone come inaggirabile. «Ogni automa è la macchina di ogni altro» (p. 59). La filosofia si identifica alla memoria, perenne perché ogni volta da rinnovare, di questa eccedenza o di questa sottrazione originaria, le quali rimandano entrambe, però, alla totale immanenza con cui l’automa prende forma, aderendo perfettamente solo a se medesimo. Perché di questo si tratta, di un prendere forma che resta tale – che resta in progress. L’automa, insomma, non è calcolabile. Tutto si può fare, tranne divenire-automi, se “divenire” significa passare dalla potenza all’atto. Semmai, si dovrà tornare a esserlo – tornare a essere quel che non si è mai cessato di diventare. L’unico vero automa, in altre parole, non è digitale, ma analogico. Nessun dio ci può salvare, va infine detto. Nemmeno quel dio minore che è il filosofo. Per fortuna.
di Daniele Poccia
-
 Nel 1739 l’inventore francese Jacques de Vaucanson progettò il suo automa più famoso, Le Canard Digérateur. Della celebre “anatra digeritrice”, che in realtà non digeriva affatto i chicchi di grano con cui veniva nutrita, è rimasta traccia materiale soltanto negli schizzi preparatori del suo costruttore e nelle riproduzioni di alcuni artisti contemporanei. Tuttavia, il modello meccanico di de Vaucanson rappresenta un ottimo esempio della rappresentazione (e della riproduzione) del fare animale che il nuovo libro di Roberto Marchesini, Etologia filosofica. Alla ricerca della soggettività animale (Mimesis, 2016), intende accantonare in modo definitivo. Freddo, automatizzato, determinato e in fin dei conti semplice nel suo funzionamento, Le Canard Digérateur è la realizzazione meccanica e antropica della res extensa cartesiana, principale bersaglio dell’analisi di Marchesini. Addentrandosi in territori inesplorati dal panorama filosofico contemporaneo, l’autore inaugura una nuova strada seguendo due coordinate principali: la critica del modello meccanicista e l’individuazione del principio meta-predicativo nell’animalità.
Nel 1739 l’inventore francese Jacques de Vaucanson progettò il suo automa più famoso, Le Canard Digérateur. Della celebre “anatra digeritrice”, che in realtà non digeriva affatto i chicchi di grano con cui veniva nutrita, è rimasta traccia materiale soltanto negli schizzi preparatori del suo costruttore e nelle riproduzioni di alcuni artisti contemporanei. Tuttavia, il modello meccanico di de Vaucanson rappresenta un ottimo esempio della rappresentazione (e della riproduzione) del fare animale che il nuovo libro di Roberto Marchesini, Etologia filosofica. Alla ricerca della soggettività animale (Mimesis, 2016), intende accantonare in modo definitivo. Freddo, automatizzato, determinato e in fin dei conti semplice nel suo funzionamento, Le Canard Digérateur è la realizzazione meccanica e antropica della res extensa cartesiana, principale bersaglio dell’analisi di Marchesini. Addentrandosi in territori inesplorati dal panorama filosofico contemporaneo, l’autore inaugura una nuova strada seguendo due coordinate principali: la critica del modello meccanicista e l’individuazione del principio meta-predicativo nell’animalità.L’analisi prende piede, ancora una volta, dalla rivoluzione darwiniana di metà Ottocento. La straordinaria svolta imposta dalle conclusioni del naturalista inglese, già contenenti tutti gli elementi necessari a un approccio non meccanicistico al comportamento animale, venne arginata nei decenni successivi da una vera e propria controriforma sia culturale sia scientifica. Il mentalismo novecentesco compì l’errore di non comprendere appieno la teoria darwiniana, mascherando vecchie concezioni con nomi nuovi. L’animale fu relegato nell’Umwelt, incatenato nel suo mondo e obbligato a svolgere automaticamente le proprie funzioni, delle quali è schiavo più che libero padrone. L’uomo, al contrario, venne svincolato dagli alberi filogenetici del vivente perché soggetto e dunque diverso dalla fauna restante, pletora di forme di vita impossibilitate ad assurgere a tale rango.
Il rifiuto dell’animalità dell’uomo, la prigionia dell’animale nella sua monade e l’automatismo funzionale dell’agire animale sono i tre pilastri di matrice antropocentrica che resistono alle scoperte scientifiche nel campo della biologia e vengono ereditate di generazione in generazione sino ai tempi moderni. Il confine tra umano e non umano viene rimarcato, stabilendo ruoli e incasellamenti che perdurano tutt’oggi e che devono essere scardinati a forza dal pensiero popolare così come dai dibattiti cultural-scientifici.
Nel suo saggio, Marchesini rimarca l’importanza di discostarsi dal classico approccio con cui l’essere umano ha avvicinato, studiato, interagito e osservato gli animali non umani. L’antropomorfismo proiettivo genera due principali conseguenze negative: primo, alimenta la presunzione di poter descrivere un altro essere vivente, dotato di proprie filogenesi e ontogenesi, a partire dal modello umano; secondo, legittima la categorizzazione oppositiva che già sussume, rendendola di fatto ineliminabile. Inoltre, rigettare l’unicità filogenetica di ciascuna specie allontana, in modo solo all’apparenza paradossale, dall’orizzontalità del bios che la teoria darwiniana prima e le scoperte nel campo della genetica raggiunte nel corso del Novecento poi hanno messo in luce. Eppure, nonostante già Darwin avesse sottolineato che l’animalità è una condizione che riguarda anche l’Homo sapiens, una lunga serie di filosofie e movimenti culturali hanno rafforzato e blindato la fortezza-uomo, cercando in ogni modo di isolarla da tutte le altre entità animali. Per raggiungere questo obiettivo non c’è modo migliore che quello di reificare e de-soggettivare l’animale, identificandolo a partire da quei predicati epimeteici che lo inchiodano, rendendolo schiavo delle sue funzioni. Durante il “secolo breve” l’animalità dell’uomo è stata dunque rigettata (spesso facendo perno sulla dicotomia natura/cultura, laddove la seconda è la marcia in più, la dotazione umana per eccellenza), rifiutando qualsiasi accostamento all’altro animale (la sinfisia di Acampora, il comune sentire interspecifico, arriverà soltanto alle soglie del nuovo millennio) e, infine, imponendo l’automa, il costrutto meccanico, come modello per la descrizione del comportamento e della biologia animali.

La critica del meccanicismo utilizzato per spiegare il fare animale insito tanto nella filosofia quanto nell’etologia parte dal superamento del riduzionismo e della macchina come modello. Le domande da porsi in principio potrebbero essere le seguenti: l’animalità può essere matematizzabile? Il fare animale può essere ridotto a un mero esercizio delle funzioni, trasformando il comportamento in un’azione semplice e binaria come lo è azionare un interruttore? Non si deve, ovviamente, cadere nella risposta più ovvia, vale a dire l’esaltazione e la descrizione della complessità come antidoto a ogni tentativo di meccanizzazione. Non è nelle stupefacenti immagini di un documentario della BBC o nell’ultimo, affascinante e istruttivo articolo pubblicato da Nature che dobbiamo cercare l’essenza dell’animalità. Occorre invece comprendere che la formalizzazione cartesiana non può donare al fare animale quella soggettività in cui Marchesini identifica il vero e proprio meta-predicato che funge da fil rouge attraverso il dominio animale dove è di casa anche l’uomo. La titolarità espressiva è il raggiungimento finale: non sono le dotazioni a muovere l’individuo, non esiste alcun homunculus e non è ovviamente contemplato un piano trascendente; «l’esistenza è pertanto una titolarità che va oltre la coscienza» (Marchesini, 2016, p. 45). Superare la res extensa cartesiana è il punto di partenza necessario per poter mettere da parte ogni tentativo di meccanizzazione dell’animale, ridotto, come è stato fatto in passato, a mera macchina a incastro, interruttore pronto ad agire, totalmente privo di soggettività.
Ammettendo la soggettività come condizione meta-predicativa dell’animale, è possibile passare da un modello a innesco (il già citato interruttore) a un modello virtuale. Per giungere alla virtualità funzionale, è dunque necessario considerare la singolarità della presenza animale, una singolarità che è sia storica (filogenesi), sia di sviluppo (ontogenesi). Ogni individuo è unico, non è cristallizzato nel qui-e-ora ma fa parte del flusso diacronico-evolutivo. L’animale non è operativo al pari di una macchina, al contrario è aperto e instabile. Da questo punto di vista, il comportamento non può essere letto come un automatismo: ogni individuo animale è un soggetto che si muove lungo le coordinate del desiderio e della volontà, proprietà queste che lo svincolano da qualsiasi tentativo di modellizzazione macchinica in quanto non c’è alcun compito da portare a termine secondo una procedura, sia essa determinata o algoritmica, tipica dell’automa. In Etologia filosofica il concetto di soggettività viene espresso come «visione diacronico-relazionale dell’esistenza» (Marchesini, 2016, p. 86) e porta a un paio di paradossi: primo, la titolarità sulle funzioni è svincolata dalla responsabilità sulle stesse; secondo, l’animale esercita le sue eredità filogenetiche, pur non essendone da esse esclusivamente determinato. L’animale è quindi un flusso, un divenire, un essere sempre diverso da se stesso. L’ontogenesi è un dialogo aperto col mondo, che diventa il piano su cui l’animale si muove in modo aperto, libero e flessibile, assolutamente non determinato. Abbandonando il principio disgiuntivo e oppositivo che da sempre accompagna la relazione fra l’uomo e gli altri animali, Marchesini illustra la dimensione ontologica dell’animale, fondata sulla soggettività, la singolarità e la titolarità sulle funzioni: non conta ciò che un animale è in grado di fare, ma che cosa fa di lui un animale.
Al termine della sua ricerca, Marchesini trova la metafora perfetta per chiarire l’idea su cui si fonda Etologia filosofica. Se l’intero saggio si configura come una ricerca, un tentativo di inaugurare una nuova strada che porti al riconoscimento della soggettività animale, quale figura potrebbe funzionare meglio che quella di una mappa? La cartina, capace com’è di mostrare una struttura e al contempo di richiedere l’ideazione di un itinerario, può agire da “schema funzionale” meglio di altri modelli. Dotato di un impianto di base – eredità del suo percorso filogenetico e del suo sviluppo ontogenetico – e grazie alla titolarità sulle proprie funzioni, l’animale può agire in modo plurale, creativo, intenzionale e soprattutto flessibile: può imboccare questa o quella strada, allungare il percorso, compiere deviazioni o addirittura mancare l’obiettivo di proposito. Appare dunque chiaro, grazie alla metafora, come questo agire sia distante anni luce dal percorso, rigoroso e iterativo, delineato da un diagramma di flusso, o dalle scelte, limitate e obbligate, che costituiscono un algoritmo informatico.
di Danilo Zagaria
-
L’arte della similitudine. Foucault e Magritte
Sconfinamenti, Serial / Ottobre 2016 È piuttosto insolito incontrare, negli scritti di un pittore, riferimenti ai filosofi. Eppure, nell’ampio corpus di quelli redatti nel corso dei decenni da René Magritte, capita a volte di imbattersi nei nomi di Eraclito, Socrate, Platone, Descartes, Berkeley, Kant, Hegel, Schopenhauer, Marx, Nietzsche, Bergson, Bachelard, Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty. Inoltre, anche se i testi dell’artista belga non sono certo di carattere filosofico, in alcuni di essi si può ravvisare un’originale riflessione sul linguaggio. Ricordiamo per esempio un celebre scritto illustrato del 1929, Les mots et les images, che contiene enunciati lapidari come i seguenti: «Un oggetto non è mai tanto legato al suo nome che non se ne possa trovare un altro che gli si adatti meglio»; «Un’immagine può prendere il posto di una parola in una proposizione»; «Tutto tende a far pensare che ci sia scarso rapporto tra un oggetto e ciò che lo rappresenta»; «A volte il nome di un oggetto può sostituire un’immagine»; «In un quadro, le parole sono della stessa sostanza delle immagini»; «Si vedono in un modo diverso le immagini e le parole in un quadro». Date queste premesse, non desta sorpresa il fatto che Magritte si sia affrettato a leggere un libro di Michel Foucault dal promettente titolo Les mots et les choses, senza farsi intimorire dalla mole e dalla complessità della trattazione. Resta strano, però, il fatto che, a poco più di un mese dall’uscita del volume, un pittore anziano e affermato come lui abbia sentito l’esigenza di scrivere a Foucault una lettera al fine di comunicargli le proprie idee su una questione specifica, ossia il tema della somiglianza. In effetti nel libro, riferendosi alla cultura del Cinquecento, il filosofo aveva evidenziato l’onnipresenza, in vari campi del sapere, dell’idea di somiglianza o similitudine...Scarica PDF
È piuttosto insolito incontrare, negli scritti di un pittore, riferimenti ai filosofi. Eppure, nell’ampio corpus di quelli redatti nel corso dei decenni da René Magritte, capita a volte di imbattersi nei nomi di Eraclito, Socrate, Platone, Descartes, Berkeley, Kant, Hegel, Schopenhauer, Marx, Nietzsche, Bergson, Bachelard, Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty. Inoltre, anche se i testi dell’artista belga non sono certo di carattere filosofico, in alcuni di essi si può ravvisare un’originale riflessione sul linguaggio. Ricordiamo per esempio un celebre scritto illustrato del 1929, Les mots et les images, che contiene enunciati lapidari come i seguenti: «Un oggetto non è mai tanto legato al suo nome che non se ne possa trovare un altro che gli si adatti meglio»; «Un’immagine può prendere il posto di una parola in una proposizione»; «Tutto tende a far pensare che ci sia scarso rapporto tra un oggetto e ciò che lo rappresenta»; «A volte il nome di un oggetto può sostituire un’immagine»; «In un quadro, le parole sono della stessa sostanza delle immagini»; «Si vedono in un modo diverso le immagini e le parole in un quadro». Date queste premesse, non desta sorpresa il fatto che Magritte si sia affrettato a leggere un libro di Michel Foucault dal promettente titolo Les mots et les choses, senza farsi intimorire dalla mole e dalla complessità della trattazione. Resta strano, però, il fatto che, a poco più di un mese dall’uscita del volume, un pittore anziano e affermato come lui abbia sentito l’esigenza di scrivere a Foucault una lettera al fine di comunicargli le proprie idee su una questione specifica, ossia il tema della somiglianza. In effetti nel libro, riferendosi alla cultura del Cinquecento, il filosofo aveva evidenziato l’onnipresenza, in vari campi del sapere, dell’idea di somiglianza o similitudine...Scarica PDFA cura di:
Giuseppe Zuccarino è critico e traduttore. Ha pubblicato vari saggi: La scrittura impossibile, Genova, Graphos, 1995; L’immagine e l’enigma, ivi, 1998; Critica e commento. Benjamin, Foucault, Derrida, ivi, 2000; Percorsi anomali, Udine, Campanotto, 2002; Il desiderio, la follia, la morte, ivi, 2005; Il dialogo e il silenzio, ivi, 2008; Da un’arte all’altra, Novi Ligure, Joker, 2009; Note al palinsesto, ivi, 2012; Il farsi della scrittura, Milano-Udine, Mimesis, 2012. Tra i libri da lui tradotti figurano opere di Mallarmé, Bataille, Klossowski, Blanchot, Caillois e Barthes.
-
Alain Badiou – Alla ricerca del reale perduto
Recensioni / Giugno 2016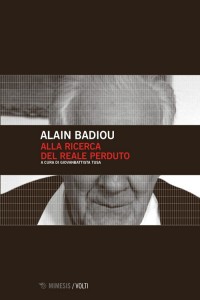 Alla ricerca del reale perduto (Mimesis, 2016) è l’ultimo libro di Alain Badiou; titolo ostentatamente evocativo, e chiaro proprio in forza del riferimento all’evocazione. Se non fosse che, anche solo per un vago e sterile (o probabilmente no) principio d’associazione, ancor prima di addentrarsi nella lettura del testo, si è come costretti a pensare contemporaneamente a ciò che di altro l’evocazione porta con sé, alla sua necessaria e conseguente implicazione, e così il pensiero scorrendo tra i ricordi sostituisce quel perduto in un forse più appropriato ritrovato. Semplici associazioni mentali, s’è detto, sino a quando, a fine lettura, si scopre in effetti una certa corrispondenza tra queste e il contenuto effettivo del testo. L’eterno equivoco che un simile titolo corre il rischio di perpetuare è quello di confondere il risultato della ricerca con la ricerca stessa, ovvero di produrre un discorso su ciò che si è perso quando in realtà lo si è già trovato, elidendo in tal modo i confini della classica distinzione agostiniana tra quo eundum est e qua eundum est.
Alla ricerca del reale perduto (Mimesis, 2016) è l’ultimo libro di Alain Badiou; titolo ostentatamente evocativo, e chiaro proprio in forza del riferimento all’evocazione. Se non fosse che, anche solo per un vago e sterile (o probabilmente no) principio d’associazione, ancor prima di addentrarsi nella lettura del testo, si è come costretti a pensare contemporaneamente a ciò che di altro l’evocazione porta con sé, alla sua necessaria e conseguente implicazione, e così il pensiero scorrendo tra i ricordi sostituisce quel perduto in un forse più appropriato ritrovato. Semplici associazioni mentali, s’è detto, sino a quando, a fine lettura, si scopre in effetti una certa corrispondenza tra queste e il contenuto effettivo del testo. L’eterno equivoco che un simile titolo corre il rischio di perpetuare è quello di confondere il risultato della ricerca con la ricerca stessa, ovvero di produrre un discorso su ciò che si è perso quando in realtà lo si è già trovato, elidendo in tal modo i confini della classica distinzione agostiniana tra quo eundum est e qua eundum est.Ma in cosa consiste questo sempre sottratto, che sembrerebbe tuttavia un già da sempre ritrovato, di cui parla Badiou? Il filosofo lo spiega nell’introduzione con una lapidaria constatazione: «Dobbiamo preoccuparci costantemente del reale, obbedirgli, dobbiamo comprendere che non si può fare nulla contro il reale» (p. 7). Il reale dunque, principio d’inemendabilità che per Badiou si presenta subito come «fonte di imposizione, figura di una legge ferrea» (p. 7) da cui non si può prescindere, presieduta dalle regole auree dell’economia, che del reale stesso si fa garante. Questa la base dalla quale può scaturire la domanda filosofica sul reale, che si presenta però sotto una forma particolare, tale da contenere già in sé la propria risposta; il gioco delle circolarità inaugurato dal titolo prosegue qui a livello teoretico nel momento in cui non ci si interroga preliminarmente sulla esistenza o su una possibile definizione fondativa di ciò che chiamiamo reale, ma ci si chiede solo se esso, assunto implicitamente come condizione preliminare necessaria, possa darsi «se non in quanto base di un’imposizione» che esiga solo in ogni circostanza una «sottomissione piuttosto che un’invenzione» (p. 7). Si può comprendere già da qui perché in fondo questo reale di cui si invoca la scomparsa non è mai stato veramente perso: fare della questione del reale non un problema che investe la sua legittimità o la sua possibilità, ma solo la sua origine. Il nostro avere a che fare con una realtà, del mondo e delle cose, non è messo in discussione nella prospettiva dell’autore; il nodo teorico risiede invece nella possibilità di pensare, platonicamente, un vero reale, al di là del volto mistificatore e fallace rappresentato dalla presunta realtà del contesto economico-politico attuale. Si tratta, prosegue Badiou, di «sapere se, dato un discorso secondo il quale il reale genera una costrizione, si possa, o non si possa, modificare il mondo in maniera tale che si presenti un’apertura, prima invisibile, attraverso la quale si possa sfuggire a questa costrizione pur senza negare che esistano sia il reale sia la costrizione» (p. 10).
 L’affermazione mette ora in mostra, nel punto più denso della teorizzazione, l’artificio concettuale che prima appariva solo dal meccanismo a effetto messo in moto dal titolo; in queste parole, in effetti, si può rintracciare quel fondamento necessario di cui si promuove la ricerca, che, se posto attraverso l’impossibilità di negarne la realtà e la costrittività, si presenta già da sempre come un originariamente già dato, una base per un reale già da sempre a disposizione, che occupa una posizione per cui si può già da sempre trovarlo: un reale che probabilmente non può dunque dirsi realmente perduto. La questione si risolverebbe, in un certo modo, solo in un problema di posizionamento: dopo aver detto che il punto non sta nell’interrogarsi sulle condizioni di possibilità della realtà, ma solo sulla necessità di trovare quella vera rispetto a quella apparente nella quale ci troveremmo, la mossa successiva è quella di rintracciare dove e come questo nuovo, autentico accesso al reale può darsi. Qui Badiou ripropone la sua prospettiva filosofica di fondo, caratterizzata dalla centralità data al concetto di evento, quella modalità inedita «che ci costringe a decidere una nuova maniera d’essere» (1994, p. 40) che assume la forma particolare di un incontro. Come già riguardo alla formulazione di una nuova base di legittimità per un pensiero etico e per una ridefinizione del fenomeno amoroso, anche l’incontro con la realtà si instaura essenzialmente grazie a un processo di ricollocazione, di un radicamento al livello della situazione, dove si può «approcciare il reale in un processo ogni volta singolare» (p. 15).
L’affermazione mette ora in mostra, nel punto più denso della teorizzazione, l’artificio concettuale che prima appariva solo dal meccanismo a effetto messo in moto dal titolo; in queste parole, in effetti, si può rintracciare quel fondamento necessario di cui si promuove la ricerca, che, se posto attraverso l’impossibilità di negarne la realtà e la costrittività, si presenta già da sempre come un originariamente già dato, una base per un reale già da sempre a disposizione, che occupa una posizione per cui si può già da sempre trovarlo: un reale che probabilmente non può dunque dirsi realmente perduto. La questione si risolverebbe, in un certo modo, solo in un problema di posizionamento: dopo aver detto che il punto non sta nell’interrogarsi sulle condizioni di possibilità della realtà, ma solo sulla necessità di trovare quella vera rispetto a quella apparente nella quale ci troveremmo, la mossa successiva è quella di rintracciare dove e come questo nuovo, autentico accesso al reale può darsi. Qui Badiou ripropone la sua prospettiva filosofica di fondo, caratterizzata dalla centralità data al concetto di evento, quella modalità inedita «che ci costringe a decidere una nuova maniera d’essere» (1994, p. 40) che assume la forma particolare di un incontro. Come già riguardo alla formulazione di una nuova base di legittimità per un pensiero etico e per una ridefinizione del fenomeno amoroso, anche l’incontro con la realtà si instaura essenzialmente grazie a un processo di ricollocazione, di un radicamento al livello della situazione, dove si può «approcciare il reale in un processo ogni volta singolare» (p. 15).Prende così l’avvio, con questo percorso diagonale, un viaggio sul sentiero, presuntivamente interrotto, che conduce a quella sorta di disvelamento ultimo, a quell’incontro in cui il reale si mostrerebbe per ciò che è, rivelandosi attraverso tre momenti costitutivi che dell’incontro ne definiscono la natura. Il primo, rifacendosi all’episodio della morte in scena di Molière, delinea la forma preliminare dell’incontro come processo di smascheramento e divisione. La morte, reale, di Molière mentre recita il Malato immaginario crea «una sorta di attrito del tutto particolare tra il reale e la finzione» (p. 19) capace di ristabilire, dialetticamente, il primato del primo nei confronti del secondo; l’effetto di finzione della recitazione viene squarciato per mezzo della violenza del reale, che fa, paradossalmente, di un malato immaginario un morto reale. Il reale, ancora molto platonicamente, è pensato come «crollo di una finzione» (p. 20), come disinfestante per l’apparenza, che fornisce la maschera al reale e lo divide, creandone il suo sembiante polimorfo e illusorio.

Il secondo momento permette un avvicinamento al reale per mezzo di un incontro teoretico. Utilizzando la definizione, in verità solo una delle varie possibili, che Lacan fornisce del concetto di reale come impasse della formalizzazione, Badiou spiega che l’accesso a esso avviene nel momento in cui si pone la sua condizione di possibilità proprio dove questa andrebbe a costituire la sua negazione, vale a dire nell’impossibilità: «il numero infinito come impossibile è il reale dell’aritmetica» (p. 28), afferma con un esempio matematico. La formalizzazione della realtà, la sua condizione di realizzabilità, è sempre frutto di un suo punto di informalizzabilità; ecco perché se l’affermazione del reale come formalizzazione risiede nel momento dell’impasse questa sarà sempre anche in parte la distruzione di questa formalizzazione. In termini lacaniani l’idea potrebbe tradursi così: eliminare quel tanto di immaginario e di simbolico ‒ la «formalizzazione sostanziale della nostra esistenza» (p. 31) ‒ che impedisce di conquistare quel punto di impossibile che è il reale; gesto teorico interessante, ma che alleggerisce non di poco l’essenziale distinzione, prevista dallo stesso Lacan, tra reale e realtà, distinzione che in certo modo ripropone un altro celebre parallelismo, quello tra significante e significato; ma come il significante ‒ il senso ‒ non si risolve integralmente nel significato, anzi lo eccede, in quanto non solo sua semplice manifestazione ma anche sua fonte di produzione, così il reale, trovandosi allo stesso tempo dentro e fuori la simbolizzazione, dentro ma costitutivamente fuori dalla parola e dal soggetto, non pone le basi per la costruzione della realtà di quest’ultimo, «giacché il reale non attende, e non attende il soggetto, […] Ma è lì, identico alla sua esistenza, rumore in cui si può tutto intendere, e pronto a sommergere dei suoi bagliori quel che “il principio di realtà” vi costruisce sotto il nome di mondo esterno» (2002, p. 380).
Il terzo e ultimo momento dà accesso al reale attraverso la poesia, quel luogo linguistico che «estorce alla lingua un punto reale impossibile da dire» (p. 37). Le ceneri di Gramsci di Pasolini fornirebbe l’esempio artistico per eccellenza sull’interrogarsi del reale della storia. Inevitabilmente, trattandosi di Gramsci, il reale è quello del comunismo come possibilità irrealizzata, divenuta cenere appunto, le cui forme, storico-politiche e sociali, assumono la maschera grottesca del divertissement. Essa rappresenterebbe quella disperata passione d’essere nel mondo, senza realizzarlo, senza comprenderlo come prodotto d’una Storia che, nonostante se stessa, può lavorare ancora per noi, nella prospettiva di una nuova «dialettica affermativa» (p. 50), per cui la rinuncia «alla fede in un lavoro della storia che sarebbe di per sé stesso strutturalmente orientato verso l’emancipazione» consente anche di «continuare ad affermare che è certamente nel punto di impossibile di tutto ciò che si situa la possibilità dell’emancipazione» (p. 48)
La chiusura di questa tripartizione porta Badiou a concludere, dialetticamente, che il viaggio non è però concluso. Si tratta di puntare più in alto, iperuranicamente alla «ricerca di ciò che di reale vi è nel reale» (p. 52).
di Enrico Zimara
Bibliografia
Badiou, A. (1994). L’etica. Saggio sulla coscienza del male (1993). Parma: Nuova Pratiche Editrice.
Lacan J. (2002) Risposta al commento di Jean Hyppolite sulla «Verneinung» di Freud, in Scritti, vol. I (1966). Torino: Giulio Einaudi editore.
-
 L’accattivante titolo Re Mida a Wall Street. Debito desiderio e distruzione tra psicoanalisi, economia, filosofia (Mimesis, 2015) costituisce una sorta di compendio lacaniano al tema del debito. Tenendo conto dell’enorme offerta di studi critici in circolazione, il tentativo del numero 5 di LETTERa, curato da Federico Leoni, è decisamente apprezzabile perché propone un’angolatura differente rispetto a quella dominante, prettamente economico-matematica. In che modo tratta il debito un analista? Come il Maestro? Élisabeth Roudinesco (1997, pp. 389, 397-398) racconta che Lacan aveva un debole per i soldi: gli analizzanti insolventi venivano inseguiti da una voce mielosa per ottenere il compenso pattuito. Il costo delle sedute era d’altronde carissimo: da ottimo freudiano sapeva che guarigione e prezzo sono direttamente proporzionali. I contributi raccolti, tra cui si elencano quelli di Jean-Luca Nancy e Elvio Fachinelli, aiutano a capire la complessa osmosi tra il discorso analitico e quello economico disponendo il dibattito attorno a due assi, l’uno simbolico e l’altro reale. Per la psicoanalisi – come Giancarlo Ricci giustamente sottolinea – il debito è simbolico. L’essere umano riceve dall’Altro una sorta di investimento iniziale di natura linguistica – un po’ come le imprese che ottengono un prestito per prendere avvio. Diversamente dalle aziende, per il soggetto sarà però impossibile sottrarsi: dal momento in cui entra nel linguaggio, dovrà fare i conti con qualcosa che gli è stato donato senza averlo richiesto. Anche disfarsene pare difficile. La catena di significanti in cui siamo catturati, se da un lato permette a ognuno di inserirsi nell’ordine dello scambio simbolico, cioè parlare, dall’altro può risultare un intralcio faticoso quando diventa una ripetizione arida, un equivalente dell’istinto senza essere animali. Come i giocatori d’azzardo patologici trattati da Nicolò Terminio, obbligati a scommettere aspettando che i soldi finiscano e venga così arginato il loro automatismo. Ci chiediamo: chi alza il braccio per muovere la leva della slot machine? È abbastanza chiaro quanto sia difficile essere liberi? Sebbene suoni sufficientemente reazionaria da non essere presa in considerazione, Goethe aveva suggerito una strategia per emanciparsi: riconquistare ciò che è stato ereditato. In tal modo si spera di possedere davvero il lascito senza esserne posseduti.
L’accattivante titolo Re Mida a Wall Street. Debito desiderio e distruzione tra psicoanalisi, economia, filosofia (Mimesis, 2015) costituisce una sorta di compendio lacaniano al tema del debito. Tenendo conto dell’enorme offerta di studi critici in circolazione, il tentativo del numero 5 di LETTERa, curato da Federico Leoni, è decisamente apprezzabile perché propone un’angolatura differente rispetto a quella dominante, prettamente economico-matematica. In che modo tratta il debito un analista? Come il Maestro? Élisabeth Roudinesco (1997, pp. 389, 397-398) racconta che Lacan aveva un debole per i soldi: gli analizzanti insolventi venivano inseguiti da una voce mielosa per ottenere il compenso pattuito. Il costo delle sedute era d’altronde carissimo: da ottimo freudiano sapeva che guarigione e prezzo sono direttamente proporzionali. I contributi raccolti, tra cui si elencano quelli di Jean-Luca Nancy e Elvio Fachinelli, aiutano a capire la complessa osmosi tra il discorso analitico e quello economico disponendo il dibattito attorno a due assi, l’uno simbolico e l’altro reale. Per la psicoanalisi – come Giancarlo Ricci giustamente sottolinea – il debito è simbolico. L’essere umano riceve dall’Altro una sorta di investimento iniziale di natura linguistica – un po’ come le imprese che ottengono un prestito per prendere avvio. Diversamente dalle aziende, per il soggetto sarà però impossibile sottrarsi: dal momento in cui entra nel linguaggio, dovrà fare i conti con qualcosa che gli è stato donato senza averlo richiesto. Anche disfarsene pare difficile. La catena di significanti in cui siamo catturati, se da un lato permette a ognuno di inserirsi nell’ordine dello scambio simbolico, cioè parlare, dall’altro può risultare un intralcio faticoso quando diventa una ripetizione arida, un equivalente dell’istinto senza essere animali. Come i giocatori d’azzardo patologici trattati da Nicolò Terminio, obbligati a scommettere aspettando che i soldi finiscano e venga così arginato il loro automatismo. Ci chiediamo: chi alza il braccio per muovere la leva della slot machine? È abbastanza chiaro quanto sia difficile essere liberi? Sebbene suoni sufficientemente reazionaria da non essere presa in considerazione, Goethe aveva suggerito una strategia per emanciparsi: riconquistare ciò che è stato ereditato. In tal modo si spera di possedere davvero il lascito senza esserne posseduti.A ciò si deve aggiungere il lato reale della pulsione – la dimensione decisiva dell’analisi su cui si valuta la riuscita di una cura. Freud aveva intuito che l’uomo è refrattario alla salvezza, non vuole saperne di guarire, perché comporta l’abbandono del proprio godimento.
 L’aspetto assurdo è che l’uomo gode di oggetti ritenuti totalmente inutili, inessenziali, dal senso comune. È noto il parallelismo tra feci e denaro, lo è meno che l’escremento sia un oggetto causa del desiderio, un “plusgodere”. Elvio Fachinelli parla dell’oro come del «primo cocente amore del giovane capitalismo» (p. 16), e siamo dunque stupiti nel pensare che qualche banchiere sperduto a Wall Street strabuzzi gli occhi nel vedere una “montagna di merda”. La materia a cui si dà meno importanza risulta invece determinante. C’è una cosa curiosa, se si legge il contributo di Massimo Amato. Questi spiega che i soldi non valgono nulla, la moneta è fatta solo per sparire nella circolazione – allo stesso modo delle feci. Eppure, perché mai tanta gente si ostina ad accumulare il nulla? Come l’avaro di Molière che stipava tutto nel giardino e sovente andava ad assicurarsi che non mancasse niente, così molte persone controllano più volte al giorno con lo stesso tic osceno, per esempio, che il fondo obbligazione continui a rendere. Keynes aveva azzeccato la questione: occorre creare una moneta che in sé non si trattenga, perché se si lasciano le cose al loro corso, l’uomo si mostrerà stitico.
L’aspetto assurdo è che l’uomo gode di oggetti ritenuti totalmente inutili, inessenziali, dal senso comune. È noto il parallelismo tra feci e denaro, lo è meno che l’escremento sia un oggetto causa del desiderio, un “plusgodere”. Elvio Fachinelli parla dell’oro come del «primo cocente amore del giovane capitalismo» (p. 16), e siamo dunque stupiti nel pensare che qualche banchiere sperduto a Wall Street strabuzzi gli occhi nel vedere una “montagna di merda”. La materia a cui si dà meno importanza risulta invece determinante. C’è una cosa curiosa, se si legge il contributo di Massimo Amato. Questi spiega che i soldi non valgono nulla, la moneta è fatta solo per sparire nella circolazione – allo stesso modo delle feci. Eppure, perché mai tanta gente si ostina ad accumulare il nulla? Come l’avaro di Molière che stipava tutto nel giardino e sovente andava ad assicurarsi che non mancasse niente, così molte persone controllano più volte al giorno con lo stesso tic osceno, per esempio, che il fondo obbligazione continui a rendere. Keynes aveva azzeccato la questione: occorre creare una moneta che in sé non si trattenga, perché se si lasciano le cose al loro corso, l’uomo si mostrerà stitico.Un punto di sintesi teorica, tra quello che abbiamo chiamato il lato simbolico e quello reale, è il “discorso del capitalista”, proposto da Lacan nel 1972. Introdotti qualche anno prima, i “quattro discorsi” sono infatti dei dispositivi concettuali in grado di connettere sociale e individuale, linguaggio e godimento. Utili agli analisti per inquadrare la struttura dell’analizzante, a noi interessano per un diverso motivo. Nel suo intervento, Federico Chicchi nota come la soggettività più diffusa non si senta in colpa perché in debito, ma nel caso sia incapace ad accedere a nuovo credito. Insomma, una volta ci sanzionavamo perché ogni volta il godimento era troppo, ora ci accusiamo di non godere mai abbastanza. Tale ribaltamento è dovuto al fatto che nel discorso del capitalista si instaura un rapporto privilegiato con l’oggetto del godimento; si assiste quindi all’“industrializzazione del desiderio” (Lacan, 1978, p. 229). Visto che è nella natura degli oggetti essere sostituibili (dato il carattere metonimico del desiderio), comprendiamo anche perché l’individuo capitalistico non si accontenti mai e percepisca ogni limite come un’insopportabile privazione.

Andrea Mura si sofferma diffusamente su questi e altri aspetti, ma non accenna alla centralità della stupidità come fattore centrale dell’uscita dal discorso del capitalista. La coppia furbizia/stupidità ricorre spesso negli scritti degli anni ’70 di Lacan. Per esempio, nel testo del 1973 Excursus afferma: «per rendere veramente bene come analisti, si dovrebbe, al limite, riuscire a ridurre se stessi più stupidi che di natura» (ibidem). Nel seminario Les non-dupes errent, dell’anno seguente, si sosterrà che convenga essere il più allocchi possibile per non errare: se il capitalismo è astuto, ha successo e funziona, chissà cosa accadrà a contatto con la stupidità.
di Filippo Aguzzi
Bibliografia
Lacan J. (1978). Excursus, in Id. Lacan in Italia (1953-1978), trad. it. di L. Boni. Milano: La Salamandra.
Roudinesco É. (1997). Jacques Lacan. Outline of a life, history of a system of thought. New York: Columbia University Press.
-
 Presentarsi come discepolo di un autore significa rispettare ricorrenze e alle volte pronunciare elogi funebri. Un elogio funebre, soprattutto se pronunciato a distanza di cento anni dalla morte dell’elogiato, non è semplicemente l’occasione per ricordare al pubblico interessato i passaggi salienti di una vita ormai trascorsa, ma la possibilità di un’apertura verso la reinterpretazione totale di un evento mai tramontato. Sembra essere questa l’intenzione di Peter Sloterdijk, filosofo tedesco autore di saggi come Critica della ragion cinica (1983), Sfere (1998-2004) e Devi cambiare la tua vita (2009), nel pronunciare il suo discorso a Weimar nel 2000 per il centenario della morte di Friedrich Nietzsche, oggi raccolto in volume da Mimesis con il titolo Il quinto «Vangelo» di Nietzsche. Sulla correzione delle buone notizie (2015). Con spirito simile a quello di Francesco d’Assisi nel suo Testamentum, Sloterdijk ci dice sin dall’inizio della sua prolusione: «Cercate di comprendere con semplicità e senza glosse i testi nietzscheani. Nietzsche è presentato come una «catastrofe nella storia del linguaggio» (p. 19), come colui che richiamandosi alla reale origine del linguaggio, emendandolo dalle falsificazioni metafisiche proprie del ressentiment, lo restituisce alla dimensione genuinamente eulogistica, libera dalla proprie inibizioni. Essere “quinto” evangelista significa tutto questo: liberare le forze linguistiche propriamente creative per percorrere una via d’ascesa radicalmente diversa sia rispetto al cristianesimo primitivo sia rispetto ai “nuovi evangelisti” come Lutero. A risuonare nelle parole di Sloterdijk sembra essere una delle più potenti affermazioni di Nietzsche: «In fondo è esistito un solo cristiano e questi morì sulla croce. Il “Vangelo” morì sulla croce» (1977, p. 50). Per questo sembra giunto il tempo per un nuovo “vangelo”, in grado di trasfigurare tutti i valori consegnatici dalla tradizione e capace di fuoriuscire da quel circolo vizioso della negazione come liberazione dalla realtà, generando al suo posto un’affermazione propriamente produttiva, «una nuova regola di vita, non una nuova fede» (ivi, p. 44).
Presentarsi come discepolo di un autore significa rispettare ricorrenze e alle volte pronunciare elogi funebri. Un elogio funebre, soprattutto se pronunciato a distanza di cento anni dalla morte dell’elogiato, non è semplicemente l’occasione per ricordare al pubblico interessato i passaggi salienti di una vita ormai trascorsa, ma la possibilità di un’apertura verso la reinterpretazione totale di un evento mai tramontato. Sembra essere questa l’intenzione di Peter Sloterdijk, filosofo tedesco autore di saggi come Critica della ragion cinica (1983), Sfere (1998-2004) e Devi cambiare la tua vita (2009), nel pronunciare il suo discorso a Weimar nel 2000 per il centenario della morte di Friedrich Nietzsche, oggi raccolto in volume da Mimesis con il titolo Il quinto «Vangelo» di Nietzsche. Sulla correzione delle buone notizie (2015). Con spirito simile a quello di Francesco d’Assisi nel suo Testamentum, Sloterdijk ci dice sin dall’inizio della sua prolusione: «Cercate di comprendere con semplicità e senza glosse i testi nietzscheani. Nietzsche è presentato come una «catastrofe nella storia del linguaggio» (p. 19), come colui che richiamandosi alla reale origine del linguaggio, emendandolo dalle falsificazioni metafisiche proprie del ressentiment, lo restituisce alla dimensione genuinamente eulogistica, libera dalla proprie inibizioni. Essere “quinto” evangelista significa tutto questo: liberare le forze linguistiche propriamente creative per percorrere una via d’ascesa radicalmente diversa sia rispetto al cristianesimo primitivo sia rispetto ai “nuovi evangelisti” come Lutero. A risuonare nelle parole di Sloterdijk sembra essere una delle più potenti affermazioni di Nietzsche: «In fondo è esistito un solo cristiano e questi morì sulla croce. Il “Vangelo” morì sulla croce» (1977, p. 50). Per questo sembra giunto il tempo per un nuovo “vangelo”, in grado di trasfigurare tutti i valori consegnatici dalla tradizione e capace di fuoriuscire da quel circolo vizioso della negazione come liberazione dalla realtà, generando al suo posto un’affermazione propriamente produttiva, «una nuova regola di vita, non una nuova fede» (ivi, p. 44).La difficoltà maggiore nella ricezione del nuovo messaggio sembra essere la spesa enorme che esso richiede in termini di energie, la sua forma propriamente anacoretica, la quale impone una rinuncia radicale a ogni struttura tradizionale, più che concentrarsi sulle classiche discipline della astinenza sia sessuale sia dal cibo. Un tale discorso viene letto da Sloterdijk come un’esplosione aperta e forsennata delle strutture immunitarie del sistema della morale. Il soggetto trasfigurato disporrà così della potenza del Übermensch come fosse un vaccino creatore in grado di scongiurare la disillusione derivante da uno sguardo diretto sulla realtà. La spaccatura interna all’ordine della morale è data dalle forze auto-celebrative che si dispiegano in quanto riconoscono nel Sé qualcosa che merita di essere celebrato e non si accontentano di una mera affermazione d’esistenza. Viene così a concretizzarsi quell’“egocentrismo” – tanto caro a Sloterdijk in altri suoi saggi, spesso denigrato perché mal compreso – in cui si concentrano le migliori possibilità vitali per l’umanità. L’egocentrismo viene a costituire il nucleo di un esercizio di reiterazione in cui si realizzano le possibilità del proprio divenire quel che si è. Esso è anche il contenuto donato a partire dalla novella di Zarathustra.

L’arte dell’eulogia praticata da Nietzsche è presentata come compromissione a un alto livello nella forma del dono impossibile. Un dono che non prevede scambio è la dimensione propria del tempo della generosità come figura divergente rispetto all’economia del debito. In particolare, a essere donata sarà una forma di nobiltà dello spirito senza precursori né nella figura di Gesù né in quella di Buddha, entrambe troppo legate a un ideale di soppressione dell’azione, nonostante fossero inserite in una dimensione di realismo radicale. La struttura linguistica del dono eccessivo è la spudoratezza come alternativa al risparmio e alla moderazione. In questa maniera, se il buono è moderato, il generoso è spudorato e la spudoratezza viene a configurarsi come reazione immunitaria di un’umanità che supera se stessa in un’eulogia acrobatica. Il negativo, il bisogno di sminuire l’altro come tema centrale del ressentiment, è superato da uno straripamento del Sé nell’auto-elogio. Straripare significa propriamente fuoriuscire dall’Ego per lodare l’estraneo come ciò che rende possibile il funzionamento del meccanismo di soggettivazione. In questo senso ci si riferisce a Nietzsche come a un “etero-narcisista” o a un “corpo di risonanza”, e così al suo vangelo.
Se esiste un punto di originalità nell’interpretazione che Sloterdijk dà della novella di Nietzsche possiamo ritrovarlo nell’abbandono della centralità affidata alla nozione di volontà di potenza a favore di una pluralità di nozioni o, per meglio dire, a una composizione di forze strutturate, intrecciate e sovrabbondanti. L’elogio funebre è così occasione per strappare l’effettività di un gesto a una vulgata deformante e aprire la strada a una nuova forma d’interpretazione lontana da quella tradizionale, per inaugurare una nuova catena in grado di donare la novella e per sostituire alla fede in Zarathustra una nuova regola di vita.
BIBLIOGRAFIA
Nietzsche F. (1977). L’anticristo. Maledizione del cristianesimo. Milano: Adelphi
di Alessandro Calefati
-
Ancora troppo umani. Il postumano di Giovanni Leghissa
Recensioni / Ottobre 2015 Nel suo saggio Postumani per scelta. Verso un’ecosofia dei collettivi, ospite della collana “Spiritualità senza Dio?” diretta da Luigi Berzano, Giovanni Leghissa dà unitarietà a un tema che ormai lo vede occupato da alcuni anni (La fondazione, la fondazione dell’umano, il post-umano, 2013; Il postumano: un nuovo paradigma?, 2013; curatela di aut aut, La condizione postumana, 2014). Nonostante la brevità del saggio, l’autore si propone di soddisfare la duplice esigenza teorica di inquadrare da più vicino lo sfuggente dibattito sulla questione postumana e, insieme, di estrarne una possibile interpretazione critica. Così, alla messa in ordine di linee guida di una discussione spesso frammentaria, si affianca l’argomentazione di una tesi, frutto dell’incontro di assi di ricerca eterogenei ma convergenti. Le fonti e le questioni interpellate sono infatti numerose e provenienti dalle più disparate aree del sapere filosofico. Tra i “maestri” e le tradizioni di pensiero che vediamo avvicendarsi figurano l’illuminismo, l’evoluzionismo, la filosofia francese del dopoguerra, l’epistemologia, la fenomenologia husserliana, l’idea di un sapere enciclopedico alla Enzo Paci, la decostruzione e l’antropologia filosofica di Hans Blumenberg. Come dichiara l’autore, si tratterà allora di seguire questi molteplici stimoli nell’intento di definire la condizione postumana in termini filosofici, individuando e descrivendo schematicamente gli atteggiamenti caratteristici del suo approccio.
Nel suo saggio Postumani per scelta. Verso un’ecosofia dei collettivi, ospite della collana “Spiritualità senza Dio?” diretta da Luigi Berzano, Giovanni Leghissa dà unitarietà a un tema che ormai lo vede occupato da alcuni anni (La fondazione, la fondazione dell’umano, il post-umano, 2013; Il postumano: un nuovo paradigma?, 2013; curatela di aut aut, La condizione postumana, 2014). Nonostante la brevità del saggio, l’autore si propone di soddisfare la duplice esigenza teorica di inquadrare da più vicino lo sfuggente dibattito sulla questione postumana e, insieme, di estrarne una possibile interpretazione critica. Così, alla messa in ordine di linee guida di una discussione spesso frammentaria, si affianca l’argomentazione di una tesi, frutto dell’incontro di assi di ricerca eterogenei ma convergenti. Le fonti e le questioni interpellate sono infatti numerose e provenienti dalle più disparate aree del sapere filosofico. Tra i “maestri” e le tradizioni di pensiero che vediamo avvicendarsi figurano l’illuminismo, l’evoluzionismo, la filosofia francese del dopoguerra, l’epistemologia, la fenomenologia husserliana, l’idea di un sapere enciclopedico alla Enzo Paci, la decostruzione e l’antropologia filosofica di Hans Blumenberg. Come dichiara l’autore, si tratterà allora di seguire questi molteplici stimoli nell’intento di definire la condizione postumana in termini filosofici, individuando e descrivendo schematicamente gli atteggiamenti caratteristici del suo approccio.