-
-
I mostri di Donna Haraway
Recensioni / Gennaio 2020 Donna Haraway continua a popolare di mostri il mercato editoriale italiano. Dopo la nuova edizione Feltrinelli del Manifesto Cyborg e la recente traduzione di Cthulucene per NERO Editions, DeriveApprodi ha tradotto e pubblicato Le promesse dei mostri. Il testo originale del 1992, apparso sulla rivista Cultural Studies, è accompagnato da un’introduzione di Angela Balzano, la curatrice e traduttrice del volume, e da una postfazione di Antonia Anna Ferrante. In che modo un testo del 1992 può continuare a interpellare il nostro presente? Anzitutto, il testo contribuisce a una generale riconfigurazione nel campo delle scienze umane e sociali: entrano con lentezza nel dibattito alcuni snodi concettuali cruciali nel nascente ambito disciplinare delle environmental humanities; basti pensare a Essere di questa terra, una recente curatela di articoli di Bruno Latour, le cui tesi sono ampiamente discusse in Le promesse dei mostri. Spostandoci dall’editoria italiana al dibattito internazionale, è evidente che l’elaborazione di nuovi paradigmi ecologici stia dando un impulso rilevante alle ricerche sul concetto di natura nelle scienze umane e sociali, che si dimostrano capaci di siglare alleanze transdisciplinari feconde con le scienze dure. Questo rinnovato interesse per la natura reagisce insieme a dei mutamenti epistemologici - ecocriticismo, studi su scienza e tecnologia, epistemologia femminista, nuovo materialismo, etnografia multispecie, studi biopolitici su razza e genere - e a tempi di catastrofi quotidiane, che colpiscono comunità e territori a velocità variabili. È in questo paesaggio teoretico che va collocato questo testo della Haraway.
Donna Haraway continua a popolare di mostri il mercato editoriale italiano. Dopo la nuova edizione Feltrinelli del Manifesto Cyborg e la recente traduzione di Cthulucene per NERO Editions, DeriveApprodi ha tradotto e pubblicato Le promesse dei mostri. Il testo originale del 1992, apparso sulla rivista Cultural Studies, è accompagnato da un’introduzione di Angela Balzano, la curatrice e traduttrice del volume, e da una postfazione di Antonia Anna Ferrante. In che modo un testo del 1992 può continuare a interpellare il nostro presente? Anzitutto, il testo contribuisce a una generale riconfigurazione nel campo delle scienze umane e sociali: entrano con lentezza nel dibattito alcuni snodi concettuali cruciali nel nascente ambito disciplinare delle environmental humanities; basti pensare a Essere di questa terra, una recente curatela di articoli di Bruno Latour, le cui tesi sono ampiamente discusse in Le promesse dei mostri. Spostandoci dall’editoria italiana al dibattito internazionale, è evidente che l’elaborazione di nuovi paradigmi ecologici stia dando un impulso rilevante alle ricerche sul concetto di natura nelle scienze umane e sociali, che si dimostrano capaci di siglare alleanze transdisciplinari feconde con le scienze dure. Questo rinnovato interesse per la natura reagisce insieme a dei mutamenti epistemologici - ecocriticismo, studi su scienza e tecnologia, epistemologia femminista, nuovo materialismo, etnografia multispecie, studi biopolitici su razza e genere - e a tempi di catastrofi quotidiane, che colpiscono comunità e territori a velocità variabili. È in questo paesaggio teoretico che va collocato questo testo della Haraway.Le promesse dei mostri abbozza una mappa geografica e mentale di conflitti locali e globali relativi alla natura, cercando di «rendere più ibridi i Science and Technologies Studies, contaminandoli con i Cultural, i Gender e i Postcolonial Studies» (p. 24). Questo tentativo di contaminazione si nutre della convinzione che sia necessario scandagliare i contesti culturali e sociali di sviluppo delle scienze, e le relazioni di potere alle quali saperi e pratiche scientifiche hanno partecipato: in altre parole, si tratta di porre in evidenza la politicità di qualsiasi epistemologia. Cultura, genere, razza e colonialità offrono quindi la possibilità di interrogare le scienze come prodotti sociali che emergono dalla storia della modernità, con il suo portato criminale e traumatico, ma anche con le sue possibilità di ricomposizione. Questa cartografia viene suddivisa in quattro quadranti che insieme compongono un “Quadrato Cyborg”, ispirato al quadrato semiotico di Greimas: A. Spazio Reale: Terra; B: L’Altro Spazio o l’Extraterrestre; Non-B: Lo spazio interno: il corpo biomedico; e infine Non-A: Lo Spazio Virtuale: Fantascienza.
Questo schema può fornire ancora oggi alcuni riferimenti chiave nel modo in cui le scienze umane e sociali possono parlare di natura secondo almeno tre prospettive: una ontologica, una epistemologica e una politica. Tuttavia, questi tre sguardi non possono essere separati: la Haraway li snoda e annoda costantemente esplorandone le geometrie di rapporto, proprio come nel gioco del ripiglino, una delle figure-guida Cthulucene. Il nome con cui la Haraway chiama il proprio approccio, cioè l’artefattualismo dinamico, ci fornisce alcune note essenziali rispetto a questo groviglio di traiettorie. Secondo l’artefattualismo dinamico, sia le posizioni realiste sia le tesi postmoderne sul mondo naturale dicono qualcosa di vero ma parziale: la natura non sarebbe solo un insieme di dati bruti e di oggetti che risiedono “fuori da noi”, ma neppure un mero avvicendarsi di labirinti di segni senza via d’uscita verso la realtà, di trompe l’oeil semiotici nei quali gli enti sono simbolicamente sublimati senza rimedio. La Haraway è certamente disposta a sostenere sia che gli agenti naturali resistano e non si riducano alle sole pratiche di rappresentazione umane, sia che la natura sia costruita. Occorre però domandarsi chi costruisca la natura, quell’oggetto concettuale impossibile, femminile, coloniale, passivo che tuttavia, secondo la Haraway, non possiamo non desiderare. È nella nozione di sympoiesi che gli sguardi si possono annodare: se il limite del realismo moderno – nel senso in cui Bruno Latour intende la modernità – è di scommettere eccessivamente sulla capacità scopica di un osservatore disincarnato, di un occhio assoluto capace di elevarsi al di sopra del mondo, e se il postmoderno radicalizza questo atteggiamento scomponendo l’oggetto scientifico in una infinita mise en abyme di rimandi sui quali lo sguardo non può mai soggiornare stabilmente, allora l’artefattualismo dinamico tempera entrambe le posizioni, sostenendo che la natura è co-costruita: gli enti naturali e gli oggetti scientifici sono fatti e costruiti discorsivamente da un groviglio di attori umani e non-umani, che collaborano alla costruzione della natura come luogo comune. In altre parole, attrici e attori non si esauriscono in "noi" (p. 46).

Una simile prospettiva sulla natura richiede dunque un nuovo modo di concepire le scienze. In La nuova alleanza, Ilya Prigogine e Isabelle Stengers sostenevano che la scienza fosse un dialogo sperimentale fra l’uomo e la natura, e non – come Koyrè – il monologo che gli umani recitano usando la natura come palcoscenico. Per la Haraway entrambe le metafore sono insufficienti. Oltre il monologo e il dialogo, Le promesse dei mostri propone una scienza materialmente compromessa con il mondo che studia, appassionata partecipante a un chiassoso consesso di agenti umani e non-umani. Ogni scienziato ha dunque a che fare con dei collettivi ibridi, che solo una complessa operazione di purificazione consente di stabilizzare come modelli e dati. Queste considerazioni sono debitrici della lezione di Bruno Latour: citandolo in La vita delle piante Emanuele Coccia ci rammenta che le macchine usate da scienziate e scienziati sono “protesi cosmiche” della sua stessa sensibilità. Esse intensificano e amplificano la capacità di percepire consentendo la costruzione di nuovi modi di relazione con gli attori che popolano il mondo. Natura e Società sono dunque risultati storici del movimento degli attanti, schiume prodotte da onde di azione. Tuttavia, nella tesi di Latour, le coppie oppositive – natura-cultura, soggetto-oggetto, ambiente-tecnica – e i binarismi non scompaiono, ma sono presi in un pozzo gravitazionale che ne fa evaporare i tratti trascendentali. Non ci sono punti di osservazione assicurati una volta per tutte, ma attanti imprevisti e favolosi, nuove storie e relazioni effettuali che fanno e disfano mondi – dato che, come ci ricorda Katie King, le epistemologie sono storie che i saperi raccontano.
Sulle specifiche delle relazioni che gli scienziati intessono con i non-umani vanno però fatte delle importanti precisazioni, che pongono in attrito le tesi della Haraway e di Latour. Se Latour reputa che gli attanti che costellano le sue reti siano anzitutto frutto di un’operazione semiotica, e che dunque agiscano in quanto sono rappresentati, la Haraway invece sostiene che la natura non sia solo un network simbolico, per almeno due ragioni: in primo luogo, gli agenti non-umani non lo sono solo in senso semiotico ma anche in senso pienamente materiale e dinamico; in secondo luogo, Latour sembra voler parlamentarizzare e testualizzare quella che in fondo è un’assemblea disordinata senza principi di ordine netti e dati una volta per tutte: l’azione dei non-umani è invece “negativa”, imprevedibile, ferina, selvatica. Pone in questione obiettività, controllo, disposizioni, ordini e gerarchie. Queste critiche potrebbero essere compresse in un mutamento di lessico: se Latour insiste sulla rappresentazione, la Haraway preme sull’articolazione. Secondo la Haraway «la rappresentazione si fonda sul possesso di una risorsa passiva, l’oggetto silenzioso, l’attante ridotto all’osso» (p. 91): guardare le scienze considerando solo la prospettiva rappresentativa significa esporsi al rischio di confondere nomi e cose, di ripetere l’antropocentrismo adamitico della nominazione originaria, per cui l’ambiente acquisterebbe senso solo al tocco dell’uomo. Inoltre, per lo sguardo che rappresenta la distanza dall’oggetto rappresentato è una virtù: l’altro non è mai ingaggiato nella sua presenza viva, ma è tutelato infinitamente, testualizzato, trattato come un «docile elettore» (p. 91) di cui sono sufficienti le tracce registrate da chi lo guarda. Le relazioni in questo caso sono asettiche, si danno solo sotto la vigenza di una separazione sterile. L’articolazione invece scommette sulla capacità generativa ed energetica degli attori, sui loro movimenti: gli agenti sono tali in quanto scaturigini di azioni, senso e perché formano collettivi. Inoltre, una volta posta la natura semiotica degli attori fra altre caratteristiche, viene a cadere anche la messa in sicurezza della rappresentazione. Ogni articolazione è quindi al contrario sempre precaria, fallibile, e pertanto richiede attaccamenti forti, cura, manutenzione e coinvolgimenti appassionati. In conclusione, una scienza mostruosa non può porsi come osservatrice trascendentale disincarnata al di sopra della mischia, ma come fonte di responsabilità concreta nei confronti del mondo con il quale scienziate e scienziati hanno a che fare.

Lynn M. Randolph e Donna J. Haraway
CyborgNon c’è quindi più spazio né per la modernità né per la post-modernità: i cyborg e i mostri della Haraway sono figure amoderne, che stanno nel mondo in senso critico ma senza oltrepassarlo verso un esterno che le metta al riparo: di qui, il grande interesse della Haraway per alcune lotte chiamate in causa in Le promesse dei mostri. Nel testo si può richiamare in particolare l’esempio dei Kayapo (p. 94), un gruppo indigeno brasiliano. Messi in pericolo da deforestazione e attività minerarie, i Kayapo fecero un uso massiccio dei mass-media per salvaguardare le proprie terre e per guadagnare potere politico, richiamando l’attenzione della comunità internazionale. L’immagine di Paulinho Paiakan di fronte alle telecamere potrebbe far leggere in senso paradossale la scena, come un cozzo fra un registro estetico “primitivo” – i vestiti tradizionali Kayapo, il richiamo alla tutela di un modo di vivere “autentico” legato indissolubilmente alla foresta pluviale – oppure, secondo la proposta della Haraway, come l’effetto di una nuova articolazione: il collettivo in cui i Kayapo si sono mossi ha avuto l’effetto di una nuova produzione di mondo, fatta di indigeni, scienziati, videocamere, foreste, animali, pubblici vicini e lontani. Si potrebbe leggere questo esempio insieme ad altri testi recenti che approfondiscono le cosmopolitiche amazzoniche, come La caduta del cielo di Davi Kopenawa e Bruce Albert; Esiste un mondo a venire? di Eduardo Viveiros de Castro e Deborah Danowski; o Earth Beings di Marisol de la Cadena.
Sembra ovvio che un testo che si muove di figura in figura si concluda con un’immagine: Cyborg, il dipinto realizzato da Lynn Randolph in collaborazione con la Haraway. Una donna indigena è circondata da un paesaggio cosmico, accompagnata da uno spirito animale, con le dita poggiate alla tastiera di un computer. Questa figura chiude il libro materializzando l’implosione dei registri tecnici, testuali, organici, mitici e politici «nel pozzo gravitazionale della scienza in azione» (p. 57) di cui la Haraway non cessa di parlare. Cyborg e mostri dunque promettono alle scienze umane e sociali nuovo alimento, richiedendo però in cambio lo sviluppo di nuove arti dell’attenzione, laddove la cura per gli oggetti di studio diventa un atto politico verso i collettivi in cui si è coinvolti. I mostri della Haraway ci esortano: ibridate i saperi, riannodate il nesso fra scienza e società, tenete i binarismi sotto costante minaccia. In uno slogan, “cyborgs for earthly survival!”.
di Dario Bassani
-
Manifesto Cyborg. Ieri e oggi
Recensioni / Dicembre 2018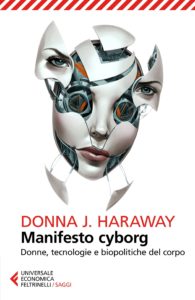 La nuova edizione di Manifesto cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo (Feltrinelli, 2018) raccoglie tre saggi di Donna Haraway, teorica femminista e storica della scienza allieva di Georges Canguilhem. I saggi in questione sono stati pubblicati la prima volta nel 1991, in Italia nel 1994, all’interno di una raccolta dal titolo Simians, Cyborgs and Women. The Reinvention of Nature (Routledge). L’importanza della riedizione di un testo considerato ormai un classico può ricercarsi nella necessità di rivalutare la portata teorica e filosofica della riflessione di Haraway, portata che fino ad ora sembra essere stata scarsamente considerata. Ciò che andrebbe messo in discussione è un inquadramento “specialistico” del testo, che lo vorrebbe di interesse unicamente per chi si occupa di “questioni legate al genere” e, ancora più nello specifico, per chi nella cornice degli studi di genere riflette sui problemi della scienza e della tecnologia. Nella rivalutazione delle implicazioni teoretiche di Manifesto Cyborg è in gioco, più in generale, la riconsiderazione dell’importanza filosofica dei cosiddetti studi di genere e postcoloniali, che normalmente trovano legittimazione solo se inseriti nella cornice dei cultural studies. Il testo di Haraway eccede queste cornici disciplinari, e con le sue incursioni “spregiudicate” nel terreno delle scienze biologiche, biomediche e delle teorie dei sistemi, può essere considerato un’argomentazione a favore della contaminazione come importante strumento di produzione e creatività teorica.
La nuova edizione di Manifesto cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo (Feltrinelli, 2018) raccoglie tre saggi di Donna Haraway, teorica femminista e storica della scienza allieva di Georges Canguilhem. I saggi in questione sono stati pubblicati la prima volta nel 1991, in Italia nel 1994, all’interno di una raccolta dal titolo Simians, Cyborgs and Women. The Reinvention of Nature (Routledge). L’importanza della riedizione di un testo considerato ormai un classico può ricercarsi nella necessità di rivalutare la portata teorica e filosofica della riflessione di Haraway, portata che fino ad ora sembra essere stata scarsamente considerata. Ciò che andrebbe messo in discussione è un inquadramento “specialistico” del testo, che lo vorrebbe di interesse unicamente per chi si occupa di “questioni legate al genere” e, ancora più nello specifico, per chi nella cornice degli studi di genere riflette sui problemi della scienza e della tecnologia. Nella rivalutazione delle implicazioni teoretiche di Manifesto Cyborg è in gioco, più in generale, la riconsiderazione dell’importanza filosofica dei cosiddetti studi di genere e postcoloniali, che normalmente trovano legittimazione solo se inseriti nella cornice dei cultural studies. Il testo di Haraway eccede queste cornici disciplinari, e con le sue incursioni “spregiudicate” nel terreno delle scienze biologiche, biomediche e delle teorie dei sistemi, può essere considerato un’argomentazione a favore della contaminazione come importante strumento di produzione e creatività teorica.Fin dalle prime pagine di Manifesto Cyborg è chiara l’urgenza teorica e politica che muove la riflessione dell’autrice: la necessità per il femminismo socialista e in generale per gli allora nuovi movimenti di sinistra di ripensarsi, alla luce del confronto con le profonde trasformazioni globali che segnavano il contesto dell’elezione di Reagan alla presidenza degli Stati Uniti negli anni ’80. Il cyborg, protagonista dell’opera, rappresentava provocatoriamente quella peculiare “creatura” contraddistinta da un’intrinseca necessità di evadere ogni forma di pensiero dicotomico, ogni forma di razionalità strutturata intorno a stringenti dualismi, in favore di un nuovo punto di vista in grado di rendere conto di una realtà infinitamente complessa ed eccedente che il suo stesso apparire metteva prepotentemente alla ribalta. A quasi trent’anni di distanza, in cui la modalità dominante di gestione della complessità (sociale, psichica, politica, scientifica) sembra ancora rimanere il riduzionismo, in cui lo scenario pare ancora caratterizzato dal riproporsi di un pensiero dicotomico e dall’intensificarsi delle logiche di dominazione patriarcale, razzista e capitalista connaturate a esso, provare a immaginare un modello di razionalità che non evade la complessità ma che se ne fa carico non si rivela meno urgente. La posta in gioco è l’elaborazione di modalità alternative e sfaccettate di gestione della complessità, rifiutando quindi anche quel pensiero che vedrebbe nella postmodernità il terreno in cui si consuma la crisi della razionalità dominante che non lascia spazio a null’altro se non alla contingenza e alla “differenza” irriducibile, intese come negazione dell’elaborazione teorica e della prassi. Manifesto Cyborg riapre invece con forza l’elaborazione teorica, etica e politica, al cuore della postmodernità e lo fa oggi non meno di ieri.
Lo sguardo attraverso cui Haraway analizza le trasformazioni che segnano il suo tempo è quello che deriva dalla sua storia in quanto biologa: in particolare, l’autrice mette in luce la profonda rielaborazione e ripensamento della biologia in relazione all’emergere di nuovi saperi, quali la cibernetica, le teorie dei sistemi, le scienze della comunicazione e dell’informazione.
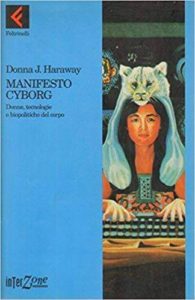 Il ripensamento della biologia in seguito alla contaminazione con nozioni, teorie e concetti provenienti da queste scienze è stato profondo al punto che, secondo Haraway, si può sostenere che l’“organismo” biologico, come oggetto della scienza, abbia cessato di esistere, e sia stato sostituito da sistemi di comunicazione completamente denaturalizzati. Gli organismi sono quindi diventati artefatti, sempre contingenti, le cui modalità di costruzione non sono vincolate da nessun’architettura naturale. Contemporaneamente, le macchine hanno preso vita: se quelle pre-cibernetiche potevano essere ancora distinte dagli organismi in quanto pensate e costruite dall’uomo, le macchine cibernetiche rendono completamente ambigua la distinzione tra autosviluppo e progettazione esterna (p.43).
Il ripensamento della biologia in seguito alla contaminazione con nozioni, teorie e concetti provenienti da queste scienze è stato profondo al punto che, secondo Haraway, si può sostenere che l’“organismo” biologico, come oggetto della scienza, abbia cessato di esistere, e sia stato sostituito da sistemi di comunicazione completamente denaturalizzati. Gli organismi sono quindi diventati artefatti, sempre contingenti, le cui modalità di costruzione non sono vincolate da nessun’architettura naturale. Contemporaneamente, le macchine hanno preso vita: se quelle pre-cibernetiche potevano essere ancora distinte dagli organismi in quanto pensate e costruite dall’uomo, le macchine cibernetiche rendono completamente ambigua la distinzione tra autosviluppo e progettazione esterna (p.43).Le ondate di denaturalizzazione e de-essenzializzazione che secondo N. Katherine Hayles definiscono il postmodernismo hanno quindi investito anche i corpi biologici: se le prime teorizzazioni degli organismi come sistemi cibernetici riposavano ancora su una concezione olistica e mantenevano intorno a questi un certo involucro, le teorie sociobiologiche di uno scienziato dalla sensibilità postmoderna come Richard Dawkins hanno radicalizzato questa tendenza, rompendo definitivamente con i paradigmi olistici e ripensando l’individualità biologica come costrutto contingente ad ogni livello. Come mettono in luce le escursioni di Haraway nel territorio delle moderne biologie della comunicazione, i processi di decostruzione e ricostruzione dei corpi occupano il centro del discorso, non solamente dal punto di vista del critico culturale o dell’archeologo delle scienze umane, ma anche dello scienziato postmoderno: le biologie moderne si occupano di tecnologie d’inscrizione e codici, di processi di disassemblaggio e riassemblaggio, di sistemi di controllo altamente tecnologizzati. La centralità delle tecnologie di scrittura emerge in modo evidente se si considerano i lauti investimenti direzionati a progetti come quello di mappatura e ricostruzione del genoma umano. Questo progetto emblematizza un “umanesimo postmoderno” in cui la ricerca biologica segnata dalla rilevanza sempre maggiore delle tecnologie d’inscrizione è messa al servizio della tradizionale ideologia umanista e del sogno ad essa associato di poter finalmente definire l’umano, di poter finalmente tracciare un confine netto e chiaro, privo di ambiguità e porosità tra il sé e il non-sé.
Il cyborg, segnalando importanti cedimenti di confine come quello tra macchina e organismo e tra umano e animale, si presenta come figurazione non dicotomica della nostra realtà sociale e corporea, che consente quindi di rompere con i dualismi che hanno strutturato la razionalità occidentale: naturale/artificiale, natura/cultura, uomo/donna, mente/corpo, materia/forma, umano/animale, soggetto/oggetto. Come ci ricorda Haraway, queste non sono mai solo opposizioni dicotomiche: attraverso questi dualismi, la razionalità occidentale ha intrecciato il suo destino a pratiche di dominio e di oppressione legate al genere, alla razza e alla specie.
D’altra parte, il cyborg in occidente è anche espressione di una cultura maschilista e guerrafondaia, che concepisce la vulnerabilità che contraddistingue la dimensione corporea come segno di una “mancanza” costitutiva, a cui far fronte attraverso un progressivo miglioramento delle strategie di difesa. Se le individualità cyborg sono per definizione contingenti e instabili, l’immagine della corsa agli armamenti e della guerra perenne lascia trasparire in filigrana il “telos apocalittico” (p. 41) di un sé finalmente libero da ogni forma di dipendenza. La realizzazione di un sé autonomo e integro, che ha “disassemblato” e digerito ogni forma di eterogeneità e alterità si accompagna al dispiegamento di un apparato di controllo diffuso e capillare, che Haraway indica come “informatica del dominio” (p. 55). Con questa figurazione si vogliono mappare i nuovi inquietanti meccanismi di controllo che attraversano il nostro tempo: alle gerarchie che contraddistinguono il “patriarcato capitalista bianco” (p. 57) si sostituisce un sistema polimorfo e reticolare, che agisce attraverso l’allacciamento di connessioni multiple. Ai vecchi sistemi di controllo centralizzato si sostituisce la delocalizzazione, la decentralizzazione, la diffusione e la moltiplicazione dei centri.

Ma il cyborg è anche un costrutto femminista, e in questo senso elicita possibilità oppositive e liberatorie. Cyborg è quel particolare oggetto di conoscenza e pratica femminista, l’esperienza delle donne, che proprio in quanto fatta oggetto di sapere, è ricostruita come aperta, non finita, contestata, vulnerabile, presa in un gioco di perenne decostruzione e riscrittura. Haraway a questo proposito da particolare importanza ai processi di decostruzione e di de-naturalizzazione che hanno interessato il femminismo in seguito al prendere voce di quelle soggettività, come le donne nere, che sfuggono al sistema di categorie attraverso cui i teorici e le teoriche occidentali hanno tentato di rappresentare il mondo degli oppressi. Questi processi hanno consentito al soggetto femminista di riarticolarsi lungo assi inediti, di immaginare e di praticare nuove forme di unità e di identità al di fuori dell’impianto dicotomico e oppositivo che ha strutturato i miti politici occidentali. La critica post-coloniale ha ricostruito le identità femministe come identità sempre parziali, contraddittorie e problematiche, definite dal non poter essere naturalizzate o essenzializzate. Haraway legge in questo senso la Sister outsider della poetessa nera Audre Lorde (p. 74), ovvero come ricostruzione letteraria dell’identità attraverso l’esclusione, la non appartenenza in quanto eccedenza rispetto a categorie prestabilite. Le identità ricostruite nelle pratiche di scrittura delle donne di colore sono identità sempre contraddittorie e frantumate, prive del privilegio dell’identità a sé, prerogativa dei corpi non marcati come quelli maschili e bianchi. Se i processi decostruttivi e de-essenzializzanti impediscono di radicare la politica nelle identità “naturali”, questo non significa che sia stata minata radicalmente la possibilità di legami: la loro ricostruzione implica politiche dell’affinità, che non ripristinano unità naturali, ma non per questo impediscono legami (parziali ma potenti) e comunità per soggetti postmoderni.
Con l’elaborazione della nozione di “saperi situati” Haraway si inserisce in un altro dibattito che attraversa il femminismo: il rapporto con l’epistemologia e la scienza e, strettamente connesso a questo, il dibattito circa lo statuto dell’oggetto di conoscenza. Proponendo “saperi situati” Haraway intende pensare una versione femminista di oggettività scientifica, che consenta di uscire dalla polarizzazione del dibattito attuale, caratterizzato dal contrapporsi di posizioni radicalmente costruzioniste ed empiriste. La rielaborazione della nozione di oggettività che Haraway propone si appoggia a un ripensamento della metafora della visione. Se quest’ultima ha significato, nella storia della razionalità occidentale, la capacità di alcuni corpi (quelli maschili, benestanti e occidentali) di “smaterializzarsi” in uno sguardo venuto dal nulla mentre si inscrivevano i corpi marcati nel mito, con la nozione di saperi situati assume un significato opposto. L’oggettività e la visione non significano più neutralità e distanza, ma corporeità, parzialità, localizzabilità, impegno e coinvolgimento. (p. 115) L’oggettività ha a che fare non con la scoperta distaccata, ma con la strutturazione reciproca e di solito ineguale; solo saperi parziali, vulnerabili e impegnati garantiscono una conoscenza oggettiva, ovvero che non sia un’illusione. Oggettività e visione non segnalano più un “trucco da dio”, che consente di scomparire arrogandosi il potere di rappresentare senza essere rappresentati, ma diventano modi per stare nel corpo, pratiche di assunzione corporea.

In How we became posthuman, Katherine Hayles sostiene che l’affermarsi di quell’entità chiamata informazione si sia accompagnata a processi di “smaterializzazione” dei corpi, di progressivo abbandono e trascendimento dei vincoli della materialità. L’approccio di Haraway ai mondi alto-tecnologici mostra una realtà più complessa: i corpi radicalmente decostruiti e ricostruiti dalle moderne biotecnologie e dalle scienze informatiche non comportano tanto la smaterializzazione di questi in puri flussi informativi, problemi di codifica e di ricerca di un linguaggio comune che permetta la perfetta comunicazione. Anche l’informazione per Haraway ha una specifica dimensione materiale, così come i testi e i codici, che dovrebbero venire ripensati attraverso la nozione di embodiment. Facendo riferimento alla dimensione corporea, Haraway non si riferisce quindi a una dimensione prettamente biologica: le tecnologie di visualizzazione sono ripensate come sistemi di percezione attivi, nelle quali siamo immersi e con le quali siamo inestricabilmente intrecciati nella costruzione di specifiche forme di vita: un aspetto del nostro embodiment.
Il ripensamento della nozione di corporeità consente ad Haraway di riprendere e al tempo stesso di andare oltre l’analisi biopolitica inaugurata da Michael Foucault, ovvero dell’analisi che fa del corpo l’entità bioculturale per eccellenza e che consente di indagare i rapporti di potere che si concentrano direttamente sul soggetto in quanto entità corporea. La decostruzione della corporeità come sistema di comunicazione tecnologico consente di indagare gli effetti del biopotere oltre la sfera organismica: oggetto delle relazioni di potere non è più un corpo organico e organizzato gerarchicamente, ma sistemi cibernetici completamente decostruiti, assemblaggi ricomposti in modo sempre parziale, costrutti contingenti. Le biopolitiche che interessano corpi ricostruiti come sistemi di comunicazione non sono quelle del sesso e della riproduzione, ma dell’immunità, legate ai processi di replicazione di un sé estremamente vulnerabile e contingente (p.159). Quali tipi di sé vengono costruiti dal discorso sul sistema immunitario? L’intento di Haraway è di risignificare il paradigma immunitario: da dispiegamento di una guerra diffusa e capillare, in cui la replicazione del sé è funzione delle sue strategie di difesa e di attacco di fronte a una minaccia costante di “invasione”, a sistema che “apre” il sé e lo mantiene aperto. In quanto dispiegamento di una rete capillare di blackout e crolli delle comunicazioni, di confusione di confini, il sistema immunitario continuamente “disfa” il sé, mantenendolo contraddittorio ed eterogeneo, impedendone la chiusura e l’autonomizzazione. In questa dimensione riposa la “promessa illegittima” (p. 42) del cyborg: la sua natura artefatta, saltando il gradino dell’unità originaria, impedisce la realizzazione del suo telos apocalittico. In quest’ottica, inoltre, la differenza irriducibile con cui obbligano a fare i conti la postmodernità e i processi a essa inestricabilmente connessi, come quelli di decolonizzazione, non segnala tanto la “morte del soggetto”, come vorrebbero alcuni, ma piuttosto ci costringe a ripensare il soggetto come non isomorfico, auto-contraddittorio e multidimensionale.
di Ambra Lulli

