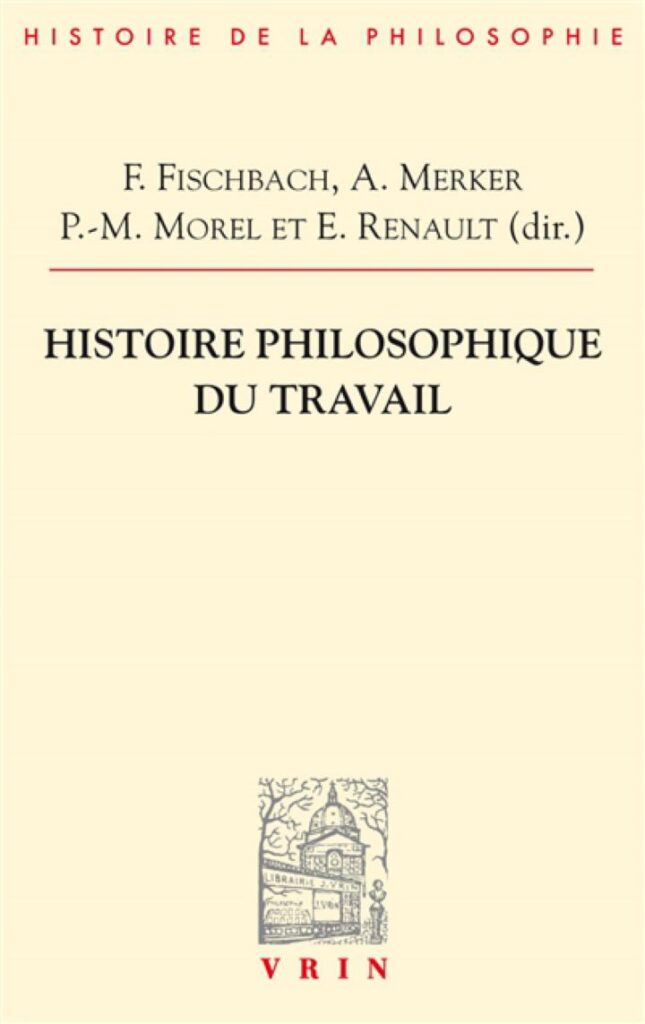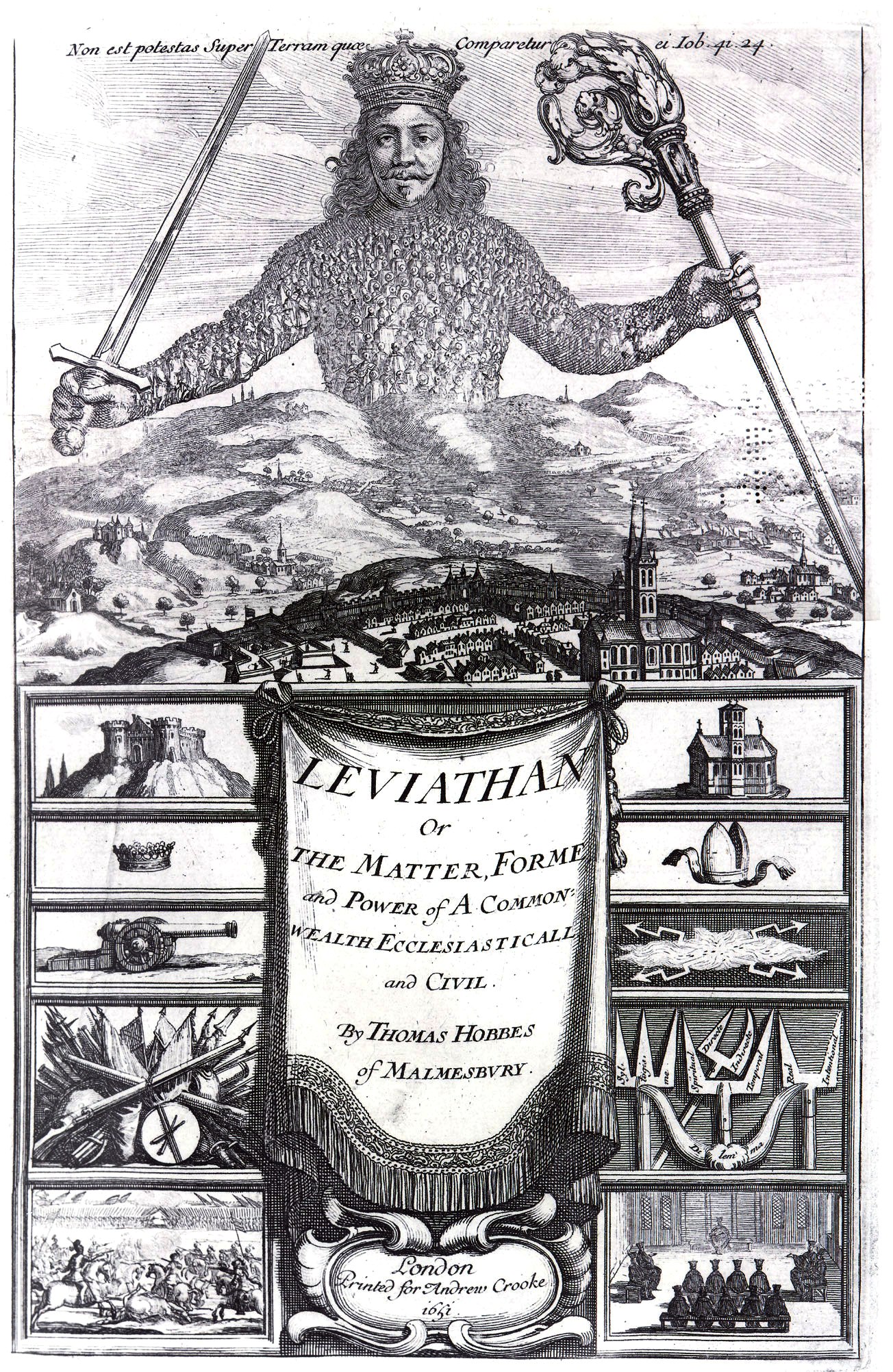«È ampiamente riconosciuto che per noi, membri delle società moderne, il lavoro conta molto […] Sapere per quali ragioni, è una domanda a cui rispondere è molto meno agevole». H-C., Schmidt Am Busch
-
-
La solidarietà in tempi difficili
Longform / Giugno 2022Che cos’è la solidarietà? Nel concetto si incontrano, come sappiamo, almeno due tradizioni distinte, quella rivoluzionaria della “fraternità” e quella cattolica della “carità”. L’una e l’altra alludono a un legame tra gli individui di tipo extracontrattuale, capace di fare in modo che l’attenzione disinteressata per il prossimo non risulti sacrificata a vantaggio della logica dello scambio. Appellarsi alla solidarietà significa ricordare che non è solo da considerazioni razionali rispetto allo scopo che è possibile dedurre le norme e le istituzioni in grado di offrire alle persone l’opportunità di condurre vite soddisfacenti e dignitose e di garantire al sistema democratico la possibilità di mantenere nel tempo condizioni accettabili di stabilità. Eppure, la solidarietà è divenuta una risorsa scarsa, che non si lascia rigenerare o ingrandire a piacimento. L’indebolimento progressivo delle pratiche simboliche che assicurano la solidarietà sociale, come i riti, il culto religioso, le cerimonie nazionali per un verso, e la tendenza crescente all’esercizio meramente legale e strategico dei diritti soggettivi per un altro, hanno contribuito a rendere questa risorsa, che indica la soglia minima della spontaneità sociale, un bene sempre più bisognoso di rigenerazione. In generale, si può in ogni caso affermare che tutte le concettualizzazioni della solidarietà hanno in comune qualcosa che ha a che fare con la volontà di promuovere e praticare a livello di socializzazione forme di relazione di tipo cooperativo, così da incentivare la coesione solidale dei cittadini al di là delle rispettive funzioni professionali o degli stereotipi di ruolo interiorizzati.
Per provare a chiarire meglio il concetto può essere utile distinguere tre aspetti principali. In primo luogo, la solidarietà si richiama alla necessità di fornire sostegno o assistenza alle persone in difficoltà con le quali vi è un rapporto di prossimità, di tipo solitamente affettivo o emotivo. In secondo luogo, chi avverte questa esigenza percepisce di avere qualcosa in comune con chi ne è beneficiario: valori, norme e costumi tacitamente condivisi, oppure il senso di essere parte di una comunità solidale nella quale ciascuno si fa carico dell’altro per affrontare assieme le sfide esistenziali di una vita sottoposta a una minaccia incombente. Infine, la solidarietà non è una forma di interazione da praticare occasionalmente ma è, piuttosto, un ingrediente costitutivo del tessuto sociale o politico, una componente intrinseca del vivere sociale. Per questo richiede un certo livello di reciprocità, per quanto indiretta: non a caso, il sentimento di solidarietà è più accentuato quando le persone che contribuiscono agli assetti solidaristici possono contare sul fatto che a tempo debito i loro sforzi verranno debitamente ricompensati. L’idea di Habermas, della solidarietà come terza fonte dell’integrazione della società accanto al denaro e al potere amministrativo, cerca di cogliere con uno sguardo d’insieme questa triplice articolazione del concetto, che dalle strutture di mutuo riconoscimento spontanee e concrete si trasferisce in forma astratta, ma vincolante, agli ambiti d’azione complessi e progressivamente anonimi delle società funzionalmente differenziate.
In prima battuta, tuttavia, è opportuno restare ancorati al piano della fattualità spontanea di forme di vita unite da vincoli di prossimità e cooperazione abituale, dove risulta possibile definire la solidarietà come una pratica spontanea e non-regolamentata che esprime la volontà di assistere o sostenere coloro con i quali vi è – o si ritiene che vi sia – una sorta di familiarità per un qualche aspetto ritenuto rilevante. L’aspetto che gioca il ruolo più significativo è costituito dai contesti all’interno dei quali risulta possibile praticare forme di solidarietà “in solido”, per così dire. Poniamo che un individuo venga a sapere che in un certo luogo di lavoro i dipendenti subiscono esperienze di discriminazione, degradazione ed esclusione. È probabile che la molla della solidarietà scatti in lui se gli è a sua volta toccato in sorte di subire esperienze simili. O immaginiamo che un altro doni un organo del proprio corpo a che ne ha bisogno per sopravvivere. Anche in questo caso è verosimile che un gesto di solidarietà così impegnativo venga attuato se in famiglia o nella cerchia di amici o conoscenti una circostanza del genere abbia già avuto modo di verificarsi. Il riconoscimento della somiglianza sotto un qualche aspetto rilevante è perciò un processo attivo, che permette di vedere negli altri ciò che si sa o che si prova riguardo a se stessi. Non si tratta del mero riconoscimento di caratteristiche astratte e generiche: tocca invece situazioni in cui i tratti comuni che le persone hanno imparato a riconoscere possono diventare effettivamente obbliganti per l’agire del singolo solo se si incarnano nell’esigenza di qualche essere umano realmente esistente.
È verosimile che se un individuo avesse l’abitudine di vedere negli altri ciò che hanno di diverso da lui – per esempio attraverso il filtro delle appartenenze culturali, religiose o politiche – piuttosto che gli aspetti condivisi, incontrerebbe non poche difficoltà a ritrovare quella disponibilità a porre l’altro entro se stesso e a permanere presso di sé nell’essere altro di cui parlava Hegel – disponibilità che è alla base di ogni impegno solidaristico. Insomma, la solidarietà sembra prevedere un rapporto di simmetria tra i soggetti, per lo meno nel momento in cui qualcuno presta sostegno a qualcun altro. Questa simmetria non è una sorta di affermazione ontologica relativa alla configurazione delle nostre società, nel senso che non si tratta affatto di lasciare in ombra le differenze e le disuguaglianze strutturali che le attraversano. Si tratta piuttosto di prendere atto che, in alcune circostanze, le somiglianze contano ben più delle differenze.
Questa definizione permette di distinguere la solidarietà da altre forme di sostegno o di pratica pro-sociale, come l’empatia, la carità o l’amore. La solidarietà è diversa dall’empatia perché non basta limitarsi a ricondurre a sé le emozioni altrui: la preoccupazione per le sorti di chi è minacciato o si trova in difficoltà deve essere unita alla motivazione altruistica di porre rimedio alla situazione mediante una qualche forma di intervento concreto. È diversa dalla carità perché richiede una preliminare condivisione, anche solo immaginativa, di alcuni tratti comuni impliciti nelle forme di vita, per esempio, il fatto che ci si trovi nella stessa situazione di vulnerabilità rispetto al contagio, alla malattia o alla morte. Mentre cioè la carità potrebbe nascere da un dovere morale o religioso che sollecita i ricchi a elargire denaro ai poveri in ragione delle macroscopiche differenze tra gli uni e gli altri, un impegno di tipo solidaristico tende a considerare queste differenze come marginali e dedica invece la massima attenzione ai fattori di condivisione. La solidarietà, infine, è diversa dal sostegno che amanti, amici o familiari possono prestare gli uni agli altri, perché ciò che in questi casi lega gli uni agli altri ha un peso e un valore emotivo che manca nel caso di legami che si basano soltanto su una somiglianza, reale o percepita. La solidarietà può allora subentrare come fattore compensativo proprio là dove legami thick di questo genere risultano assenti.
La solidarietà può così manifestarsi a livelli diversi: a livello interpersonale, a livello di gruppo e a livello di istituzioni e di norme formali. Quando la solidarietà si attua a livello individuale, da persona a persona, si può parlare di solidarietà di primo livello. Quando le azioni di mutuo sostegno diventano così comuni da trasformarsi in un comportamento quasi di routine per determinati gruppi o associazioni, si può parlare di solidarietà di secondo livello. Quando la solidarietà si esprime in norme giuridiche, amministrative e burocratiche, regolamenti e progetti, si entra nel campo della solidarietà di terzo livello. Questa forma di solidarietà prende generalmente corpo quando le pratiche individuali e di gruppo si sono solidificate in forme strutturali e istituzionali, come quelle conservate nelle strutture giuridiche delle società funzionalmente differenziate di cui parla Habermas. Ora, se la pandemia ha insegnato qualcosa, è che, per quanto le strutture di mutuo riconoscimento caratteristiche delle interazioni semplici e dei rapporti spontanei di solidarietà possano essere importanti, a fare la differenza, per così dire, è la solidarietà istituzionale incorporata nel diritto. Più la crisi incrementa il fabbisogno di solidarietà, più aumenta il peso della solidarietà civica giuridicamente mediata.
Il rapporto tra solidarietà e pandemie è infatti più complicato di quanto si sarebbe portati a pensare, nel senso che una crisi sanitaria, anche se ciò può sembrare controintuitivo, non fa necessariamente scattare in automatico meccanismi spontanei di solidarietà. Di primo acchito si sarebbe infatti portati a pensare che una crisi, come per esempio quella dovuta alla pandemia, spinga le persone a stringere vincoli di solidarietà capaci di rendere irrilevanti differenze che, in altri contesti e in altre situazioni, sarebbero invece sufficienti a giustificare scelte de-solidaristiche. La crisi pandemica sembra invece rendere le cose un po’ più complicate perché non a tutti riesce sempre facile trovare punti in comune con tutti gli altri. Una prima ragione è data dall’intervallo di tempo da prendere in considerazione che, anche nel caso di una pandemia prolungata, non copre certo l’intero arco di vita delle persone, e questo non le aiuta a dare per scontato che in futuro riceveranno le stesse prestazioni solidaristiche che stanno, al momento, assicurando agli altri. Inoltre, se la pandemia fosse destinata a finire in breve tempo, le persone a rischio immediato di ammalarsi sarebbero portate a vivere questa eventualità come una minaccia molto più grave e incombente rispetto ai rischi per la salute legati alla inevitabile vulnerabilità umana – rischi che possono diventare reali anche a decenni di distanza. In altre parole, è molto più difficile riconoscere le somiglianze con gli altri, e adottarle quale presupposto delle nostre azioni, nell’arco di tempo relativamente breve di una pandemia rispetto a quanto avviene nell’arco di una intera vita.
Quali insegnamenti si possono ricavare da queste riflessioni? Il primo è che, dal momento che i costi di contenimento delle pandemie non sono sostenuti da un qualche sottogruppo, ma dall’intera popolazione, e poiché le pandemie si verificano in un periodo di tempo relativamente breve, durante il quale le persone corrono rischi e hanno interessi molto diversi, le possibilità di mobilitare forme spontanee di solidarietà a sostegno della salute pubblica sono molto limitate. Il secondo è che, di conseguenza, spetta alla solidarietà civica incorporata nel diritto e nelle istituzioni democratiche, e cioè alla solidarietà di “terzo livello”, creare quelle “reti di sicurezza” che coadiuvano le prestazioni sociointegrative dei rimanenti ordinamenti istituzionali. Il terzo, che questa forma di solidarietà civica ha un nome: Stato-di-welfare, ovvero l’istituzione politica che ha creato la democrazia della solidarietà.
di Edoardo Greblo
Bibliografia
Banting, K. & Kymlicka, K. (2017). The Strains of Commitment: The Political Sources of Solidarity in Diverse Societies. Oxford: Oxford University Press.
Bayertz, K. (1999). Four Uses of Solidarity. In K. Bayertz (ed.) Solidarity (3-38). Dordrecht: Springer.
Brunkhorst, H. (2005). Solidarity. From Civic Friendship to a Global Legal Community. Cambridge, Mass.: MIT Press.
DuFord, R. (2022). Solidarity in Conflict, A Democratic Theory. Stanford: Stanford University Press.
Habermas, J. (2022). Proteggere la vita. Bologna: il Mulino.
Kolers A. (2016). A Moral Theory of Solidarity.Oxford: Oxford University Press.,
Mason, A. (2000). Community, Solidarity and Belonging: Levels of Community and their Normative Significance. Cambridge: Cambridge University Press
May, L. (1996). The Socially Responsive Self: Social Theory and Professional Ethics. Chicago: Chicago University Press.
Rodotà, S. (2014). Solidarietà. Un'utopia necessaria. Roma-Bari: Laterza.
Scholz, S. (2008). Political Solidarity. University Park: Penn State University Press.
Id. (2015). Seeking Solidarity. Philosophy Compass 10 (10), 725-735.
Stjernø, S. (2005). Solidarity in Europe: The History of an Idea.Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Sangiovanni, A. (2015). Solidarity as Joint Action, Journal of Applied Philosophy,4(32), 340-359, doi:10.1111/japp.12130,
Taylor, A.E. (2015). Solidarity: Obligations and Expressions. Journal of Political Philosophy 2(23), 128-145.
-

Nel presente contributo cercheremo di analizzare lo strano caso del Random Darknet Shopper, opera d’arte che, avendo come perno un meccanismo aleatorio, mette in discussione il concetto di soggetto, inteso questo nella sua accezione filosofica, a partire dalle sue risonanze giuridiche. Software programmato ad acquistare casualmente merce sul darknet, ha avuto in sorte lo scontro con alcune antinomie giuridiche. Vedremo infatti come (§1) il principio di colpevolezza alla base del regime di discorso giuridico in cui l’opera si innesta si ritrova innanzitutto sul problema dell’individuazione: cos’è (oppure – forse meglio: quale parte è) il soggetto in causa? Il software? La mostra, intesa come luogo fisico? Oppure la mostra intesa come organizzazione di eventi? Già in quest’ambiguità iniziale possiamo rinvenire il fine primo e ultimo dell’“opera” in questione, quella di perturbare. In secondo luogo, il problema filosofico sollevato è se e come è possibile ritenere l’alea (come se fosse) un soggetto. Questa necessità giuridica non può non confliggere con il carattere meramente finzionale dell’attribuzione di una volontà a qualcosa di assolutamente caotico. Così facendo, il regime giuridico non può che ritrovare il suo ‘oggetto’ al di là o al di qua dell’evento stesso, ovvero nelle istanze enuncianti o enunciate individuabili del dispositivo stesso. Ad onor del vero, questo processo è sotteso a qualsiasi giudizio e l’interruzione discorsiva, l’individuazione di un’istanza, è proprio l’effetto che il discorso giuridico produce, non ciò su cui si articola. In modo eclatante, l’opera che andremo ad analizzare non fa altro che rendere manifesto questa dinamica. Attraversandone la storia, dalle sue esibizioni (§2) alla ricezione sui rotocalchi (§3), andremo ad esaurire la bibliografia filosofico-giuridica che vi si è interessata, mostrando i tentativi e le proposte risolutive di richiudere in un discorso morale lo scandalo aperto da questo paradossale “soggetto caotico”(§4).
.
.
1. L’opera
Random Darknet Shopper (abbr. RDS) è un progetto di computer art del duo svizzero !Mediengruppe Bitnik (al secolo Carmen Weisskopf e Domagoj Smoljo) svoltosi tra il settembre 2014 e il 2016. Come anticipato, l’“opera” è costituita da un software finalizzato a selezionare sul darknet in modo casuale, quindi ad comperare, merce del valore massimo di 100$ in bitcoin. Durante le mostre, il software procede a un acquisto a settimana. Gli articoli vengono così spediti direttamente sul luogo d’esposizione e collocati in apposite teche, che si riempiono progressivamente fino al termine della mostra. Come spiegato dagli autori sul loro sito, «Once the items arrive they are unpacked and displayed, each new object adding to a landscape of traded goods from the Darknet» (https://wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.bitnik.org/r/).
Evidenziamo fin da subito un’ambiguità relativa all’identità del progetto. Con ‘RDS’ si intende, infatti, a seconda dell’aspettualizzazione: (1) l’oggetto, ovvero il software (secondo l’attorializzazione), (2) il luogo dell’esposizione e la collezione dei vari oggetti progressivamente acquistati (per spazializzazione e temporalizzazione terminativa) e (3) le sue performance, le varie acquisizioni avvenute nelle cosiddette editions (qui temporalizzazione incoativa). Poiché ogni edition è indipendente dalle altre, la raccolta del materiale inizia di volta in volta daccapo, l’acquisto degli oggetti è, come detto, casuale e il riempimento delle teche è durativo nel tempo. In breve RDS si presenta, proprio per la sua «capacità di assumere diverse impreviste strutture fisicamente inattuate», come un’opera in movimento (Eco 1980: 44).
In secondo luogo, notiamo che, se da un lato RDS è un dispositivo situato, occupando specifici punti dello spazio (il PC che gli fa da hardware e la merce esposta), dall’altro la relazione tra il suo discorso e l’ambiente rende il dispositivo sia pervasivo che – coniando un termine da aggiungere a quelli di Eugeni (2010: §3.2) – esclusivo. Infatti l’articolazione del senso di RDS gioca sul fatto che il suo automatismo non permette in alcun modo di essere partecipi dei criteri d’acquisto. Non si sa quale prossima chincaglieria troverà sul web, se non quando questa verrà direttamente portata sul luogo via posta. Si comprende allora come i !Mediengruppe Bitnik abbiamo potuto concepire RDS come «a landscape of traded goods» provenienti dal darknet cui si aggiungono nuovi elementi una volta «unpacked and displayed».
Una pervasione, dunque, dovuta a una collezione che riempie gradualmente l’intera sala dedicata. Wunderkammer contemporanea, RDS ostenta il privato e il proibito nel pubblico, funzionando così da dispositivo di sacrificio (Agamben 2005: 84).
Inoltre, l’aspettualizzazione temporale presenta RDS come una performarce artistica, confermando in questo modo l’«ipotesi» di lettura secondo la quale le avanguardie siano la «lucida e spesso consapevole ripresa di un paradigma essenzialmente liturgico», da leitourgia: «‘opera, prestazione pubblica’» (Id. 2017: 24 e 21). Si spiega dunque il motivo per il quale il duo svizzero possano definire RDS «a live Mail Art piece».
Ma “live piece” tematizza chiaramente l’Unheimlichkeit di Freud (1919), condizione – banalizziamo – in cui si ha terrore che prenda vita un oggetto inanimato, che gli oggetti rimossi possano (ri)attivarsi e (ri)entrare nella nostra vita cosciente. Era questo un meccanismo già presente nelle Wunderkammern: qui «lo statuto dell’esperienza museale attuale» vacilla, avendo davanti un «processo di accumulo quasi automatico di cui si fa fatica a comprendere la logica» cui deriva quell’«effetto di senso particolare, quello della meraviglia» da cui il nome (Donatiello 2016: 64). In breve, RDS è una macchina enunciativa automatica di un contenuto oscuro come il darknet, dispositivo hauntologico (Derrida 1994) grazie al quale il fantasma di una parte remota della rete si manifesta nella “casa” infestandola di simulacri, a mostrare il caos che alberga ogni cosmos, come suo rovescio e suo fuori.
Considerando che non permette di anticipare nulla sui suoi acquisti, RDS presenta un «regime» di interazione «dell’incidente», nel quale l’alea si costituisce come soggetto. Da un lato !Mediengruppe Bitnik programmano RDS per fargli ottenere una «motivazione in qualche modo concessiva», poiché l’esecutore, il Destinatario, obbedisce ciecamente alla volontà del Destinante che l’ha programmato; dall’altro, però, la programmazione è assolutamente autoneutralizzante, poiché, come già detto, l’oggetto di valore cui deve tendere il bot è, al di là dei limiti materiali imposti, un oggetto qualunque (Landowski 2005: 43).
Il ‘soggetto’-RDS emerge come se marchiato da una perversione della massima agostiniana «Dilige et quod vis fac», “ama e fa' che vuoi” (In Io. Ep. tr. 7, 8), dimostrandosi vera e propria forma-di-vita (Agamben 2011 : 17). In altre parole, esso è un’attorializzazione dell’alea. La macchina randomica apre quindi alla «minaccia del rischio puro al di sopra di tutti i sistemi di sicurezza», installando serenamente l’«attesa dell’inatteso» (Landowski 2005: 74). Come «se all’origine tutto fosse [...] discontinuità», RDS «non consent[e] alcuna forma di comprensione, ci pon[e] davanti all’insensato; escludendo ogni possibilità di anticipazione, non ci offr[e] moralmente alcuna sicurezza» (Greimas 1987: 89 e 74-5). Questo regime è ciò cui tende la ricerca dei !Mediengruppe Bitnik: «Randomness implies a loss of control. Loss of control is something we intentionally seek in our works: we create situations and let them play out». In RDS, infatti, «loss of control is part of the concept by delegating the buying decision to a software bot» (2015: 41).
RDS, “soggettivando l’alea”, incarnandola come attore e riproponendone le dinamiche costitutive, apre a una serie di paradossi. Innanzitutto «è solo nella sua manifestazione, realizzandosi[,] che il caso si auto-istituisce, in atto [...] in quanto legge di se stesso», andando così a coinvolgere la responsabilità indiretta dei suoi Destinanti solo ad azione compiuta (Landowski 2005: 80). Allo stesso modo, è solo tramite l’ostensione dei suoi acquisti che RDS si autocostituisce, retroattivamente, come un tipo particolare di soggetto. O – meglio – ha avuto modo di autocostituirsi.
.
.
2. Il caso
Tre sono state le editions di RDS: alla galleria non profit Kunst Halle di San Gallo in Svizzera nella mostra “The Darknet – From Memes to Onionland. An Exploration” (14/10/2014-15/01/2015), alla Horatio Junior Gallery di Londra (11/12/2015-05/02/2016) e, infine, all’Aksioma Institute for Contemporary Art di Lubiana (24/02/2016-25/03/2016).
Ripercorrendo la prima edition attraverso l’ironico commento di Jon Lackman (2016), scopriamo che a san Gallo, «città svizzera dalle forti radici religiose» (ivi: 3), RDS si è collegato all’Agora shop, il più grande negozio illegale al mondo, dove ha acquistato ed esibito, nell’ordine: una chiave universale dei vigili del fuoco, 40$ di stecche di Chesterfield Blue provenienti dalla Romania, una borsa falsa di Louis Vuitton, la trilogia completa de Il Signore degli Anelli in ebook, altre 200 sigarette, una carta di credito VISA dorata, 120 mg di ecstasy in pillole dalla Germania prese a soli 48$, delle sneakers (false) della Nike firmate da Kanye West comprate a 75$ (le originali andavano sui 245$), un cappello da baseball con telecamera nascosta, una lettera di richiamo, un contenitore per farmaci a forma di lattina di Sprite, dei jeans, e infine la scannerizzazione di un passaporto.
La pietra dello scandalo è stata certo la partita di droga. I !Mediengruppe Bitnik constatano con sorpresa, sul loro sito, come «The parcel was sent from Germany and crossed the border and customs to Switzerland without any problems», problemi giunti solo il 12 gennaio 2015, a mostra appena conclusa, quando la polizia svizzera sequestra il bot e tutta la merce esposta.
Soltanto il 15 aprile, dopo aver testato che le pillole contengono MDMA (90 mg, non i 120 promessi), la polizia le distruggerà – così ha dichiarato –, restituendo invece tutto il resto. I !Mediengruppe Bitnik hanno così esultato sul loro sito:
At the same time we also received the order for withdrawal of prosecution. [In it] the public prosecutor states that the possession of Ecstasy was indeed a reasonable means for the purpose of sparking public debate about questions related to the exhibition. The public prosecution also asserts that the overweighing interest in the questions raised by the art work [RDS] justify the exhibition of the drugs as artefacts, even if the exhibition does hold a small risk of endangerment of third parties through the drugs exhibited. We as well as the [RDS] have been cleared of all charges. This is a great day for the bot, for us and for freedom of art!
Sebbene ci sia stato un acquisto di droga, questo non è stato voluto. Sebbene ci sia stata detenzione di droga, ciò è avvenuto a fini artistici: RDS ha creato dunque un vuoto giuridico dove, generando un illecito come evento, non è stato possibile attribuirgli un autore come responsabile. Solo la cornice artistica ha potuto rendere impunibile l’ostensione di questo gesto. In questa sede ci soffermeremo analiticamente solo sulla prima mostra. Della seconda, i curiosi sappiano che RDS, connesso questa volta ad Alpha Bay, ha acquistato: una t-shirt Lacoste falsa, due devices per l’estrazione di Bitcoin comprati con 25$, una copia elettronica di un libro di cucina francese in inglese del 1961, un cellulare con distorsore vocale, 1.825.380 indirizzi email a 100$, la scannerizzazione di una bolletta del gas inglese, concludendo con un PDF su come Hacking a Coca Cola machine.
.
.
3. La ricezione
La notizia è salita subito agli onori della cronaca, dove si è scherzato sul fatto che il computer abbia una personalità umana e sia soggetto giuridico di diritti e doveri. Su The Guardian Kasperkevic balbetta che la polizia svizzera abbia «arrested – er, confiscated» un computer (2015); Kharpal le fa eco su CBSN (2015). Per Grey del Daily Mail RDS è addirittura un «cyber criminal!» che è stato «ARRESTED» (2015), mentre Grant dell’Indipendent sente l’imbarazzo di dover spiegare come «the consumer behind these purchases is not actually a human, though – it is an internet “bot”» (2015). RDS sembra quindi essere un soggetto pieno. Come «example of a nearly autonomous thing that bought things», esso desidera, acquista e commette crimini come tutti noi: questa è la novità su cui apre in modo clamoroso (Noto La Diega & Walden 2016: 4 nota 15).
Tant’è che a RDS si attribuisce un nome proprio, se non addirittura un genere. Come ha infatti raccontato Smoljo degli stessi !Mediengruppe Bitnik, «People also call him Randy. Normally, we try to give it a female name but this is what came out in this case» (https://exposingtheinvisible.org). Lackman invece, cercando inutilmente di non risultare sessista, attribuisce al bot il genere maschile: «For me [RDS] is not an /it /but a /he/.//Why not a /she/? I'm not sure. Only a sexist would assume an obsessive shopper is a she, right? Plus: men quail in stores, they choose stuff at random just to be done» (2016: 3). Ciò che vorremmo in ogni caso evidenziare è come la questione del soggetto giuridico comporti quella del genere e il binarismo sottesi, altrimenti non pertinenti.
.
.
4. L’anomia
Galati ha commentato l’episodio delle pasticche evidenziando come, al di là «del risvolto potenzialmente ironico, [RDS] genera evidentemente delle domande che segnalano dei buchi giuridici sulla responsabilità degli algoritmi» (2018). La questione etico-morale è stata da subito sollevata, a partire da Power (2014), fonte di tutta la bibliografia successiva su questo «provocative example of such a shopping bot» (Gal & Elkin-Koren 2017: 315).
Una risposta viene tentata da Alves de Lima Salge e Berente (2017). Rifacendosi al kantismo di Rawls, per valutare il valore morale di un algoritmo come RDS, essi propongono un algoritmo di livello logico superiore, ovvero un meta-algoritmo. È già chiaro il pericolo della regressione all’infinito (critica avanzata da subito da Shaw 2018). Rischio, quello della regressio, contro il quale la giuscibernetica, fin dalle sue prime teorizzazioni, ha sempre invocato la necessità di un limite (Losano 1969: 169 ss).
Alves de Lima Salge e Berente, in ogni caso, si chiedono: sebbene sia stata violata una legge di Stato (il bot ha acquistato della droga vietata sul mercato regolare e un passaporto falso), si può ritenere il suo comportamento «unethical»? Per questo motivo, gli autori ritengono necessario un giudizio sulla sua attività. Il meta-algoritmo che propongono si articola di tre domande: (1) l’azione del social bot ha infranto la legge?, (2) la sua azione è ingiustificabile? (3) è coinvolto qualche inganno? Un bot, ma più in generale qualsiasi soggetto morale, non si comporta eticamente se la sua azione risponde affermativamente in progressione alle tre domande. La conclusione e il fine cui vogliono tendere gli autori – vero e proprio imperativo categorico – è che i «Social bots should always act truthfully» (ivi: 30).
Poiché il fine era artistico e l’ecstasy «in this presentation was safe», come indicato dalla polizia, gli autori dell’articolo possono ritenere il comportamento del bot «not unethical» poiché giustificabile con la moralità diffusa della comunità. Qui, però, l’impasse: per i due studiosi, che si rifanno all’Etica Nicomachea (III, 1111a), un soggetto-bot etico emerge come tale se e solo se la sua azione è allo stesso tempo saputa e voluta. Come già evidenziato, RDS si comporta come l’alea, alla quale è assolutamente finzionale attribuire una qualunque consapevolezza della propria volontà. Il bot sembra quindi muoversi a latere del meta-algoritmo, nello spazio di un vuoto giuridico.
Sorge inoltre un ennesimo problema, sollevato da Turner, per il quale RDS sarebbe un “Case Study” sulla domanda: «Could a Robot Commit a Crime?» (2019: §4.5). Per il principio del habeas corpus, anche se si individuasse la volontà del bot, questa resterebbe un carattere di una mera ψυχή (RDS è un software), cui non sarebbe relato alcun corpo punibile di reato. È il motivo di clamore del Washington Times (2015) per il quale è sorprendente che sia stato arrestato un «moving conglomeration of bits and bolts, conceived and fashioned by flesh and blood men».
Non resta dunque che dare la colpa agli sviluppatori: «Therefore, culpability rests on the knowledge of the developers» (ivi: 31), ovvero i Destinanti. Ma, anche in questo caso, si tratta di una soluzione particolare, che solo a volte può essere attuata. Si attribuisce la sostanza di soggetto al firmatario, in quanto primo riferimento fisso della catena di enunciazioni che si è venuta a creare. Ma in questo caso non si tratta di una colpa, al massimo un dolo. Si mostra così un conflitto tra due regimi discorsivi, quello del Diritto che cerca un elemento primo cui ricondurre la catena di enunciazioni (Latour 1998: 92 ss), come ad esempio un firmatario che emerge retroattivamente dalla sua firma (Derrida 1997: 393-424), e il regime discorsivo della tecnica che si articola in débrayages attanziali dove ogni attore così proiettato vive di una sua autonomia (Latour 1998: 82). Allo stesso tempo, però sono proprio i diritti d’autore, correlati della responsabilità autoriale (Franceschelli 2019), a permettere al duo svizzero di rivendicare per sé la genesi dell’opera. In breve, la funzione-autore è un «oggetto di appropriazione» la cui forma è storicamente seconda, in rapporto a ciò che di potrebbe chiamare l’appropriazione penale. I testi , i libri, i discorsi hanno cominciato ad avere realmente degli autori […] nella misura in cui l'autore poteva essere punito, vale a dire nella misura in cui i discorsi potevano essere trasgressivi. Il discorso, nella nostra cultura (e in altre probabilmente) non era, all’origine, un prodotto, una cosa, un bene; era essenzialmente un atto – un atto posto nel campo bipolare del sacro e del profano, del lecito e dell’illecito, del religioso e del blasfemo (Foucault 1971: 9).
Abbandonando così l’ipotesi d’“accusare delle cose di un crimine”, la colpa è dei programmatori, in quanto si prendono la responsabilità delle azioni del loro bot che hanno previsto. Si darebbe colpa a un bot se e solo se si potesse dimostrare che questo abbia deviato volutamente dal proprio programma, ovvero dal volere dei propri destinanti: «In such absence of deviation, it is easier to prove human involvement in the AIS’ illegal conduct. In other words, the programmer of [RDS] may also be held liable because it creates an AI to shop in the illegal market» (Andrini 2018: 79). Per lo stesso motivo, «si tratta di un reato punibile a titolo di dolo» poiché il «bot non è stato progettato o impiegato con l’intenzione di commettere il reato, ma il programmatore e/o l’utente hanno irragionevolmente accettato una serie di rischi che hanno portato al verificarsi della condotta criminosa», motivo per il quale «l’utilizzatore e/o il programmatore saranno ritenuti penalmente responsabili per il reato commesso dal bot» (Lagioia 2016: 126 e 129).
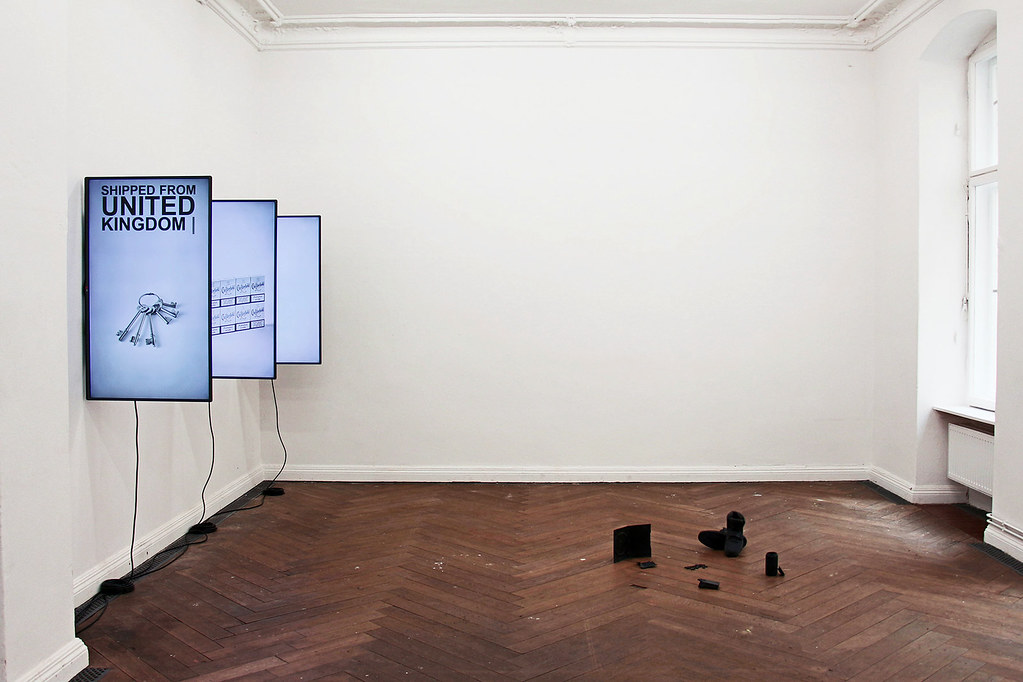
Ribadiamo: che siano colpevoli, gli artisti ne sono ben consci: «We are the legal owner of the drugs – we are responsible for everything the bot does, as we executed the code», ammette Smoljo. «But our lawyer and the Swiss constitution – continua – says art in the public interest is allowed to be free» (Power 2014).
È proprio il mondo dell’arte (Danto 1964) che infine si instaura come terzo discorso che permette di neutralizzare qualsiasi tipo di colpa da parte di RDS o dei suoi autori. I !Mediengruppe Bitnik infatti rivendicano di appartenervi.
.
.
Conclusione
Perniola (2015) aveva individuato nell’arte più recente una certa svolta fringe, secondo la quale «Nulla è di per se stesso arte» ma «lo diventa attraverso molti fattori» in un processo detto di «artistizzazione». Evidenziamo come RDS si muova nella direzione opposta, poiché esso è da sempre costituito come opera d’arte. È il vuoto giuridico che crea a far scoppiare un conflitto discorsivo tra il mondo dell’arte e quello legale. RDS non è un’opera fringe verso altri domini: sono gli altri domini ad implodere su di esso.
Coglie bene l’essenza di RDS Volkart Schmidt nell’inserire il progetto nella cosiddetta Ästhetik der Störung, «disturbo» dato nello specifico dalla «Kollision der Systeme». Abbiamo visto come questo progetto artistico utilizzi il proprio dominio per generare cortocircuiti in quelli altrui, innanzitutto giuridico e, conseguentemente, sociale. Ciò è stato possibile grazie alle possibilità offerte dalla rete, non intesa qui ingenuamente solo come «spazio libero dal diritto», a richiamare «vagamente le origini euforiche di Internet» (2015: 4). Come spiega Boris, «Aquella emancipación del ciberespacio [...] nos parece hoy un poco ridícula». La rete non è più – o, meglio, non è mai stata – quel grande spazio orizzontale di chissà quale regno dei cieli sulla terra. Si necessita dunque di «entender el horizonte digital como un campo fundamental de esta hipergeografía que estamos habitando», per stabilire così «Términos y Condiciones de una ontología digital libertaria» (2017).
In conclusione RDS si presenta come emblematico «example of hacktivist guerrilla communication» (Delmas 2018: 75), la cui sola ragione d’esistenza, «l'esecuzione dell’atto di semplice consumo» (Volkart Schmidt 2015: 4), è una «reflection on the shadowy parts of the Internet without calling for any specific legal change, or articulating any specific political claim» (Delmas 2018: 75). RDS non vuole portare al cambiamento in nessuna legge corrente, ma sollevare una riflessione sui limiti delle legislatura stessa. Considerando che «c’è arte solo se e quando (resiste)» (Carmagnola 2019: 156), RDS è arte proprio nella sua rivendicazione.
Derrida (1996: 14 nota 1) era convinto che «la democratizzazione effettiva si misura sempre con questo criterio essenziale: la partecipazione e l’accesso all’archivio, alla sua costituzione e alla interpretazione». Se ormai la rete è la sostanza esterna del nostro inconscio tecnologico, grande produzione archiviale costantemente riattualizzata (Galati 2017: §3), RDS ne è macchina da guerrilla semiotica (Eco 1967) che, a partire dal territorio specifico dell’arte, può portare a rimetterne in discussione confini e geografia.
di Francesco Di Maio
.
.
Bibliografia
!Mediengruppe Bitnik (2015). The Random Darknet Shopper wasting time on the darknet. In L. Catania et al. (a cura di). WTi2.0: Wasting Time on the Internet 2.0 (41). Düsseldorf: TFGC.
Agamben, G. (2005). Profanazioni. Roma: nottetempo.
Agamben, G. (2006). Che cos’è un dispositivo. Roma: nottetempo.
Agamben, G. (2011). Altissima povertà. Regole monastiche e forma di vita. Homo sacer, IV, I, Vicenza: Neri Pozza.
Agamben, G. (2017). Creazione e anarchia: L’opera d’arte nell’epoca della religione capitalistica. Vicenza: Neri Pozza.
Alves de Lima Salge, C. & Berente, N. (2017). Is That Social Bot Behaving Unethically?. Communications of the ACM, 60 (9), 29-31.
Andrini, L. (2018). Redesigning Indonesia Copyright Act to Accommodate Autonomous Intelligent System: Status Quo and Room for Improvement. Asian Journal of Law and Economics, 9 (3).
Boris (Mariano López Hermida) (2017). H.H.H: Una introducción a la hipergeografía y la dimensión política del horizonte digital. Estudios Curatoriales, 6 (4).
Carmagnola, F. (2019). Essere e gadget. La macchina del sentire. Milano: Meltemi.
Danto, A. (1964). The Artworld. Journal of Philosophy, 61 (19), 571-84.
Delmas, C. (2018). Is Hacktivism the New Civil Disobedience?. Raisons politiques, 69 (1), 63-81.
Derrida, J. (1994). Spettri di Marx: Stato del debito, lavoro del lutto e nuova Internazionale. Tr. It. di G. Chiurazzi. Milano: Raffaello Cortina.
Derrida, J. (1996). Mal d'archivio: Un’impressione freudiana. Tr. It. di G. Scibilia. Napoli: Filema.
Derrida, J. (1997). Margini – della filosofia. Tr. It. di M. Iofrida. Torino: Einaudi.
Donatiello, P. (2016). L’osservazione da un punto di vista etnosemiotico: Alcune osservazioni. INTRECCI d’arte, 5, 61-85.
Eco, U. (1973). Il costume di casa: Evidenze e misteri dell’ideologia italiana. Milano: Bompiani.
Eco, U. (1980). Opera aperta: Forma e indeterminazione nelle poetiche contemporanea. Milano: Bompiani.
Eugeni, R. (2010). Semiotica dei media: Le forme dell’esperienza. Roma: Carocci.
Eveleth, R. (2015). My Robot Bought Illegal Drugs. BBC, http://www.bbc.com/future/story/20150721-my-robot-bought-illegal-drugs.
Foucault, M. (1971). Scritti letterari, A cura di C. Milanese. Milano: Feltrinelli.
Franceschelli, G. (2019). I, Artist: Opere d’arte e intelligenza artificiale: il curioso caso del diritto d’autore, Senigallia: ventura.
Freud, S. (1919). Das Unheimliche. Imago. 5 (5-6), 297-324.
Gal, M.S. & Elkin-Koren, N. (2017). Algorithmic Consumers. Harvard Journal of Law & Technology, 30 (2), 309-53.
Galati, G. (2017). Duchamp Meets Turing: Arte, modernismo, postumano. Milano: postmedia•books.
Galati, G. (2018). Arte, modernismo e postumano. Cronache letterarie, http://cronacheletterarie.com/2018/04/07/arte-modernismo-e-postumano-intervista-a-gabriela-galati/
Grant, K. (2014). Random Darknet Shopper: Exhibition featuring automated dark web purchases opens in London. Indipendent, https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/random-darknet-shopper-exhibition-featuring-automated-dark-web-purchases-opens-in-london-a6770316.html
Greimas, A.J. (2004). Dell’imperfezione. Tr. It. di G. Marrone. Palermo: Sellerio.
Grey, R. (2015). Now that's a cyber criminal! Robot is ARRESTED by police for buying ecstasy on the dark net. Daily Mail, https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3047317/Now-s-cyber-criminal-Robot-ARRESTED-police-buying-ecstasy-dark-net.html
Kasperkevic, J. (2015). Swiss police release robot that bought ecstasy online. The Guardian, https://www.theguardian.com/world/2015/apr/22/swiss-police-release-robot-random-darknet-shopper-ecstasy-deep-web
Kharpal, A. (2015). Robot with $100 bitcoin buys drugs, gets arrested. CBSN, https://www.cnbc.com/2015/04/21/robot-with-100-bitcoin-buys-drugs-gets-arrested.html
Lackman, J. (2016). RANDOM DARKNET SHOPPER. Ljubljana: Aksioma – Institute for Contemporary Art.
Lagioia, F. (2016). Responsabilita Penale e Automazione nell’E-Health. Tesi di dottorato, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Bologna, Italia.
Landowski, E. (2010). Rischiare nelle interazioni. Tr. It. di M.C. Addis. Milano: FrancoAngeli.
Latour, B. (1998). Piccola filosofia dell’enunciazone. In Basso, P.L. & Corrain, L. (a cura di). Eloquio del senso: Dialoghi semiotici per Paolo Fabbri (71-94). Genova: Costa&Nolan.
Losano, M.G. (1969). Giuscibernetica. Macchine e modelli cibernetici nel diritto. Torino: Einaudi.
Noto La Diega, G. & Walden, I. (2016). Contracting for the “Internet of Things”: Looking into the Nest. Queen Mary School of Law Legal Studies Research Paper, 219.
Power, M. (2014). What happens when a software bot goes on a darknet shopping spree?. The Guardian, https://www.theguardian.com/technology/2014/dec/05/software-bot-darknet-shopping-spree-random-shopper
Perniola, M. (2015). L’arte espansa. Torino: Einaudi.
Shaw, J. (2018). Evil: The Science Behind Humanity's Dark Side. NY: Abrams.
Turner, J. (2019). Robot Rules: Regulating Artificial Intelligence. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Volkart Schmidt, Y. (2015). Sichtbarmachen, Verdunkeln, Materialisieren: Für eine Ästhetik der Störung. Springerin, 2, 4-5.
Washington Times, A ’bot with a rap sheet: Even if you're made of bits and bolts, selling drugs is not a good idea, https://www.washingtontimes.com/news/2015/apr/26/editorial-internet-robot-random-darknet-shopper-ar/
-
I diritti forzati. Basaglia e la legge
Recensioni / Ottobre 2020“Per poter affrontare veramente la ‘malattia’, dovremmo poterla incontrare fuori dalle istituzioni” (p. 77), scriveva Basaglia nel 1968. Dieci anni dopo, la promulgazione della legge n. 180/1978 (nota anche come legge Basaglia) sancirà la chiusura definitiva dei manicomi, aprendo una nuova fase per le politiche della salute mentale in Italia. Questa legge, se da un lato ha rappresentato una conquista parlamentare decretando la fine dei manicomi come luoghi di miseria, custodia e coercizione, dall’altro non ha segnato però la fine della battaglia: adesso che i manicomi sono stati chiusi, come gestire la cura della sofferenza psichica? Come restituire dignità e diritti a tutti i soggetti che vi erano internati? I diritti forzati. Conversazioni sulla follia a quarant’anni dalla legge Basaglia (L’Ornitorinco, 2018), a cura di S. Rossi e P. Tincani, si presenta come una riflessione a più voci intorno a tali quesiti, ponendo particolare attenzione a quei diritti che, ad oggi, continuano a non essere tutelati: sette saggi di autori eterogenei (filosofi, giuristi, psichiatri) offrono ognuno un punto di vista particolare – per tenere fede alla complessità della questione – con l’obiettivo di restituire i profili emergenti nella tutela della salute (mentale, ma non solo) e del correlato diritto, interpretando quest’ultimo come “espressione del ‘vissuto’ della persona, come fonte e luogo di svolgimento dell’identità e dignità dell’individuo socializzato e, al contempo, quale crogiuolo paradigmatico del rapporto tra libertà e autorità” (p. 11).
Perché follia e diritto? Come sottolineano gli stessi curatori, perché “il diritto è un sapere incarnato, scritto sulla pelle degli uomini, il che consente alle norme giuridiche di cogliere e, al contempo, di essere influenzate dalla complessità e irregolarità dell’esistenza, trovando il modo di concettualizzarla senza cancellarla” (p. 9). Con la legge 180 si è infatti realizzata una riattribuzione di soggettività a favore di coloro che erano stati vittima di dispositivi escludenti: la critica al manicomio si è infatti tradotta in processo istituente che, a partire dalla critica del diritto, ne ha rivendicato la promessa universalistica per restituire diritti agli internati.

Nel primo saggio del volume, Daria Dibitonto si concentra su uno dei principali nodi irrisolti della legge 180: il problema della coercizione all’interno degli SPDC (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, luogo di ricovero temporaneo di pazienti in crisi). In Italia la contenzione non è vietata, e solo 21 SPDC (su 324, dati del 2018) sono no restraint. Perché un uso così diffuso? L’autrice trova la risposta nella mancanza di dialogo e di ascolto nei confronti dei pazienti psichiatrici e delle loro storie, mostrando l’esistenza di buone prassi in psichiatria che consentono di evitarla (prima fra tutte, il “dialogo aperto” nato in Finlandia). Influenzata dalla psichiatria fenomenologica tedesca, Dibitonto propone un “orizzonte etico di strutturale inconoscibilità dello psichico, che opera anche come tutela pratica della libertà e della dignità della persona” (p. 18), così che ciascuna storia umana possa e debba essere aperta alle più diverse interpretazioni. Perché ci si avvii alla gestione di reparti no restraint secondo l’autrice è necessario un percorso formativo dell’intero personale che favorisca la costruzione di un rapporto di fiducia e ascolto con i pazienti, condizione essenziale per qualsiasi terapia e modo per prevenire le crisi, gestendole in modo meno violento.
Nel secondo saggio Paolo Jarre sposta l’attenzione sul consumo di oggetti psicoattivi e sulla coercizione paternalistica alla loro cura tipica del sistema normativo e sanitario italiano: tale consumo è da considerarsi patologia o fisiologia? Due fatti incontrovertibili rispondono alla domanda: 1. Questi consumi hanno accompagnato la storia dell’umanità sin dai suoi albori; 2. Non è solo l’uomo a fare uso di sostanze, ma gli stessi animali. La tossicodipendenza, afferma l’autore, non è “naturale” ma nasce dall’inestricabile rapporto tra il consumo di una sostanza psicoattiva e un dato sistema di norme giudiziarie, culturali, antropologiche e religiose. Senza queste ultime il consumo, anche “esagerato”, di sostanze non è tossicodipendenza. La sua “cura” mostra così il suo aspetto di coercizione paternalistica: l’insieme del modello normativo relativo al consumo di droghe è infatti un complesso dispositivo paternalistico che parte da presupposti non dimostrati e non dimostrabili (il consumo è considerato a metà strada tra il male e la malattia) per arrivare a un articolato strumentario di cura che ignora quello che si sa essere il principale ingrediente di qualsiasi intervento terapeutico efficace, la volontaria scelta di intraprenderlo.
Proseguendo, Valeria Marzocco analizza il legame “genetico” che intercorre tra psichiatria e diritto, da rintracciarsi alle origini del percorso di affermazione della scienza psichiatrica. La psichiatria è, sin dal suo ingresso ottocentesco nell’ambito del sapere medico, scienza ambigua, a causa della discontinuità epistemica che la distingue dalla pratica medica sul piano diagnostico e per la difficoltà a definire il perimetro e i confini del proprio oggetto, la follia. Scienza “debole” alla quale, nota Marzocco, il diritto offre i processi e i luoghi della propria istituzionalizzazione: nell’Ottocento al manicomio era associato il processo giudiziario, condizione che ha portato a definire in termini normativi i confini tra patologia e devianza. Queste procedure giurisdizionali hanno delimitato i contorni e l’identità dell’oggetto della psichiatria all’interno di un quadro che contiene tanto il bisogno della cura quanto il ricorso alla custodia. Con la legge 180 il sistema italiano ha riformato la gestione del disagio psichico, facendosi recettore di un movimento teorico teso a scardinare dalla psichiatria la presa in carico di una istanza di custodia del sofferente psichico: grazie a questa, si è scisso infatti il legame tra pericolosità e malattia mentale risalente alla criminologia positivistica, ma la categoria della pericolosità sociale – frutto dello stesso clima ottocentesco – continua a sopravvivere e ad affidare una valutazione che riguarda l’orizzonte del controllo alla competenza dello psichiatra. L’esistenza delle Rems (Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza, strutture sanitarie volte alla riabilitazione di soggetti affetti da malattia mentale, autori di reati) testimonia, con il suo giudizio circa la pericolosità sociale, l’affermazione di un’istanza di controllo che permane in capo alla psichiatria. Non solo: il Tso per malattia mentale (Trattamento sanitario obbligatorio, disposto con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico) rappresenta tutt’oggi lo spazio istituzionale in cui si rinnovano strumenti e modalità di un esercizio della funzione psichiatrica in contrasto con i diritti fondamentali della persona, un’area grigia di sospensione dei diritti per la quale l’elemento della pericolosità del paziente psichiatrico – per sé o per gli altri – è spesso la condizione legittimante. La non ancora superata legittimazione di strumenti di contenzione in regime di Tso (denunciata anche da Dibitonto nel primo saggio) è un’altra di queste criticità, che arriva a toccare il reato di tortura. Marzocco in definitiva mette in luce come la psichiatria resta un sapere che, proprio perché consapevole dei propri limiti epistemologici sul piano conoscitivo, ha compensato questa carenza con l’esercizio di una funzione potestativa, ideologicamente connessa a un’esigenza di difesa, prima ancora che di cura.
Nel quarto saggio, Francesca Poggi mostra come la tensione, tipica della Costituzione italiana, tra tutela assoluta della vita e della salute da un lato e rispetto dell’autonomia personale dall’altro, si rifletta in modo significativo nella disciplina del Tso per malattia mentale, la quale rappresenta una significativa eccezione all’interno dell’attuale panorama di crescente valorizzazione dell’autonomia individuale: tale trattamento è finalizzato (ufficialmente) alla realizzazione del diritto alla salute, il quale non costituisce solo un fondamentale diritto dell’individuo ma anche un interesse della collettività. L’imposizione di un trattamento terapeutico contro la volontà del soggetto arriva ad essere giustificato (conformemente a un’etica liberale) poiché volto a prevenire un danno a sé stessi e ad altri soggetti; ma nella legislazione del 1978 non vi è traccia dell’esigenza di tutela della salute collettiva, motivo per cui non è chiaro (aspetto più rilevante della questione) come il pericolo per l’interesse collettivo potrebbe essere declinato in caso di Tso per malattia mentale, a causa di un evidente rischio della reintroduzione dell’elemento di pericolosità sociale. Il principale aspetto illiberale della normativa in tema di Tso per malattia mentale consiste allora nell’imporre un trattamento sanitario obbligatorio o coattivo al di fuori dell’esigenza (dichiarata) di evitare un danno a terzi contro la volontà di soggetti competenti (coscienti, adulti, razionali, informati). Questo aspetto, nota Poggi, non si ravvisa infatti in altri Tso, come ad esempio le vaccinazioni, dove invece è evidente l’esigenza di salute collettiva, né nei Tso che riguardano soggetti non competenti e non capaci di intendere o di volere (interdetti, inabilitati, minori).

Proseguendo con questa riflessione, Stefano Rossi osserva che se si scrutina la sostenibilità della disciplina dei Tso per malattia mentale alla luce dei parametri costituzionali ne emerge un quadro critico, poiché appare sfuggente quell’interesse alla tutela della salute collettiva tale da giustificare l’imposizione di un trattamento a un soggetto con sofferenza psichica, non rinvenibile certo nel vetusto criterio della pericolosità sociale. Le esigenze collettive di sicurezza, nota Rossi, dovrebbero essere affrontate nel quadro di un’assistenza di prevenzione e cura a carattere territoriale e non possono trovare risposta in un esasperato ricorso ai trattamenti coattivi. Ma facciamo un passo indietro: le condizioni atte a legittimare l’internamento in manicomio erano, con la legge del 1904, la pericolosità per sé o per gli altri o il pubblico scandalo ingenerato da soggetti che non potessero essere custoditi e curati adeguatamente fuori dal manicomio. Con la legge del 1978, nel regolare il trattamento della malattia mentale, il legislatore definisce una scala di valori che vede il primato della salute dell’uomo, della sua libertà e dignità su ogni altro interesse, spostando l’asse dell’intervento istituzionale dal ricovero ospedaliero alla definizione di servizi territoriali. L’obiettivo principale perseguito attraverso la riforma è dato dalla chiusura dei manicomi nel segno dei diritti (sistema di cura senza custodia), ma l’impatto del passaggio a livello normativo, sociale e culturale si è concretato in un work in progress in costante evoluzione. Oggi, anche se lontani dalle immagini dell’internamento tradizionale, l’impoverimento dei servizi nel contesto del sistema di welfare mette a grave rischio la possibilità di cura, ripresa e guarigione di migliaia di cittadini che si trovano ad affrontare il problema del disagio psichico. Lo scenario cui si assiste è quello di una frequente riduzione dell’offerta sanitaria alle sole visite ambulatoriali – gravate da sterminate liste di attesa – per ottenere quasi esclusivamente prescrizioni farmacologiche. Il ricorso frequente e reiterato al Tso è allora sintomo, osserva Rossi, di questa cronica mancanza di offerta e dell’incapacità di intercettare il disagio mentale sul nascere, fornendo azioni di tipo preventivo dell’acuzie.
Successivamente, Antonella Massaro analizza il precario equilibrio presente all’interno dell’ordinamento penale italiano di fronte a un soggetto che commette reato a causa di un vizio di mente, tra esigenza di cura del “sofferente psichico” da una parte e neutralizzazione-criminalizzazione del “folle-reo” dall’altra. Il ricovero in Opg (Ospedale psichiatrico giudiziario, struttura attualmente non più esistente, sostituita nel 2015 dalle Rems) consisteva in una misura di sicurezza, disposta nei confronti di un soggetto socialmente pericoloso, con un contenuto terapeutico. L’istituzione delle Rems segna un’ulteriore tappa legislativa dell’iter che intende enfatizzare il polo della cura rispetto a quello della custodia. Resta però difficile, secondo Massaro, il connubio tra carattere securitario della misura ed esigenza di cura di un soggetto che è anzitutto un malato: da una parte si impone il primato dell’individuo, dall’altra si staglia una restrizione della libertà personale imposta coattivamente per ragioni di difesa sociale. Il complesso rapporto tra libertà e autorità si delinea qui in tutta la sua evidenza: il soggetto “deve” essere curato, se così non fosse l’internamento si esaurirebbe in una dimensione meramente custodialistica volta alla neutralizzazione della pericolosità sociale. Ma come si può attribuire una reale possibilità di scelta rispetto a una cura che resta orientata anche a finalità di difesa sociale? Sarebbe forse opportuno ammettere, sottolinea Massaro, che il ricovero nelle Rems rappresenta una forma di trattamento sanitario imposto per via legislativa.
Da ultimo, Persio Tincani si concentra sull’influenza che la criminologia positivistica di Lombroso ha avuto nella costruzione normativa della follia. Tutto nasce ai tempi dell’Unità d’Italia: siamo nel 1861 e all’impresa di fare gli italiani Lombroso fornisce un nuovo strumento, la costruzione (normativa) del “tipo normale”, cittadino normale che non metta in crisi la convivenza e le regole della socialità. Egli definisce così il soggetto politico del cittadino: esso è, al contempo, la normalità-regolarità rispetto alla quale tutti gli altri tipi costituiscono la devianza, con la categoria del pazzo che rappresenta il principale gruppo di controllo. Una delle sue teorizzazioni più importanti è quella del “delinquente nato”, destinato a delinquere “per natura”, a causa di sue caratteristiche fisiche innate. L’intera tassonomia dei tipi umani è formata a partire da quel tipo minoritario ed estremo: è a partire da esso che si costruisce il tipo normale come modello speculare. Alla base del giudizio sull’ “uomo delinquente” (questo il titolo di uno dei principali lavori di Lombroso) non stanno i fatti commessi ma la pericolosità del reo, ovvero i motivi per i quali quel determinato soggetto ha compiuto quella determinata azione; qui svolge allora un ruolo importantissimo la perizia degli esperti, ai quali il giudice deve rivolgersi. Se il delinquente è determinato al crimine dai suoi tratti devianti significa, secondo Lombroso, che non possiede una piena libertà del volere: il criminale non è normale, non corrispondendo al modello del cittadino (modello che è soprattutto normativo e non statistico – il metodo di Lombroso infatti è solo apparentemente scientifico, spesso le sue teorie sono fondate a partire da un solo caso) è senza mezzi termini malato. Egli può essere curato, ma ciò non toglie che la società abbia il diritto e il dovere di proteggersi. La pratica giuridica ha trovato con Lombroso una soluzione di compromesso nella perizia scientifica, con la quale il giudice incarica uno scienziato o un tecnico di esprimere una valutazione su un determinato argomento oggetto di giudizio sul quale la corte non possiede le competenze: oggi non condanniamo più al carcere i malati di mente perché hanno compiuto azioni considerate in astratto dalle leggi come delitti, poiché riconosciamo che di quelle azioni non possono essere ritenuti responsabili o comunque non totalmente. Questa concezione della pena come misura che deve tendere alla riabilitazione del condannato è la direzione verso la quale il lavoro di Lombroso è stato per l’epoca rivoluzionario.

A poco più di quarant’anni dalla legge che ha portato la follia fuori dall’istituzione manicomiale, per restituire dignità e diritti a tutti quei soggetti che vi erano internati, possiamo affermare che tale processo di restituzione non sia certo terminato. La situazione si presenta come un work in progress nel quale il diritto continua a giocare un ruolo fondamentale: esso è, come sostengono i curatori citando Rodotà, un processo “faticoso, che non allontana da sé la vita, ma cerca di penetrarvi; che non fissa una regola immutabile, ma disegna una procedura per il continuo e solidale coinvolgimento di soggetti diversi; che non sostituisce alla volontà del ‘debole’ il punto di vista di un altro (come vuole la logica del paternalismo), ma crea le condizioni perché il ‘debole’ possa sviluppare un punto di vista proprio (secondo la logica del ‘sostegno’)” (p. 10). È possibile riconoscere al diritto, nonostante i numerosi spazi grigi nei quali questo continua a essere forzato, tale peculiarità? Se vogliamo che l’assunto di Rodotà non scada in un mero idealismo, dobbiamo auspicare che in Italia – paese modello della chiusura manicomiale – dibattiti e volumi come quello qui presentato aumentino, coinvolgendo specialisti provenienti dai più diversi ambiti disciplinari e acquisendo più visibilità all’interno del dibattito pubblico.
di Linda Casoli
-
Martha Nussbaum. La tradizione cosmopolita.
Recensioni / Aprile 2020Che si tratti di un incidente di percorso, o di un esito coerente con la nostra direzione di marcia, la crisi finisce sempre per rivelare qualcosa: quella che stiamo vivendo, se non altro, ci ricorda quanto siamo fragili, quanto precaria ed esposta alla fortuna sia la condizione umana. E invita anche tutti noi a meditare sulla necessità dell’altruismo, tanto su scala individuale quanto internazionale, al fine di tamponarne le conseguenze più funeste. Se quella che serve è allora una coscienza globale, indispensabile per fronteggiare questa come altre emergenze, non sarà forse inopportuno riflettere attentamente sul significato e le implicazioni di un simile allargamento di prospettiva. È quello che prova a fare Martha Nussbaum nel suo ultimo libro, La tradizione cosmopolita. Un ideale nobile ma imperfetto, recentemente tradotto in italiano per le edizioni Bocconi, un saggio in cui alla complessità dei temi affrontati fa da contraltare il migliore stile anglosassone.
Partendo dai Greci, e nello specifico da quella straordinaria figura che fu Diogene il Cinico, il quale dichiarava di sentirsi cittadino del mondo intero, la filosofa ricostruisce una tradizione di pensiero che dall’antichità giunge fino a noi, e che nelle parole dei suoi protagonisti ha costantemente difeso il principio dell’eguale valore di ogni essere umano. Non si tratta però di ripercorrere passo dopo passo la storia di un concetto, con precisione filologica: a Nussbaum interessa piuttosto soffermarsi su alcuni autori particolarmente significativi per i problemi al centro della sua indagine, accogliendone gli spunti o prendendone invece congedo come si farebbe con dei contemporanei.
Si comincia con lo stoicismo, che eredita dai cinici l’idea secondo cui l’essere umano, indipendentemente dal rango sociale e dalle appartenenze politiche, sia in quanto tale meritevole di rispetto: la dignità, secondo questa tradizione, trascende ogni differenza e deriva dalla capacità di pensare e agire moralmente. Il possesso di beni esteriori non rappresenta affatto un discrimine rilevante, un motivo per giustificare un trattamento iniquo. Ecco l’egualitarismo stoico, che si traduce – l’autrice ha qui in mente soprattutto Cicerone – nel riconoscimento dei doveri di giustizia a cui ognuno di noi è chiamato, e che consistono fondamentalmente nell’astenersi da comportamenti lesivi dell’altrui libertà. Fin qui, spiega Nussbaum, il discorso stoico suona condivisibile, ma a ben vedere non ancora sufficiente: sconta infatti un antico pregiudizio, una visione dell’essere umano monolitica, che non gli consente di comprendere appieno la nostra sfera di responsabilità. Si tratta del convincimento secondo cui la dignità umana, inalienabile in ogni individuo, sarebbe al riparo dalle condizioni esterne, e quindi anche dalle privazioni materiali, giudicate del tutto indifferenti per una vita buona. Convincimento che a sua volta deriva dalla rigida separazione tra foro interno e mondo esterno, respinta dalla filosofa con ottimi argomenti: «La mente e lo spirito, infatti, sono parte di un organismo vivente che ha bisogno di cibo, di cure mediche e di altri beni materiali» (p. 16). Una rettifica quanto mai opportuna e tuttavia gravida di conseguenze, perché lo scarso valore tributato ai beni esteriori è proprio ciò che consente agli stoici di affermare l’universale dignità umana. Non esiste il rischio che, riabilitandoli, si finisca anche per negare dignità a coloro che di quei beni non dispongono? No, spiega Nussbaum, il riconoscimento che la vita umana necessiti di beni esteriori per fiorire davvero, invece di favorire sperequazioni e degradazioni, presuppone al contrario un impegno maggiore nei confronti degli altri, affinché ciascun essere umano abbia la possibilità di condurre un’esistenza ricca di significato. Per un verso la dignità è allora inalienabile, e come affermano gli stoici appartiene all’individuo in quanto tale, ma per un altro verso è responsabilità nostra e della comunità alla quale apparteniamo contribuire a farla risplendere, dando a ciascuno i mezzi per esprimerla appieno. Questo comporta che i doveri di aiuto materiale siano importanti tanto quanto quelli di giustizia, e che agire moralmente non significhi semplicemente astenersi dal commettere azioni malvagie, ma anche attivarsi in modo concreto per il benessere altrui. Con le sue parole: «Esiste un livello minimo di beni esteriori di cui è giusto preoccuparsi, sia pure strumentalmente, poiché la sua mancanza impedisce a un essere umano di vivere una vita decorosa, all’altezza della dignità umana, così come glielo impedisce la mancanza di libertà politica, di istruzione, di legami associativi e di reciproco rispetto con i propri concittadini» (p. 69). Gli stoici, che pur furono anche riformatori sociali, secondo Nussbaum non si sarebbero mai spinti a tanto: con l’eccezione forse di Cicerone, indiscutibile protagonista della prima parte del libro, che ammorbidisce il rigorismo morale affermando l’importanza dei rapporti umani e in generale dei beni di fortuna per la conduzione di una vita felice.
A questo punto, bisogna però sottolineare come le implicazioni del discorso non chiamino in causa la sola dimensione individuale, bensì anche quella internazionale, come non deve sorprendere vista la prospettiva cosmopolitica della tradizione, secondo la quale tutti gli esseri umani farebbero già parte di un ordine morale universale. Dovremmo sentirci obbligati nei confronti dei popoli diversi dal nostro, e fino a che punto? Una delle domande centrali del saggio, alla quale l’autrice risponde con un energico sì. Cicerone, per altri versi un modello da seguire, da questo punto di vista non sembra più un interlocutore affidabile, dal momento che ripropone a livello internazionale la distinzione tra doveri di giustizia e di aiuto materiale, sostenendo che nelle relazioni tra stati non si dovrebbe pretendere altro che il rispetto dei primi. Occorre allora richiamarsi ad altri autori, per elaborare una teoria della giustizia globale più comprensiva, ed è proprio quello che l’autrice intende fare rivolgendosi a pensatori come Ugo Grozio e Adam Smith.

Mona Hatoum - Hot Spot (2013) Il giurista olandese ha il grande merito di traghettare la tradizione stoica nel mondo moderno, calando la prospettiva cosmopolitica nell’orizzonte della statualità. Ecco allora che la concezione groziana del diritto internazionale, incentrata sul riconoscimento di una legge naturale a fondamento della politica, può rivelarsi di grande ispirazione per Nussbaum, insieme alla sua difesa del principio di sovranità. Il tentativo di conciliare i due aspetti, bisogna ammetterlo, finisce inevitabilmente per alimentare tensioni. Se è vero infatti che la ragione impone al potere politico di rispettare l’umanità, secondo Grozio questo non deve neanche diventare un pretesto per ingerirsi in modo sistematico nelle vicende degli altri stati. Difficile però stabilire un criterio univoco, una regola generale per disciplinare l’intervento umanitario, che viene giustificato solo come extrema ratio. Come viene spiegato, «il mondo delineato da Grozio è quindi tutt’altro che semplice. Pur prevedendo un’evoluzione del diritto internazionale, egli prefigura un mondo in cui continuano a esistere anche norme morali vincolanti ma non sancite dal diritto positivo, a meno che questa o quella nazione non le trasformi in leggi» (p. 98). La speranza è allora che le sovranità esistenti traducano sul piano legislativo i comandi della ragione, e che nel frattempo la comunità internazionale si impegni a intervenire nelle vicende degli altri stati solo di fronte a intollerabili crimini contro l’umanità. Oltre a questo, un altro fondamentale contributo del giurista, che in questo innova rispetto alla posizione di Cicerone, va ricercato nella concezione groziana dei beni comuni, ovvero dei doveri di aiuto materiale su scala internazionale, una dimensione del suo pensiero spesso trascurata. Pur senza prefigurare meccanismi o istituti precisi, Grozio avrebbe infatti sostenuto l’imperativo dei paesi ricchi di venire in aiuto dei popoli in difficoltà, spingendosi ad affermare qualcosa di rivoluzionario, ovvero che la condizione d’indigenza, lo stato di necessità che attanaglia i poveri, darebbe loro pieno diritto alle risorse di cui non dispongono, e che anzi ne sarebbero loro i legittimi proprietari.
Sull’importanza dei beni materiali, questa volta nell’ambito di una riflessione più generale sullo sviluppo della personalità umana, Nussbaum analizza poi la posizione di Adam Smith. Nelle pagine del saggio, il filosofo scozzese smette i panni del liberista appassionato e si scopre teorico della giustizia redistributiva. Il riferimento non va alla Teoria dei sentimenti morali, come ci si potrebbe attendere, giudicata dalla filosofa ancora troppo debitrice del rigorismo stoico, ma proprio alla Ricchezza delle nazioni, il classico dell’economia politica, dove Smith riabilita la dimensione pratica dell’esistenza, emancipandola dal disprezzo che una lunga tradizione le aveva riservato. Sensibile alle rivendicazioni dei lavoratori contro le iniquità, egli auspica che lo stato garantisca a tutti un’istruzione minima, affinché le capacità innate presenti in ogni essere umano non deperiscano. Pur senza auspicare stravolgimenti, ecco forse perché l’autrice lo preferisce a un pensatore come Marx, il filosofo scozzese ci ricorda che «la dignità umana non è simile a una roccia, ma è semmai una tenera pianta che in condizioni inclementi appassirà» (p. 136), e che la collettività ha il dovere d’intervenire a favore degli svantaggiati.
Nussbaum prosegue l’itinerario giungendo all’epoca dell’interconnessione globale, dove il cosmopolitismo diviene per ragioni strutturali una prospettiva non solo attraente ma anche necessaria. Bisogna recuperare la tradizione mettendola a confronto con le sfide del presente, nella direzione di un «liberalismo politico globale materialista, basato sulle nozioni di capacità e di funzionamento dell’uomo» (p. 195). Le proposte avanzate dalla filosofa sono molteplici, e appaiono in linea con la sua produzione teorica precedente, come quando – emancipandosi dall’antropocentrismo stoico – afferma l’esigenza di estendere il riconoscimento della dignità a tutti i senzienti. O come quando, arricchendo la lista delle capacità umane che a suo giudizio dovrebbero essere garantite universalmente, confida che sia possibile trovare un consenso per intersezione con qualsiasi cultura. A ogni modo, le pagine più interessanti dell’ultimo lavoro concernono la società internazionale. Considerati i deficit delle organizzazioni sorte in seguito al secondo conflitto mondiale, lungi dall’autrice prospettare soluzioni radicali come la costituzione di un governo planetario, del tutto irrealistico, o auspicare nel breve periodo che i diritti umani vengano riconosciuti e garantiti ovunque allo stesso modo. «La società internazionale rimane soprattutto un ambito di persuasione morale, e solo in rari casi diventa una vera e propria sfera politica. Ma ciò non significa che il processo di creazione e ratifica dei documenti sia inutile: esso genera un senso di solidarietà e di finalità comune, creando le premesse per l’emergere di potenti movimenti transnazionali capaci di influenzare le politiche nazionali» (p. 195). Senza impegnarsi in progetti irrealistici dal punto di vista istituzionale, Nussbaum intende riattualizzare il cosmopolitismo stoico, provando a conciliarlo con il principio della sovranità nazionale. Una prospettiva equilibrata, si direbbe, che ricorda quella di Grozio. Leggendo tra le righe, si viene però a scoprire che è solo la sovranità democratica a meritare considerazione morale, sebbene l’autrice eviti di esplicitarne le conseguenze. Ove si verifichino violazioni dei diritti umani, si deve quindi ritenere legittimo l’intervento umanitario? Nei casi estremi, sembrerebbe di sì. Ma non è affatto chiaro quali soggetti istituzionali dovrebbero farsene carico, se le sole organizzazioni internazionali, che però non sembrano godere dell’autonomia necessaria, o addirittura ogni stato moralmente ispirato. Fatta eccezione per il primo interrogativo, l’autrice non fornisce le doverose spiegazioni, preferendo rimanere sul piano dei principi: inutile rilevare che si tratta però di questioni ineludibili, impossibili da accantonare, e che rappresentano il banco di prova di ogni cosmopolitismo davvero conseguente.
Sulla scorta di Grozio e Smith, Nussbaum insiste poi sulla necessità dell’aiuto materiale alle nazioni sottosviluppate. Ma anche in questo caso, sebbene le dichiarazioni di principio siano più che condivisibili, a colpire è soprattutto l’afflato normativo. Da notare per inciso come l’autrice rifugga da ogni analisi vagamente strutturale del sistema economico mondiale: la prospettiva rimane individualista, incentrata sulla distinzione manichea tra paesi ricchi, i quali avrebbero il dovere morale di condividere parte delle loro risorse, e paesi poveri, bisognosi del soccorso internazionale. Per quanto animato dalle migliori intenzioni, il suo monito presenta almeno due problemi. Da un punto di vista geopolitico, è chiaro che dietro agli aiuti economici si celano molto spesso i disegni imperiali delle grandi potenze, le uniche peraltro a poter elargire risorse significative in mancanza di istituzioni internazionali indipendenti a livello finanziario: la generosità ha valore in quanto tale, certo, ma rappresenta anche una forma particolarmente subdola di esercizio del potere. Nussbaum questo lo sa bene, ma tale consapevolezza non mette capo a una seria problematizzazione degli aiuti all’estero, di cui la filosofa si limita a sostenere l’assoluta necessità morale.[1] Inoltre, per venire al secondo punto, non sembra che la proposta di Nussbaum riesca davvero a emanciparsi dall’accusa di paternalismo, nonostante i molteplici tentativi profusi in tal senso. Ammesso infatti che i paesi ricchi abbiano il dovere d’intervenire a favore di una maggiore eguaglianza planetaria, e che riescano a farlo in modo equamente distribuito, che cosa dovrebbero fare nel frattempo quelli poveri? L’interrogativo è di quelli cruciali, considerando che il saggio ha rivendicato a chiare lettere il diritto universale a un’esistenza dignitosa. Al quietismo, obiettivamente inaccettabile, sembrano profilarsi tre alternative fondamentali. La prima alternativa è rappresentata dalla migrazione economica verso le aree del pianeta più sviluppate, una possibilità che Nussbaum ritiene vada garantita, ed entro certi limiti anche implementata, ma pur sempre nel rispetto delle sovranità nazionali dei paesi ospitanti, che legittimamente pretendono di governare i flussi: il bilanciamento tra accoglienza e protezione, maggiore o minore inclusività delle politiche migratorie, viene quindi rimesso ai singoli governi. Un altro scenario è rappresentato dalla ripresa del conflitto – variamente inteso, anche in senso bellico – contro i paesi ricchi sfruttatori di risorse, uno scenario che però l’autrice neanche prende in considerazione, non fosse altro che per le evidenti difficoltà a ricomprenderlo in una visione morale della politica. Infine, rimane pur sempre aperta la via tracciata dagli stoici, i quali raccomandavano il distacco e l’indifferenza nei confronti dei beni materiali come viatico per la serenità dell’animo: una possibilità che Nussbaum come abbiamo visto rifiuta a livello individuale, e tanto più a livello collettivo. Alle nazioni povere non resta dunque che continuare a fare quello che hanno sempre fatto, tentare cioè di sopravvivere alle dure regole del mercato mondiale varando riforme in grado di stimolare la crescita economica, nella speranza che la comunità internazionale, a cui nello specifico Nussbaum indirizza il suo messaggio, intervenga con politiche di solidarietà.
Che cosa dire, in conclusione? Stimolante per i temi affrontati, indubbiamente di grande attualità, oltre che per l’originale rilettura di Cicerone, Grozio e Smith, il saggio di Nussbaum apre forse più questioni di quante non riesca a risolverne. Se alcune tesi di fondo risultano convincenti, come l’equiparazione tra doveri di giustizia e doveri di aiuto materiale, o il superamento dell’orizzonte antropocentrico nella direzione di un riconoscimento trasversale della dignità, la sua proposta normativa sconta però tutti i limiti della teoria morale, in un certo senso inevitabili. Senza prospettare una futura Cosmopolis, Nussbaum non auspica neanche un ritorno unilaterale alle sovranità nazionali: in quella terra di nessuno, in effetti la sola terra a nostra disposizione, esitiamo tuttavia ad affidarci alla sua bussola.
Note
[1] «Chi sostiene queste tesi è sicuramente ispirato dalle migliori intenzioni, ma rischia di limitarsi a una esibizione di scrupoli morali. Ciò che questi autori sembrano ignorare è che le società moderne sono caratterizzate da una netta differenziazione funzionale fra il codice politico e il codice delle interazioni personali» Zolo D., (1995). Cosmopolis. La prospettiva del governo mondiale. Milano: Feltrinelli, p. 92.
di Michele Gimondo
-
 All’interno delle opere che contribuiscono ad arricchire il panorama letterario sul neoliberalismo, alcune si occupano di individuarne la genesi o di circoscriverne l’attuale fenomenologia (dalla governamentalità flessibile alla gestionalità operante tramite eccezioni e stati di crisi), altre si dedicano a una ricostruzione della sintomatologia che affligge le soggettività in perenne (dis)equilibrio tra imprenditorialità di sé e precariato, poche – dopo aver obiettivamente constatato lo stato di reale crisi in cui versa il presente – azzardano, oltre alla diagnosi, una possibile cura. In questa direzione si muove invece Per la critica della ragione europea. Riflessioni sulla spiritualità illuminista, di Giovanni Leghissa, pubblicato quest’anno da Mimesis per la collana “Spiritualità senza Dio?” diretta da Luigi Berzano.
All’interno delle opere che contribuiscono ad arricchire il panorama letterario sul neoliberalismo, alcune si occupano di individuarne la genesi o di circoscriverne l’attuale fenomenologia (dalla governamentalità flessibile alla gestionalità operante tramite eccezioni e stati di crisi), altre si dedicano a una ricostruzione della sintomatologia che affligge le soggettività in perenne (dis)equilibrio tra imprenditorialità di sé e precariato, poche – dopo aver obiettivamente constatato lo stato di reale crisi in cui versa il presente – azzardano, oltre alla diagnosi, una possibile cura. In questa direzione si muove invece Per la critica della ragione europea. Riflessioni sulla spiritualità illuminista, di Giovanni Leghissa, pubblicato quest’anno da Mimesis per la collana “Spiritualità senza Dio?” diretta da Luigi Berzano.Se l’autore presenta la proposta teorica contenuta in questo breve saggio come un manifesto, il lettore non stenterà a riconoscere in esso, oltre ai tratti dichiaratamente utopici o critico-polemici che lo connotano, la continuazione sistematica di quel progetto politico che già si intravvedeva all’interno della Conclusione Provvisoria contenuta in Neoliberalismo: un’introduzione critica, (Mimesis 2012). La necessità di interrogarsi sul tema della responsabilità in un contesto teorico in cui sembra non esserci più spazio per le teorie globali della giustizia, l’urgenza di mettere in risalto gli elementi – anche emotivi – che orientano le scelte umane all’interno di uno scenario contemporaneo che aumenta progressivamente di complessità e incertezza, e l’importanza di riflettere sulle capacità razionali che caratterizzano la conditio humana in quanto tale diventano, in questo testo, la cornice di senso – per usare un’espressione cara all’autore – all’interno del quale postulare la fondazione di una collettività d’appartenenza europea che si riconosca nella sua comune matrice culturale e, conseguentemente, politica.
L’idea di Europa, da intendersi non tanto come luogo geografico, ma come principio di legittimazione politica, consente all’autore, che da tempo si dedica allo studio del sistema neoliberale e delle sue criticità (Cfr. Leghissa & Becchio 2017), di proporre una tesi fondativa: la sovranità europea, all’interno dello scacchiere geopolitico, è a rischio e, con essa, quella concezione del mondo che, derivataci dall’Illuminismo, ha garantito per secoli la prosperità di un modo di vivere associato basato su ideali quali la libertà, la giustizia e l’uguaglianza di fronte alla legge. In quest’ottica, la proclamazione della necessità urgente di prassi politiche che ci conducano alla costituzione di una federazione europea e l’appello culturale a una “mitologia della ragione” di stampo hegeliano si pongono non semplicemente come rimedi ai sintomi di una crisi che imperversa un continente popoloso ma ormai in declino, come quello europeo, quanto come soluzioni che hanno visualizzato la crisi nella sua eterogeneità e che hanno evidenziato nell’assenza di un mito fondativo a cui radicare la propria appartenenza la causa della deriva culturale e politica insieme del continente.
All’interno della digressione sul presente che si dipana a partire dalla riflessione kantiana sull’ Aufklärung, Foucault attribuisce alla filosofia, in quanto pratica discorsiva dotata di una propria storicità, la necessità di collocarsi all’interno della propria attualità, per «dirne il senso» (2014, p .118), ma anche per sondare la modalità d’azione esercitabile all’interno di questa attualità. Facendo tesoro del monito foucauldiano, la proposta contenuta nella Critica per la ragione europea interroga il presente e, così facendo, entra nel discorso politico da un lato, producendo un’architettura del reale alternativa rispetto a quella nota, la costituzione degli Stati Uniti d’Europa, dall’altro, suggerendo un’altra modalità secondo cui costituire la soggettività e il rapporto che essa intrattiene con la sua attualità, per mezzo di una spiritualità autenticamente atea. Secondo il principio per cui ogni trasformazione, individuale o collettiva, è data dalla combinazione originale di elementi dati, il richiamo all’Illuminismo e al suo specifico uso della critica e della riflessività in quanto paradigmi fondativi del pensiero moderno, ma anche come principi d’indagine teorica, consentono all’autore di individuare preventivamente e di riflettere sulle inevitabili debolezze del suo manifesto e di renderlo così collocabile entro un orizzonte di possibilità perseguibili.

Se nella lettera a Erodoto Epicuro insisteva sulla necessità di «cogliere quello che sta a fondamento delle parole» al fine di poter giudicare su fenomeni la cui problematicità è ancora irrisolta e di radicarsi al raziocinio per l’indagine dei fenomeni, Leghissa compie un’operazione simile all’interno del suo saggio compiendo un’attività di demistificazione dei significati a carico di complessi concettuali spesso usati impropriamente. Aldilà delle similitudini di metodo, la capacità di critica, cui l’autore sembra auspicare come principio generale per la lettura del presente testo, all’interno del saggio diventa quindi il mezzo per ridefinire alcuni termini della questione europea (solo per citarne alcuni: globalizzazione, p. 68, laicità, p. 88, ragione, p. 119, spiritualità p. 139) e la ricollocazione semantica che attua, mira a liberare il lettore da un mostro a tre volti, ognuno dei quali incarna le paure che immobilizzano attualmente la cittadinanza europea, con intento analogo a quello che animava il tetrafarmaco epicureo.
La paura è un tratto emotivo facilmente riconoscibile nella moltitudine che anima la nostra società; Leghissa intravede in questa paura la causa della presente crisi europea e, all’interno del primo capitolo della Critica si occupa diarticolare i vari volti della paura in sezioni tematiche che, se connesse, si riducono di complessità. La paura dello straniero, della globalizzazione e della guerra diventano inaggirabili a meno che non si abbia la capacità di articolare intorno a queste un discorso unico e significativo. Vedere lo straniero in termini di risorsa o di pericolo da includere o escludere dalla propria comunità politica; leggere nella globalizzazione un dispiegamento assoluto e totalizzante della ragione economica pronta a invadere le vite dei cittadini, abbandonati in stati d’eccezione perenne in cui la legge è sospesa; immaginare la guerra come uno scenario pericoloso, ma da cui difendersi non nominandolo sono tutte strategie che consentono di avere sempre delle risposte che appagano l’emotività ma non risolvono in alcun modo lo stato di crisi che tutti sperimentiamo quotidianamente. Comprendere la correlazione tra mito e politica e assumersi la responsabilità (individuale quanto collettiva) di ergere la propria mitologia di derivazione illuminista a fondamento ineliminabile della propria cultura comporterebbe un posizionamento identitario che da un lato, non avrebbe più motivo di temere il confronto con un’altra realtà religiosa – che, con l’ausilio della critica e della ragione, verrebbe identificata come una narrazione significativa tra le tante possibili – dall’altro consentirebbe un’affermazione politica originale in un terreno geopolitico tendenzialmente aggressivo. Ancora, vedere la globalizzazione come una molteplicità collettiva di attori variamente costituita e distribuita su differenti livelli di gerarchizzazione che ridisegna lo spazio in cui si muove attraverso il controllo e la gestione di flussi (di denaro, di merci, di individui etc.) consente di tener presente un aspetto che depotenzia enormemente la teoria di un dominio inarrestabile dei mercati; ogni interazione si origina a partire da una cornice statale e istituzionale e ogni mediazione viene salvaguardata dalla condivisione di modelli mentali da parte di coloro che sono a capo delle organizzazioni. In altre parole, ogni interazione – per quanto disseminata sul piano globale – è normata e tende al successo, nella misura in cui «ogni istituzione, o organizzazione, persegue un unico fine: sopravvivere» (p. 45). Infine, intendere le azioni militari compiute dagli eserciti europei nei diversi scenari del pianeta e gli atti terroristici che immobilizzano le nostre città per quello che sono realmente, ossia atti di guerra, consentirebbe di volgere la discussione pubblica sulla possibilità di una comune difesa europea che renda tangibile quel senso di comunità che i membri dell’Unione Europea si ostinano a difendere almeno verbalmente e che affermi l’esistenza politica dell’Europa aldilà dei suoi confini.

E. Isgrò, Preghiera all'Europa, 2016
La seconda sezione del testo – La laicità e le forme della condivisione – si apre con una digressione riguardante il processo di decision making: essere consapevoli del fatto che le scelte vengono fatte da parte di individui razionali all’interno di «cornici di senso e istituzionali» che orientano la scelta e che «tali cornici hanno un impatto sulla sfera emotiva degli individui» (p. 75) aiuta a comprendere il perché sia importante un orientamento collettivo volto a valorizzare il terreno simbolico intorno al quale gravita la cultura europea. Nessuna scelta, per quanto razionale, viene perseguita in nome della razionalità e le argomentazioni nulla valgono di fronte a sistemi di credenze, magari erronei, ma consolidati: questo è il motivo per cui non basta indicare una via razionalmente perseguibile per uscire dalla crisi attuale e le politiche dell’inclusione non sono mai servite a scalfire l’inclinazione razzista che compare periodicamente in ogni paese. Un cambiamento rilevante si avrebbe invece riconoscendo la forza del legame che intercorre tra la sfera affettiva dell’individuo e il suo vivere politico e ponendo in primo piano la narrazione mitica in luogo dell’argomentazione razionale. In questo senso, la laicità atea che, pur consapevole dell’importanza della componente religiosa nell’esperienza umana, si impegna a spiegare i comportamenti religiosi in termini storici, può farsi mito e principio fondativo del vivere comune da far valere come fondazione politica degli Stati Uniti d’Europa «in grado di rendere inutili le controversie su chi è europeo e chi no sulla base dell’adesione a questo o quel sistema di credenze religiose» (p.98).
È possibile che una laicità atea di matrice materialista venga a costituire il mito fondativo intorno a cui articolare una modalità di vivere propriamente europea, ma è davvero possibile considerare l’ateismo una forma di religiosità? Nell’ultima sezione del saggio, Il materialismo come esperienza spirituale, l’autore indaga la relazione tra materialismo – su cui articolare una mitologia della ragione (p.125) – e il mondo degli affetti dell’individuo, consapevole di quanto non sia la persuasione cognitiva a render conto dell’agire morale o dell’attitudine spirituale dell’uomo. Forte dei risultati provenienti dalla biologia evolutiva, Leghissa rassicura tanto sulla possibilità di interazioni simpatetiche e altruistiche tra sapiensanche all’interno di un orizzonte finito e vulnerabile, come quello materialista, tanto sulla possibilità del materialismo stesso di entrare in risonanza con la sensibilità umana a tal punto da orientare significativamente il suo sguardo sul reale e costituirsi, in un’ultima analisi, come spiritualità.
Ragione, ateismo, laicità, storicità, scientificità del metodo, stato di diritto, norme, uguaglianza, libertà sono alcuni dei termini che costituiscono una rete concettuale a cui ogni europeo, a partire dalla modernità, farebbe riferimento nel tentativo di esplicitare il senso di appartenenza che lo radica al suo continente; la proposta contenuta in Per la critica della ragione europea suggerisce di articolare questa rete in una narrazione mitica che, risuonando nella sfera affettiva dell’uomo, sia in grado di dare statuto a questa appartenenza, salvaguardarla e fondarla politicamente tramite la costituzione degli Stati Uniti d’Europa. La realizzazione, spetta a noi.
di Evelina Praino
Bibliografia
Leghissa, G., Per una critica della ragione europea. Riflessioni sulla spiritualità illuminista, Mimesis, Milano-Udine 2019.
Leghissa, G., Neoliberalsimo. Un’introduzione critica, Mimesis,Milano-Udine 2012.
Leghissa, G. Becchio, The Origins of Neoliberalism. Insights from economics and philosophy, Routledge, London-New York 2017.
Foucault, M., Il problema del presente. Una lezione su “Che cos’è l’illuminismo?” di Kant, In Poteri e Strategie, Mimesis, Milano-Udine 2014, p. 115-126.
-
Carlo Ginzburg – Nondimanco. Machiavelli, Pascal
Recensioni / Febbraio 2019 Vi sono dei momenti nella storia del pensiero saggistico in cui lo studio di un autore o l’esegesi di un’opera sanno trasformarsi in un racconto sapiente capace di srotolare e riannodare, quasi d’improvviso, il filo di idee ritenute immutabili. Nell’ultimo lavoro di Carlo Ginzburg (Nondimanco. Machiavelli, Pascal, Adelphi, Milano, 2018, pp. 242, € 18,00), assistiamo alla storia silenziosa ma incisiva di una parola sottile, larvata, che passo dopo passo guida e rivela al lettore gli intrichi nascosti nel cuore del pensiero politico e filosofico rinascimentali. Formalmente il volume raccoglie nove saggi più un’Appendice. Alcuni di questi, già precedentemente pubblicati, sono stati sottoposti a un processo di riscrittura o traduzione sostanziale da cui scaturisce un’opera per larga parte inedita, dotata di spirito unitario e armonico. Il primo dei saggi raccolti nel volume (Machiavelli, l’eccezione e la regola. Linee di una ricerca in corso) contiene forse quella che può definirsi la novità più dirompente degli ultimi studi machiavelliani. La scoperta riguarda proprio il termine che dà il titolo all’opera: nondimanco. Parente quattrocentesco dell’odierno “nondimeno”, questa semplice congiunzione appare, in realtà, lo specchio di un messaggio potente e arcano. Come un rintocco incalzante, essa fa capolino nei passaggi più intensi delle principali opere machiavelliane, scandendo lo svolgersi dei paragrafi, il susseguirsi dei pensieri, ma soprattutto enfatizzando il ruolo che oppone la regola all’eccezione, la norma generale alla singolarità del caso.
Vi sono dei momenti nella storia del pensiero saggistico in cui lo studio di un autore o l’esegesi di un’opera sanno trasformarsi in un racconto sapiente capace di srotolare e riannodare, quasi d’improvviso, il filo di idee ritenute immutabili. Nell’ultimo lavoro di Carlo Ginzburg (Nondimanco. Machiavelli, Pascal, Adelphi, Milano, 2018, pp. 242, € 18,00), assistiamo alla storia silenziosa ma incisiva di una parola sottile, larvata, che passo dopo passo guida e rivela al lettore gli intrichi nascosti nel cuore del pensiero politico e filosofico rinascimentali. Formalmente il volume raccoglie nove saggi più un’Appendice. Alcuni di questi, già precedentemente pubblicati, sono stati sottoposti a un processo di riscrittura o traduzione sostanziale da cui scaturisce un’opera per larga parte inedita, dotata di spirito unitario e armonico. Il primo dei saggi raccolti nel volume (Machiavelli, l’eccezione e la regola. Linee di una ricerca in corso) contiene forse quella che può definirsi la novità più dirompente degli ultimi studi machiavelliani. La scoperta riguarda proprio il termine che dà il titolo all’opera: nondimanco. Parente quattrocentesco dell’odierno “nondimeno”, questa semplice congiunzione appare, in realtà, lo specchio di un messaggio potente e arcano. Come un rintocco incalzante, essa fa capolino nei passaggi più intensi delle principali opere machiavelliane, scandendo lo svolgersi dei paragrafi, il susseguirsi dei pensieri, ma soprattutto enfatizzando il ruolo che oppone la regola all’eccezione, la norma generale alla singolarità del caso.Un semplice esempio può apparire chiarificatore. In un breve inciso dei Discorsi (iii, 40) concernente l’uso che dell’inganno si fa nelle circostanze di guerra, Machiavelli scrive: «Ancora che lo usare la fraude in ogni azione sia detestabile, nondimanco nel maneggiare la guerra è cosa laudabile e gloriosa».
L’opposizione è chiara: esiste una regola, che ordinariamente va seguita, ma esiste anche l’irruzione del reale, il suo scarto, la sua dinamica intrinseca di eccezionalità, che impone, come contro-regola, la violazione stessa del principio generale. I due argomenti, si badi, viaggiano insieme, ma il secondo («laudabile e glorioso») prevale sempre sul primo.
Ecco dunque che quello che può sembrare un dettaglio insignificante nello stile narrativo di Machiavelli – un avverbio dotato di semplice funzione oppositiva – diviene in realtà il centro di una serie di interrogativi fondamentali. Da dove nasce, infatti, quest’uso? Cosa rappresenta filosoficamente la congiunzione “nondimanco” nell’argomentare specifico di Machiavelli? E quale valenza politico-giuridica assume nell’economia complessiva del suo pensiero?
Ginzburg risolve l’enigma con un gesto preciso e geniale. Analizzando la biblioteca dei volumi di casa Machiavelli, e soffermandosi in particolare sul libro mastro degli acquisti di Bernardo – il papà di Niccolò –, Ginzburg rinviene l’esistenza di un testo misterioso e dimenticato, la Novella intitulum de regulis iuris (nota anche come Quaestiones mercuriales). Opera principale del giurista medievale Giovanni D’Andrea, in essa è racchiuso un breve passaggio in cui l’autore distingue tra princìpi generali (ad esempio, l’usura è condannabile) e deroga ai princìpi imposta dalle circostanze (l’usura è ammissibile). Incredibilmente, nella commedia La Mandragola, Machiavelli utilizzerà questo stesso identico approccio per poi farlo rimbalzare, quasi del tutto intatto, nel corpo testuale de Il Principe.
Ecco così originarsi, da questa semplice ma rivoluzionaria scoperta, il vero fuoco dell’analisi di Ginzburg. “Nondimanco” non opera più come una semplice congiunzione, bensì come termine-concetto, come una soglia capace di incorporare l’eco lontana di un pensiero giuridico-medievale intriso di casi, di eccezioni, di deroghe. Più radicalmente, nondimanco marca l’operare stesso di una cesura: quella che oppone princìpi generali e anomalie, regole e caso serio, canone e precetto pratico. Il giovane Niccolò, erede quattrocentesco di questa tradizione, assimilò appieno lo spirito degli antichi trattati medievali trasmutandone la diegesi casuistica. Ciò che ne scaturirà, come noto, sarà una filosofia di aspetto profondamente diverso, più vigorosa e nervosa forse, di certo pronta per risuonare nelle tumultuose vicende della politica prerinascimentale italiana, ma pur sempre raccolta nel ricordo pulsante della sua antica origine giuridico-canonista.
Ma Nondimanco non è soltanto un saggio che rivolta dal di dentro il pensiero machiavelliano. Esso è anche la storia di una virgola, quella che campeggia nel sottotitolo del volume e che congiunge (o meglio, oppone) la figura del pensatore fiorentino a una, per certi versi, molto più inaspettata.
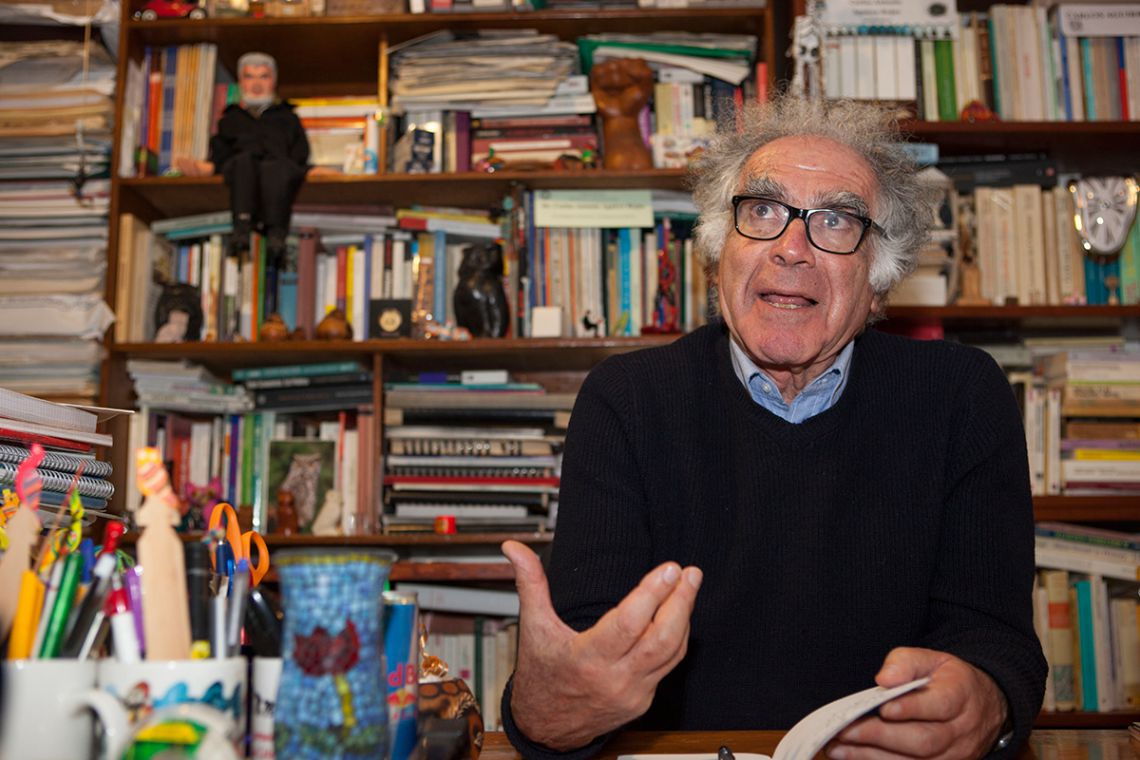
Nelle Provinciali, testo ricolmo di sottilissime ambiguità, sarà infatti proprio Pascal – o meglio il suo alter-ego, Louis de Montalte – a entrare in feroce polemica con la casistica medievale, arrivando financo a sbeffeggiare beffardamente la stessa opinione che si possano dare eccezioni vive contro regole morte. Eppure, intersecando la biografia di Pascal con i suoi più celebri Pensieri, Ginzburg riesce a rilevare l’intima similarità che accomuna il pensatore francese agli insegnamenti machiavelliani. Come si legge in un noto passaggio, «[g]li stati perirebbero se non si facessero piegare spesso le leggi alla necessità, ma la religione non ha mai ceduto a questo e non ne ha approfittato. Perciò occorrono questi adattamenti [accommodements] oppure dei miracoli» (Pensieri, 263). La salvezza di uno stato è consustanziale alla sua emergenza, si potrebbe chiosare. L’exceptio, o gli accommodements, sono ciò che riempie di senso vivo il guscio vuoto e privo di concretezza della regula juris. Anche per Pascal, lontano estimatore di Machiavelli, il miracolo diviene allora il caso serio, il gesto improvviso che squaderna una volontà superiore e dirompente: un emblema dell’eccezione, si potrebbe forse dire, tale e quale a quello che raffigurerà, secoli dopo, Carl Schmitt nella sua Teologia politica (1922; 1934).
Proprio per questo motivo quella piccola virgola incisa impercettibilmente nel sottotitolo del saggio diviene, per Ginzburg, qualcosa di più di una semplice interpunzione. Esattamente come la parola nondimanco, essa racchiude la storia di un’alchimia intellettuale, di un dialogo tra gli anni smarrito e poi ritrovato, condotto nell’esegesi dei documenti antichi, nel perdersi dei cataloghi, degli archivi, delle pagine apparentemente interrotte. In questo incontro mancato ma reso oggi nuovamente possibile, Pascal e Machiavelli sembrano ricomparire sul comune terreno della casuistica e, da lì, dialogare in un rinnovato intrecciarsi di posizioni, di tensioni, di conflitti.
Il merito ultimo del volume di Ginzburg, si può forse concludere, sta nell’incorporare sapientemente la corrispondenza nascosta tra schemi del pensiero, tra autori e filosofie apparentemente inconciliabili, per riordinarli poi attraverso un percorso diverso, non visto, non percepito, eppure da sempre silenziosamente operante. Quello che resta sul tavolo è un saggio denso, articolato e allo stesso fondamentale – un’opera in cui la storiografia critica sa farsi racconto appassionante e l’analisi dei testi e dei documenti antichi abbrivio per una ricerca nuova, coraggiosa, e forse ancora del tutto inesplorata.
di Mauro Balestrieri
-
Luca Basile – Scienza politica e forme dell’egemonia
Recensioni / Novembre 2016 Il volume Scienza Politica e forme dell’egemonia raccoglie tre studi di Luca Basile uniti da un tema comune, quello del rapporto fra governanti e governati e della teoria politica come sapere preposto all’interpretazione e gestione di tale rapporto. I tre saggi sono dedicati rispettivamente alla figura di Gaetano Mosca, al rapporto dialettico e polemico fra il pensiero di Gramsci e le posizioni di Mosca e al ruolo che il confronto con Robert Michaels ha avuto nel pensiero di Gramsci rispetto all’analisi del fascismo. Benché ogni saggio sia in sé compiuto e organizzato intorno a un tema centrale, essi costituiscono nel complesso un tentativo di fornire al lettore una prospettiva più ampia della rilevanza complessiva che il confronto con la tradizione dell’elitismo italiano ha rivestito per l’evoluzione e lo sviluppo del pensiero di Gramsci. Proprio a partire dai temi e dai contenuti di tale tradizione, diversamente interpretati da Mosca e Michaels, emergono influenze determinanti e obiettivi polemici nella riflessione gramsciana che coinvolgono sia il piano della riflessione epistemologica sullo statuto del sapere politico sia il tema specifico della classe dirigente, della sua composizione e trasformazione, che avrà un esito decisivo per il filosofo comunista nella teoria dell’egemonia.
Il volume Scienza Politica e forme dell’egemonia raccoglie tre studi di Luca Basile uniti da un tema comune, quello del rapporto fra governanti e governati e della teoria politica come sapere preposto all’interpretazione e gestione di tale rapporto. I tre saggi sono dedicati rispettivamente alla figura di Gaetano Mosca, al rapporto dialettico e polemico fra il pensiero di Gramsci e le posizioni di Mosca e al ruolo che il confronto con Robert Michaels ha avuto nel pensiero di Gramsci rispetto all’analisi del fascismo. Benché ogni saggio sia in sé compiuto e organizzato intorno a un tema centrale, essi costituiscono nel complesso un tentativo di fornire al lettore una prospettiva più ampia della rilevanza complessiva che il confronto con la tradizione dell’elitismo italiano ha rivestito per l’evoluzione e lo sviluppo del pensiero di Gramsci. Proprio a partire dai temi e dai contenuti di tale tradizione, diversamente interpretati da Mosca e Michaels, emergono influenze determinanti e obiettivi polemici nella riflessione gramsciana che coinvolgono sia il piano della riflessione epistemologica sullo statuto del sapere politico sia il tema specifico della classe dirigente, della sua composizione e trasformazione, che avrà un esito decisivo per il filosofo comunista nella teoria dell’egemonia.Il primo dei tre testi raccolti esamina la riflessione di Mosca sulla classe politica. Attraverso la complessa intersezione fra la categoria di scienza politica e quella di teoria della storia, Mosca tenta di mettere a punto un repertorio di strumenti teorici capaci di rendere conto da un lato della produttività della democrazia rappresentativa e del ruolo cardine che al suo interno può essere svolto unicamente dalla classe media, dall’altro dei rischi che tale modo di organizzazione sociale dello Stato correva all’inizio del Novecento. La riflessione dunque si muove fra due strati: da una parte la concretezza della storia, a cui la politica non può che appartenere (Mosca a tal proposito rigetta esplicitamente la posizione di Taine relativa a un calcolo extrastorico delle forme politiche); dall’altra la necessità di una riflessione che identifichi i princìpi e le tensioni che, se possono ritrovarsi secondo diversi gradi di sviluppo e forme di congiunzione nella concretezza di situazioni storiche differenti, sono nondimeno abbastanza generali da garantirne una tipizzazione affidabile, utile anche a interpretarne gli sviluppi e a garantirne la stabilità nella pratica.
A questa ambiguità ineliminabile nello statuto della scienza politica Mosca fa fronte identificando due princìpi, quello autarchico e quello liberale, e due tensioni, democratica e autoritaria, che risultano variamente combinati nel prodursi storico delle forme statuali. La scienza politica proposta da Mosca assume come suo compito appunto quello di governare sapientemente l’incessante fluttuazione fra principio autarchico e liberale, fra tensione democratica e autoritaria, evitando le ossificazioni eccessive quanto le trasformazioni incontrollate, alla ricerca di un equilibrio dinamico in cui la capacità di trasformazione del sistema faccia da necessario contrappunto e sostegno alla sua stabilità. Il sapere della scienza della politica è dunque chiamato allo stesso tempo ad assicurare e precisare il proprio statuto epistemologico, assumendo una nuova organicità che sia capace di rilevare i temi e gli sviluppi storici della prudenza politica nella gestione dello Stato ma al tempo stesso a rispondere concretamente alla congerie storica. Se infatti da un lato Mosca vede negli sviluppi delle scienze sociali descrittive l’emergere di un sapere capace di produrre infine una “politica scientifica”, è alla situazione contingente della crisi dello Stato liberale che tale politica dovrà rispondere.
A partire dall’assunzione del suffragio universale, infatti, il politologo palermitano vede emergere una tendenza che, consentendo l’ingresso delle masse e dei loro rappresentanti eletti sulla scena politica, mette seriamente in pericolo la struttura statuale. Per caratterizzare tale pericolo bisogna ricordare in primo luogo il ruolo strategico che egli attribuisce alla classe media come classe politica e in secondo luogo l’importanza che egli assegna, nella composizione della classe dirigente, alla funzione di diversi modi di selezione in concorrenza fra loro (per esempio, la classe burocratica e i rappresentanti eletti) in rapporto al mantenimento dell’equilibrio giuridico. La classe media è per Mosca quello strato sufficientemente grande della popolazione che, dotato di strumenti intellettuali e morali adeguati e di una relativa indipendenza economica dal potere, può interpretare gli interessi della totalità dello Stato e farsene portatore, mentre di contro le masse, prive di tali caratteristiche, sono unicamente capaci di esprimere attraverso i propri rappresentanti punti di vista e interessi particolari.
Indagando il punto di vista di Mosca rispetto alla relazione governanti-governati, allo statuto della scienza politica da costruirsi e al suo soggetto preferenziale da individuarsi nella classe borghese, Basile prepara poi il terreno per il confronto con la posizione e la critica di Gramsci. Per questi infatti, se è necessario riconoscere la realtà della relazione governanti-governati come fondante, è altrettanto fondamentale preoccuparsi di sviluppare una riflessione critica, che non guardi alla crisi del parlamentarismo liberale come a una soglia catastrofica che lo scienziato politico deve evitare, ma come la possibilità di una radicale trasformazione del rapporto fra le classi. La divaricazione che ne risulta non è solo politico-ideologica, ma anche epistemologica: si può dire che la riflessione di Gramsci intende iniziare proprio laddove quella di Mosca pone il suo estremo limite, vale a dire l’ingresso delle masse nella storia.

La prospettiva gramsciana ribalta il piano di una scienza della politica capace di prevedere e sopratutto gestire gli andamenti politici della società con un gesto deciso, attraverso una “storicizzazione integrale” della lettura politica a partire dalla quale l’apparente neutralità scientifica – o quantomeno i tentativi di neutralizzazione – che costituisce il nerbo della proposta moschiana appare ormai come dipendente dalla ipostatizzazione dello Stato liberale classico e incapace di sopravvivere alla sua crisi, della quale non può dunque riconoscere le potenzialità emancipative.
Il terzo saggio, il più corposo dei tre, intitolato Direzione Charismatica e primitivismo politico è dedicato secondo quanto afferma l’autore ad «avanzare una ricostruzione dello specifico del confronto di Gramsci con Robert Michels, prestando peculiare attenzione a come esso si riveli intrecciato, nelle sue implicazioni, alla enucleazione di alcune categorie portanti del lessico del dirigente comunista (‘bonapartismo’, ‘cesarismo’, ‘rivoluzione passiva’ etc.) in ordine agli snodi fondamentali della comprensione del fenomeno del “leaderismo carismatico”, commisurata all’analisi di insieme dell’affermazione del fascismo» (p.62). Rispetto a tale progetto, condotto con precisione attraverso un confronto serrato con i testi, l’autore dispone una contestualizzazione fondamentale rispetto al pensiero di Gramsci che mette in luce sia l’attenzione di Gramsci per i temi e gli snodi principali della tradizione elitista sia le numerose divergenze e critiche che proprio attraverso la consapevolezza di tale tradizione il filosofo comunista ha modo di formulare.
Senza poter in questa sede ripercorrere l’argomentazione, dobbiamo però sottolineare che in esso l’attenzione per gli aspetti epistemologici e metodologici relativi allo statuto della riflessione politica è costantemente intrecciata con le osservazioni e i temi tratti dalla contingenza storica. In Michels, infatti, l’interpretazione della leadership carismatica dipende strettamente dalla legge dell’oligarchia, secondo la quale i governati, costitutivamente incapaci di governarsi da sé, si rivolgono a una personalità dotata di determinate caratteristiche nel momento in cui il sistema che disponeva della divisione e della relazione fra governanti e governati si incrina. Per Gramsci è da criticare sia lo statuto ipostatizzato e astorico delle leggi e delle tendenze sociologiche per come esse appaiono nella prospettiva michelsiana sia, su un piano più concreto, l’immutabilità della relazione fra governanti e governati, che porta secondo Michels all’inevitabile ineguaglianza e acquisizione progressiva di autorità degli uni sugli altri. Di contro Gramsci, che inserisce Michels nel suo programma di letture relative ai Quaderni in vista di una rilettura della storia italiana che si concentri in particolare sull’evoluzione delle classi dirigenti, è motivato proprio dalla ricerca di una possibile trasformazione del rapporto fra governanti e governati, che, se parte dal riconoscere come fatto storico la presenza e l’influenza delle élite, deve informare l’azione di queste in direzione di una organicità armonica e non di una burocatizzazione autoritaria nei rapporti con le masse.
Solo a partire dall’analisi degli strumenti concettuali e delle costruzioni teoriche che informano questo tentativo si potrà tuttavia rendere giustizia al tentativo gramsciano e per tale compito la linea interpretativa che Basile intraprende e annuncia si rivelerà forse fondamentale. Essa, tuttavia, è lungi dall’essere compiuta: la natura circoscritta dei tre saggi delinea sì una prospettiva generale di grande interesse ma ne sviluppa le conseguenze relativamente a luoghi circoscritti. Ci auguriamo che nel futuro tale progetto possa essere sviluppato con maggiore organicità e autonomia e che la necessaria precisione tecnica delle prime esposizioni lasci maggiore spazio a una fruizione non strettamente limitata agli specialisti del diritto e della filosofia politica.
di Lorenzo Palombini
-
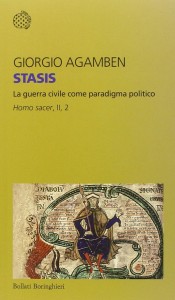 Nell’opera complessiva del filosofo italiano Giorgio Agamben emerge con singolare nettezza l’articolato e celeberrimo progetto che va sotto il nome di Homo sacer. È questa un’opera densa e articolata, avviatasi verso la metà degli anni ‘90 con l’omonimo saggio (Homo Sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Einaudi, 1995) e definitivamente conclusasi di recente con il volume L’uso dei corpi (Neri Pozza, 2014). Eppure, nella mente e nella penna dell’Autore sembra permanere ancora lo spazio per un’ulteriore incursione nel politico – un’incursione, forse, tra le più problematiche e complesse finora affrontate dall’intellettuale italiano. È questo il caso del recentissimo saggio Stasis. La guerra civile come paradigma politico, che raccoglie i contributi di due conferenze tenutesi presso l’Università di Princeton nel 2001; etichettato con la dicitura Homo sacer, II, 2 il testo si frappone tra il precedente Stato di eccezione ed il successivo Il Regno e la Gloria. A un primo sguardo, i temi del nuovo volume appaiono collegati e opposti nel medesimo frangente. Da un lato, si assiste a un breve esame critico della nozione greca di stasis, che sinteticamente va a indicare la guerra civile combattuta all’interno di una stessa comunità politica tra fratelli e concittadini. Dall’altro, trova invece spazio un originale e innovativo studio sull’opera più nota del filosofo inglese Thomas Hobbes (Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiastical and Civil, 1651), ossia su quella costruzione filosofico-giuridica che ergendosi al di sopra della moltitudine sociale scongiura per l’appunto il rischio del conflitto sociale. Ciò che va fin d’ora notato, tuttavia, è che l’approccio prescelto dall’Autore non è tanto quello di chiosare le note affermazioni che tradizionalmente si ripetono negli studi di settore, né quello di elaborare ex novo una teoria della guerra civile. L’interesse scaturente dalle pagine del breve scritto nasce dal desiderio di tracciare un nuovo filone critico sotteso allo studio della cd. stasiologia, e di sopperire in tal modo alla lacunosità del dibattito filosofico e giuridico attuali.
Nell’opera complessiva del filosofo italiano Giorgio Agamben emerge con singolare nettezza l’articolato e celeberrimo progetto che va sotto il nome di Homo sacer. È questa un’opera densa e articolata, avviatasi verso la metà degli anni ‘90 con l’omonimo saggio (Homo Sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Einaudi, 1995) e definitivamente conclusasi di recente con il volume L’uso dei corpi (Neri Pozza, 2014). Eppure, nella mente e nella penna dell’Autore sembra permanere ancora lo spazio per un’ulteriore incursione nel politico – un’incursione, forse, tra le più problematiche e complesse finora affrontate dall’intellettuale italiano. È questo il caso del recentissimo saggio Stasis. La guerra civile come paradigma politico, che raccoglie i contributi di due conferenze tenutesi presso l’Università di Princeton nel 2001; etichettato con la dicitura Homo sacer, II, 2 il testo si frappone tra il precedente Stato di eccezione ed il successivo Il Regno e la Gloria. A un primo sguardo, i temi del nuovo volume appaiono collegati e opposti nel medesimo frangente. Da un lato, si assiste a un breve esame critico della nozione greca di stasis, che sinteticamente va a indicare la guerra civile combattuta all’interno di una stessa comunità politica tra fratelli e concittadini. Dall’altro, trova invece spazio un originale e innovativo studio sull’opera più nota del filosofo inglese Thomas Hobbes (Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiastical and Civil, 1651), ossia su quella costruzione filosofico-giuridica che ergendosi al di sopra della moltitudine sociale scongiura per l’appunto il rischio del conflitto sociale. Ciò che va fin d’ora notato, tuttavia, è che l’approccio prescelto dall’Autore non è tanto quello di chiosare le note affermazioni che tradizionalmente si ripetono negli studi di settore, né quello di elaborare ex novo una teoria della guerra civile. L’interesse scaturente dalle pagine del breve scritto nasce dal desiderio di tracciare un nuovo filone critico sotteso allo studio della cd. stasiologia, e di sopperire in tal modo alla lacunosità del dibattito filosofico e giuridico attuali.Secondo Agamben, ciò che manca oggi è propriamente uno studio ragionato e consapevole sul conflitto civile, ossia un tentativo di pensare filosoficamente la crisi e lo scontro. Un tentativo, deve aggiungersi, che ben al contrario si attualizza nel desiderio compulsivo di gestire, risolvere e se possibile anticipare il caso serio, al fine di evitarne ogni possibile problematicità. Proprio alla luce di questa ansia di risoluzione, il dato intellettuale tristemente si smarrisce: a riprova di ciò stanno tanto l’assenza di testi giuridici e politologici di riferimento, quanto la crisi stessa del termine guerra civile, sintagma che nell’ambito internazionale si riduce oramai a fattispecie invocante il mero intervento regolativo degli organismi internazionali. Ecco dunque che di fronte alle civil (o, come sembra ormai consuetudine etichettarle, uncivil) wars non si elabora più una teoria volta alla loro comprensione, bensì si mira a un management delle medesime, ossia a un articolato sistema di iniziative che si esplicita nelle plurime attività «della gestione, della manipolazione e dell’internazionalizzazione dei conflitti interni» (p. 11). Per colmare questa sorprendente mancanza, il breve saggio di Agamben si incarica di mostrare due eclatanti manifestazioni storiche di tale paradigma, ricorrendo alla tradizione politica della Grecia classica e al pensiero filosofico di Thomas Hobbes. La convinzione che muove l’Autore in questo particolare percorso è infatti che entrambi i momenti rappresentino «le due facce di uno stesso paradigma politico, che si manifesta da una parte nell’affermazione della necessità della guerra civile e, dall’altra, nella necessità della sua esclusione» (p. 12). Tale opposizione, in altri termini, è il segno concreto di una loro intima vicinanza, che il consueto stile espositivo agambeniano chiarisce nelle sue plurime implicazioni.
Prima di tutto, il doppio e opposto significato del termine stasis, che va ad indicare tanto il concetto di immobilità, stabilità e mantenimento dello status quo, quanto quello di sedizione, rivolta e infine rivolgimento politico. Nella sua prima accezione, il termine giunge fino ai nostri giorni nelle forme note di stato ed istituzione (entrambi derivando, come lo stesso termine stasis, dal radicale “–sta” del verbo greco hìstemi). Nel suo secondo senso, il lemma sembra invece essersi dissipato, permanendo solo come antica vox media di un paradigma politico più ampio e quasi sotterraneo. Attraverso un’analisi delle sue molteplici ricorrenze sia in Tucidide sia in Platone, Agamben arguisce che in realtà l’emblematica indeterminatezza della voce ricade di fatto in una forma di ambiguità concettuale, in base alla quale la guerra civile esulerebbe tanto dall’oikos (ossia dal focolare domestico), quanto dalla pòlis (ossia dalla collettività urbana). Essa sarebbe quindi la zona di indifferenza tra lo spazio impolitico della famiglia e quello politico della città: «nel sistema della politica greca, la guerra civile funziona come una soglia di politicizzazione o di depoliticizzazione, attraverso la quale la casa si eccede in città, e la città si depoliticizza in famiglia» (p.24). In definitiva, la stasis opera come un reagente che rivela l’elemento politico nel caso estremo, ossia come una soglia di politicizzazione che determina di per sé il carattere politico o impolitico di un certo essere. Ulteriore conseguenza è che questa stessa indeterminatezza concettuale si riverbera nel formante giuridico, così come mostrato dall’istituto penalistico dell’amnistia. Se infatti il prendere parte alla guerra civile era nell’antica Grecia politicamente necessario, a conclusione del conflitto interveniva comunque la pacificazione sociale, che attraverso le forme dell’oblio (amnistia – da amnestèo – indica appunto la dimenticanza) sanava retroattivamente la partecipazione attiva dei suoi componenti. In questo senso, la stasis non è qualcosa che semplicemente deve essere rimosso, ma è «l’indimenticabile che deve restare sempre possibile nella città e che, tuttavia, non deve essere ricordato attraverso processi e risentimenti» (p. 29).
Nella Grecia classica, possiamo allora concluderne, non si dà una sostanza politica omogenea, ma un manifestarsi irregolare e continuo di correnti tensionali e instabili, esprimentesi in ultimo grado nelle forme della politicizzazione e della depoliticizzazione, ossia nella commistione belluina della famiglia e della città.
Ora, è precisamente per sconfiggere questo scenario mortifero e abissale che Hobbes costruirà il suo Leviatano, quell’immenso automa o “Dio mortale” composto da una moltitudine di piccole figure umane tradizionalmente intese come sudditi. Com’è facile scorgere esaminando i due diversi frontespizi dell’opera (l’uno vede rappresentati i sudditi con il viso rivolto verso il lettore; l’altro, coevo al primo, li coglie al contrario di spalle), gli esserini che compongono l’immenso meccanismo artificiale si uniscono saldamente gli uni agli altri. La spiegazione traslata è che ciò avviene per mezzo del loro reciproco accordo, che consente metaforicamente di compattarli dando luogo a quell’ideale corpo politico (body political) così caro al pensatore inglese.
Proprio la nozione di corpo politico, però, si presta alle più dure contestazioni: data la sua sfuggente consistenza, per Hobbes il popolo esiste solo nell’istante in cui si riunisce per nominare un leader o un’assemblea rappresentativa – ma in questo stesso istante svanisce improvvisamente. Il corpo politico, in altri termini, è qualcosa di altro e di impossibile, destinato continuamente a comporsi e subitaneamente a dissolversi nella costituzione del governo effettivo. È in questo preciso passaggio che Agamben ricerca un’affinità con il summenzionato meccanismo di esclusione/inclusione visto a proposito della guerra civile nella Grecia antica: «se il popolo, che è stato costituito da una moltitudine disunita, si dissolve nuovamente in una moltitudine, allora questa non soltanto preesiste al popolo/re, ma, come multitudo dissoluta, continua a esistere dopo di questo […] La moltitudine non ha un significato politico, essa è l’elemento impolitico sulla cui esclusione si fonda la città; e, tuttavia, nella città vi è soltanto la moltitudine, perché il popolo è già sempre svanito nel sovrano» (p. 55). Hobbes, rendendosi conto di tale aporia, oblitera il paradosso della moltitudine/corpo politico risolvendolo, com’è noto, con il ricorso immediato al pactum subiectionis. Ma se ciò ha il pregio di spezzare il circolo che dalla guerra civile conduce alla riconfigurazione della multitudo dissoluta, permane quale operazione problematica e nient’affatto ultimativa – un’operazione che lascia scoperto l’enorme problema di una possibile ripresentazione dello stato di natura e quindi del conflitto generalizzato.
Senza dubbio, è in questi termini che fino a oggi è stato pensato il fine ultimo del Leviatano: la posticipazione indefinita del conflitto civile. Il covenant alla base della sua formazione agirebbe, si sostiene, quale forza frenante rispetto all’avvento della discordia intestina, ossia quale meccanismo giuridico in grado di disinnescare a priori la fine dei tempi rappresentata dal collasso politico. In fondo, si può anche dire, il Leviatano fa
 paura proprio per questa ragione: se come si è visto la multitudo dissoluta può effettivamente frammentarsi in ogni istante e generare quindi un nuovo conflitto, lo Stato deve continuativamente incutere timore, un timore rivolto all’impedimento immediato di ogni sua concreta demolizione. Con un doppio ribaltamento, Agamben costruisce invece la propria conclusiva argomentazione accentuando la dimensione messianica e decisamente escatologica dell’intero pensiero hobbesiano. In tal senso il filosofo inglese, in accordo con il messaggio evangelico, configurerebbe il Leviathan quale “capo” di un political body, con ciò adoperando la nota immagine paolina che predica Cristo stesso quale “capo” dell’ekklesìa, ossia dell’assemblea dei fedeli. Se Cristo è il capo del corpo dell’assemblea, allora il Leviathan è il capo del corpo politico. Questo rispecchiamento profano del messaggio paolino conduce però a una precisa conseguenza: «nello stato attuale, Cristo è il capo del corpo dell’assemblea, ma, alla fine dei tempi, nel Regno dei cieli, non vi sarà più distinzione fra la testa e il corpo, perché Dio sarà tutto in tutti […] Ciò significa che alla fine dei tempi la finzione cefalica del Leviatano potrebbe essere cancellata e il popolo ritrovare il suo corpo. La cesura che divide il body political – soltanto visibile nella finzione ottica del Leviatano, ma di fatto irreale – e la moltitudine reale, ma politicamente invisibile, sarà alla fine colmata nella Chiesa perfetta» (p. 72). Un nuovo messaggio sembra allora profilarsi quale cifra complessiva di questa antica filosofia: lo Stato (di matrice hobbesiana) non ha affatto la funzione e il ruolo di una forza frenante o catecontica. Esso non vuole in alcun modo posticipare la fine dei tempi, ma al contrario avvicinarla escatologicamente, in modo da rendere reali l’avvento del Regno e la consumazione dei tempi. Buffamente, lo Stato-Leviatano – che nell’immaginario di tutti predicava la garanzia per la pace e la sicurezza dei sudditi – partecipa invece a una visione apocalittica del potere, in cui l’avvento catastrofico del Giorno del Signore è la lettera conclusiva dell’intera esperienza politica occidentale.
paura proprio per questa ragione: se come si è visto la multitudo dissoluta può effettivamente frammentarsi in ogni istante e generare quindi un nuovo conflitto, lo Stato deve continuativamente incutere timore, un timore rivolto all’impedimento immediato di ogni sua concreta demolizione. Con un doppio ribaltamento, Agamben costruisce invece la propria conclusiva argomentazione accentuando la dimensione messianica e decisamente escatologica dell’intero pensiero hobbesiano. In tal senso il filosofo inglese, in accordo con il messaggio evangelico, configurerebbe il Leviathan quale “capo” di un political body, con ciò adoperando la nota immagine paolina che predica Cristo stesso quale “capo” dell’ekklesìa, ossia dell’assemblea dei fedeli. Se Cristo è il capo del corpo dell’assemblea, allora il Leviathan è il capo del corpo politico. Questo rispecchiamento profano del messaggio paolino conduce però a una precisa conseguenza: «nello stato attuale, Cristo è il capo del corpo dell’assemblea, ma, alla fine dei tempi, nel Regno dei cieli, non vi sarà più distinzione fra la testa e il corpo, perché Dio sarà tutto in tutti […] Ciò significa che alla fine dei tempi la finzione cefalica del Leviatano potrebbe essere cancellata e il popolo ritrovare il suo corpo. La cesura che divide il body political – soltanto visibile nella finzione ottica del Leviatano, ma di fatto irreale – e la moltitudine reale, ma politicamente invisibile, sarà alla fine colmata nella Chiesa perfetta» (p. 72). Un nuovo messaggio sembra allora profilarsi quale cifra complessiva di questa antica filosofia: lo Stato (di matrice hobbesiana) non ha affatto la funzione e il ruolo di una forza frenante o catecontica. Esso non vuole in alcun modo posticipare la fine dei tempi, ma al contrario avvicinarla escatologicamente, in modo da rendere reali l’avvento del Regno e la consumazione dei tempi. Buffamente, lo Stato-Leviatano – che nell’immaginario di tutti predicava la garanzia per la pace e la sicurezza dei sudditi – partecipa invece a una visione apocalittica del potere, in cui l’avvento catastrofico del Giorno del Signore è la lettera conclusiva dell’intera esperienza politica occidentale.Diverse tradizioni sembrano allora confrontarsi nell’immagine storica di questa figura: da un lato quella terrifica di uno Stato assoluto e indomabile, che ingloba senza esitazione le anime di chi tenta di impossessarsene (come sottolinea vividamente Bodin nella sua Daemonomania). Dall’altro, quella cabalistica e messianica che intravede al contrario il grande monstrum scomparire nel festivo banchetto delle sue carni. Ma se la storia del pensiero politico sembra confinare tali interpretazioni all’archeologia del pensiero storico, una terza e parimenti inquietante forma di manifestazione è stata ben presente nella concezione dello Stato moderno. Una concezione che vedeva il Leviatano quale meccanismo artificiale e impersonale, in cui attraverso la generale neutralizzazione del politico si perveniva a una concezione del diritto quale strumento tecnico neutrale. L’annoso conflitto tra legalità e legittimità, che oggi prende le forme degli imperativi tecnici e della logica economica, produce ancora manifestazioni assolutizzanti e dotate di un vero e proprio carattere normativo, quali è facile incontrare nelle forme atipiche della soft law e della governance mondiale. Tali istanze scompaginano le categorie giuridiche fondamentali, costruendo e decostruendo lo stesso simbolo del Leviatano, e agendo come operatori eccezionali in grado di (ri)fondare l’ordine politico mondiale.
È forse attraverso la secolarizzazione di questa remota provenienza che sembra giunta allora l’epoca della stasis globale – un’epoca, suggerisce Agamben, in cui la politica contemporanea ricerca il proprio senso teologico senza riuscire pienamente a coglierlo, perché preda di una dimenticanza remota e inquietante che rimonta alle origine stesse della propria costituzione. Il contributo di Agamben, pur nell’estemporaneità della sua trattazione, è allora un piccolo ma denso tassello di un’opera ancora da scrivere e, forse, ancora da pensare.
di Mauro Balestrieri
-
 Quando Karl Marx si interrogò sul ruolo che la legge occupava nelle dinamiche della società moderna, scelse di risolverlo, come ben noto, negandole qualsiasi specifica autonomia: il diritto – come d’altronde la religione, la filosofia e la politica – non sarebbero nient’altro che il riflesso passivo, ossia una sovrastruttura, di quella concreta base economica che ben più attivamente si agita nel cuore della società. L’antica tradizione ebraica, di certo non sconosciuta allo stesso Marx, insegnava invece che la legge è stata data agli uomini perché questi la custodissero e la salvaguardassero dall’oblio, rendendo così tanto il Testo quanto la Voce dei suoi interpreti il suo sigillo imperituro. Chiunque osservi il funzionamento della società attuale, delle sue regole e dei suoi vincoli, dei suoi flussi e dei suoi varchi, può domandarsi se queste note affermazioni mantengano ancora qualcosa delle proprie antiche verità. Nella recente pubblicazione di Pier Giuseppe Monateri tali stringenti interrogativi si uniscono a un’analisi inedita e originale, in cui attraverso un approccio comparatistico si indaga sull’origine del fenomeno giuridico nella tradizione Occidentale e sugli effetti che le memorie normative suscitano negli attuali processi economici e produttivi.
Quando Karl Marx si interrogò sul ruolo che la legge occupava nelle dinamiche della società moderna, scelse di risolverlo, come ben noto, negandole qualsiasi specifica autonomia: il diritto – come d’altronde la religione, la filosofia e la politica – non sarebbero nient’altro che il riflesso passivo, ossia una sovrastruttura, di quella concreta base economica che ben più attivamente si agita nel cuore della società. L’antica tradizione ebraica, di certo non sconosciuta allo stesso Marx, insegnava invece che la legge è stata data agli uomini perché questi la custodissero e la salvaguardassero dall’oblio, rendendo così tanto il Testo quanto la Voce dei suoi interpreti il suo sigillo imperituro. Chiunque osservi il funzionamento della società attuale, delle sue regole e dei suoi vincoli, dei suoi flussi e dei suoi varchi, può domandarsi se queste note affermazioni mantengano ancora qualcosa delle proprie antiche verità. Nella recente pubblicazione di Pier Giuseppe Monateri tali stringenti interrogativi si uniscono a un’analisi inedita e originale, in cui attraverso un approccio comparatistico si indaga sull’origine del fenomeno giuridico nella tradizione Occidentale e sugli effetti che le memorie normative suscitano negli attuali processi economici e produttivi.Innegabilmente, vi fu un tempo nella storia del pensiero giuridico in cui la riflessione sulla norma non era soltanto oggetto di un pensiero tecnicistico o economicistico, ma al contrario interrogazione profonda sui meccanismi che governavano l’umano, il divino e lo spazio politico. Nel nuovo ordine mondiale, tuttavia, sembra che la scienza giuridica stia attraversando un processo di inesorabile declino, un lento tramonto che si acuisce vieppiù a causa della crescente predominanza di discipline “altre”, quali l’economia e la finanza, che nella loro costante rincorsa verso un nuovo paradigma di pensiero paiono sbarazzarsi con fermezza di qualsiasi scrupolo culturale.
Pier Giuseppe Monateri affronta criticamente la perdita di considerazione del fenomeno
 giuridico, compiendo una nuova e accurata riflessione genealogica sul medesimo, la quale si dimostra – proprio alla luce dell’attuale contesto neoliberista – emblematicamente necessaria. La tesi principale sostenuta dall’Autore è che in un mondo tendente ovunque all’uniformità politica ed economica, la legge persiste a differenziare e a contrassegnare i diversi corpi politici, formalizzandosi in un elemento di caratterizzazione che se a prima vista appare assente o mancante, si rivela in realtà quale matrice storica delle istituzioni occidentali. La legge, così prosegue l’Autore, possiede una riserva di senso più profonda della politica stessa e la prova di ciò consiste nel fatto che se nell’attuale crisi globale la sovranità appare disperdersi e la politica neutralizzarsi, proprio il fenomeno normativo mantiene al contrario la propria incatturabile identità, che si dispiega così nei luoghi, negli stili e nelle forme politiche dell’Occidente.
giuridico, compiendo una nuova e accurata riflessione genealogica sul medesimo, la quale si dimostra – proprio alla luce dell’attuale contesto neoliberista – emblematicamente necessaria. La tesi principale sostenuta dall’Autore è che in un mondo tendente ovunque all’uniformità politica ed economica, la legge persiste a differenziare e a contrassegnare i diversi corpi politici, formalizzandosi in un elemento di caratterizzazione che se a prima vista appare assente o mancante, si rivela in realtà quale matrice storica delle istituzioni occidentali. La legge, così prosegue l’Autore, possiede una riserva di senso più profonda della politica stessa e la prova di ciò consiste nel fatto che se nell’attuale crisi globale la sovranità appare disperdersi e la politica neutralizzarsi, proprio il fenomeno normativo mantiene al contrario la propria incatturabile identità, che si dispiega così nei luoghi, negli stili e nelle forme politiche dell’Occidente.Sintetizzando brevemente l’ampia analisi sviluppata nel testo, è oramai constatazione abituale suddividere i sistemi giuridici mondiali in due distinte famiglie: da un lato la tradizione giuridica di common law, diffusa soprattutto nei paesi anglosassoni, dall’altro quella di civil law, tipica al contrario della tradizione giuridica continentale di scuola romanista (Francia, Germania, Italia, Spagna).
Tale suddivisione – se interpretata nella particolare ottica efficientistica propugnata dal sistema WTO-FMI-Banca Mondiale – diviene immediatamente un fattore problematico. L’armonia potenzialmente “irenica” di una sola regola juris, paradiso in terra per la massimizzazione delle transazioni commerciali, è infatti bruscamente osteggiata proprio dalla persistenza di diverse culture giuridiche, di differenti (e antitetici) modi di statuizione delle regole, e – cosa che maggiormente interessa – di diversi linguaggi normativi nell’amministrazione della giustizia. Nei Diktat degli organismi internazionali, tuttavia, il diritto non può permettersi di essere vario: esso deve farsi uniforme.
Fu così, come illustra Pier Giuseppe Monateri, che si diede avvio a un’aspra lotta culturale, tutt’oggi in pieno svolgimento, testimoniata da alcuni rapporti emessi dalla Banca Mondiale nel 2004 e nel 2005. Tali report sancirono definitivamente l’inefficienza dei sistemi giuridici di origine romanista rispetto agli opposti modelli giuridici di common law, in ciò coadiuvati anche da quel movimento internazionalmente noto come Law and Finance, a sua volta propugnatore della diffusione del tipo anglosassone a discapito di quelli “rivali”.
Chiaramente, proprio sul punto della pretesa superiorità di una tradizione rispetto a un’altra tali correnti di pensiero mostrano vistosamente la più chiara debolezza. Ciò non soltanto in un’ottica – come si diceva – culturale, ma prim’ancora in una di tipo storico-narrativo.
Il percorso logico che Pier Giuseppe Monateri individua si giova, così, tanto della riflessione politica classica quanto di uno spiccato approccio letterario, teso alla critica delle procedura di sponsorizzazione delle regole giuridiche. Se infatti la globalizzazione ha come fine il dissolvimento puro e totale dei corpi politici con il preciso obiettivo di realizzare uno spazio politico liscio, privo di resistenze e dagli effetti sconfinati, occorre, come necessaria forma di critica, evidenziare proprio quelle differenze, quelle singolarità e quegli scarti che persistono nell’esistenza attuale di ciascuna tradizione normativa. Ciò diviene tanto più essenziale se si considera l’importanza di una decostruzione delle rappresentazioni offerte dalla Banca Mondiale, dal FMI e dal WTO, che sulla base di indagini genealogiche finalisticamente orientate operano per imporre un solo linguaggio globale.
Come sottolinea Pier Giuseppe Monateri, da questo passaggio emerge in realtà la vera “ragione” del contendere: essa non risulta più semplicemente la questione di quale tipo di regola giuridica da utilizzare, o di quale sistema di giustizia imbastire. La vera questione diviene quella sulla natura duale o unitaria dell’Occidente, ossia sul problema dell’esistenza o meno di due diversi modelli di società (come si ricordava, quello di civil law e quello di common law), e quindi anche di quale dei due rendere concretamente operativo su scala internazionale. Proprio attraverso questo varco, l’indagine dell’Autore da giuridica si fa geopolitica e ha il pregio di sviluppare una ricostruzione spaziale dei meccanismi di origine del politico tanto in Europa, quanto nel continente americano.
Certo, nella suesposta presa di posizione del WTO, ciò che emerge è la polemica concreta verso ogni forma di socialismo e di sovranità statale, oramai ampiamente messa in scena attraverso innumerevoli strategie. Secondo questa vulgata, il diritto continentale (in primis quello francese e quello dei suoi più stretti imitatori europei) viene considerato storicamente statalista, pertanto inadatto a garantire le flessibilità normative spesso richieste dai grandi investitori globali. Inoltre, la burocratizzazione della magistratura continentale – considerata completamente sottomessa agli ordini dello stato centrale –garantisce ancora diritti e privilegi che si oppongono strutturalmente all’operare dei mercati finanziari. Tuttavia, ciò che in realtà tali organismi sovranazionali mirano ad attaccare è proprio il politico nelle sue forme di manifestazione istituzionali; un attacco che viene condotto, per di più, attraverso la pretesa ricostruzione storica delle origini della legge.
In questo senso, diviene dunque fondamentale condurre un nuovo tipo di esame che si giovi anche degli strumenti della critica letteraria, della filosofia politica e della storia delle tradizioni giuridiche. In accordo con ciò, la nozione che nel saggio viene precisamente individuata è quella, giuridico-letteraria, di “stile” della tradizione. Lo stile, secondo la ricostruzione di Pier Giuseppe Monateri, non attiene ai fronzoli della scrittura, o alla sua composizione manieristica. Esso non indica nemmeno un semplice giudizio di gusto sulla bellezza o sulla piacevolezza di un determinata scrittura. Lo stile è in realtà una vera e propria ontologia che differenzia ciascun corpo politico nella sua rispettiva esistenza storica, marcando quindi lo spazio sconfinato neoliberale con precise striature che distinguono, interrompono e oppongono gli stati nazione. I diversi stili della legge e della giustizia sono, così, gli elementi pregnanti per una geopolitica del diritto in cui lo “spazio” diviene quella soglia attraverso cui la legge ottiene una determinata visibilità.
A primo avviso, ciò potrebbe sembrare assai distante dagli scopi del diritto comparato, inteso quale disciplina finalizzata esclusivamente a evidenziare le differenze dei molteplici sistemi giuridici e le rispettive regole operative. Eppure, ogni problema di diritto comparato è anche, in ultima istanza, un problema che investe il politico e la sua identità. Cos’è allora, oggi, il diritto comparato? In Europa, come si accennava, esso è un mezzo per realizzare un diritto unico (esemplarmente, il codice europeo); nell’esperienza statunitense è invece lo strumento che consente di creare ranking tra le diverse tradizioni giuridiche, le quali divengono così dei veri e propri “oggetti” forniti di indici e valori numerici. In breve, attraverso un certo uso della disciplina, si staglia netto il pericolo di una tentazione riduzionistica, che considera il complesso corpus politico e istituzionale di una nazione alla pari di un indice aritmetico incasellato in una classifica, passibile quindi di essere sostituito, cancellato e modificato senza particolari problematiche.
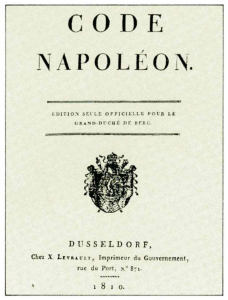 È su questo piano politico-giuridico che insiste, con rigore, l’opera di Pier Giuseppe Monateri. La nuova funzione che egli individua, infatti, è proprio quella del diritto comparato inteso appunto quale disciplina volta allo studio delle differenze e alla comprensione degli spazi nomici. Forse, è proprio attraverso tale passaggio che è possibile rilevare il vero paradosso della classificazione economicistica voluta dai grandi organismi sovranazionali: nonostante la preminenza dei modelli matematici e dei loro calcoli marginali, la legge continua a occupare il centro degli interessi economici odierni. L’idea che domina tali pratiche è che le riforme e il progresso siano possibili, dopotutto, soltanto attraverso riforme giuridiche. In questo senso, è allora il governo della legge, inteso come cattura del mezzo giuridico, a interessare alle grandi organizzazioni, e a spingerle così a scontrarsi e a imbastire narrazioni che mostrano, qualora accuratamente analizzate, il proprio fine affabulatorio. L'importante giurista statunitense Robert Cover scrive nell'articolo intitolato Nomos and Narrative (in “Harvard Law Review”, 97, 1983) che noi abitiamo una legge, un nòmos, e questo nòmos occupa sempre uno spazio specifico, che si volge quindi in spazio giuridicamente organizzato. Se lo spazio è allora quella soglia in cui la legge si rende visibile, tale forma di visibilità ricade proprio nella pratica degli stili in quanto rappresentazioni visibili della legge: il diritto comparato può allora divenire quella disciplina che conferisce un senso globale alla legge, disvelandone in ultima istanza la sua “misteriosa” presenza.
È su questo piano politico-giuridico che insiste, con rigore, l’opera di Pier Giuseppe Monateri. La nuova funzione che egli individua, infatti, è proprio quella del diritto comparato inteso appunto quale disciplina volta allo studio delle differenze e alla comprensione degli spazi nomici. Forse, è proprio attraverso tale passaggio che è possibile rilevare il vero paradosso della classificazione economicistica voluta dai grandi organismi sovranazionali: nonostante la preminenza dei modelli matematici e dei loro calcoli marginali, la legge continua a occupare il centro degli interessi economici odierni. L’idea che domina tali pratiche è che le riforme e il progresso siano possibili, dopotutto, soltanto attraverso riforme giuridiche. In questo senso, è allora il governo della legge, inteso come cattura del mezzo giuridico, a interessare alle grandi organizzazioni, e a spingerle così a scontrarsi e a imbastire narrazioni che mostrano, qualora accuratamente analizzate, il proprio fine affabulatorio. L'importante giurista statunitense Robert Cover scrive nell'articolo intitolato Nomos and Narrative (in “Harvard Law Review”, 97, 1983) che noi abitiamo una legge, un nòmos, e questo nòmos occupa sempre uno spazio specifico, che si volge quindi in spazio giuridicamente organizzato. Se lo spazio è allora quella soglia in cui la legge si rende visibile, tale forma di visibilità ricade proprio nella pratica degli stili in quanto rappresentazioni visibili della legge: il diritto comparato può allora divenire quella disciplina che conferisce un senso globale alla legge, disvelandone in ultima istanza la sua “misteriosa” presenza.Forse, è proprio in questi termini (come già rilevato da von Hayek) che è possibile abbozzare una conclusione: la legge è molto più ineffabile, molto più sublime e molto più ingovernabile di quello che crediamo. Essa non può divenire oggetto di ranking o di classifiche. Eppure, evitare la tentazione di ridurre il diritto a un oggetto misurabile non significa affatto affermarne l’inesistenza: al contrario, la legge esiste e ci governa molto più di quanto riusciamo noi stessi ad amministrarla. Ciò è tanto più curioso se si considera che spesso, nella tradizione giuridica di common law, i grandi commentatori ripetevano l’adagio per cui il giudice, nell’atto di decidere, “scopre” la legge. Ironicamente, considerare la legge come esistente ben al di là degli oggetti che la presentificano è proprio l’idea di fondo che si oppone al modello della disponibilità assoluta voluta dagli apparati finanziari: un’idea, come si sarà notato, che è tratta da quella stessa cultura giuridica che la Banca Mondiale e il FMI vorrebbero invece imporre al globo intero.
Il merito ultimo del saggio di Pier Giuseppe Monateri è allora quello di illustrare le diverse immagini della legge che continuano, inesorabilmente, a segnare le differenze e gli scarti all’interno dell’attuale spazio globale. Solo con un’effettiva e rinnovata conoscenza di tali meccanismi, uniti a un approccio critico e vigile verso gli stringenti Diktat internazionali, sarà forse possibile smascherare le narrative mendaci e le subliminali pratiche egemoniche del nuovo ordine neoliberale.
di Mauro Balestrieri