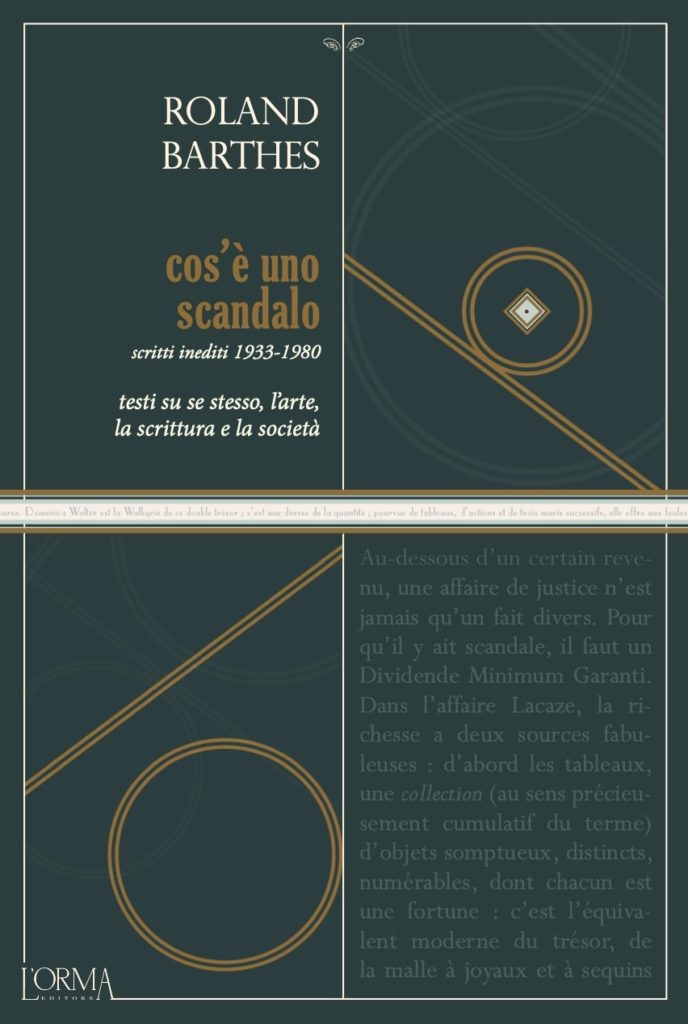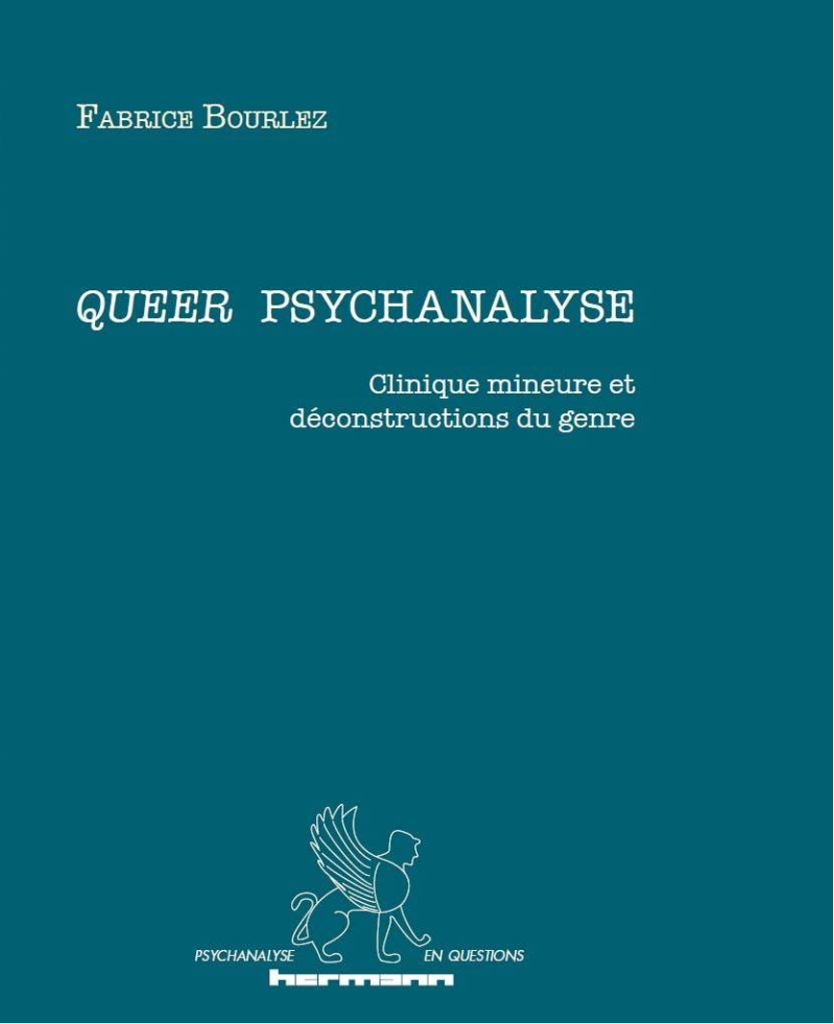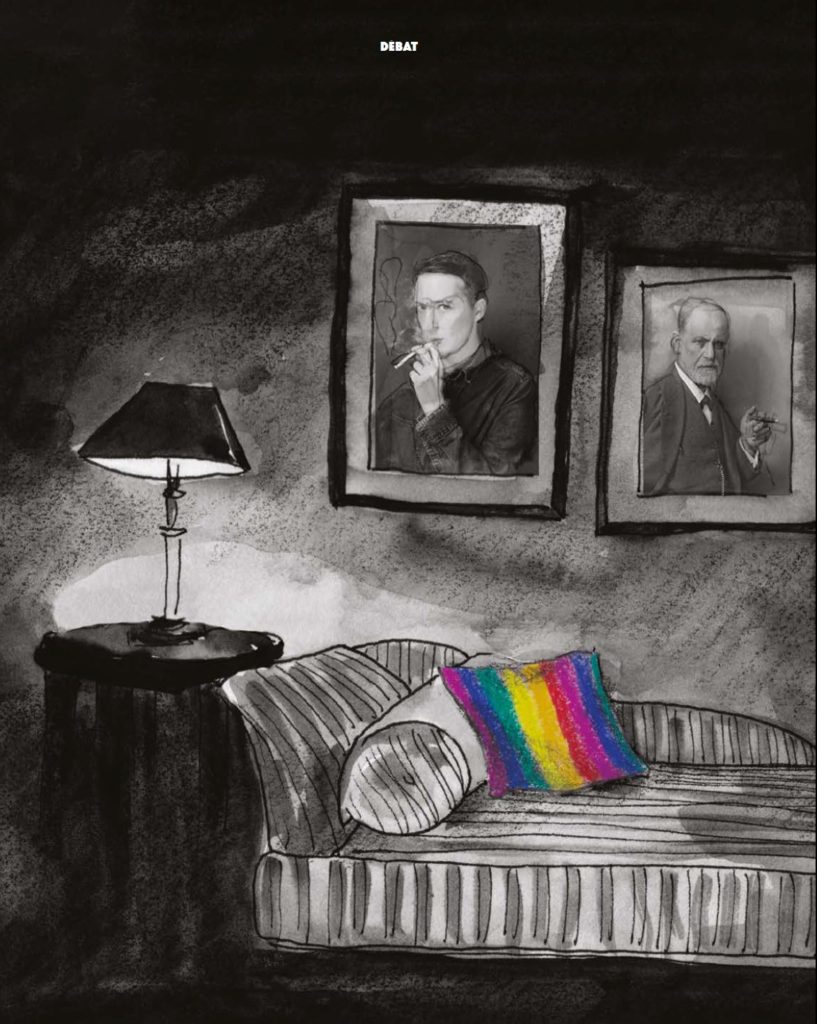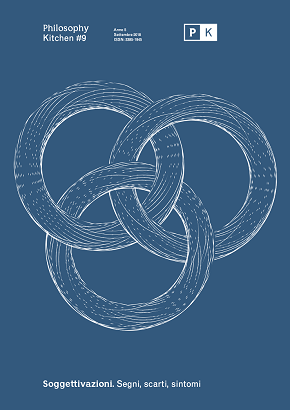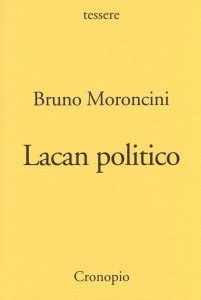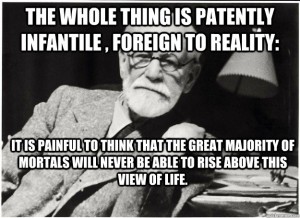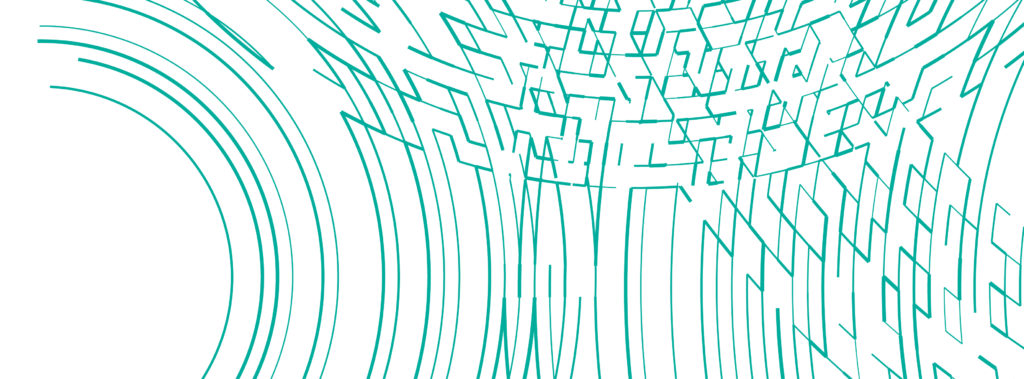-
-
Bernard Stiegler e la miseria simbolica
Recensioni / Aprile 2022Non c’è evoluzione tecnologica senza che, nel più profondo, avvenga una mutazione del capitalismo
G. Deleuze, Proscritto alle società di controlloPer cogliere il senso complessivo del denso lavoro di Bernard Stiegler, La miseria simbolica. L’epoca iperindustriale 1 (Meltemi, 2021) iniziamo con l’interrogare i termini che compongono il titolo dell’opera. In cosa consiste per l’autore “la miseria simbolica” che caratterizza le nostre società in quella che egli definisce l’“epoca iperindustriale?”
«La nostra epoca – scrive Stiegler – si caratterizza come presa di controllo del simbolico da parte della tecnologia industriale, laddove l’estetica è diventata al contempo l’arma e il teatro della guerra economica» (p. 25). L’effetto di un tale conflitto sugli individui è la miseria simbolica, vale a dire «la perdita di individuazione derivante a sua volta dalla perdita di partecipazione alla produzione di simboli, designanti, questi, tanto i frutti della vita intellettiva (concetti, idee, teoremi, saperi) che quelli della vita sensibile (arti, saper-fare, costumi)» (p. 38).
Come l’autore annuncia nella Prefazione, il testo va considerato come un commento al Proscritto sulle società di controllo (in Pourparler, Quodlibet, 2019) di Gilles Deleuze. In quelle poche pagine, com’è ben noto, Deleuze sostiene che le “società disciplinari” analizzate da Michel Foucault, con l’organizzazione dei grandi ambienti di internamento (famiglia, scuola, fabbrica, ospedale, carcere) che caratterizza la loro logica, e storicamente collocabili tra il XVIII e l’inizio del XX sec., siano ormai state sostituite dalle società di controllo, la cui peculiarità consiste nell’estensione, nell’intensificazione e nella complessificazione della logica dei processi distintivi della rivoluzione industriale applicati anche alla sfera simbolica del desiderio. Nell’attuale forma di capitalismo, che Stiegler definisce con Jeremy Rifkin «culturale» (p. 83), la dimensione estetica – qui intesa in senso ampio come dimensione del sentire in generale, e nella quale soltanto è possibile costituire un “io” e un “noi” a partire da un pathos comune – viene sistematicamente presa nelle maglie del calcolo, il cui dominio, anche grazie al recente processo di digitalizzazione, si è esteso ormai ben al di là della sfera della produzione, «nella integralità dei dispositivi caratteristici di ciò che Simondon chiama l’individuazione psichica e collettiva» (p. 82).
Nell’epoca iperindustriale la legge del capitale non è più la produzione, ma «il marketing in quanto controllo dei tempi di coscienza e dei corpi attraverso la macchinazione della vita quotidiana» (p. 83), così come il luogo paradigmatico non è più la fabbrica, ma l’impresa. L’iperindustrializzazione – è questa la tesi di Stiegler – ha dunque un riscontro paradossale: da un lato fa apparire una nuova immagine dell’individuo, il consumatore, dall’altro la generalizzazione del calcolo impedisce, o quantomeno ostacola fortemente, il processo di individuazione stesso che, solo, rende l’individuo possibile.
Del saggio deleuziano, Stiegler non condivide soltanto l’analisi insieme storica e logica relativa all’insediamento progressivo di un nuovo regime di dominazione, quello, cioè, caratteristico delle società di controllo, e che comporta una notevole perdita di individuazione, vale a dire la miseria simbolica, ma fa pienamente suo, se così possiamo esprimerci, anche lo spirito politico battagliero, che anima quelle pagine e che ben si esprime in queste parole, che lo stesso Stiegler cita: «Non è il caso né di avere paura né di sperare, bisogna cercare nuove armi» (Deleuze, 2019, p. 235). Come ben specifica Rosella Corda nell’Introduzione, il lavoro di Stiegler non si limita infatti «alla costatazione sterile o alla rassegnazione diagnostica», ma si pone l’obiettivo di trovare, «proprio in questo disperare, mancare di speranza, un po’ di possibile» (Stiegler, 2021, p. 9)
La questione delle armi, come esplicitamente afferma l’autore, è la «questione della tecnica in generale» – ovvero la questione cardine su cui ruota tutta l’opera di Stiegler fin dal suo primo lavoro La technique et le temps 1. La faute d’Épimethée, –, la quale è anche questione del politico, questione, cioè, «del destino di un noi» (Stiegler 2021, p. 38). La questione della tèchne, che, ricordiamolo, per Stiegler è un pharmakon, vale a dire insieme veleno e antidoto, si articola qui nell’ipotesi di un’organologia generale, la quale si pone l’obiettivo di indagare, dal punto di vista di una prospettiva antropologico-filosofica, la genesi del processo di ominazione. La domanda a cui l’organologia risponde è dunque una domanda sulla seconda natura dell’uomo, vale a dire sulla natura “originariamente” protesica, e cioè tecnica, dell’uomo. Un’adeguata interrogazione della secondarietà che contraddistingue l’umano rappresenta una condizione senza la quale non è possibile comprendere l’epoca attuale e la sua miseria simbolica, né risulta possibile – ed è questo ciò che più conta per Stiegler – indicare delle vie alternative a tale stato di miseria.
Il progetto di un’organologia generale prevede lo studio congiunto di quelle che Stiegler considera le «tre grandi organizzazioni che formano la potenza estetica dell’uomo: il suo corpo con la sua organizzazione fisiologica, i suoi organi artificiali (tecniche, oggetti, utensili, strumenti, opere d’arte) e le sue organizzazioni sociali che risultano dalla articolazione degli artefatti e dei corpi (pp. 31-32)». Il concetto chiave su cui l’autore costruisce tale progetto è il concetto di ritenzione terziaria, il quale, a differenza dei concetti di ritenzione primaria e di ritenzione secondaria con i quali Husserl indicava rispettivamente la dimensione della percezione e la dimensione dell’immaginazione, indica la dimensione artificiale della produzione da parte dell’uomo di oggetti di memoria esteriorizzata, come ad es. lo smartphone, i libri, gli edifici, le targhe commemorative, i film.
Nel terzo capitolo del libro “Allegoria del formicaio. La perdita di individuazione nell’epoca iperindustriale”, Stiegler ricostruisce per tappe storiche il processo di produzione delle ritenzioni terziarie, che egli chiama epifilogenesi. «L’ambiente epifilogenetico – scrive l’autore – come insieme delle ritenzioni terziarie costituisce il supporto dell’ambiente preindividuale permettendo l’individuazione del genere» (p. 89). Essendo l’epifilogensi il «deposito di memoria che è specifico di una forma di vita unica, quella del genere umano» (p. 66), ed essendo la natura dell’uomo già da sempre tecnica, la storia dell’epifilogenesi segna le tappe dell’individuazione dell’uomo, in particolare dell’uomo occidentale. Senza poter approfondire i vari passaggi che caratterizzano questa storia, che è anche la storia di una lotta per la definizione delle criteriologie dei dispositivi ritenzionali («processo di grammatizzazione», p. 90), ci preme mettere in luce il fatto che secondo Stiegler questo processo ha raggiunto un punto limite nell’epoca iperindustriale. Il processo di individuazione rischia cioè di annullarsi in favore di una «ipersincronizzazione» (p. 96) – ben resa dall’allegoria del formicaio – in cui la differenza tra “io” e “noi” collassa nel “si”, ovvero in quella condizione che Stiegler chiama anche di «mal-essere» (p. 98), tale per cui gli individui, non avendo più accesso alla produzione di simboli, perdono la loro singolarità e la correlata possibilità di proiettarsi in un “noi” e, dunque, in una dimensione politica. Privati di singolarità, gli individui cercano di singolarizzarsi mediante gli artefatti che il mercato mette loro a disposizione, il quale sfrutta la miseria propria del consumo stesso, e così facendo fanno esperienza del loro fallimento: «non si amano più e si rivelano sempre meno capaci di amare» (p. 99).
Concediamoci ora una considerazione generale sul senso dell’opera di un autore come Stiegler. Se ci soffermassimo soltanto sul lato diagnostico, sulla pars destruens del suo discorso correremmo il rischio di eludere l’aspetto più rilevante dello sforzo intellettuale – e non solo – dell’opera e della vita di Stiegler, il quale riguarda l’impegno con cui l’autore ha da sempre tentato di rispondere alla domanda: “che fare?”. Se infatti considerassimo solo l’aspetto analitico della sua opera, finiremmo per giudicare Stiegler, come pure è stato fatto soprattutto dopo la pubblicazione de La società automatica. 1. L’avvenire del lavoro (Meltemi, 2019), un autore catastrofista. Per quanto la situazione diagnosticata dall’autore sia effettivamente catastrofica, Stiegler, come si è detto, non cede nemmeno per un attimo al catastrofismo. È questo un punto battuto da tutti i curatori delle edizioni italiane recenti delle opere di Stiegler, sulla cui insistenza, potremmo dire, Meltemi ha costruito la cifra peculiare della sua operazione editoriale, che ha portato alla pubblicazione dei due volumi sulla miseria simbolica (Stiegler, 2021; La miseria simbolica. 2. La catastrofe del sentire) e a quello sulla società automatica (Stiegler, 2019) nella serie “Culture radicali” diretta da Gruppo Ippolita.
Come scrive Giuseppe Allegri in un articolo online su OPERAVIVA dal titolo Dentro, oltre e contro la società automatica, «il ricercare e l’agire di Stiegler si oppone radicalmente a qualsiasi visione apocalittica che altri rintracciano nel suo pensiero, del tutto inspiegabilmente e proprio leggendo il volume sulla Società automatica, mentre la postura del Nostro è anche e soprattutto quella progettuale e sperimentale, per la promozione e il sostegno di collettivi di ricerca che coinvolgano e che già coinvolgono ampi spezzoni di società, associazionismo di base e frammenti di classe dirigente, disposti ad accettare e orientare la trasformazione tecno-digitale e socio-economica nel senso di un ripensamento radicale delle categorie e delle pratiche sociali per maggiore autodeterminazione, dignità, felicità in favore dei molti» (https://operavivamagazine.org/dentro-oltre-e-contro-la-societa-automatica/). Lo stesso Allegri, autore della postfazione al testo qui recensito, e significativamente titolata Ricchezza delle pratiche inventive, fa un lungo elenco delle attività che hanno impegnato Stiegler dalla fine degli anni Novanta fino alla sua scomparsa nell’agosto del 2020, e che lo hanno coinvolto nella fondazione di «nuove istituzioni», quali, tra le molte altre, citiamo Ars Industrialis, «la cui “ragione sociale” è quella di un’associazione europea per una politica industriale delle tecnologie dello spirito», o «IRI – Institute pour la Recherche et l’Innovation presso il Centre Pompidou, all’interno del quale è riuscito a promuovere una rete di Digital Studies inaugurata nel 2012»,o che lo hanno visto collaborare al «progetto avviato nel maggio 2016 di Territoire Apprenant Contributif, che coinvolge i 9 comuni di Paris Nord/Seine-Saint-Denis» (pp. 160-161).
Specificamente per quel che riguarda La miseria simbolica 1. L’epoca iperindustriale, in tutte le pagine che compongono i quattro capitoli del libro, finanche nei punti in cui la disperazione emerge in maniera più forte, e, anzi, soprattutto lì, la domanda sul “che fare?” e la ricerca continua di quella che con una bella espressione Stiegler definisce l’«energia zoppicante della chance» (p. 124) non scompaiono mai dall’orizzonte. In particolare, si ha un riscontro evidente dell’insistenza con cui Stiegler si spende per “cercare nuove armi” nell’analisi dei due film On connaît la chanson di Alain Resnais e Tiresia di Bertrand Bonello, che egli conduce rispettivamente nel secondo (Come se ci mancassimo o di come trovare delle armi a partire da Parole parole parole… (On connaît la chanson) di Alain Resnais”) e nel quarto capitolo (“Tiresia e la guerra del tempo. A proposito di un film di Bertrand Bonello”) del testo.
Nel film di Resnais il nostro autore trova esemplarmente tracciata, nel modo in cui il regista compone e scompone cliché attraverso l’utilizzo della tecnica del sampling e più specificamente attraverso la ripetizione ventriloqua che i personaggi si trovano a fare dei ritornelli di alcune famosissime canzoni francesi, la via «per una nuova capacità di immaginare/sentire» (p. 15), che prenda le mosse proprio da quel processo che fa scomparire la differenza tra “io” e “noi” nel “si”, ma tentando di invertirne la direzione.
di Gian Marco Galasso
-
bell hooks: il femminismo è per tutti!
Recensioni / Aprile 2022Era sera ed ero in coda da qualche parte. Poi, a un tratto, ho letto:
È il 15 dicembre 2022, ed è morta bell hooks.
Non immaginavo che la scomparsa di un’autrice, incontrata soltanto un anno prima, potesse lasciarmi addosso una sensazione analoga a quella che avevo già provato nel perdere dei punti di riferimento.
Mi sono allora chiesta perché e in che modo, senza accorgermene, avesse assunto un simile ruolo; per cui ho deciso di provare in parte a mettere nero su bianco ciò che bell hooks mi ha trasmesso.
Il femminismo è per tutti – scriveva nel 2015 all’interno dell’omonimo libretto che ho scelto di attraversare, tradotto in italiano da Maria Nadotti e pubblicato da Tamu Edizioni nel 2021 – evitando di nascondere il proprio io dietro a terze persone tanto impersonali quanto inesistenti, dietro a giri di parole tanto impeccabili quanto incomprensibili. Non è infatti – il femminismo – un mero stile di vita: non è possibile approcciarsi ad esso senza esporsi personalmente, dal momento che riguarda innanzitutto la capacità di fare i conti con il sessismo che ognuno trascina dentro di sé.
Del resto, «per capire il femminismo è necessario capire il sessismo» (p. 31), nelle cui insidie cadono tanto gli uomini quanto le donne: questo è il presupposto da cui parte bell hooks nel dire che, appunto, il femminismo dev’essere per tutti: deve assumersi la missione di includere. Il sessismo diventa allora l’elemento che le consente – nel primo capitolo – di stendere innanzitutto un itinerario degli sviluppi storici del movimento femminista e, poi, di distinguere tra femminismo riformista e rivoluzionario. Il primo (quello con maggiore risonanza mediatica), ponendosi come obiettivo principale il raggiungimento della parità di genere e della mobilità sociale, considera l’impegno verso la lotta al sessismo un elemento quasi accessorio; mentre il secondo, ponendosi come scopo la trasformazione radicale del sistema patriarcale (e quindi non la sua semplice modifica), vede nella lotta al sessismo una delle sue principali missioni.
Mettere fine all’oppressione sessista è infatti ciò a cui ci richiama con ostinazione la rivoluzionaria bell hooks. È possibile indirizzarsi verso questa meta attraverso numerose vie e quella teorica è sicuramente un buon punto di partenza. Del resto, come bell hooks, in tanti siamo approdati alla lotta femminista all’università, entrando in contatto soprattutto con la teoria femminista più che con la sua pratica; tuttavia, a differenza sua, molti di noi si sono fermati e continuano a fermarsi semplicemente alla teoria. Purtroppo, però, solo con questa non si può riuscire nell’impresa di mettere fine all’oppressione sessista: a un certo punto, occorre chiudersi alle spalle la porta del proprio studiolo comodo e confortante per calarsi nel mondo – correndo il rischio di sporcarsi –, incontrando la voce, i gesti, la carne e gli abissi degli altri.
A questo proposto, nelle sue opere, la femminista afroamericana evoca spesso la potenza liberatoria che hanno avuto, durante il secolo scorso, i gruppi di autocoscienza. Ce li descrive come veri e propri siti di conversione, in cui donne tra loro molto diverse per età ed estrazione sociale riuscivano a trovare a turno una “camera tutta per sé”, in cui rivelare e mostrare «apertamente la profondità delle loro ferite intime» (p. 41). In quelle camere, nessuna aveva più diritto delle altre di essere ascoltata, nessuna aveva il dovere di rimanere in silenzio, bensì tutte condividevano la possibilità di dire ciò che pensavano realmente, di discutere e far valere le proprie ragioni: in quelle camere, nessuna voce era strozzata, perché ognuna veniva così preparata a «sfidare le forze patriarcali sul posto di lavoro e in casa» (ibidem).
Con il tempo, purtroppo o per fortuna, le cose sono cambiate: i Women’s Studies hanno cominciato a configurarsi come una disciplina accademica riconosciuta e l’aula universitaria – che «era e rimane un luogo di privilegio di classe» (p. 44) – ha progressivamente spazzato via quelle camere, che invece consentivano una trasmissione ampia e orizzontale del pensiero femminista e delle strategie rivolte al cambiamento sociale, prescindendo da distinzioni di classa e di razza. Tale cambiamento oltre a depoliticizzare il movimento femminista e a renderlo, per certi versi, più elitario, ha soprattutto contribuito al graduale allentamento della solidarietà politica tra le donne – forza che precedentemente aveva saputo mettere in atto un cambiamento positivo. Tutto ciò ha prodotto delle stratificazioni all’interno del movimento femminista, che, talvolta, ha finito per perdere di vista il fatto che «finché le donne usano il loro potere di classe o di razza per dominare altre donne, la sorellanza femminista non può realizzarsi appieno» (p. 53).
A partire da tali rilievi, Il femminismo è per tutti. Una politica appassionata si fa promotore della necessità di ripercorre la storia del movimento femminista, di esplorarne criticamente tanto i punti deboli, quanto quelli forti. Attraverso uno stile schietto, semplice, asciutto, bell hooks reclama la creazione di «un movimento di massa che offra un’educazione femminista a tutti» (p. 65), in grado di spiegare, in forme iper-accessibili, alle donne e agli uomini come opera il pensiero sessista, in che modo è possibile metterlo in discussione e cambiarlo e come, nel corso del tempo, il femminismo abbia inciso sulle vite di tutti noi. Si tratta di una sorta di testamento intellettuale, in cui vengono affrontati acutamente, seppur in poche pagine, tanti temi essenziali. Uno di questi – quello su cui mi capita di arrovellarmi più spesso – è il corpo: perno introno al quale ruotano, in particolare, il quinto capitolo, il sesto e l’undicesimo.
Essere il proprio corpo per una donna è un gesto rivoluzionario, che comincia con la scoperta della propria sessualità, con la ricerca del proprio piacere (e in questo tutti gli strumenti di controllo delle nascite hanno aiutato un bel po’), che passa attraverso la possibilità di rimanere incinta. Misurarsi con tale eventualità ha prodotto innumerevoli discorsi nel corso del tempo, alcuni dei quali elogiano la maternità, restituendola come un ineluttabile destino; altri sottolineano invece come quest’esperienza possa finire per costituire un intralcio alla realizzazione personale di una donna. L’intrecciarsi e lo scontrarsi di questi innumerevoli discorsi hanno contribuito a generare quel rumore che da anni avvolge il dibattito intorno all’aborto.
La posizione di bell hooks al riguardo – che mi sento di sottoscrivere in pieno – è molto semplice e parte dal presupposto che «se noi donne non abbiamo il diritto di decidere che cosa succede al nostro corpo, rischiamo di rinunciare ai nostri diritti in ogni altra sfera della nostra vita» (p. 72): essere pro aborto significa essere pro scelta, cioè sostenere «il diritto delle donne che hanno bisogno di abortire, di scegliere se farlo o no» (p. 73); ecco perché occorre lottare affinché non si torni «a un mondo in cui gli aborti sono accessibili solo alle donne che hanno un sacco di soldi» (p. 70), essendo questo un primo passo verso il ritorno a una politica che mira a rendere illegale l’aborto. Essere pro scelta, dunque, vuol dire battersi tanto affinché donne sole e senza mezzi possano permettersi di scegliere di essere madri, tanto affinché donne che vogliano abortire possano farlo in sicurezza.
Il femminismo ha il merito di aver contribuito a puntare i riflettori sull’incapacità di molte donne di scoprire «che la nostra carne è degna d’amore e di adorazione al naturale» (p. 75), dal momento che «tutte le donne, indipendentemente dalla loro età, vengono consciamente o inconsciamente educate a essere assillate dal pensiero del proprio corpo, a considerare problematica la carne» (pp. 80-81). Tale assillo si fa sempre più incombente durante la pubertà, quando una giovane donna percepisce più che mai il suo corpo come sfuggente, arrivando talvolta a sentirlo a lei estraneo. Allo stesso tempo, gli occhi maschili, che seguono sempre più frequentemente il ritmo dei suoi fianchi per strada, comunicano giudizi sulla sua anatomia, inducendola a viversi come un oggetto per gli altri.
A tutto questo si può reagire in vari modi: mettendo più o meno radicalmente in mostra la propria carne, traendo piacere dal forte desiderio che suscita negli altri; oppure – provando per essa paura o disgusto – ricercando l’invisibilità. Oggi, in un numero sempre crescente di giovani, il disgusto per la propria carne degenera in maniera patologica. Disturbi del comportamento alimentare come l’anoressia nervosa sono infatti una vera e propria piaga per il mondo occidentalizzato: si tratta di una patologia estremamente fatale, che, nello specifico, colpisce prevalentemente le giovani donne e che ogni anno miete un numero sempre maggiore di morti. Uno dei tanti aspetti che la caratterizzano è dato dal fatto che – come ben nota bell hooks – «non c’è monito, per quanto terribile, che riesca a dissuadere le donne convinte che il loro valore, la loro bellezza, il loro merito intrinseco sono determinati dal fatto di essere magre o no» (p. 79). Un disturbo come l’anoressia nervosa porrebbe allora il mondo femminista di fronte a un’urgenza: «anche se oggi le donne sono più coscienti delle insidie e dei pericoli insiti nell’accettazione di una visione sessista della bellezza femminile, non stiamo facendo abbastanza per eliminare, per creare un’alternativa […]. Finché le femministe non torneranno a misurarsi con l’industria della bellezza e con la moda, provocando una rivoluzione costante e di lunga durata, non saremo libere. Non sapremo come fare ad amare il nostro corpo e noi stesse» (pp. 81-82).
Il corpo di una donna è sempre attraversato dalla possibilità di esser ferito, cioè di subire in esso la volontà di un altro; tuttavia, questo non deve trarci in inganno su quella che dovrebbe essere una delle missioni principali del femminismo. Secondo bell hooks, quest’ultimo deve puntare, non tanto a contrastare esclusivamente la violenza degli uomini verso le donne, bensì a far cessare ogni forma di violenza. Alla base di ogni forma di violenza, compresa quella patriarcale, c’è sempre l’idea secondo cui è accettabile che un individuo dotato di maggiore potere controlli gli altri tramite varie forme di forza coercitiva. Ecco perché, mirando in fondo a minare la libertà che ciascuno ha di disporre del proprio corpo, la violenza patriarcale, oltre a poter essere perpetuata tanto dagli uomini quanto dalle donne, si rivela come un fatto che riguarda l’umanità intera.
Per quanto breve, il libro di bell hooks è talmente pieno di spunti che sarebbe davvero difficile diffondersi qui su ognuno di essi. Ho scelto di ricordarla parlando proprio di questo volume, non solo perché, di recente, è comparsa la sua traduzione italiana, ma anche perché trovo che esso racchiuda perfettamente alcuni dei punti essenziali del pensiero che bell hooks ha sviluppato per una vita intera: nel leggere, mi è piaciuto pensare di star conservando il suo testamento tra le mani…
di Giulia Castagliuolo
-
Psicoanalisi Queer Manifesto
Recensioni / Dicembre 2021Nella convinzione che non sia sostenibile una scrittura impersonale e non situata, chi scrive in questa sede lo fa da una posizione di soggettività queer e di adesione a un certo quadro epistemologico, quello di una psicoanalisi queer fin dai suoi quattro concetti fondamentali: l'inconscio, la ripetizione, il transfert e la pulsione.
Che si possa fare una psicoanalisi rigorosa, sia in sede teoretica che clinica, aderendo alla filologia lacaniana (se ce n’è una!) e al contempo attestandone il fondamento queer, lo mostra il saggio Queer Psychanalyse: clinique mineure et déconstructions du genre di Fabrice Bourlez (Éditions Hermann, Paris 2018), in traduzione italiana ad aprile per i tipi di Mimesis. Nella ricezione italiana dell’intersezione tra psicoanalisi e studi di genere, che si approssima al deserto concettuale, la scrittura di Bourlez colma una lacuna che non può persistere oltre. Una lacuna che ha prodotto effetti reali, attestati sia dal silenzio delle Scuole di Psicoanalisi impegnate in querelles lontane dalla causa analitica intesa come causa del desiderio, sia dai disagi soggettivi degli analizzanti che nei cabinets dei propri analisti non trovano risposta alle urgenze della contemporaneità e dei propri corpi.
Aspettando di leggere l’edizione italiana, diamo un occhio allo stato del terreno su cui andrà a installarsi. Da una parte, troviamo la proposta teologica del nostro pastore lacaniano Massimo Recalcati, fondata sul binomio Bibbia-Psicoanalisi, su una solida retorica del sacrificio? e su una speranza di guarigione dal sintomo che si approssima alla grazia divina; il tutto affiancato da una lettura delle tavole della sessuazione (Seminario XX) marcatamente binaria ed etero-patriarcale, poiché la sua intera opera risulta pervasa di dicotomie manichee e attestazione di differenze uomo-donna strutturanti, presuntamente fondate nella logica dell’inconscio: il queer non è chiaramente passato di qui. La carica di potere e autorità di cui gode il controtransfert dell’analista è – non esageriamo – quella di un dio, possibilmente maschio e paternalista, incarnato, e qualsiasi tentativo di rivendicare una psicoanalisi costitutivamente laica nei suoi fondamenti viene “punito” con scomuniche.
Differentemente, lo psicoanalista presentato da Bourlez è una figura etica, nel senso di un essere di desiderio, la cui consistenza non è l’autorità ma l’erratica, fallimentare e sempre eccentrica movenza del desiderio. Un analista che porta dei tacchi, coi quali gioca, cade, gode, performando la propria instabilità. Il tallone d’Achille, ossia la debolezza, il difetto, della psicoanalisi, diventa les talons hautes: i tacchi alti su cui essa svetta, solo a condizione di traballare e di poter cadere da un momento all’altro (pp. 142-44). La clinica di Bourlez ci permette di opporre al pugno duro del soggetto che è supposto sapere perché sa, o perché ha la presunzione di sapere, il tatto di chi abdica alla propria funzione e la decostruisce, limitandosi – eticamente – a occupare una posizione, che è quella del desiderio. Ecco dunque un primo punto per cui Queer Psychanalyse può portare buone notizie al neo-lacanismo italiano, arroccato in una condizione di neo-lacanismo classico, rigidamente milleriano e consacrato all’Uno: l’Uno dell’Unico Lettore (Miller fu così nominato da Lacan), l’Uno de La (Signora) Psicoanalisi, l’Uno del godimento masturbatorio di una pratica che, volendosi una, si vuole sola. Il caposaldo del neo-lacanismo L’Uno-tutto-solo di Jacques-Alain Miller conteneva a sua insaputa una profezia: la solitudine. Ma più che versare lacrime su un neo-lacanismo classico solo e moribondo, dobbiamo condannarne la violenza sistemica, che ha adoperato nella precisa scelta di escludere le psicoanalisi. Le psicoanalisi critiche, cliniche, decostruttive, che lo hanno minacciato con la loro alterità, costitutiva peraltro della sua materia-principe: l’inconscio che è discorso dell’Altro.
Queer Psychanalyse propone dunque non solo una clinica minore, ma minorizzata (minorisée), perché costretta dalla violenza padronale di un’esclusione a esprimersi dal margine. Ricorrendo a una metafora derridiana, possiamo dunque parlare della psicoanalisi diffusa – quasi con atteggiamento coloniale – da Miller come di un neo-lacanismo bianco, laddove “bianco” non (solo) indica il parlante in questione come maschio bianco cisgender eterosessuale ma soprattutto il tentativo di occultare dietro una supposta neutralità del discorso psicoanalitico (che non è mai neutrale, ma immediatamentepolitico) la messa a tacere, colpevole, violenta e intrinsecamente escludente, delle minoranze queer e trans. Bourlez ripristina un uso politico della psicoanalisi sottraendo l’uno-per-uno, l’esercito degli uni-tutti-soli, alla masturbazione paranoica del lettino, e riconsegnandoli alla specificità delle rivendicazioni del loro desiderio, che è passata attraverso il sangue di Stonewall e il “martirio” dei sieropositivi (cfr. pp. 37-38). Altra frontiera che Bourlez apre è il confronto con le teorie femministe, in particolare un urgente Butler con Lacan “Qu’y a-t il entre nous”? La linea che la nostra recensione persegue, riguardo l’imminente ricezione italiana di una psicoanalisi queer, non può che sostare su un fenomeno perlomeno bizzarro che ha colpito il neo-lacanismo: esso consiste nel dare centralità al godimento de la donna millantando un femminismo che non ha rapporto con alcuna delle quattro ondate femministe e che è avulso da rivendicazioni storiche e militanti. Insomma, un “puro” femminismo psicoanalitico, condotto – di nuovo – in solitudine sul lettino, una-per-una, combattendo coi propri fantasmi e accedendo a un godimento tanto singolare quanto innominabile, al di là del fallo: una vera deriva mistica.
La razionalità, il rigore, la logica radicale dell’inconscio – ben illustrata da Matte Blanco nel suo Saggio sulla bi-logica – sembrano rigettare questi accostamenti teologici e mistici, che non solo ridicolizzano l’impresa freudo-lacaniana ma occultano nuovamente la posizione del “chi parla” (né dio, né un al di là di…, ad esempio del fallo). Fortunatamente per noi, Bourlez corregge il tiro ricordandoci che tale godimento singolare (jouissance) può essere pronunciato perché l’esistenza di una comunità militante lgbtqia+ l’ha consentito, e decenni di lotte gay hanno fatto sì che l’innominabile assuma nomi, posizioni e colori di un arcobaleno, attraverso atti di nominazione del suddetto godimento, come il coming out: “sono psicoanalista e gay. L’ho detto, lo ripeto e ci ritornerò. Sarà meglio che vi abituiate” (cfr. p.19, trad. mia). In questo senso, anche l’ascolto (l’Ouïr) dell’analista deve essere un queer-ouïr. Bourlez gioca sulla medesimezza dei due fonemi, a cui aggiungerei jouir, per cui queer ouïr c’est jouir, l’ascolto queer è una forma di godimento: un ascolto in modo sempre già deviante, non coincidente con sé stesso, che diventa-altro e apre da dentro il fuori che rende i quadri clinici non chiudibili, infinitamente eccentrici, per far evolvere in maniera autenticamente critica i concetti fondamentali dell’inconscio. È quel che si intende con psicoanalisi open to revision, aperta alla revisione costante della sua prassi, e in questo senso inclusiva delle minoranze e spazio safe. In Francia i nomi per definirla proliferano: psychanalystes homosexuel.le.s, psylesbiennes, psy gay.e.s, homoanalystes, psy safe inclusif, analystes mineur.e.s, psy queer.
In questi spazi non aleggia il fantasma eteronormativo dell’analista uomo la cui analizzante è donna, con la presunzione maschile da parte del primo che vi sia tra i due un potenziale o un rischio di seduzione.
L’urgenza di far circolare in Italia Queer Psychanalyse di Bourlez deriva anche dall’errato confronto che è stato instaurato tra psicoanalisi lacaniana, femminismi e queer studies allo stato attuale del dibattito: pensiamo a testi come L’essere e il genere. Essere uomo/donna dopo Lacan della filosofa e psicoanalista lacaniana Clotilde Leguil, che ha messo per iscritto qualcosa che non esito a definire come una catastrofe del queer. Il modello di “essere donna” che Leguil propone consiste nel “godere della propria esclusione”, atto che dalla prospettiva di Bourlez sarebbe insostenibile. Per Leguil essere donna, oltre che essere esclusa e, paradossalmente, goderne, significa “confrontarsi con la follia”, e “godere di un’inesistenza per arginare la propria mancanza a essere”. Questi brevi estratti si affiancano a una ricostruzione storica semplicistica e a un’opera permeata, fin dal titolo, di una logica identitaria e binaria. Il binarismo è affermato fin dalla contrapposizione delle due opposte letture del concetto di “gender”, da parte degli studi di genere e della psicoanalisi: per i primi il gender sarebbe un’“artiglieria pesante”, una “gabbia che paralizza l’essere”, da abolire; per la seconda sarebbe il “soffio vitale dell’essere”, la possibilità più propria del soggetto, il quale “rincorre il genere per cogliere e raggiungere qualcosa del suo essere”. Correggere il tiro rispetto a questi quadri teorici fallaci sull’intersezione tra psicoanalisi e gender studies sembra essere per Bourlez un preciso dovere morale: nel suo saggio mostra che attestare l’esistenza di un punto di impossibilità tra La Psicoanalisi e il Queer è un gesto deliberato di occultamento, quello di un pensiero straight, per dirlo à la Wittig, di una precisa matrice eterosessuale che si dà come discorso maggioritario e maggiore: un discorso che silenzia i punti di espressione delle letterature minori, quelle che spingono la lingua al limite facendo tremare la grammatica maggioritaria. Maggiore e minore sono due modi possibili di leggere il testo lacaniano. Bourlez lo mostra anche con le dibattute tavole della sessuazione del Seminario XX, Ancora: uno schema bipartito che distingue il modo di godere fallico da quello femminile, col rischio di creare due universali che governano due logiche differenti, e dunque di riprodurre la differenza dei sessi. Il due è l’unico a priori della sessuazione o possiamo porre, già trascendentalmente, n-sessi, n eccezioni singolari a una legge piena di buchi, che fa acqua da tutte le parti? Attenersi alla binarietà dello schema non ci rende complici di una costruzione culturale ancora intrinsecamente dualista? Leggere le tavole in modo minore significa, invece, sessuare in modo queer, non prima di esser passati da Butler e Fausto-Sterling, intersecando la psicoanalisi con la storia del femminismo e della biologia. Significa intendere i sessi come un continuum e come i colori di un prisma (p. 281), a partire da nient’altro che i corpi (chiaramente significanti e sessuati), dalla loro innata biologia della complessità e della diversità, fino a includerne quel punto tanto imprendibile quanto matematico che è il Reale di ciascuno.
Il saggio di Bourlez ha un andamento decostruttivo: in cinque capitoli, vengono ripensati, in-fondati e reintegrati i fondamenti della pratica analitica. Nel primo, Bourlez sostiene di dover dé-faire l’analyse: e così ri-farla. Per disfare un’analisi, serve scrivere, resistere, fare in un certo senso e a proprio modo coming out (pp. 9-15). Nel secondo, manda in rovina l’Edipo: lo mantiene come osso fondamentale dell’analisi e come contenuto dell’inconscio, ma aprendolo a delle possibilità; ossia che ci siano n-sessi coinvolti nel teatrino edipico e che ci sia un necessario al di là dell’Edipo (pp. 94-98). La sorpresa è che la decostruzione dei generi non viene da un’integrazione, ma da una lettura radicale del testo freudiano stesso.
Bourlez prosegue tematizzando un atto nuovo, quello di performare l’omo-analista: nel terzo capitolo si chiede se i cabinets di Freud e Lacan fossero degli spazi che col lessico di oggi definiremmo safe, o ancora gay-friendly. Perché Dora fugge dopo sole tre settimane di analisi? (pp. 148-153) Perché le diagnosi di isteria spesso celano l’omosessualità femminile dietro la seduzione dell’analizzante per l’analista uomo, investito libidicamente come padre? (p. 147). La migliore sovversione che le isteriche abbiano potuto attuare nel discorso analitico è consistita nell’averlo fatto cessare. Dopo averlo inconsciamente istituito coi propri sintomi, se ne sono sbarazzate. Come? Andandosene. Rispettivamente nel Frammento di un’analisi di isteria (caso Dora) e in Psicogenesi di un caso di omosessualità femminile (caso della giovane omosessuale) “le due donne hanno buttato via il trattamento e le interpretazioni freudiane che lo accompagnano. Le sue manie d'interpretazione del sesso da parte del Padre le hanno fatte inorridire. Sono scappate. Lo hanno lasciato da solo con le sue pipe, le sue statuette e il suo divano” (p. 149).
I successivi capitoli sono dedicati a due precise operazioni politiche: l’inversione dell’etero-sessimo e l’apertura di un al di là della differenza dei sessi (ben diverso dall’al di là del fallo), per smontare le mosse che governano, in ogni nostra terapia individuale, quella che Bourlez definisce la micropolitica dell’atto analitico.
Perché leggere Queer Psychanalyse in Italia e farne, al contempo, il point de départ e il point de capiton del dibattito psicoanalitico contemporaneo? Per farla finita col verbo lacaniano come “sacra scrittura” da riconsegnare alla corretta filologia definitoria, e dunque con le derive teologiche e paranoiche che esso incarna, reiterando il discorso del padrone. Per de-feticizzare la Grande Psicoanalisi intesa come sola e unica soluzione al sintomo, sostituendola con la proliferazione di psicoanalisi queer, transfemministe e decostruttive. Il senso delle psicoanalisi, inteso qui come il loro desiderio, alla luce del saggio di Bourlez, non è l’indagine su un presunto “solo” godimento, ma il re-inquadramento dei modi di godere in un’analisi politica affiancata a un’epistemologia critica della sessuazione. Solo così potremo interrogare preliminarmente la scena eterosessuale, smascherarla nei suoi statuti oppressori e violenti, individuare i modi di vivere maggioritari e incarnare le nostre resistenze soggettive nelle grammatiche che non scegliamo di abitare, aprendo nuove possibilità di sessuazioni queer.
di Sara Fontanelli
Bibliografia
F. Bourlez, Queer Psychanalyse. Clinique mineure et déconstructions du genre, Éditions Hermann, Paris 2018.
J. Derrida, La mitologia bianca (pp. 275-349), in Id., Margini della filosofia (1972), Einaudi, Torino 1997.
J. Lacan, Il Seminario. Libro XX. Ancora (1972-1973), Einaudi, Torino 1983.
C. Leguil, L’essere e il genere. Essere uomo/donna dopo Lacan, Rosenberg & Sellier, Torino 2019.
J.-A. Miller, A. Di Ciaccia, L’Uno-tutto-solo. L’orientamento lacaniano, Astrolabio, Roma 2018.
-
PK#9 \ Soggettivazioni. Segni, scarti, sintomi
Rivista / Settembre 2018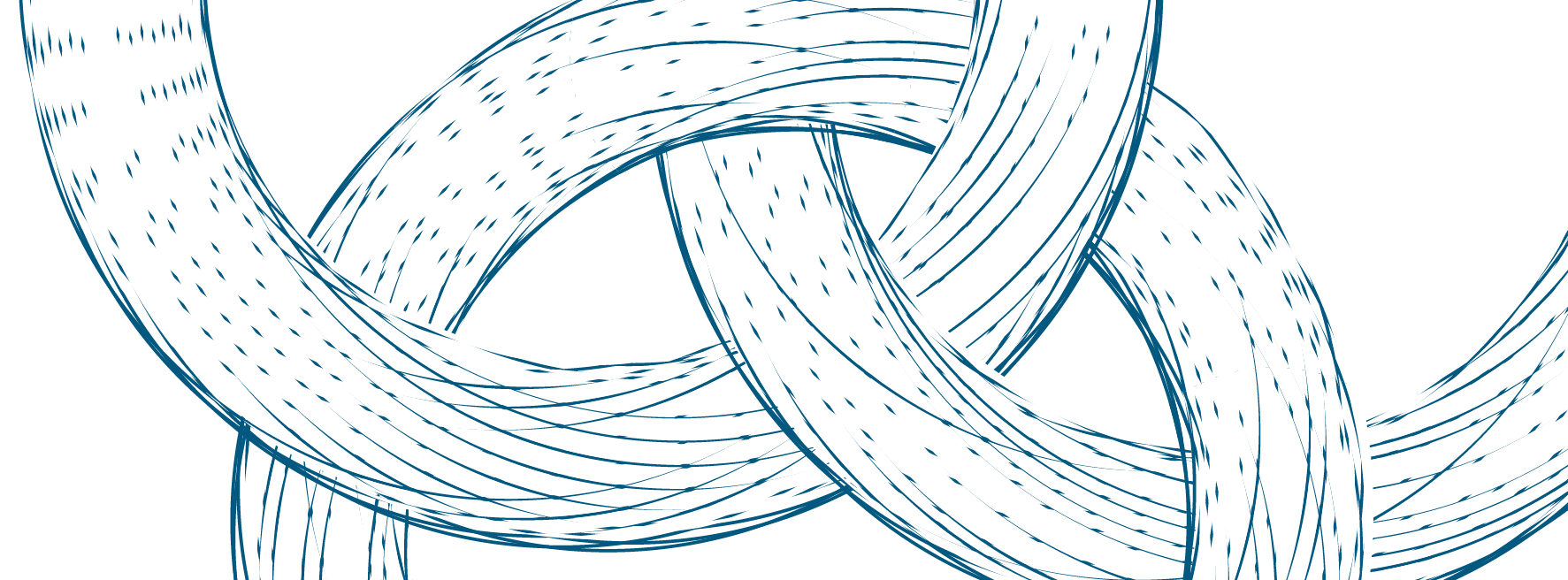
L’intento di questa raccolta, che prende il titolo di “Soggettivazioni”, è stato quello di aprire una riflessione attorno alla teoria della soggettivazione lacaniana, così per come ce l’ha lasciata in eredità Lacan, a singhiozzi, nei testi stabiliti a partire dai suoi trent’anni di insegnamento orale. Cosa può dirci una psicoanalisi asistematica, distante dalle istituzioni universitarie rispetto a problemi di una concretezza innervata di realtà? Chi frequenta i dipartimenti di Psicologia e assieme l’insegnamento lacaniano sa che è incommensurabile la distanza che intercorre tra la specificità e la settorializzazione degli strumenti istituzionali a confronto con l’universalità dei concetti larghi e volontariamente mai definiti dello psicoanalista parigino. Tra l’estremamente particolare (l’ad hoc della psicologia contemporanea) e l’estremamente universale (il concetto, unità sintetica della filosofia) si rischia di incorrere in un deragliamento del punto focale, causato da uno scontro di metodi epistemologici che si sono stabilizzati ai bordi opposti l’uno rispetto all’altro. Nella scelta di prendere in considerazione un tema vasto e generale come la teoria della soggettivazione c’era l’interesse, da parte nostra, di porlo in dialogo con il campo altrettanto vasto e generale del presente. Speriamo che questa prima ricerca possa costituirsi come un’indagine (sebbene parziale) sullo statuto del soggetto in quanto campo epistemologico aperto: attingendo dalla teoria psicoanalitica e dal dibattito che ne è scaturito, il presente volume segue molteplici sentieri analitici e sottolinea di contributo in contributo la difficoltà di giungere a un’idea organica di soggetto, per la varietà di ipotesi spesso contrastanti in merito alla sua rappresentazione, formalizzazione e interpretazione. In questa raccolta crediamo che i punti maggiormente messi in rilievo da chi ha collaborato riguardino il problema della genesi, lo statuto della trasformazione, e infine un’attenzione specifica è stata rivolta al registro del Reale e ai suoi effetti.
A cura di Lorenzo Curti e Irene Ferialdi
Scarica PDF
English version
DOI: https://doi.org/10.13135/2385-1945/9.2018
Pubblicato: settembre 2018
Indice
Editoriale
L. Curti, I. Ferialdi, Soggettivazioni: tra vuoti e contiguità [PDF It]
I. Genesi
P. G. Curti, Estrarre il soggetto [PDF It]
C. Mola, Intrecci concettuali. Il soggetto tra Hegel, Kojève e Lacan [PDF It]
A. Lattuada, L’atto reale e la genesi del soggetto nella psicoanalisi di Jacques Lacan [PDF It]
D. Tolfo, Per un'analisi non significante della soggettività: la funzione del punto-segno ne l'Anti-Edipo [PDF It]
II. Trasformazioni
L. Melandri, La parola contaminata dei movimenti non autoritari degli anni Settanta [PDF It]
R. Chiafari, Drammaturgia e metamorfosi del genio maligno: soggetti e spettri tra follie e ragione [PDF It]
M. Di Bartolo, La psicoanalisi come estetica dell'esistenza [PDF It]
A. Soares De Moura Costa Matos, Streaming Subjectivation: Two Questions and One Thesis about Netflix [PDF En]
III. Reale
F. Cimatti, La lingua c'è. Saussure, Chomsky e Lacan [PDF It]
A. Pagliardini, Verso il reale: schizofrenia/psicoanalisi [PDF It]
F. Vergine, Le origini trascendentali del mondo. Per un'ontologia topologica del reale [PDF It]
Traduzioni
A. Zupančič, Differenza sessuale e ontologia [PDF It]
F. Rambeau, La fosforescenza delle cose [PDF It]
Interviste e recensioni
Intervista a Franco Lolli [PDF It]
F. Zambonini, Una quasi-recensione a "Lacan, oggi. Sette conversazioni per capire Lacan" di Sergio Benvenuto e Antonio Lucci. Considerazioni marginali sul rapporto filosofia-psicanalisi [PDF It]
-
Rocco Ronchi – Deleuze. Credere nel reale
Recensioni / Settembre 2015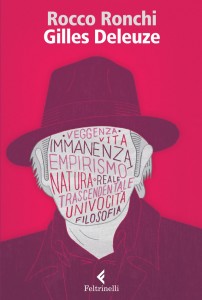 Perché un’altra monografia su Deleuze? E perché dedicare un lavoro a Deleuze in una collana che si chiama «Eredi» (diretta da Massimo Recalcati), quando si è cominciato il proprio cammino filosofico studiando Bergson? Ma, soprattutto, perché scegliere un sottotitolo, Credere nel Reale, per un saggio consacrato al re dei simulacri, a colui che ha rovesciato ogni credenza e ogni realtà, similmente a ogni credenza nella realtà?Il Deleuze di Rocco Ronchi (Feltrinelli, Milano 2015) non è l’ennesimo saggio dedicato al filosofo francese a cui Michel Foucault, con una lungimiranza prossima alla veggenza, legò le sorti della filosofia a venire. Non è l’ennesimo saggio però proprio perché lo è: è ennesimo e lo vuole essere.Questo è solo il primo dei tre paradossi con cui è possibile afferrare l’operazione che Ronchi fa col suo ultimo lavoro. Gli altri due sono veicolati rispettivamente dal rapporto che quest’ultimo intrattiene col titolo della collana («Eredi») e col suo stesso sottotitolo (Credere nel reale). A partire da questi tre interrogativi, solo apparentemente aporetici, è cioè possibile trattenere per qualche istante l’attenzione sulla nuova immagine che, di Deleuze, emerge dall’ultimo libro di Ronchi., non stupendosi però che sia proprio una via paradossale e lastricata da cattive intenzioni a permetterci di toccare il senso di questo breve ma calibratissimo saggio.
Perché un’altra monografia su Deleuze? E perché dedicare un lavoro a Deleuze in una collana che si chiama «Eredi» (diretta da Massimo Recalcati), quando si è cominciato il proprio cammino filosofico studiando Bergson? Ma, soprattutto, perché scegliere un sottotitolo, Credere nel Reale, per un saggio consacrato al re dei simulacri, a colui che ha rovesciato ogni credenza e ogni realtà, similmente a ogni credenza nella realtà?Il Deleuze di Rocco Ronchi (Feltrinelli, Milano 2015) non è l’ennesimo saggio dedicato al filosofo francese a cui Michel Foucault, con una lungimiranza prossima alla veggenza, legò le sorti della filosofia a venire. Non è l’ennesimo saggio però proprio perché lo è: è ennesimo e lo vuole essere.Questo è solo il primo dei tre paradossi con cui è possibile afferrare l’operazione che Ronchi fa col suo ultimo lavoro. Gli altri due sono veicolati rispettivamente dal rapporto che quest’ultimo intrattiene col titolo della collana («Eredi») e col suo stesso sottotitolo (Credere nel reale). A partire da questi tre interrogativi, solo apparentemente aporetici, è cioè possibile trattenere per qualche istante l’attenzione sulla nuova immagine che, di Deleuze, emerge dall’ultimo libro di Ronchi., non stupendosi però che sia proprio una via paradossale e lastricata da cattive intenzioni a permetterci di toccare il senso di questo breve ma calibratissimo saggio.Deleuze è stato infatti il filosofo che più di tutti, almeno nel 900, ha fatto del paradosso l’agente provocatore della filosofia, il lampo scatenante il tuono del pensiero. A esso, ci insegna, siamo costretti da un trauma, da un incontro imprevisto e letale al quale non possiamo sottrarci. Un unico e intempestivo incontro che poi risuona e si distribuisce frattalmente in piccoli traumi che si ripetono come “piccoli limiti” (L’Anti Edipo, 1972), traumi e limiti che coincidono con i singolari arresti della doxa, con i suoi controsensi e i suoi inciampi.
È qui che si comincia a pensare, perché è in un controtempo che Deleuze rintraccia la possibilità di “generare l’atto di pensare nel pensiero” (Differenza e ripetizione, 1968). E prima di lui fu Platone a intercettare la stessa possibilità nel contraccolpo provocato dai ta parakalunta, oggetti capaci di scuotere il pensiero provocando “sensazioni nello stesso tempo contrarie” (Filebo 46 c e Repubblica VII, 523 b). Pensare non è nulla di ovvio, afferma Ronchi (p. 77) e i ta parakalunta sono proprio le pieghe in cui si sospende il dativo dell’“a me pare”, sono gli scogli su cui si frantuma bruscamente l’opinione, i luoghi in cui si contorce e storce il duplice filo del senso comune e del buon senso.
Al bucolico e troppo irenico thaumazein di aristotelica memoria, Deleuze ha del resto sempre preferito il traumatizestai, l’essere ferito, la violenza dell’urto, l’impatto col Reale e col Fuori che, solo, forza il pensiero costringendolo al movimento. Il traumatizestai è dunque questa spinta paradossale e quella situazione ottica pura in cui, soltanto, gli eventi fanno segno (p. 63).
Che sia una via paradossale a permetterci di cogliere il senso di questo libro è dunque forse il primo e più significativo segno che non si tratta di lettera morta. Per dire, per esplicitare il sottinteso di una filosofia, lo storico, così come il saggista e lo scrittore, deve d’altronde condividere con quel pensiero una “causa comune”, la medesima urgenza nascosta magari tra le pieghe del discorso. In altre parole, l’atto ermeneutico è sempre creativo, ma creativo perché critico e critico perché violento.
«Con questo saggio non pretendo di aggiungere una mia introduzione all’opera di Gilles Deleuze alle tante, validissime, che circolano. La mia intenzione è un’altra. Ciò che mi sono proposto è scrivere un capitolo di storia della filosofia contemporanea» (p. 9). Tutto sta, quindi, nell’intendersi su cosa sia la storia della filosofia contemporanea e su cosa significhi scriverne un capitolo. Deleuze al riguardo è piuttosto chiaro: «Il mio modo di cavarmela –scrive ‒ consisteva soprattutto nel fatto di concepire la storia della filosofia come una specie di inculata o, che è lo stesso, di immacolata concezione. Mi immaginavo di arrivare alle spalle di un autore e fargli fare un figlio, che fosse suo e tuttavia fosse mostruoso» (Pourparler, 1990).
L’immacolata concezione evocata da Deleuze è critica radicale all’immagine dogmatica e stereotipata della filosofia e della storia che se ne scrive. «Critica» nel senso in cui, provocando un “crollo centrale” del pensiero, obbligandolo a pensare questo crollo e questa impotenza che è sua propria, essa apre una crisi che mette in causa il modello trascendentale implicato dall’immagine dogmatica, ossia il modello della ricognizione mediata dall’esercizio concorde di tutte le facoltà e garantita dall’identità dell’Io per un soggetto supposto identico. Nella sua differenza la filosofia deve, per Deleuze, opporre all’immagine l’avventura dell’incontro senza affinità né predestinazione. Detto altrimenti, in gioco è una certa tensione, da sopportare e da cui lasciarsi attraversare. Per Deleuze infatti non è questione di giudicare ma di “far esistere” (Critica e clinica, 1993), di creare, spingendo il pensiero critico fino in fondo, ossia al di là del principio della quadruplice e organica ragione.
“Sua e mostruosa”, in una parola, perturbante, la nuova immagine del pensiero (a cui Deleuze dà il nome di empirismo trascendentale) non è perciò una semplice rappresentazione ma un’intuizione e questa non tanto come sguardo panottico e distaccato che tenta il sorvolo quanto, piuttosto, come esperienza diretta, intensiva e affettiva di forze che si dispiegano e che disfano ogni elemento di trascendenza, il soggetto come l’oggetto. Questa è l’avanguardia deleuziana: stazionare, fuggire fermi sul posto, perché divenienti infinite variazioni. E quale filosofo non si augurerebbe di produrre una immagine del pensiero che non dipenda più dalla buona volontà del pensatore e dalla sua decisione premeditata? Chi cioè non vorrebbe affrancarsi dal dogmatico atteggiamento trascendentale che questiona le condizioni dell’esperienza possibile per guadagnare quella genitalità che è genesi statica e intrinseca dell’esperienza reale?
La differenza dunque risiede nella concezione di storia della filosofia che si presuppone e che, nel caso di Ronchi lettore di Deleuze, è indubbiamente mutuata dal suo oggetto di studio. Nessun racconto lineare in cui la vicenda si è già tutta consumata e che, da qualche parte nella “mente” dell’autore che si accinge a esporla, attende solo di essere “rivelata”. Nessun monumentale e mortifero allestimento di fatti avvenuti, e perciò morti, in cui il tempo del racconto non fa nulla (p. 9). Da Deleuze viene tutta un’altra idea di storia della filosofia che, accettando il suggerimento di Ronchi, si può definire “problematica”, campo e insieme teatro di una battaglia di cui non si conosce anticipatamente né l’esito né lo scioglimento. Del resto, solo l’assenza di presupposti punta dritta alla creazione. E lo fa procedendo senza concetto: come l’intuizione di Kant e al modo della differenza di Deleuze.
Affermare che il testo di Ronchi non è l’ennesimo saggio su Deleuze proprio perché lo è significa, allora, affermare quest’assenza di presupposti, ribadire quel “senza concetto”. Così vicino al “senza tempo” dell’inconscio di Freud, al “senza senso” del Reale che ossessiona Lacan, ma anche e soprattutto, al “senza immagini” che Deleuze attribuisce al pensiero.
E tuttavia, se il saggio di Ronchi non è l’ennesimo lavoro consacrato a Deleuze è perché, anzitutto, esso consiste in quell’atto, del vivente prima che della matematica (o della matematica perché del vivente) che è l’elevazione alla n, la “messa in potenza”. La n come lettera, viva, della ripetizione cara a Deleuze, della buona ripetizione in cui a tornare è la differenza. N è la lettera del ritornello a cui la musica fa subire il “trattamento molto speciale della diagonale o della trasversale” (Millepiani, 1980) strappandolo così alla sua territorialità. Ennesima è cioè la ripetizione che sfugge al concetto perché preferisce crearlo, è la differenza come forza selettiva. N è il tema assunto come radiale e non come terminale per dirla con Glenn Gould; è il marchio di quella “superfetazione di un atomo intuitivo e indicibile” che è il filosofo secondo Henri Bergson. N è, infine, il segno di una nuova immagine del pensiero.
A partire da un singolare anacronismo si sostanzia la scelta di dedicare a Deleuze e non a Bergson un saggio in una collana che si chiama «Eredi». Se infatti il filosofo, come Deleuze ama ricordare, è l’artista del concetto, egli è tale, ossia lo diviene, solo dopo essere stato un umile ritrattista. Perché è nel servizio, nell’apprendistato e nell’esercizio con la E maiuscola che si prepara il terreno propizio alla creazione. Ronchi ha cominciato ritraendo Bergson e lo ha fatto mostrando che ogni volta che si rileggono davvero, ossia integralmente e senza pregiudizi, i testi di autori famosi, di filosofi e maestri da tempo assegnati e «sistemati» entro la tradizione storico-critica, si scopre, con immenso stupore, quanto quest’ultima sia spesso in difetto rispetto alla verità. E siccome ogni apprentissage è, nel tempo, un’avventura dell’involontario (Proust e i segni, 1964), accade che, après-coup, dopo i colpi della tecnica e dell’esercizio, improvvisamente s’incontri qualcuno per la prima volta pur avendo certezza che sia l’ennesima. Primultima direbbe Jankélevitch.
 In una collana dedicata ai maestri di cui ci sente eredi, Ronchi sceglie Deleuze proprio perché ha cominciato con Bergson. Ritraendo il filosofo dell’élan vital (cose antiche), egli si è infatti imbattuto nell’empirismo trascendentale (cose meno antiche). Meglio: è riuscito a ritrarre Bergson come un filosofo dell’interpretazione solo perché, senza saperlo, era già interpretante dei segni deleuziani (cose antiche che vengono dopo cose meno antiche). Come ricorda Deleuze: «apprendere è qualcosa che concerne essenzialmente i segni. Questi sono appunto oggetto di un apprendimento temporale e non di un sapere astratto […] Occorre essere predisposto ai segni, aprirsi al loro incontro, aprirsi alla loro violenza» (Proust e i segni, 1964).
In una collana dedicata ai maestri di cui ci sente eredi, Ronchi sceglie Deleuze proprio perché ha cominciato con Bergson. Ritraendo il filosofo dell’élan vital (cose antiche), egli si è infatti imbattuto nell’empirismo trascendentale (cose meno antiche). Meglio: è riuscito a ritrarre Bergson come un filosofo dell’interpretazione solo perché, senza saperlo, era già interpretante dei segni deleuziani (cose antiche che vengono dopo cose meno antiche). Come ricorda Deleuze: «apprendere è qualcosa che concerne essenzialmente i segni. Questi sono appunto oggetto di un apprendimento temporale e non di un sapere astratto […] Occorre essere predisposto ai segni, aprirsi al loro incontro, aprirsi alla loro violenza» (Proust e i segni, 1964).Dalle cinque sezioni-sfondo in cui si articola il volume, si staglia l’immagine di un Deleuze radicalmente monista, inaspettatamente platonico e sorprendentemente reale. Contro ogni lettura della filosofia deleuziana in termini di metamorfismo energetico, caleidoscopico e, però, eminentemente entropico, Ronchi insiste su quell’unico ritornello, su quell’unico evento colto da diverse date e rifrangentesi in quella “multiversità dello spettro filosofico” (P.A. Rovatti) che è la filosofia di Deleuze, il quale, come l’autore sottolinea più volte, dice, in fondo, sempre la stessa cosa. In secondo luogo, ribaltando la vulgata tradizionale – quella che allestisce l’immagine, forse la più stereotipata, di un Deleuze eroe del rovesciamento del platonismo, colui che cioè ha realizzato, nel senso di portare a compimento, il programma nietzscheano ‒ Ronchi piazza al centro del pensiero contemporaneo l’immagine di un Deleuze profondamente platonico, di un Deleuze classico e perciò davvero eversivo. Infine, alla lettura militante ma sclerotizzata che ha fornito le chiavi per aprire e utilizzare quello scrigno di parole-azione che è L’Anti Edipo, immagine sacrificata all’aut-aut tra simbolico e immaginario, Ronchi sostituisce quella di un Deleuze speculativo, filosofo rigoroso e singolarmente realista, nel duplice senso di colui che, con un unico atto di fede nel Reale, dichiara simultaneamente scacco matto al re e alla regina. Né simbolico né immaginario, al di là del padre e della madre, il Deleuze di Ronchi è infatti assolutamente reale, vera e propria intrusione del primum et tertium, puro e anedipico, che spezza il doppio vincolo tra legge repressiva e godimento illimitato. Facendo dell’intuizione un metodo e della diairesis agonistica il suo banco di prova, la lettura che Ronchi propone di Deleuze è militante perché atletica, in lotta per l’affermazione dell’infinita uguaglianza dell’essere in ogni ente contro ogni oscena e fascista visione di questa univocità.
Si tratta, per riprendere una battuta delle pagine iniziali del testo, di essere “veggenti più che attanti”, di provare a vedere nella luce più che con gli occhi e di indicare, poi, ciò che si è visto, piuttosto che sforzarsi a organizzarne fin da subito la traduzione simbolica. Il mistico infatti “fissa, intensifica e completa in azione” ma, soprattutto, crede. Crede intransitivamente perché veggente. L’atto di fede è questa forza neghentropica che approda a un’immagine diretta del tempo e/o dell’evento e che spinge in direzione contraria all’entropia del senso comune (p. 18). E l’evento in questione è il ’68. A quella data Deleuze associa l’intrusione del Reale puro, del Reale univoco che è processo morfogenetico, produzione incessante della forma risalente all’indietro la china dell’indifferenziato. Se il Deleuze di Ronchi non né simbolico né immaginario è perché è un’esperienza pura, un’intuizione come simultaneità delle due direzioni contrarie e una penetrazione insieme impossibile (per la rappresentazione) e necessaria (alla filosofia).
Solo nell’opportuna espressione, che è inevitabile esplicatio, di questa esperienza e complicatio riecheggia quell’unico ritornello che intona ciò che tutti vogliamo e siamo: unitas multiplex. Ed è questo rumore di fondo, che è quello del processo ‒ per dirla con Whitehead ‒, dell’atto in atto – per usare un lessico caro a Gentile ‒ e/o della molteplicità illimitata e mouvante di forme finite, che sono le immagini mobili di Bergson e le figure atletiche di Deleuze, che bisogna allenarsi a ascoltare trasformando l’occhio in orecchio. Si tratta di esercitarsi a stazionare presso questo brusio fino a fare tutt’uno con esso, fino a sentirsi divenire quel rumore e quel fondo. Solo così si è degni dell’istante pulsionale in cui Alfa cortocircuita Omega.
Se questo, come rimarca Ronchi, è il programma di ogni ontologia è perché è anzitutto il compito primo della filosofia, della philosophia perennis et bona: «arrivare alla formula magica che cerchiamo tutti. Pluralismo=monismo, passando per tutti i dualismi che sono il nemico, ma il nemico assolutamente necessario, il mobile che non cessiamo di spostare» (p.79). Millepiani = un piano: questo è il sesamo per una filosofia dell’immanenza assoluta.
di Alessandra Campo
-
Martha C. Nussbaum – Persona oggetto
Recensioni / Marzo 2015 Può l’oggettualizzazione essere considerata una parte meravigliosa e inestirpabile della vita sessuale? È questa la spiazzante domanda che Martha Nussbaum si pone in un articolo risalente al 1995, ora disponibile in edizione italiana presso le Edizioni Centro Studi Erickson, dal titolo Persona oggetto. In quell’occasione la filosofa americana si inseriva in un dibattito che trovava quali interlocutrici privilegiate due voci autorevoli e irriverenti del femminismo radicale d’oltreoceano come Andrea Dworking e Catharine MacKinnon. L’oggetto del contendere – mi si perdoni il gioco di parole – consisteva nella ridefinizione di un concetto fondamentale della teoria femminista, per la quale appunto l’oggettualizzazione rappresentava il problema centrale nella vita delle donne – ma anche eventualmente per gli uomini, data la generalità della questione – e contro il quale andava concentrato tutto l’impegno politico. Il testo che qui proponiamo alla lettura tenta di fare chiarezza sul senso del termine oggettualizzazione, non tanto proponendone una definizione chiara ma piuttosto dimostrando la sua ambiguità sia logica che morale attraverso l’esempio fornito da sei estratti di altrettanti romanzi, nei quali sono narrati una serie di comportamenti che oggettualizzano il o la partner sessuale in modi difficilmente giudicabili in maniera univoca. Partendo da Lawrence e Joyce per giungere a Hollinghurst e Henry James, senza dimenticare Playboy e Laurence St. Clair, Nussbaum mostra come la definizione più elementare di tale comportamento, «trattare come un oggetto ciò che in realtà non è un oggetto, ciò che è, di fatto, un essere umano», non renda la complessità di una simile pratica.
Può l’oggettualizzazione essere considerata una parte meravigliosa e inestirpabile della vita sessuale? È questa la spiazzante domanda che Martha Nussbaum si pone in un articolo risalente al 1995, ora disponibile in edizione italiana presso le Edizioni Centro Studi Erickson, dal titolo Persona oggetto. In quell’occasione la filosofa americana si inseriva in un dibattito che trovava quali interlocutrici privilegiate due voci autorevoli e irriverenti del femminismo radicale d’oltreoceano come Andrea Dworking e Catharine MacKinnon. L’oggetto del contendere – mi si perdoni il gioco di parole – consisteva nella ridefinizione di un concetto fondamentale della teoria femminista, per la quale appunto l’oggettualizzazione rappresentava il problema centrale nella vita delle donne – ma anche eventualmente per gli uomini, data la generalità della questione – e contro il quale andava concentrato tutto l’impegno politico. Il testo che qui proponiamo alla lettura tenta di fare chiarezza sul senso del termine oggettualizzazione, non tanto proponendone una definizione chiara ma piuttosto dimostrando la sua ambiguità sia logica che morale attraverso l’esempio fornito da sei estratti di altrettanti romanzi, nei quali sono narrati una serie di comportamenti che oggettualizzano il o la partner sessuale in modi difficilmente giudicabili in maniera univoca. Partendo da Lawrence e Joyce per giungere a Hollinghurst e Henry James, senza dimenticare Playboy e Laurence St. Clair, Nussbaum mostra come la definizione più elementare di tale comportamento, «trattare come un oggetto ciò che in realtà non è un oggetto, ciò che è, di fatto, un essere umano», non renda la complessità di una simile pratica.Complessità che affiora invece in maniera evidente dalle molteplici e stratificate connessioni logiche che intercorrono tra le sette nozioni fondamentali (Strumentalità, Negazione dell’autonomia, Inerzia/Passività, Fungibilità, Violabilità,
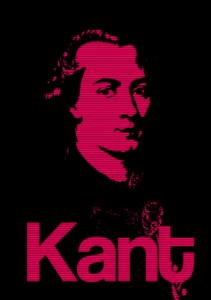 Proprietà, Negazione della soggettività) riconosciute quali modalità determinanti nel trattare una persona come una cosa. Spesso infatti, ammonisce l’autrice, usiamo tale termine come un contenitore approssimativo applicando il quale giudichiamo solo uno di questi tratti, benché più frequentemente siano presenti una pluralità di elementi nel suo verificarsi. Dunque per capire che cosa accade e quando si tratta di oggettualizzazione bisogna chiedersi se ciascuna di queste voci sia una condizione sufficiente perché si possa definire un comportamento oggettualizzante. L’analisi che ne segue mette in luce una grande varietà nelle modalità attraverso le quali ci relazioniamo agli oggetti – tra loro molto differenti come una penna a sfera e un quadro di Monet – ma nello specifico mostra che gli elementi che caratterizzano maggiormente il nostro modo di trattare un oggetto sono la considerazione di non autonomia e di strumentalità in quanto moralmente più esigenti. In particolare la non strumentalità risulta determinante nel veder garantita l’umanità altrui kantianamente intesa come fine in sé. Del resto trattiamo i nostri figli piccoli come soggetti non autonomi ma sarebbe riprovevole considerarli come meri strumenti per i nostri scopi. Il rapporto tra autonomia e strumentalità è invece messo in evidenza dalla condizione dei lavoratori e da quella degli schiavi.
Proprietà, Negazione della soggettività) riconosciute quali modalità determinanti nel trattare una persona come una cosa. Spesso infatti, ammonisce l’autrice, usiamo tale termine come un contenitore approssimativo applicando il quale giudichiamo solo uno di questi tratti, benché più frequentemente siano presenti una pluralità di elementi nel suo verificarsi. Dunque per capire che cosa accade e quando si tratta di oggettualizzazione bisogna chiedersi se ciascuna di queste voci sia una condizione sufficiente perché si possa definire un comportamento oggettualizzante. L’analisi che ne segue mette in luce una grande varietà nelle modalità attraverso le quali ci relazioniamo agli oggetti – tra loro molto differenti come una penna a sfera e un quadro di Monet – ma nello specifico mostra che gli elementi che caratterizzano maggiormente il nostro modo di trattare un oggetto sono la considerazione di non autonomia e di strumentalità in quanto moralmente più esigenti. In particolare la non strumentalità risulta determinante nel veder garantita l’umanità altrui kantianamente intesa come fine in sé. Del resto trattiamo i nostri figli piccoli come soggetti non autonomi ma sarebbe riprovevole considerarli come meri strumenti per i nostri scopi. Il rapporto tra autonomia e strumentalità è invece messo in evidenza dalla condizione dei lavoratori e da quella degli schiavi.Questi ultimi due esempi mostrano inoltre che riducendo a mero strumento un altro essere umano, sembra manifestarsi un’automatica tendenza nel produrre altre forme di oggettualizzazione non implicate logicamente dalla prima a causa di un blocco dell’immaginazione. Come se fosse più difficile rendersi conto dell’umanità altrui. Nonostante ciò anche la strumentalità – ci avverte Nussbaum – non risulta negativa in tutti i contesti ma solo quando l’altro viene trattato principalmente o esclusivamente come strumento. Non parleremo infatti di strumentalizzazione in senso negativo qualora usassi la pancia della mia amante come cuscino, a patto di avere il suo consenso naturalmente, ma anche in questa situazione si tratterebbe ugualmente di strumentalizzazione. Ciò che ne emerge è che per determinare un trattamento di oggettualizzazione nei confronti di qualcuno entrano in gioco valutazioni complesse che non si devono limitare all’individuazione di una sola delle nozioni indicate, ma piuttosto distinguere quali di queste si manifestano e in quale relazione si dispongono, con la consapevolezza che prese di per sé singolarmente e fuori contesto non possiedono un carattere intrinsecamente negativo o positivo.

È a questo punto che Nussbaum mostra il suo legame con la teoria kantiana del desiderio sessuale e del matrimonio. La filosofa americana concorda in parte con Kant rispetto all’idea che il desiderio sessuale sia una forza molto potente che contribuisce alla strumentalizzazione delle persone come se fossero cose, mezzi per la soddisfazione dei propri desideri. Nell’atto sessuale – secondo il filosofo tedesco – entrambi i soggetti smettono di considerare l’altro come autonomo e come dotato di soggettività poiché non si domandano più che cosa l’altra persona sente o pensa, protese come sono ad assicurarsi la propria soddisfazione. Al tempo stesso però il forte interesse reciproco di entrambe le parti per la soddisfazione sessuale le spingerà a permettere a se stesse di farsi trattare come cose, farsi cioè deumanizzare per deumanizzare a loro volta l’altro/a. Tale dinamica non presenta connotazioni di genere o asimmetrie gerarchiche di matrice sociale ma è intrinseca all’atto sessuale stesso. La reciprocità diviene dunque elemento rilevatore della natura intrinsecamente ambigua della relazione sessuale, nella quale strumentalizzazione, inerzia, passività etc., possono avere un ruolo positivo a seconda del contesto. «Il contesto è tutto» se affrontiamo un'analisi di questo genere poiché operiamo su di un terreno in cui la psicologia dei particolari individui coinvolti risulta determinante, così come la natura del loro rapporto e le sue dinamiche interne in relazione alle consuetudini culturali nel quale è immerso. Spesso intimi scambi di battute, atteggiamenti e comportamenti tra amanti, se avulsi dalla situazione in cui si verificano o vengono pronunciati, possono essere fraintesi poiché ciò che viene perduto dalla generalizzazione è proprio quella densità significante data dall’interrelazione tra essa e gli elementi che compongono, stratificandolo, il concetto di oggettualizzazione.
 A questo livello opera la critica di Nussbaum nei confronti delle posizioni assunte da Dworking e MacKinnon che, se pur fedeli alla visione kantiana dell’incompatibilità tra rispetto e negazione dell’autonomia, della soggettività e strumentalizzazione, non sono disposte a credere che tali negazioni siano intrinseche alla natura stessa del desiderio sessuale, ma fanno pendere l’ago della bilancia interamente verso la socializzazione dell’erotismo in un contesto ricco di gerarchia e dominazione. Ciò impedisce loro di distinguere i differenti aspetti che costituiscono l’oggettualizzazione e che fanno emergere la complessità del desiderio e della sessualità. Questa semplificazione del campo di indagine si riflette soprattutto a livello politico poiché la soluzione addotta per questo stato di cose consisterà in un progressivo disfacimento di tutte le strutture istituzionali che inducono gli uomini a erotizzare il potere. Se pur in parte d’accordo sulla necessità di una profonda riforma sociale e istituzionale, Nussbaum pare meno incline a considerare le istituzioni soltanto in senso negativo; il punto non sembra tanto essere una questione di disfacimento, quanto piuttosto di modifica e riformulazione attraverso la conoscenza di come gli elementi che costituiscono la pratica dell’oggettualizzazione si connettono, interagiscono ed emergono dal contesto.
A questo livello opera la critica di Nussbaum nei confronti delle posizioni assunte da Dworking e MacKinnon che, se pur fedeli alla visione kantiana dell’incompatibilità tra rispetto e negazione dell’autonomia, della soggettività e strumentalizzazione, non sono disposte a credere che tali negazioni siano intrinseche alla natura stessa del desiderio sessuale, ma fanno pendere l’ago della bilancia interamente verso la socializzazione dell’erotismo in un contesto ricco di gerarchia e dominazione. Ciò impedisce loro di distinguere i differenti aspetti che costituiscono l’oggettualizzazione e che fanno emergere la complessità del desiderio e della sessualità. Questa semplificazione del campo di indagine si riflette soprattutto a livello politico poiché la soluzione addotta per questo stato di cose consisterà in un progressivo disfacimento di tutte le strutture istituzionali che inducono gli uomini a erotizzare il potere. Se pur in parte d’accordo sulla necessità di una profonda riforma sociale e istituzionale, Nussbaum pare meno incline a considerare le istituzioni soltanto in senso negativo; il punto non sembra tanto essere una questione di disfacimento, quanto piuttosto di modifica e riformulazione attraverso la conoscenza di come gli elementi che costituiscono la pratica dell’oggettualizzazione si connettono, interagiscono ed emergono dal contesto.L’uso della letteratura assume proprio questo scopo, fungendo all’autrice da laboratorio sperimentale nel quale mettere alla prova la sua proposta e la critica alle sue interlocutrici, analisi questa che lasciamo percorrere al lettore.
di Alberto Giustiniano