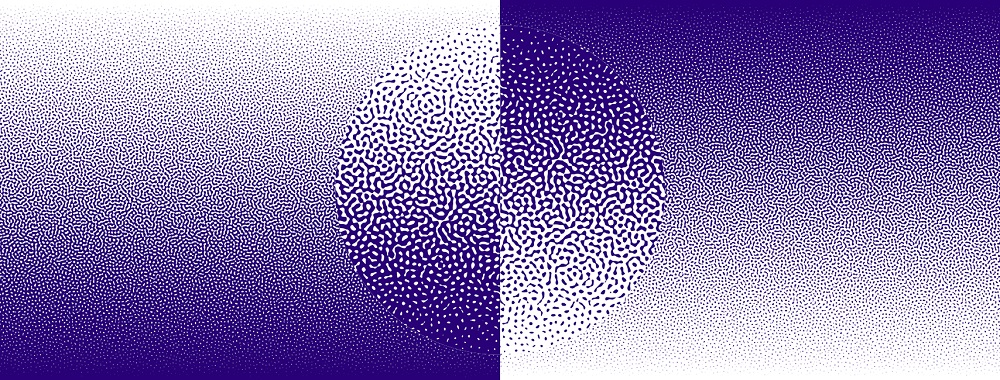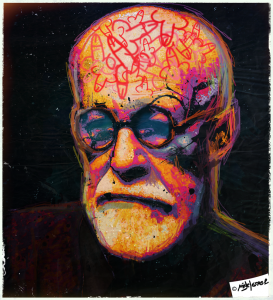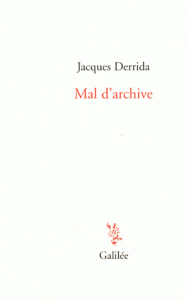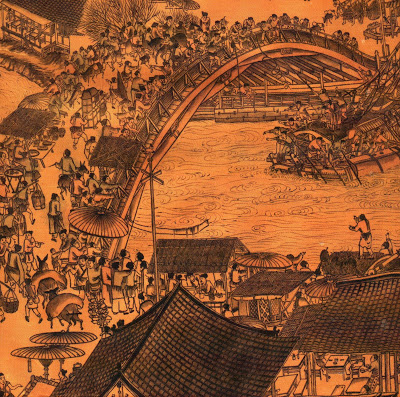Pinne scagliose, penne remiganti, corna, zanne, pellicce e colori aposematici, arti di ogni foggia e dimensione che incidono, artigliano e pestano il substrato. La pletora di predicati, la stravagante e composita coda di pavone sfoggiata dal vivente non umano, affascina o terrorizza, ma di sicuro non lascia indifferenti. L’appeal generato dalle molteplici fattezze del mondo animale stupisce l’uomo e lo attrae, oggi come in passato. È sufficiente sfogliare le cento tavole litografiche contenute ne Le forme d’arte della Natura (1904), opera artistico-scientifica del biologo tedesco Ernst Haeckel, per cogliere il medesimo senso di meraviglia che pervade Charles Darwin nella stesura delle ultime, stupefacenti pagine de L’origine delle specie (1859). Ma che si tratti del padre dell’evoluzionismo in viaggio nei mari del sud o di un qualsivoglia bambino alla scoperta del mondo prossimo, la certezza è una sola: è l’animale l’entità non umana che in noi suscita immediata attrazione. Ma allora, si domanda Roberto Marchesini nel suo Epifania animale. L’oltreuomo come rivelazione, per quale motivo all’animale, alterità principe con cui l’uomo si interfaccia da sempre, è stato destinato un ruolo di secondo piano nelle dissertazioni filosofiche, una categoria indifferenziata in opposizione a quella umana? Perché all’animale è stata imposta la funzione di sfondo che attornia il palcoscenico su cui l’uomo esercita il suo protagonismo?
«Dovunque posiamo lo sguardo troviamo unicità, e unicità significa diversità» scrive Ernst Mayr nell’incipit del suo seminale Storia del pensiero biologico (1982), esponendo un concetto che oggi sintetizzeremmo in un solo termine: biodiversità. Ma la pluralità di predicati che caratterizza il mondo dei viventi non consente di ragionare in termini di categorizzazione oppositiva, in quanto ogni specie possiede caratteri che ne permettono l’adattamento all’ambiente ma che non possono essere utilizzati per far emergere una specie rispetto alle altre al fine di operare una spaccatura dicotomizzante. Se la frattura non può sfruttare la specificità/diversità dei predicati animali allora si rende necessaria una mossa differente, che sposti l’attenzione sul radicamento di ogni essere non umano ai suoi predicati. L’ambiente-mondo che ogni animale abita e in cui ogni animale agisce e percepisce – l’Umwelt di J. J. von Uexküll – diventa quindi una dimensione imprigionante, un mondo-monade non sovrapponibile a quello occupato da un’altra specie. L’eterospecifico resta schiavo della sua specializzazione, inabile di quella fondamentale capacità di astrazione dal qui-e-ora propria invece dell’umano. La dicotomia è stata dunque creata: l’essere umano è libero perché non declinato, condizione che gli permette di determinarsi attraverso un processo autarchico, mentre l’animale – essere mancante di slanci creativi e colpito dal Benommenheit, lo stordimento teorizzato da Heidegger – è de-soggettivato in quanto mero abitatore di mondi, prigioniero di pulsioni e istinti.

La tradizione classica assegna alla figura mitica di Epimeteo, il titano non avveduto, il ruolo di elargitore delle facoltà naturali agli esseri appena creati dalla miscela di terra, fuoco e altri elementi. Come si legge nel Protagora, Epimeteo è talmente coinvolto nella distribuzione di pellicce, abilità e dimensioni che dimentica l’uomo, lasciandolo nudo, scalzo e circondato da una selva di animali altamente specializzati. Ecco allora che il lavoro maldestro del titano causa una netta disparità fra gli esseri viventi, consentendo al paradigma umanistico di inaugurare una stagione di pensiero basata su di una dicotomia netta e difficilmente sanabile. La lettura umanistica dei predicati epimeteici – che interpreta il predicato animale come trappola, simile a una bolla spazio-temporale che ingloba l’eterospecifico – consente all’essere umano di emergere. L’uomo si percepisce isolato e nudo, ma è proprio il senso di carenza che egli prova a essere una condizione solo all’apparenza disastrosa. Infatti dal mito dell’incompletezza l’uomo s’innalza quale essere non specializzato, centripeto, non predeterminato e proprio per questo capace di autoderminarsi. Così come l’eterospecifico viene inserito a forza in un imbuto da cui esce l’indifferenziato-animale, categoria che annulla la pluralità di predicati e appiattisce la diversità, dalla figura umana carente e nuda sorge l’uomo creatore di mondi, dotato da Prometeo – il titano che ruba agli dèi per completare i mortali – di tecnica e ragione. Che il prometeismo sia basato sulla carenza filogenetica di partenza o sull’emergenza ex-post di predicati caratteristici (per esempio il linguaggio, come hanno suggerito molti autori, da Chomsky a Dennett) poco importa, in quanto tale antropocentrismo segrega l’animale in una bolla sincronica e pone l’uomo in una posizione eccentrica, separandoli con uno iato ontologico che ha il potere di elevare il secondo e di nominarlo unico attante del proprio processo poietico, un percorso rigidamente autarchico e privo di qualsiasi ibridazione con il non umano.
Partendo da un’analisi ad ampio raggio del paradigma umanistico e del ruolo che l’animale occupa in esso, Roberto Marchesini giunge ad analizzare l’incontro fra l’eterospecifico e l’uomo, un momento di fondamentale importanza che deve riappropriarsi dei propri presupposti dialogici. L’uomo autarchico, isolato e distante teorizzato dai principali esponenti dell’antropologia filosofica (Scheler, Plessner e Gehlen) deve superare l’abisso che lo separa dal vivente non umano, cosicché possa ritrovare il suo principale interlocutore dialogico, abbandonando al tempo stesso la sua deriva narcisistica. L’antropopoiesi necessita di un motore decentrativo, un’entità riflettente in grado di favorire la riflessione e permettere lo sviluppo successivo all’apprendistato specie-specifico e alla declinazione adattativa. E qual è dunque l’entità riflettente principe, il prossimo non umano con il quale l’uomo ha fin dal principio potuto rapportarsi in modo dialogico? Proprio l’animale risponde Marchesini, quell’animale che sfoggia una miriade di predicati che affascinano e attirano l’uomo con il suo appeal irresistibile. L’incontro con l’eterospecifico si muove lungo due coordinate precise: il riconoscimento della comunanza (l’unità biologica e filogenetica, il “ponte darwiniano”) – un sentimento amplificato dalle straordinarie capacità empatiche della nostra specie – e successivamente il riconoscimento della diversità. Affinché l’incontro abbia carattere epifanico, l’uomo deve riuscire a proiettarsi nella dimensione animale, spazio a lui estraneo ma proprio per questo saturo di creatività e possibilità, e unico luogo in cui è possibile l’evento epifanico. Per riprendere l’«icona ermeneutica» di Derrida, l’animale che dunque, per comunanza, l’uomo è individua nella dimensione animale in cui si proietta la diversità che lo contraddistingue, riconoscendo nell’eterospecifico l’animale che dunque non è. Solo allora, quando l’animale diventa alterità, avviene l’epifania, vale a dire l’assunzione di una posizione decentrata dalla quale l’uomo può osservare se stesso. Il riconoscersi nella diversità, tappa imprescindibile dell’intero processo per la quale Marchesini conia l’espressione «biocentrismo funzionale», non è possibile nell’interpretazione umanistica, in cui l’eterospecifico è un essere estraneo all’uomo, la res extensa con cui egli non può e non deve entrare in contatto.

L’immagine che l’uomo ha di sé in seguito all’incontro con l’eterospecifico è un riflesso modificato dalla sorprendente scoperta di una realtà a lui così prossima eppure così diversa. Le vie del possibile inaugurate dall’epifania animale restituiscono all’uomo nuove immagini di sé: l’uomo si scopre teriomorfo, superandosi e attirandosi sempre più in posizione decentrata. La lettura classica dei predicati epimeteici ripresa dall’umanismo viene ribaltata dal riconoscimento dell’epifania animale e delle sue conseguenze quando la pluralità di predicati ostentata dal mondo animale diviene una distesa pressoché infinita di possibili ibridazioni che alimentano il bisogno metamorfico dell’uomo. L’epimeteismo è quindi la dimensione del possibile (l’animale che dunque potrei essere) così come il prometeismo assume un nuovo significato: l’assunzione nel proprio corpo di forme nuove e ibride ispirate dai predicati dell’eterospecifico. Ecco dunque la zoomimesis, vale a dire l’atto di assumere forma ibrida attraverso i predicati oltreumani, momento in cui l’uomo si fa animale con la danza, la musica, la cosmesi, il rituale e la moda.
La lenta ma inesorabile erosione della tradizione umanistica nel corso del Novecento ha inaugurato spazi in cui prendono forma nuove concezioni dell’umano. L’epifania animale che porta all’emergenza dell’oltre uomo si situa al centro del paradigma post-umanistico, pensiero in cui l’uomo perde progressivamente centralità a causa delle continue ibridazioni con l’alterità e della moltiplicazione delle interfacce di dialogo col mondo. Nel saggio Epifania Animale, Roberto Marchesini lega in modo inestricabile l’eterospecifico all’uomo e sottolinea la natura ibrida di quest’ultimo: «Ogni auto-poiesi è in realtà un atto etero-riferito». In città sempre più simili a barriere coralline e foreste pluviali per complessità di rapporti e piani di connessione, il riconoscimento dell’animale non umano come ispiratore di mondi possibili non può e non deve passare inosservato. L’eterospecifico non è mero fondale, uno scenario inanimato e immobile all’interno del quale l’uomo si muove recitando la parte principale, bensì interlocutore dell’uomo, co-protagonista del dialogo che genera l’antropopoiesi umana.
di Danilo Zagaria