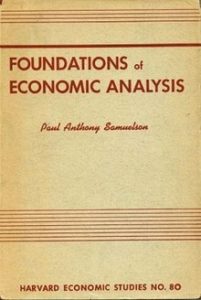 Secondo la ben nota, non solo tra i filosofi, “fallacia naturalistica” di Hume, è illecito dedurre dall’essere il dover essere, dai fatti i valori, dalle spiegazioni i desideri, dal vero il bene. Allo studio dell’essere, dei fatti, delle spiegazioni e della verità si sono da sempre dedicate le scienze “dure”, cioè le scienze naturali, che hanno carattere descrittivo, e mai normativo. L’economia, almeno nella sua accezione mainstream, è la scienza sociale generalmente ritenuta più vicina, nei suoi metodi, alle scienze naturali: a tale indirizzo “scientista” ha dato lustro l’opera di Paul Samuelson. Nel 1947 egli diede alle stampe un’opera fondamentale, dal titolo Foundations of Economic Analysis, in cui, tramite l’applicazione dei principi dell’equilibrio termodinamico alla teoria neoclassica dell’equilibrio, delineava un modello elegante ed efficace per una teoria generale dell’equilibrio economico: secondo Samuelson, così come fanno i sistemi fisici, anche i sistemi economici reagiscono alle modifiche esterne, minimizzandone l’impatto e preservando il loro stato di equilibrio. L’opera di Samuelson è rilevante anche per gli scopi teorici che si prefigge dal punto di vista metodologico: l’autore si propone infatti di procedere ad un lavoro di unificazione, attraverso il linguaggio della matematica, dei fondamenti della teoria neoclassica micro e macroeconomica. Nel 1970, egli fu il primo economista americano ed essere insignito del premio Nobel: i suoi meriti scientifici consistono nel progetto di formalizzazione matematica delle tesi elaborate dagli economisti neoclassici, operazione che permise di elevare il livello di analisi della scienza economica.
Secondo la ben nota, non solo tra i filosofi, “fallacia naturalistica” di Hume, è illecito dedurre dall’essere il dover essere, dai fatti i valori, dalle spiegazioni i desideri, dal vero il bene. Allo studio dell’essere, dei fatti, delle spiegazioni e della verità si sono da sempre dedicate le scienze “dure”, cioè le scienze naturali, che hanno carattere descrittivo, e mai normativo. L’economia, almeno nella sua accezione mainstream, è la scienza sociale generalmente ritenuta più vicina, nei suoi metodi, alle scienze naturali: a tale indirizzo “scientista” ha dato lustro l’opera di Paul Samuelson. Nel 1947 egli diede alle stampe un’opera fondamentale, dal titolo Foundations of Economic Analysis, in cui, tramite l’applicazione dei principi dell’equilibrio termodinamico alla teoria neoclassica dell’equilibrio, delineava un modello elegante ed efficace per una teoria generale dell’equilibrio economico: secondo Samuelson, così come fanno i sistemi fisici, anche i sistemi economici reagiscono alle modifiche esterne, minimizzandone l’impatto e preservando il loro stato di equilibrio. L’opera di Samuelson è rilevante anche per gli scopi teorici che si prefigge dal punto di vista metodologico: l’autore si propone infatti di procedere ad un lavoro di unificazione, attraverso il linguaggio della matematica, dei fondamenti della teoria neoclassica micro e macroeconomica. Nel 1970, egli fu il primo economista americano ed essere insignito del premio Nobel: i suoi meriti scientifici consistono nel progetto di formalizzazione matematica delle tesi elaborate dagli economisti neoclassici, operazione che permise di elevare il livello di analisi della scienza economica.
Il dibattito, tuttavia, resta aperto: l’economia è una scienza naturale? Studia i fatti o studia i valori? Le scienze sociali hanno potere predittivo? Prevedono esperimenti? È possibile equipararle alle scienze “dure”? Quale rigore scientifico ci aspettiamo da esse? È nell’ambito di questa disputa metodologica che è importante affrontare lo studio di due tra le principali scuole del pensiero economico contemporaneo, spesso confuse e poco lette al di fuori del pubblico degli addetti ai lavori: la scuola di Chicago e la scuola austriaca, le due tradizioni di studi che, attraverso due approcci per molti versi opposti, più hanno caratterizzato il dibattito epistemologico ed economico-politico del Novecento.
Secondo gli austriaci, la cui scuola di pensiero nacque a Vienna alla fine dell’Ottocento, l’homo oeconomicus, l’attore economico della tradizione neoclassica, non agisce sempre in modo razionale, vale a dire, allo scopo di massimizzare gli utili e minimizzare le perdite: tutti i fenomeni economici hanno infatti il proprio fondamento nelle scale di valori liberamente scelti dai singoli individui, e relativamente alle particolari circostanze che questi ultimi si trovano di volta in volta ad affrontare – a differenza del paradigma mainstream, infatti, i bisogni sono sempre situati, mai semplicemente “dati”. In conseguenza di ciò, gli austriaci sono convinti che la libertà sia il più alto valore morale, da preservare e garantire a ogni costo. Per questa ragione, dal punto di vista metodologico, gli austriaci diffidano del culto per gli strumenti matematici degli economisti mainstream, che a loro parere non possono restituire, col solo affidarsi alle grandezze aggregate, la complessità della libera azione umana. Se, dal lato epistemologico, il “culto del numero” è uno strumento riduttivo per catturare la spontaneità dell’azione umana, dal lato epistemologico esso risulta persino dannoso. La pianificazione economica, che per definizione si avvale di statistiche, modelli e predizioni, secondo gli austriaci è una minaccia per la libertà umana: non esiste una “volontà collettiva”, né il “bene comune”, e ogni decisione è presa dai singoli individui, che, se messi nelle condizioni di agire liberamente, sono in grado di autoregolarsi senza l’intervento paternalistico del potere politico: è evidente, a questo punto, come questo argomento sia connesso a una critica esplicita alla pianificazione economica del socialismo. Ne consegue che il liberalismo sia l’unica opzione, in politica e in economia, per garantire benessere e progresso.
Il caposcuola, che ne definì anche i fondamenti epistemologici, fu Carl Menger, il quale, nei suoi Principi fondamentali di economia (1871), affermò che gli economisti possono formulare leggi generali e principi validi in qualsiasi luogo e tempo, ma questo non significa che si possano rinvenire delle relazioni quantitative stabili nei dati statistici relativi alle attività economiche. Anzi, la statistica nasconde la vera realtà della vita sociale ed economica: le grandezze aggregate sono inutilizzabili perché non restituiscono la complessità di milioni di individui che effettuano in modo libero e spontaneo le loro scelte. Per questa ragione, gli austriaci diffidano dell’uso e dell’abuso degli strumenti matematici così diffusi nel mainstream, dato che le scelte e i valori non sono entità numericamente descrivibili. Dalla pubblicazione del suo saggio Sul metodo delle scienze sociali (1883) ebbe origine una diatriba (spesso indicata con il nome di Methodenstreit) tra la scuola austriaca, che difendeva un approccio logico-deduttivo grazie al quale era possibile dedurre leggi universalmente valide a partire da primi principi, e la scuola storica tedesca, in particolare Gustav Schmoller (1838-1917), secondo cui gli economisti dovrebbero soffermarsi sulla raccolta e sullo studio di fatti storici, diffidando di teorie non derivate dall’esperienza storica. Nella sua opera, Menger coniava la distinzione tra “scienze teoretiche” e “scienze storiche”: mentre le prime formulano leggi e teorie generali, le seconde si limitano a rilevare regolarità contingenti. La disputa sul metodo delle scienze sociali coinvolse anche i pensatori neokantiani, e in particolare dalla scuola del Baden, tra i cui maggiori esponenti vi fu Wilhelm Windelband (1848-1915), che coniò la distinzione tra scienze nomotetiche e scienze ideografiche: le scienze nomotetiche, o scienze naturali, come la fisica, hanno lo scopo di elaborare teorie e leggi generali; al contrario, le scienze idiografiche, o scienze umane, come ad esempio la storia, studiano fenomeni contingenti e soggettivi, e si soffermano sulle caratteristiche di unicità e di individualità dei temi studiati. Secondo Windelband, dunque, le scienze naturali e le scienze sociali hanno uno statuto epistemologico radicalmente diverso: sull’azione umana, infatti, non sono possibili esperimenti di laboratorio, dati i possibili esiti non intenzionali che ne conseguono.
La critica contro l’“imperialismo” degli strumenti matematici finalizzati allo studio dell’azione umana divenne una critica contro il socialismo e la pianificazione economica: nessun pianificatore centrale, infatti, può avere alcuna conoscenza diretta del valore che individui differenti attribuiscono a prodotti differenti. La più alta espressione di questo genere di argomenti nell’ambito della scuola austriaca si presenta in un’opera di Friedrich von Hayek, L’abuso della ragione (1952). Hayek è scettico nei confronti di qualsiasi politica economica che trovi le proprie giustificazioni su ipotetici aggregati o indici numerici: L’abuso della ragione si può considerare come il più compiuto manifesto contro l’iper-razionalismo positivista che, presupponendo che ogni società dovrebbe organizzarsi sulla base di paradigmi razionali e scientifici, costituisce lo strumento di controllo adoperato dallo Stato sociale in nome del “bene comune”. Hayek rileva come la verità scientifica, piuttosto che essere frutto dell’analisi razionale del singolo, sia anch’essa un “monopolio” dello Stato, che la strumentalizza nelle sue funzioni di controllo, in modo paternalistico ed oppressivo e a spese della libertà individuale. Il mutamento sociale, sostiene Hayek per converso, è catalizzato dalla libera e spontanea iniziativa degli individui, per cui la magmatica complessità dell’azione sociale non può essere ridotta a pura razionalità, né tantomeno tale azione potrebbe essere pianificata e regolata dal potere statale.
Sulla limitazione dell’intervento statale in economia concorda la scuola di Chicago, nata tra gli anni Cinquanta e Sessanta nell’alveo dell’economia mainstream. Tale tradizione di studi, infatti, sviluppò le linee di ricerca dell’economia neoclassica che, combinando le teorie di Alfred Marshall e Vilfredo Pareto con i modelli dell’equilibrio generale elaborati dai matematici Abraham Wald (1902-1950) e John Von Neumann (1903-1957) negli anni Trenta, assume principalmente due ipotesi di ricerca: da una parte, la razionalità degli agenti economici e, dall’altra, la possibilità di ottenere l’equilibrio del sistema massimizzando le variabili economiche, ovvero utilità e profitti, che sottostanno alle leggi della domanda e dell’offerta. In questo modo, la scuola di Chicago si collocò pienamente nel mainstream accademico, forgiandolo in maniera definitiva. Sin dalle origini di questa corrente di pensiero, i suoi esponenti si posero in netto contrasto con le teorie istituzionaliste americane e al post-keynesianesimo, opponendosi fermamente alla pianificazione economica e allo Stato sociale, e schierandosi in favore di un capitalismo improntato al laissez-faire fondato sulla convinzione che il mercato sia la migliore alternativa possibile per l’organizzazione economica di una società.
La genealogia della scuola di Chicago, anche nelle sue linee metodologiche, si deve far risalire all’opera di Frank Knight (1885-1972). Knight fu maestro di Milton Friedman e George Stigler, e tuttavia il suo approccio epistemologico è diverso, e per certi versi opposto, rispetto a quello dei suoi allievi. Knight è spesso ricordato per la sua opera del 1921, Risk, Uncertainty and Profit, in cui stabiliva una differenza tra rischio e incertezza: una condizione di incertezza si verifica nel caso in cui un operatore economico non possa quantificare la probabilità che si verifichi un certo evento in futuro, mentre il rischio è sempre associato a una probabilità quantificabile. Knight svolse un ruolo fondamentale nella definizione dell’identità e delle linee di ricerca dell’analisi economica a Chicago per i decenni a venire, contribuendo alla costruzione di quel mainstream economico ereditato, nei suoi presupposti teorici, dagli allievi Friedman e Stigler: Knight si ispirò infatti alle teorie marginaliste di William S. Jevons (1835-1882) per l’elaborazione del proprio approccio soggettivista, basato sulla razionalità individuale all’interno di un sistema di libera competizione. E tuttavia, pur condividendo le premesse dell’economia neoclassica, Knight contemplava, nella propria analisi, anche categorie come “temporalità”, “creatività” e “incertezza”, condividendo lo spirito della Scuola austriaca. Non è un caso, infatti, il suo legame con Friedrich Hayek, allora docente di Scienze Politiche a Chicago: entrambi contribuirono nel 1947 alla fondazione della Mont Pélerin Society, un’associazione costituita allo scopo di preservare l’eredità liberale, e in favore di un impegno globale volto a impedire la rinascita dei regimi totalitari. Questa iniziativa vide protagonisti molti studiosi provenienti dal milieu di Chicago – tra cui, oltre a Knight, anche Milton Friedman e George Stigler. Il fatto che nella Mont Pélerin Society avesse avuto un ruolo imprescindibile anche uno dei maggiori esponenti della Scuola austriaca, non deve lasciare dubbi sul fatto che la scuola di Chicago ebbe una centralità indiscutibile nel formare l’ortodossia neoliberale che determinò il clima politico americano – e mondiale – nei decenni a venire. Hayek si trasferì negli Stati Uniti nel 1950, invitato dall’Università di Chicago a assumere un incarico d’insegnamento, anche se, a causa del suo approccio eterodosso, non poté insegnare al dipartimento di Economia. Fu in questo periodo che Hayek e Knight rafforzarono la loro collaborazione: Knight infatti era uno dei più assidui frequentatori dei seminari di Hayek sulla tradizione liberale. A testimonianza della vicinanza di Knight all’approccio austriaco, si noti anche che fu lui a introdurre il pensiero della Scuola austriaca negli Stati Uniti, traducendo nel 1950 la già citata opera di Carl Menger Principi fondamentali di economia. La seconda generazione della scuola di Chicago, tuttavia, si allontanò considerevolmente dalla prospettiva di Frank Knight. Il maggiore esponente della linea teorica che rese Chicago famosa in tutto il mondo fu Milton Friedman, il quale, in contrasto con le teorie di Keynes, che furono in voga fino alla fine degli anni Sessanta, avanzò la propria teoria monetarista, che si fondava sullo studio dei flussi di moneta nelle crisi depressive dell’economia capitalista. Il lavoro di Friedman ebbe il merito di aver posto particolare enfasi sulla quantità di moneta in circolazione in un sistema economico, e sul suo ruolo di fattore scatenante dell’inflazione: secondo Friedman, infatti, sono le manovre di politica monetaria a generare incrementi o riduzioni nei redditi reali. Pertanto, politiche economiche volte a espandere ad hoc la massa monetaria rischiano di generare fenomeni inflazionistici. La scuola di Chicago è considerata portavoce del neoliberalismo, grazie all’indefesso lavoro di Friedman come divulgatore della teoria neoclassica. Furono infatti gli anni Settanta, come si è accennato, a segnare il periodo d’oro della scuola: la stagflazione, alla metà del decennio, aveva messo in ginocchio le economie dell’Occidente; la disoccupazione era in crescita, l’inflazione fuori controllo, e i governi rischiavano di perdere legittimità di fronte all’impossibilità di gestire i conflitti sociali. Gli effetti di questa fase di emergenza dimostravano l’inefficacia delle teorie keynesiane e post- keynesiane e i loro appelli in favore dell’aumento della spesa pubblica. Si determinò in tal modo il graduale sfaldamento di quel consenso che si era raccolto intorno alle tesi di Keynes, secondo cui, per uscire da una recessione, era necessario far crescere l’occupazione tagliando le tasse e aumentando la spesa pubblica, fornire ai cittadini una rete di servizi tra cui un sistema sanitario nazionale gratuito e un’educazione a basso costo, conferire allo Stato un ruolo preponderante in economia, attraverso un’opera di regolamentazione dei mercati e la gestione di grandi imprese nazionali. Friedman, oltre che essere il principale sostenitore della teoria monetarista, fu anche autore di quello che si può considerare il “manifesto” teorico e epistemologico della scuola: The Methodology of Positive Economics. L’economia “positiva”, secondo Friedman, deve essere aliena dai giudizi di valore: non contempla i concetti di bene e di male, di giusto o sbagliato, ma si concentra soltanto sull’evidenza fattuale. Ne consegue che, sulla base del metodo scientifico, la validità di una teoria deve essere giudicata sulla base del suo potere predittivo del fenomeno che intende spiegare. In questo senso, l’economia è una scienza “oggettiva” tanto quanto lo sono le scienze naturali.
keynesiane e i loro appelli in favore dell’aumento della spesa pubblica. Si determinò in tal modo il graduale sfaldamento di quel consenso che si era raccolto intorno alle tesi di Keynes, secondo cui, per uscire da una recessione, era necessario far crescere l’occupazione tagliando le tasse e aumentando la spesa pubblica, fornire ai cittadini una rete di servizi tra cui un sistema sanitario nazionale gratuito e un’educazione a basso costo, conferire allo Stato un ruolo preponderante in economia, attraverso un’opera di regolamentazione dei mercati e la gestione di grandi imprese nazionali. Friedman, oltre che essere il principale sostenitore della teoria monetarista, fu anche autore di quello che si può considerare il “manifesto” teorico e epistemologico della scuola: The Methodology of Positive Economics. L’economia “positiva”, secondo Friedman, deve essere aliena dai giudizi di valore: non contempla i concetti di bene e di male, di giusto o sbagliato, ma si concentra soltanto sull’evidenza fattuale. Ne consegue che, sulla base del metodo scientifico, la validità di una teoria deve essere giudicata sulla base del suo potere predittivo del fenomeno che intende spiegare. In questo senso, l’economia è una scienza “oggettiva” tanto quanto lo sono le scienze naturali.
In conclusione, è evidente come le due scuole, quella austriaca e quella di Chicago, concordino su un sostanziale individualismo metodologico ed etico, che sfocia nell’apologia del liberalismo, e conseguentemente nel capitalismo e nel laissez-faire. E tuttavia, le due scuole differiscono sensibilmente sotto più di un aspetto. Innanzitutto, a livello epistemologico, secondo la scuola di Chicago, come si è detto riguardo alla Metodologia dell’economia positiva di Friedman, l’economia è una disciplina empirica che si basa sullo stesso modello formalizzato della fisica; al contrario, secondo gli austriaci, l’economia è una scienza sociale con il solo scopo di individuare regolarità contingenti nei comportamenti umani, non formulare teorie generali. Dal punto di vista dell’“antropologia”, per così dire, mentre i Chicagoans sostengono l’ipotesi secondo cui gli agenti economici siano sempre razionali, e compiano scelte alla luce di informazioni complete e perfette, gli austriaci vedono gli individui come agenti liberi, che si muovono nel mondo in accordo con i valori che hanno scelto, e hanno a disposizione informazioni limitate e disperse. In definitiva, la scuola di Chicago rientra nell’economia mainstream e riconosce i meriti del positivismo e dell’uso degli strumenti matematici. La scuola austriaca, invece, adotta una metodologia eterodossa, e assume che un ragionamento di tipo induttivo non si possa applicare per analizzare il corso imprevedibile dell’azione umana. In ultimo, una differenza fondamentale tra le due scuole può essere individuata nel modo di intendere il potere politico. Se Milton Friedman sosteneva l’importanza del ruolo dello Stato nel garantire le condizioni per la competitività economica, prevenendo la formazione di monopoli, le teorie degli austriaci, e di Ludwig von Mises in particolare, furono cooptate dai teorici del pensiero libertarian, in una prospettiva di “liberalismo estremo”, fondato sulla centralità della razionalità individuale e la massima limitazione – quando non la totale assenza – dell’intervento statale in economia.
di Alessandra Maglie
