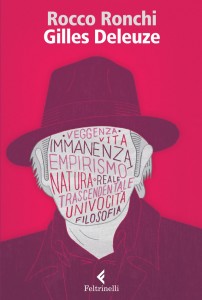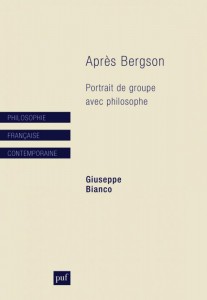 Après Bergson. Portrait de groupe avec philosophe di Giuseppe Bianco (PUF, 2016) si presenta come un’appassionante narrazione “fantasmatica”: il protagonista del libro, infatti, non appare mai sulla scena, ma si manifesta attraverso i suoi effetti, come un’immagine – o, per meglio dire, un insieme di immagini ‒ che non ha mai smesso di inquietare il novecento filosofico francese. Se l’obiettivo esplicito dell’analisi di Bianco concerne la ricostruzione della stratificata e tortuosa ricezione della filosofia bergsoniana in Francia, il libro non risulta ipso facto etichettabile come un erudito volume di storia della filosofia, per almeno due ragioni, strettamente collegate: 1) lo stile narrativo che pervade il libro e che alleggerisce notevolmente il carico di informazioni, contribuendo a costruire una vera e propria narrazione corale, potremmo dire à la Altman, nella quale, a contare, più che le azioni dei singoli personaggi, è innanzitutto e perlopiù il contesto che li muove; 2) l’affascinante impronta sociologica dell’analisi, che considera la disciplina filosofica, nel suo concreto svolgersi, prima di tutto come una pratica relazionale, che vede impegnati uomini e donne, con il loro bagaglio di mitologie, convinzioni, simpatie e antipatie.
Après Bergson. Portrait de groupe avec philosophe di Giuseppe Bianco (PUF, 2016) si presenta come un’appassionante narrazione “fantasmatica”: il protagonista del libro, infatti, non appare mai sulla scena, ma si manifesta attraverso i suoi effetti, come un’immagine – o, per meglio dire, un insieme di immagini ‒ che non ha mai smesso di inquietare il novecento filosofico francese. Se l’obiettivo esplicito dell’analisi di Bianco concerne la ricostruzione della stratificata e tortuosa ricezione della filosofia bergsoniana in Francia, il libro non risulta ipso facto etichettabile come un erudito volume di storia della filosofia, per almeno due ragioni, strettamente collegate: 1) lo stile narrativo che pervade il libro e che alleggerisce notevolmente il carico di informazioni, contribuendo a costruire una vera e propria narrazione corale, potremmo dire à la Altman, nella quale, a contare, più che le azioni dei singoli personaggi, è innanzitutto e perlopiù il contesto che li muove; 2) l’affascinante impronta sociologica dell’analisi, che considera la disciplina filosofica, nel suo concreto svolgersi, prima di tutto come una pratica relazionale, che vede impegnati uomini e donne, con il loro bagaglio di mitologie, convinzioni, simpatie e antipatie.
Bianco, prima di far partire la narrazione, pone una serie di indicazioni metodologiche (pp. 1-23) che incrociano parametri, variabili e paradigmi, con l’obiettivo esplicito di rendere intellegibili i percorsi che, unendosi, andranno a costituire un’autentica eredità culturale. Saranno proprio le variabili sintetizzate nelle due tabelle presenti nell’introduzione a essere concretamente mobilitate nel corso dello studio. Fare una vera e propria sociologia della filosofia significa allora evitare di dare la precedenza a una pretesa purezza nella circolazione delle idee, ma calare le posizioni teoriche degli attori all’interno di un contesto, come quello del primo novecento francese, in piena evoluzione. Non si comprenderebbe per esempio nulla della fama di Bergson, per lo meno nei primi trent’anni del novecento, se non si confrontasse la sua traiettoria intellettuale con la progressiva professionalizzazione del “mestiere di pensare” che modificherà in modo radicale il rapporto tra filosofi e grande pubblico o con l’irriducibile dialettica includente/escludente tra centro (Parigi) e periferia che ha da sempre orientato i destini della filosofia d’oltralpe.
Comprendiamo così che occuparsi dell’eredità di Bergson significa innanzitutto confrontarsi con una serie di immagini elaborate da contemporanei e successori, e in seguito assorbite o filtrate dalle operazioni degli allievi. I ritratti di Bergson occupano così uno spettro vastissimo, apparentemente auto-contraddittorio: da filosofo della scienza a anti-positivista, da umanista cattolico a filosofo dell’impersonale, da ideologo della borghesia a emancipatore. Bianco, attraverso un’imponente mole di dati, impreziosita da una ricca (e in parte divertente) aneddotica, ricostruisce le altalenanti ondate della ricezione bergsoniana, incrociandole con l’affermarsi progressivo delle tonalità dominanti del discorso filosofico francese (“spirito”, “esistenza” e “struttura”). Sempre presente nel dibattito, ma mai al suo centro, il bergsonismo scorre così sottotraccia per tutto il novecento, modificando progressivamente la propria identità. Molto schematicamente, si potrebbero isolarne tre immagini:
1) L’immagine, in fondo condivisa da entusiasti e detrattori, di una filosofia dell’interiorità, impegnata a sondare la temporalità della coscienza in opposizione a qualsiasi forma di positivismo o intellettualismo. Da un lato, infatti, la vulgata bergsoniana, vera e propria moda di inizio secolo, penetrerà nell’arte, nella letteratura, nella psicologia, sino a diventare vero e proprio sentire comune; dall’altro, come reazione a questo successo indiscriminato, emergeranno fin da subito una serie di posizioni critiche da parte dei principali concorrenti di Bergson, in primis Alain (al secolo Émile-Auguste Chartier) e Brunschvicg, che, a diverso titolo, faranno valere le ragioni di una tradizione filosofica francese e tedesca sostanzialmente alternativa ai sofismi bergsoniani (p. 61) e alle sue “pillole rosa” (p. 78). Non è difficile vedere come una tale immagine, unita alla progressiva canonizzazione del pensiero bergsoniano, sia in fondo quella ancora dominante, perlomeno nelle ricostruzioni manualistiche, che spesso inseriscono la riflessione bergsoniana nell’alveo dello spiritualismo francese.
2) L’immagine, emersa in particolare a partire dal primo dopoguerra, di un filosofo dell’inazione, compromesso e incapace di cogliere le contraddizioni della contemporaneità. La partecipazione di Bergson alla propaganda nazionalista in favore del conflitto mondiale segnerà una vera e propria condanna da parte della nuova generazione filosofica, attiva dagli anni ’20 del novecento e profondamente influenzata dall’ideologia marxista: Bergson diventerà il pensatore borghese per eccellenza. Prolungando l’onda delle critiche di Alain e Brunschvicg, pensatori come Bachelard e Canguilhem si impegneranno nello smantellamento delle nozioni di durata, slancio e intuizione. Sarà però soprattutto Georges Politzer, nel velenoso La fin d’une parade philosophique: le bergsonisme (1929), a tenere insieme tutte le critiche pre e postbelliche, liquidando Bergson ormai come un pensatore non soltanto astratto, “senza storia” e sorpassato, ma persino pericoloso da un punto di vista etico-politico.
3) L’immagine di un pensiero “anticipatore”, capace di porsi in relazione con la fenomenologia, l’esistenzialismo, ma anche con la scienza e, in particolare, con la biologia. Dalle seminali operazioni di Wahl (Verso il concreto) e Jankélévitch (Henri Bergson) al bergsonismo inconsapevole di Sartre, passando per la riscoperta di molte intuizioni bergsoniane da parte di Ruyer, Canguilhem e Merleau-Ponty e per le più recenti operazioni di Stengers e Prigogine, il pensiero di Bergson, nonostante i numerosi tentativi di sbarramento, non è mai uscito completamente di scena, ma ha continuato a inserirsi nei più disparati dibattiti filosofici.
È proprio a partire da questo complesso e stratificato orizzonte, caratterizzante i decenni centrali del novecento, che Gilles Deleuze, protagonista della parte finale del testo, “riceve” il pensiero bergsoniano. Come Bianco sottolinea più volte, il bergsonismo di Deleuze sarebbe impensabile senza tutta quella serie di operazioni che, tra gli anni ’30 e ’60 del novecento, ha impresso un’immagine ben precisa al pensiero bergsoniano: si tratta in particolare della questione del campo trascendentale impersonale che, a partire dal primo capitolo di Materia e memoria, percorre la filosofia di Sartre, Merleau-Ponty, Hyppolite e Simondon, prima di giungere, in una forma inedita nella riflessione deleuziana sul piano di immanenza. Nella ricostruzione dei debiti bergsoniani di Deleuze, si nota nel testo una certa verve teorica: l’influsso di Bergson su Deleuze non risulta infatti riconducibile, secondo Bianco, a una presunta comunità di intenti tra i due filosofi, ma è tutto interno all’esigenza deleuziana di indagare “una condizione genetica del reale che non gli rassomigli, sebbene gli sia immanente” (p. 340). È questa esigenza, prima ancora dell’evidente presenza, in Deleuze, di ulteriori influenze (Nietzsche, Spinoza, Leibniz, gli Stoici, etc.), a impedire uno spericolato appiattimento delle due figure in nome di un unico pensiero del divenire. Certo, Deleuze si richiamerà a Bergson nel corso di tutta la sua opera e, certo, l’idea di una logica immanente del senso manifesta un evidente debito nei confronti del bergsonismo: ciò non toglie, tuttavia, che i problemi a cui le due filosofie rispondono risultano eterogenei (p. 355). Deleuze, in particolare, rileva gli aspetti più ontologici della riflessione bergsoniana (il passato in sé, la virtualità, il concetto di differenza pura), trasformando di fatto Bergson in un filosofo postkantiano e impostando così, sulla scia dell’opera di Hyppolite, un implicito confronto con la dialettica hegeliana (pp. 281-305).
Al di là della presunta fedeltà al dettato bergsoniano, la traiettoria di Gilles Deleuze, unico della sua generazione a utilizzare in modo così sistematico il pensiero di Bergson, ha avuto il merito di riattivare l’interesse verso un pensatore che, ormai glorificato e insieme decomposto, sembrava avviarsi verso una tranquillizzante neutralizzazione storiografica. Deleuze ha così riaperto un varco nella ricezione bergsoniana, contribuendo inoltre, inconsapevolmente, al consolidamento di una narrazione di cui Bianco ricostruisce la filiazione, ovvero la percezione di una filosofia francese divisa in due metà, da un lato “cartesiana” e impegnata nella fondazione del sapere attraverso la razionalità del concetto, dall’altro mistico-vitalista e legata all’esperienza, alla sensibilità e al soggetto (p. 325-333). Se questo “grande racconto” interno alla filosofia francese ha proliferato, con differenti sfumature, nelle riflessioni di Hyppolite, Foucault, Derrida e Badiou, l’indagine di Bianco ci ricorda quanto questa bipartizione risulti schematica e non renda in fondo ragione dei sostanziali e costitutivi sfondamenti di campo (l’impossibilità di sistemare l’opera di Canguilhem all’interno di questa dicotomia risulterebbe qui emblematica).
Après Bergson ci fa insomma penetrare in un secolo di interpretazioni del pensiero di Bergson, mostrandoci l’eredità della sua opera attraverso un’invidiabile cura per i dettagli (tra i vari strumenti di lavoro, è presente un utile grafico delle relazioni tra i filosofi citati, nonché la lista degli anni in cui Bergson era presente nel programma dell’agrégation). Più defilato rispetto ad altre tradizioni pensiero, quali la fenomenologia, l’esistenzialismo o lo strutturalismo, il bergsonismo emerge dal testo come filosofia “carsica”, tanto plastica da fornire intuizioni in campi di riflessioni tra loro anche molto distanti. Come le infinite biforcazioni dello slancio vitale, l’influenza di Bergson si è ripartita su un intero secolo: ecco perché, allora, il prisma bergsoniano analizzato da Bianco riflette indirettamente l’atmosfera di un’epoca.
di Giulio Piatti