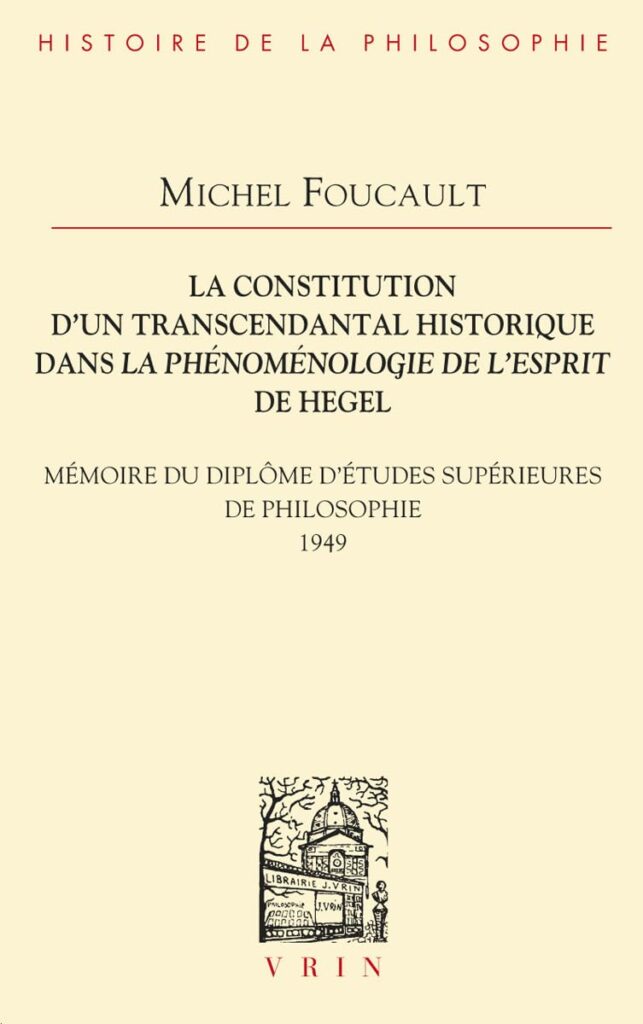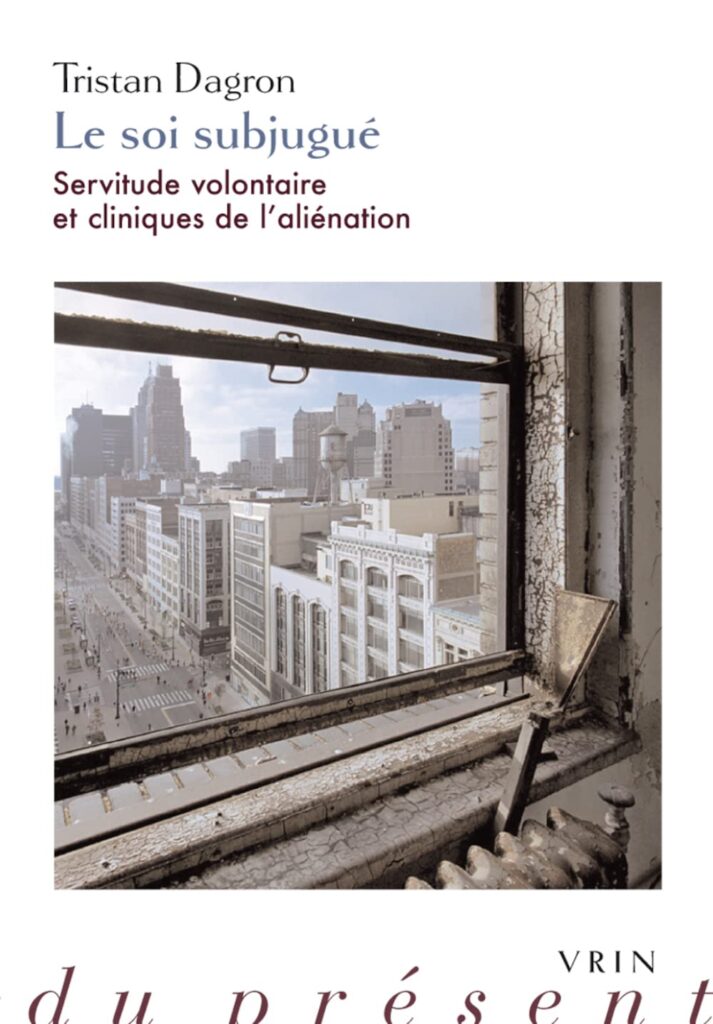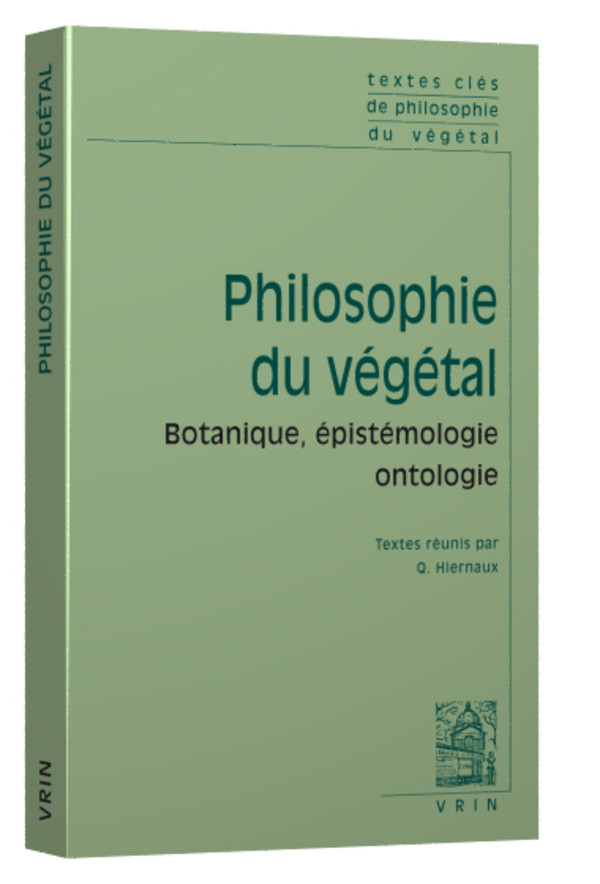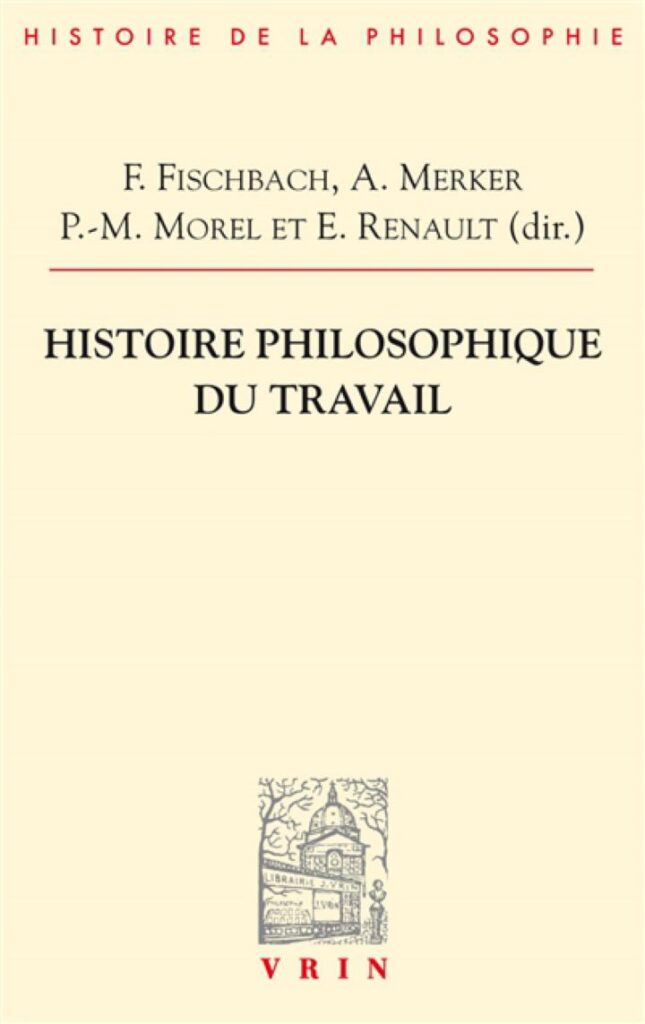-
-
La servitù volontaria dell’io soggiogato
Recensioni / Maggio 2023«Se il testo di La Boétie è incontestabilmente un testo politico, tuttavia affronta le relazioni di potere e di dominio sotto una prospettiva specifica, dal punto di vista dell’ombra proiettata dalla realtà sociale sul funzionamento mentale dei soggetti, per mettere in rilievo i danni identitari e narcisistici tipici della sofferenza sociale. Interroga anche, per converso, gli effetti sociali di questo funzionamento mentale, la sua capacità ad alimentare condotte di sottomissione e ad alimentare il sistema di dominio»
– T. Dagron, p. 380
Da qualche mese, sugli scaffali dedicati alla filosofia moderna e contemporanea della celebre libreria «Vrin» di Place de la Sorbonne a Parigi, è comparsa una sezione «La Boétie». Segnale dell’ottima salute di cui gode tanto il Discours de la servitude volontaire quanto il fenomeno che il suo autore definisce. Entrambi continuano a interessare studiosi, studiose e case editrici (tra le edizioni più recenti, questa in lingua spagnola è assai pregevole). Tra i volumi della sezione, spicca Le soi subjugué. Servitude volontaire et cliniques de l’aliénation (Librairie Philosophique J. Vrin, 2022, pp. 405) di Tristan Dagron, direttore di ricerca al CNRS di Lione.
Il nome di Dagron è legato a quello di La Boétie ormai da diverso tempo: suo è uno dei contributi che si trovano nell’edizione Vrin del Discours del 2002, che si proponeva come alternativa all’edizione Payot del 1975, a cura di Miguel Abensour e Marcel Gauchet. È sua anche l’introduzione al Discours della nuova edizione Vrin del 2012. Un’introduzione che merita di essere citata: Dagron vi sanziona la specificità della «riattualizzazione della nozione della servitù volontaria» (p. 18) avvenuta negli ultimi anni, quale strumento euristico adoperato da sociologia e psicologia per esplorare le forme di dominio nel mondo del lavoro (cfr. Dejours 2006).
Le soi subjugué prosegue le ricerche che Dagron ha avviato con Pensée et cliniques de l’identité. Descartes, Cervantès, Montaigne (Librairie Philosophique J. Vrin, 2019). La prospettiva adottata è la medesima: coniugare il lavoro di storico della filosofia con la psicoanalisi. Lo sguardo di Dagron sul Discours non è solo quello dello specialista in storia della filosofia; il suo spettro di domande e di interessi è rivolto verso «processi mentali che sono in fondo assai ordinari» (p. 16) e nutrito dell’approccio psicoanalitico di René Roussillon e dall’ambiente lionese (cfr. Roussillon, 1991). Narcisismo, identità, riflessività, alcuni dei termini chiave.
Se mai fosse necessario prevenire qualsiasi esitazione in merito a un simile approccio, la lettura di Dagron si tiene ben lontana da freudismi spiccioli o selvagge interpretazioni psicoanalitiche della vita degli autori. Il lettore, al massimo, potrà risentire un certo spaesamento a causa di un percorso argomentativo talvolta complesso, che si sposta rapidamente da discussioni storico-filosofiche a discussioni psicoanalitiche e che lascia implicite alcune definizioni tecniche. Questo non intacca la rilevanza de Le soi subjugué, nel contesto del rinnovato interesse per La Boétie degli ultimi due decenni.
Nel primo dei dieci capitoli del volume, Dagron si occupa, per l’appunto, mettere in luce l’attualità del Discours, in particolare rispetto alla tematica della cosiddetta «sofferenza sociale», quella forma specifica di sofferenza che deriva dall’effetto prodotto da determinate situazioni sociali sull’individuo (cfr. Renault 2008). Nel secondo capitolo, l’autore esplicita l’interesse del proprio approccio pluridisciplinare che propone d’integrare la prospettiva psicoanalitica sul narcisismo alla problematica dell’identità secondo i termini della psicologia sociale.
Conclusa questa sorta di preambolo, Dagron orienta gli altri capitoli sui temi canonici connessi al Discours: amicizia, libertà, memoria, abitudine, volontà e patto. Qui svolge un lavoro di analisi storico-filosofica per rendere conto del rapporto di La Boétie con autori quali Aristotele, Cicerone o Marsilio Ficino, o per confrontare la «servitù volontaria» con l’ethelodouleia del discorso di Pausania nel Simposio o, ancora, per ricostruire la psicologia della memoria di Avicenna, che è uno dei sostrati teorici del Discours. Tuttavia, la finalità di Le soi subjugué non si esaurisce in quest’ordine di discussioni.
L’obiettivo di Dagron, in effetti, è dimostrare che il Discours presenta «una ricca riflessione clinica sulla posta in gioco della socializzazione e della soggettivazione» (p. 383). Più esattamente, La Boétie offre «un bilancio della violenza sociale» e dei fenomeni che essa induce dal punto di vista delle capacità mentali e riflessive degli individui. Sicché, il vero e proprio asse su cui si articola Le soi subjugué è l’interesse per il Discours in quanto testo che concerne una «realtà clinica» assai precisa: la «disorganizzazione identitaria» della psiche individuale dalla società e le sue conseguenze sul giudizio d’attribuzione di ciò che suscita piacere e dispiacere.
Stando alla lettura de Le soi subjugué, la servitù volontaria indica non tanto una forma di governo quanto una relazione di dominio. Per descriverla, Dagron sembra voler adoperare il termine di «subjugation», ma non è chiaro a riguardo: l’espressione che dà il titolo al volume non è oggetto di una discussione specifica che la definisca. Alla voce «subjuguer», però, il dizionario Robert riporta: «mettere qualcuno nell’impossibilità di resistere, per ascendente, all’influenza che si ha su di lui». E tale pare essere la condizione dei servi volontari.
La celebre paradossalità della formula laboetiana della servitù volontaria (il dominio si sostiene sul decisivo e volontario contributo dei servi: allora perché, pur potendo smettere di servire, non lo fanno?) si riflette nell’insieme di caratteristiche che si rinvengono nell’interpretazione di Dagron: la servitù volontaria è tanto estorta e indotta quanto spontanea e non deliberata, cioè frutto di un’azione volontaria ma i cui moventi sono per lo più inconsci. Infatti, essa è un risultato che il tiranno ottiene dai sudditi e corrisponde a una «strategia di difesa, tra le altre possibili, che può essere mobilitata dalla psiche per far fronte all’impatto disorganizzatore della violenza sociale» (p. 96).
Questo è un dato fondamentale che va sottolineato: per Dagron la servitù volontaria non si spiega con una «sete di obbedienza» presente nei servi né indica una delle cause prime del dominio. È un adattamento difensivo che alimenta e mantiene il dominio che lo induce. In altri termini, occorre ricercare la servitù volontaria non a monte di dinamiche politico-sociali, in qualità di loro principio causale; al contrario, la servitù volontaria è un fenomeno che sta a valle, portato di un «mondo perseguitato dalla morte sociale e psichica» (p. 305).
Dagron si serve allora della psicoanalisi per sondare i «moventi interni, ma non per questo meno oscuri ed enigmatici» (p. 38) degli individui. Posto il narcisismo quale meccanismo di difesa dell’io dalle esperienze negative e di integrazione di queste ultime (cfr. Freud 1921 [1975]), alla vulnerabilità sociale corrisponde la «precarizzazione psichica» (p 63). La sottrazione di alcuni «oggetti sociali» (quali l’impiego, il reddito, e l’alloggio, secondo gli esempi proposti da Dagron) che l’individuo investe narcisisticamente, spinge l’individuo a un «tentativo, tanto strano quanto oneroso, di restaurazione narcisistica» (p. 49) che si configura come una «relazione addittiva» nei confronti dei «frammenti» di quegli oggetti che «tiranno sa bene come far scintillare» (p. 50). In questo modo si innesta il suo comportamento di sottomissione e di asservimento nei confronti di chi domina.
Questo è un altro aspetto dell’interpretazione di Dagron che va tenuto in considerazione: la servitù volontaria non è dovuta all’ignoranza, all’inganno o all’illusione dei servi. Al contrario, è la disillusione, cioè «il riconoscimento, in sé doloroso, della verità» (p. 50), a giocare un ruolo cruciale. Gli individui adottano la strategia di adattamento in cui consiste la servitù volontaria proprio in quanto consapevoli del pericolo dell’esclusione sociale della precarietà: a tal proposito non si sbagliano. Sono particolarmente interessanti le pagine in cui Dagron definisce la servitù volontaria come una condotta di «auto-inclusione» in una relazione di sottomissione e la confronta con la strategia della «auto-esclusione» di cui rinviene il modello in Diogene (cfr. pp. 305 e ss.).
Dunque, secondo la prospettiva che propone Dagron, il fulcro del Discours de la servitude volontaire si trova sul piano clinico: un’opzione interpretativa particolare (per un approccio per alcuni aspetti simile: cfr. Renault 2016) e non certo l’unica possibile (cfr. Provini, Rees, Vintenon 2016). In Le soi subjugué, però, Dagron non si spende in alcuna discussione polemica con altre interpretazioni del Discours. In particolare, risalta il totale silenzio su Miguel Abensour, il principale artefice della riscoperta di La Boétie negli anni Settanta e uno dei massimi interpreti del pensiero laboetiano (cfr. Abensour 2011). Palese è la distanza tra loro: per Dagron, La Boétie non fornirebbe «alcuna teoria filosofica del potere politico» (p. 127), laddove per Abensour La Boétie non fonda niente di meno che una nuova teoria del dominio (cfr. Abensour 2018).
Un confronto tra le loro interpretazioni del Discours eccede certamente i limiti di una recensione. Tuttavia, questo permette di rilevare un merito importante de Le soi subjugué, su cui vale la pena concludere. Con questo volume, Dagron consolida e contribuisce a definire un certo approccio alla questione della servitù volontaria e, pertanto, Le soi subjugué diventa un valido termine rispetto a cui confrontare le altre forme assunte dalla riattualizzazione del Discours de la servitude volontaire.
Bibliografia
Abensour, M. (2011). Per una filosofia politica critica (a cura di Pezzella, M.), Jaca Book, Milano.
Abensour, M. (2018). La Boétie prophète de la liberté, Sens & Tonka, Paris.
Dejours, C. (2006). Aliénation et clinique du travail, in «Actuel Marx », 39, pp. 123-144.
Freud, S. (1921). Psicologia delle masse e analisi dell’io, Bollati Boringhieri, Torino, 1975.
Provini, S., Rees, A., Vintenon, A. (dir.) (2016). Cahiers La Boétie. La parole de La Boétie : approches philosophiques, rhétoriques et littéraires, Classique Garnier, Paris
Renault, E. (2008). Souffrances sociales. Sociologie, psychologie et politique, La Découverte, Paris.
Renault, E. (2016). Domination et pathologie sociale chez La Boétie, in Gerbier, L. (dir.). Cahiers La Boétie. Lectures politiques de La Boétie, Classique Garnier, Paris, pp. 137-151.
Roussillon, R. (1991). Paradoxes et situations limites de la psychanalyse, P.U.F., Paris.
Armando Arata
-
Storia della filosofia del lavoro
Recensioni / Settembre 2022«È ampiamente riconosciuto che per noi, membri delle società moderne, il lavoro conta molto […] Sapere per quali ragioni, è una domanda a cui rispondere è molto meno agevole». H-C., Schmidt Am Busch
Histoire philosophique du travail (Vrin, 2022), curato da Frank Fischbach, Anne Merker, Pierre-Marie Morel ed Emmanuel Renault, è uno dei risultati del progetto di ricerca «Approches philosophiques de la centralité du travail» diretto da Fischbach e Renault tra il 2014 e il 2017. A loro due si deve l’interessante introduzione, a cui seguono sedici saggi (per i titoli e gli autori, rinvio all’indice) organizzati in due sezioni, la prima dedicata alla filosofia antica, la seconda, più ampia, dedicata alla filosofia moderna. Completa il volume, una bibliografia che amplia i riferimenti proposti dai singoli saggi e che si rivolge quasi esclusivamente alla filosofia contemporanea, in particolare ai più recenti sviluppi della Teoria critica francese, di cui, d’altronde, Fischbach e Renault sono esponenti.
Histoire philosophique du travail non ambisce a proporsi come una «storia della filosofia» sul tema del lavoro. I curatori non hanno ricercato né la sistematicità né la completezza che avrebbe richiesto una simile opera: rimandano ai sette volumi curati da Antimo Negri (Negri 1980-1981) e al progetto in fieri di Jean-Philippe Deranty. I saggi, infatti, sono stati scelti tra gli interventi di tre diverse giornate di studio, tenutesi, tra il 2015 e il 2017, nell’ambito di suddetto progetto di ricerca, e presentano, pertanto, una certa aleatorietà. Così, sebbene i curatori stessi riconoscano che mancano, ad esempio, la filosofia medioevale e quella contemporanea (cfr. p. 11), nondimeno va notato che la selezione dei saggi riduce la filosofia antica a quella greca da cui, però, è escluso Platone (che pure era oggetto di più di una conferenza). Al contempo, occorre segnalare la pubblicazione dell’antologia curata dagli stessi Fischbach e Renault (Fischbach, Renault 2022) con cui integrano Histoire philosophique du travail della parte mancante sulla filosofia contemporanea (nell'indice, ad esempio, si trovano Simone De Beauvoir, Adina Schwartz e Elizabeth Anderson).
Alle mancanze contenutistiche, si può forse aggiungere una mancanza di tipo pratico, quella di un indice analitico. Componendo una mappa del nutrito elenco di termini che gravitano attorno al lavoro e che ricorrono nell’arco del volume, un indice analitico avrebbe certamente agevolato il lettore a muoversi trasversalmente tra i saggi e sarebbe stato coerente con un interesse teorico che i curatori sottolineano nell’Introduzione (cfr. pp. 12-13), cioè seguire le inflessioni di significato che, nel corso della storia della filosofia, i concetti che si riferiscono al lavoro hanno assunto. Inoltre, tanto più in un volume come questo, che presenta una notevole varietà tra gli autori trattati, ciò avrebbe reso possibile reperire i diversi fili rossi che s’intessono nelle riflessioni filosofiche sul lavoro. Piacere, macchina, corpo, dignità, ma anche democrazia, salute, tempo, solo per ipotizzare alcune delle possibili voci.
Tuttavia, non si può additare come lacunosa questa Histoire philosophique du travail, poiché si tratta di un progetto pionieristico e poiché presenta, comunque, una certa organicità. Sin dall’Introduzione, intitolata Historicité et centralité du travail, Fischbach e Renault fissano ed esplicitano il fulcro del volume, che è la centralità del lavoro. A quest’ultima è legato il chiaro obiettivo teorico a cui essi mirano, cioè favorire una rivalutazione delle «risorse» che la storia della filosofia mette a disposizione «per pensare l’importanza delle diverse poste in gioco del lavoro» (p. 9). L’intento è invitare a «rivisitare la storia della filosofia occidentale dal punto di vista del lavoro e così elevare il tema del lavoro alla dignità filosofica che merita e che raramente gli è stata riconosciuta dalla storia della filosofia» (p. 10).
Questo è il tono che i curatori danno al volume e a cui tutti i contributi s’accordano. Gli autori e le autrici si propongono di rileggere tale filosofo o filosofa o una certa tradizione, per dimostrare il valore euristico di tematizzare il lavoro all’interno della loro produzione. Pertanto, per una valida recensione dei singoli saggi, servirebbe l’intervento di altrettanti specialisti. Ad esempio, Morel (Démocrite et le travail technique. Comment produire en régime atomiste?)sceglie di interrogare «la coerenza globale della filosofia di Democrito» non sulla pista più battuta dell’etica bensì «per quanto riguarda l’attitudine umana a modificare la natura attraverso il lavoro» (p. 88), mentre Frédéric Porcher (Nietzsche, penseur du travail?) intende mostrare che in Nietzsche è possibile individuare una nozione positiva di lavoro su cui egli sviluppa la sua critica, alla quale, invece, si fermano normalmente i suoi interpreti.
È possibile, quindi, definire una prima portata dell’espressione «centralità del lavoro». Bisogna intenderla come il tentativo di contrastare l’idea che il lavoro sia un tema poco rilevante nella storia della filosofia o che ha acquisito interesse solo recentemente, con la modernità. Fischbach e Renault vogliono, invece, «rendere manifesta la presenza costante del tema del lavoro, rendere percettibili un più ampio numero delle sue implicazioni, e far apparire la ricchezza dei concetti e delle problematiche attraverso le quali esso è stato pensato» (p. 11). In altri termini, si tratta di affermare la centralità del lavoro per smuovere la filosofia dalla sua posizione affine alla «lunga tradizione di svalorizzazione delle attività lavorative» (p. 9).
È un obiettivo piuttosto urgente per Fischbach e Renault. Infatti, la filosofia, dopo aver assecondato il primo discorso sulla fine del lavoro (cfr. Rifkin 1995), potrebbe assecondare anche il nuovo discorso sulla fine del lavoro che si sta diffondendo e che si basa sull’intelligenza artificiale e il machine learning. Riprendendo le analisi di A. A. Casilli (cfr. Casilli 2020), i curatori sottolineano che anche questo nuovo discorso è solo un nuovo capitolo dell’«occultamento del lavoro, della sua cancellazione nei fatti e della sua svalorizzazione nelle norme […], e dell’estensione e della diffusione del regno della produzione di merci» (p. 7). È evidente, quindi, che la «centralità del lavoro» ha una portata che tracima i limiti della storia della filosofia.
Con la «centralità del lavoro» Fischbach e Renault, infatti, non intendono soltanto opporsi alla perifericità o alla trascurabilità del lavoro quale tema filosofico, bensì vogliono affermare una tesi a pieno titolo. L’espressione indica più propriamente l’opzione teorica su cui la Teoria critica di stampo francese si sta spendendo negli ultimi anni (cfr. Dejours et al. 2018), cioè affermare «il potere strutturante, tanto socialmente quanto psicologicamente, tanto individualmente quanto collettivamente» (p. 16) del lavoro. Contro certe critiche del capitalismo che considerano che il lavoro sia diventato centrale solo con l’avvento della modernità (cfr. Postone 1993), inoltre, ritengono che la svolta che quest’ultima rappresenta consiste nel fatto che il lavoro ha assunto una centralità ulteriore, quella sociale: «La centralità del lavoro diventa così essa stessa sociale nelle società moderne, nel senso che il lavoro vi diventa socialmente strutturante, di modo tale che questa nuova centralità sociale riconfigura completamente e di riflesso le modalità secondo cui il lavoro è e resta strutturante anche sui diversi piani economico, psicologico e politico» (p. 19).
L’articolo di Renault su John Dewey (Dewey, l’anti-Arendt) è quasi un prolungamento dell’Introduzione. Infatti, ricostruendo l’argomentazione del tutto originale del pragmatista americano a proposito della centralità del lavoro, Renault offre una lucida esposizione dell’articolazioni delle «dimensioni» di tale problema. La prima è quella epistemologica, ovvero l’estensione da assegnare al concetto di lavoro. La questione è decisiva perché, come spiega Renault, una «concezione ristretta» esclude la possibilità di riconoscere la centralità del lavoro, laddove una «concezione allargata» la ammette (cfr. p. 369). Tra l’altro, questo spiega perché in Histoire philosophique du travail, a dispetto del fatto che il primo tipo di definizioni siano quelle più diffuse nella storia della filosofia - le rappresenta, ovviamente, Arendt, qui discussa da K. Genel (Hannah Arendt, une critique du travail: comment sortir de «la triste alternative de l’esclavage productif et de la liberté improductive»?) -, sia il secondo tipo di definizioni a prevalere: oltre a quella di Dewey (cfr. pp. 359 e sg.), si veda, per esempio, quella di Weil, esaminata da M. Labbé (Le travail chez Simone Weil: réalité, subjectivité, liberté, cfr. pp. 309-312).
Posta in via preliminare tale questione, la centralità del lavoro si decide propriamente sotto tre riguardi, cioè decretando la sua posizione dal punto di vista antropologico, dal punto di vista psicologico e dal punto di vista della teoria sociale. A tal riguardo, secondo Renault, l’originalità di Dewey consiste nel fatto che la sua argomentazione investe tutti e tre gli ambiti congiuntamente, laddove altri autori e autrici sostengono la centralità del lavoro sotto uno solo di questi aspetti. Infine, vi è la questione della «diagnosi storica» della centralità del lavoro che riguarda il ruolo del lavoro nelle varie società, in particolare in quella contemporanea.
Negli articoli che compongono Histoire philosophique du travail, se ne può quindi individuare una serie che, mentre contribuiscono ad affermare l’interesse filosofico del tema del lavoro, alimentano la prospettiva «forte» della centralità del lavoro e la esplorano secondo le diverse prospettive degli autori che vengono discussi. A proposito della centralità del lavoro dal punto di vista antropologico, ad esempio, sono di grande interesse le pagine del ricco esame che Merker dedica alla concezione aristotelica di schiavitù (L’esclave-Organon d’Aristote: entre machine-outil et homme augmenté). L’inattesa conseguenza delle riflessioni di Aristotele sullo schiavo e il lavoro, infatti, è la sanzione dell’«inclusione indelebile della problematica del lavoro nella condizione umana» (p. 154). H.C. Schmidt Am Busch, invece, esaminando i Lineamenti di filosofia del diritto di Hegel (La valeur du travail: sur l’actualité de la théorie hégélienne de la société moderne) si propone indagare «il valore non monetario del lavoro» (p. 213) tanto per l’individuo quanto per la società.
Tra gli autori che compongono suddetta serie, ha un peso specifico Marx, in quanto è uno degli autori di riferimento per chi sostiene le «obiezioni storicistiche» alla centralità del lavoro (cfr. Deranty 2013). Dapprima, J. Quétier (Marx et le travail) ricostruisce la posizione di Marx a proposito della centralità del lavoro: essa è cruciale tanto per la sua antropologia quanto per la sua analisi del capitalismo e le sue prospettive emancipative. Per riprendere le parole di Quétier, la centralità del lavoro è per Marx «problematica: da una parte perché occultata, dall’altra perché incompleta» (p. 233). Quindi, Fischbach (Le salariat Le salariat doit-il quelque chose à l’esclavage? Capitalisme, esclavage et salariat selon Marx) si concentra su questo secondo aspetto, cioè sulle ragioni per cui, secondo Marx, la centralità del lavoro non può essere realizzata nel capitalismo. Quest’ultimo, infatti, non solo conserva la schiavitù ma ha «una tendenza permanente» (p. 345) a reinventarla e congiungerla con il salariato e con nuove forme indirette di subordinazione del lavoro.
In definitiva, grazie al consistente novero dei filosofi e delle filosofe che sono prese in esame, Histoire philosophique du travail persegue l’obiettivo di rendere meno «fantasmatica» l’esistenza del tema del lavoro nella storia della filosofia (cfr. p. 10). D’altro lato, Histoire philosophique du travail segnala l’interesse e l’urgenza di ampliare e sviluppare, se si accetta la metafora, il cantiere del «potere strutturante» del lavoro ovvero della sua centralità.
di Armando Arata
Bibliografia
Casilli, A. A. (2020). Schiavi del clic. Perché lavoriamo tutti per il nuovo capitalismo?, Feltrinelli, Milano.
Dejours, C., Deranty, J-Ph., Renault, E., Smith, N. H. (2018). The Return of Work in Critical Theory. Self, Society, Politics, Columbia University Press, New York.
Deranty, J-Ph. (2013). Cartographie critique des objections historicistes à la centralité du travail, in «Travailler. Revue internationale de Psychopathologie et Psychodynamique du Travail», 30, pp. 17-47.
Fischbach, F., Renault, E. (2022). Philosophie du travail. Activité, technicité, normativité, Libraire Philosophique J. Vrin, Paris.
Rifkin, J. (1995). La fine del lavoro. Il declino della forza lavoro globale e l'avvento del post-mercato, Baldini & Castoldi, Milano.
Negri, A. (1980-1981). Filosofia del lavoro. Storia antologica (7 volumi), Marzorati Editore, Milano.
Postone, M. (1993). Time, Labor and Social Domination: A Reinterpretation of Marx's Critical Theory, Cambridge University Press, New York and Cambridge.
-
L’ornamento. «Cahiers philosophiques» n. 162/3
Recensioni / Febbraio 2022Il tema dell’ornamento sta al centro del numero 162 dei Cahiers philosophiques, pubblicato da Vrin nel terzo trimestre del 2020. Il volume non pretende di offrire un’analisi sistematica del suo oggetto d’indagine: piuttosto, mimando la natura poliedrica e irriducibilmente ambigua dell’ornamento stesso, il numero di rivista mette in scena una serie di interventi in cui temi e problemi ritornano e variano da un contributo all’altro, affrontando la questione dell’ornamento da prospettive diverse, che talvolta s’intersecano, e partendo da casi sempre specifici e singolari.
Ad aprire il volume è l’articolo di Bernard Sève, in cui l’indagine viene condotta da un punto di vista ontologico. Una storia e teoria dell’ornamento a cavallo tra diciottesimo e diciannovesimo secolo è invece offerta da Claire Pacquet, la quale rivolge la propria attenzione alla querelle berlinese che ha visto tra i suoi protagonisti autori del calibro di Moritz e Goethe. Marie Schiele, con un testo sul panneggio in Aby Warburg, e Rémi Labrusse, con un intervento dedicato all’arabesque, in maniere diverse mostrano come l’ornamento possa andare a perturbare il regime rappresentativo occidentale. Il testo di Aurélie Ledoux si articola invece intorno a questioni di ordine politico. Il volume si chiude proponendo la traduzione in francese di alcuni testi classici sul tema: l’introduzione de Il senso dell’ordine di Ernst Gombrich (1979), in cui l’ornamento, inteso come pattern, viene indagato con strumenti psicologici e biologici, e due conferenze di William Morris, intitolate L’arte e i suoi produttori (1888) e Conferenza sulla collezione di pittura della scuola preraffaelita inglese (1891). Le traduzioni, realizzate da Laure Bordonaba, sono precedute da un suo commento introduttivo.
Come gli autori mostrano fin dalle prime pagine del volume, l’ornamento rifiuta non solo una definizione univoca, ma anche una collocazione chiara: pullulando, accidente fantasmatico separato dal suo supporto sostanziale, esso è in grado di migrare, andando a innestarsi nei più diversi contesti. Basti pensare alle grottesche, motivi ibridi di derivazione antico romana che mescolano il registro dell’umano, dell’animale, del vegetale e del geometrico (fig. 1), o alle arabesques, volute fitomorfe di origine islamica: soprattutto a partire dagli scavi di Ercolano (1738) e Pompei (1748), questi motivi ornamentali hanno avuto la capacità di circolare come vere e proprie formule di sapore warburghiano, andando a “infestare” le produzioni artistiche più disparate, dal disegno alla danza.
Proprio la capacità di attraversare i diversi linguaggi artistici fa dell’ornamento un elemento di straordinaria rilevanza nel mettere in discussione il paradigma moderno dell’autonomia dell’arte, come si evince dagli articoli di Sève e Pacquet. L’ornamento, “concetto transartistico” (p. 9 e ss.), evidenzia non solo la continuità tra pittura, scultura, musica, danza e così via, ma permette anche di ripensare i rapporti tra arte alta e arti applicate, mettendo in luce zone di fertile commistione (p. 25). Il tema è anche al centro delle preoccupazioni di William Morris (1834-1896), che individua proprio nell’ornamento l’area di intersezione tra le proprie posizioni politiche ed estetiche. Morris, unendo la militanza socialista all’attività artigianale presso il movimento Arts and Crafts, promuove una concezione secondo cui “tutta l’arte è ornamentale” poiché tutta l’arte – dalla minore alla maggiore – si dà nell’articolazione ad un ambiente. Il museo, “luogo melanconico” (p. 131), strappa invece l’opera alla vita. Portando avanti una critica d’ispirazione marxista all’industria e alla distruzione del fare artigianale, Morris pone l’ornamento al centro del proprio “pensiero ecologico” (p. 136): se il capitalismo si impernia su pratiche di separazione e parcellizzazione, l’ornamento, nozione relazionale, segnala invece l’essenziale giuntura tra arte e contesto. L’arte, per Morris, è “socialista per essenza” (p. 136): essendo ornamentale, essa è relazionale, e non può essere separata dal politico.
D’altro canto, proprio l’ambiguità che anima intimamente l’ornamento fa sì che esso possa essere letto anche in una chiave politica molto diversa. È ciò che viene evidenziato nell’articolo di Ledoux: partendo dalla tesi di Siegfried Kracauer su La massa come ornamento, in cui si rinviene un’omologia strutturale tra la parcellizzazione del lavoro nell’organizzazione tayloristica e le composizioni di ballerine che verranno poi esibite in maniera eminente dalle coreografie per cinema di Busby Berkeley, l’autrice analizza l’“impensato fascista” che può venire ad animare il motivo ornamentale. Qui, la massa umana che diviene ornamento è il correlato estetico dei modi di produzione capitalista: “la ballerina, come l’operaio” (p. 79), una volta sussunta nell’insieme perde il proprio valore individuale.

Raffaello Sanzio (attribuito): Calamaio con Apollo e le Muse (1584). The Friedsam Collection, Bequest of Michael Friedsam, 1931 Fenomeni come quello delle Tiller girls di fine Ottocento o delle Rockettes americane, in cui il corpo individuale sparisce e la sincronia dei movimenti dà vita a formazioni astratte, dall’apparenza quasi inorganica, ci permettono di volgere l’attenzione alla natura morfologica dell’ornamento. Aspetto poco esplicitato nel volume, il carattere anzitutto morfologico di ogni motivo ornamentale anima però implicitamente tutti gli interventi, in particolare quelli di Pacquet e Labrusse: si tratta, ad esempio, della “gratuità formale” delle arabesques (p. 58), “forme mute” che eccedono la figurazione (p. 59) e che, nella loro qualità puramente plastica, autonoma rispetto a significati e finalità estrinseche, quasi si configurano come astrazione ante litteram. L’arabesque, forma errante che, come ha notato Moritz, incarna il gesto che la traccia e sorge da una pulsione (un Trieb) di decorazione (pp. 34-38, 69), ha dunque carattere “capriccioso, arbitrario, non mimetico” (p. 33). Questa indulgenza formale, sganciata da ogni possibile dinamica di riferimento, denota il peculiare erotismo dell’ornamento: se già Goethe evidenziava la sensualità dell’arabesque (p. 33), non pare azzardato rinvenire qualcosa come un “sex appeal dell’inorganico” (secondo l’espressione benjaminiana recuperata da Mario Perniola) all’opera anche nelle formazioni delle chorus girls. Il luogo dell’erotico non è, qui, il corpo della singola ballerina; l’erotismo riguarda piuttosto la composizione nei suoi tratti irriconoscibili e inorganici, puramente morfologici.
La gratuità formale dell’ornamento si lega, evidentemente, alla questione della rappresentazione. Come mostrano Schiele e Labrusse, l’ornamento non sembra tanto negare il regime rappresentativo, quanto deviarlo dal suo interno: l’arabesque orientale, ad esempio, va a innestarsi nell’immaginario occidentale secondo la logica della hantise, in cui l’infestato e l’infestante non sono mai esenti da contaminazioni reciproche. È così che la perturbante alterità dell’arabesque, interiorizzata dall’Occidente, può introdurre una frattura nel regno dell’oggettività rappresentativa a cui l’immagine mimetica fa capo (p. 57). Anche nelle analisi che Warburg dedica a Botticelli sono proprio gli elementi secondari a creare uno spazio in cui è possibile il prodursi di novità stilistica. Le capigliature e più ancora i panneggi, “estensioni inorganiche dell’individuo” o “organi indolori” (p. 49), sono ornamenti espressivi nella misura in cui essi danno forma grafica all’interiorità del personaggio introducendo movimento nella sua figura; questi elementi, “margini della rappresentazione”, costituiscono delle “zone di sovversione in cui progressivamente si elaborano le trasformazioni di stile” (p. 44). Marginalità e minorità dell’ornamento si convertono così nel suo punto di forza, in ciò che ne fa un oggetto dal potere trasformativo se non addirittura sovversivo.
Tuttavia, la secondarietà stessa dell’ornamento può essere messa in questione – non per negarla tout court, quanto piuttosto per evidenziare come anche in questo caso la natura ambigua della dimensione ornamentale richieda una complicazione ulteriore. Si tratta dell’operazione teorica condotta da Sève nel suo testo. In prima battuta sembra possibile affermare semplicemente che “l’ornamento non esiste in sé, [poiché] ogni ornamento è ornamento di qualcosa che lo precede ed è da esso indipendente” (p. 11): la sua secondarietà ontologica appare tanto più evidente qualora si considerino oggetti come le cornici (di cui basamenti, piedistalli, paratesti e così via non costituiscono che delle variazioni). La cornice presenta il quadro; il parergon, soglia ornamentale, permette di accedere all’opera (all’ergon). In questo senso, la secondarietà dell’ornamento risponde anzitutto alla funzione transitiva di presentazione. Eppure, come nota Sève, ci sono casi in cui l’ontologia dell’ornamento si rovescia ed esso diviene elemento “primo”, intransitivo, pura manifestazione di sé. Casi del genere possono essere osservati nel dominio del vivente, se si sceglie di adottare una prospettiva antiutilitarista: autori come Roger Caillois e Jacques Dewitte permettono di guardare a certe forme e colori animali come a casi in cui in natura si dà una dépense formale, un eccesso che non risponde a valori ed esigenze estrinseche (fig. 2). L’ornamento, qui, è quell’auto-presentazione, quell’esuberante manifestazione priva di destinatario (l’unadressierte Erscheinung di Adolf Portmann) che caratterizza anche alcuni motivi ornamentali realizzati dall’uomo: per usare le parole di Caillois, citate da Sève, si tratterebbe di comprendere “i quadri dei pittori come la varietà umana delle ali delle farfalle” (p. 22). Ancora una volta, la marginalità dell’ornamento cambia di segno e viene ad esibire una forza dirompente, seppur sottile: concetto non solo “transartistico”, capace di attraversare i confini tra le diverse arti, l’ornamento appare ora in grado di superare anche il partage tra natura e cultura (p. 23), nell’ottica di una comune e pervasiva profusione di forme.
di Alice Iacobone