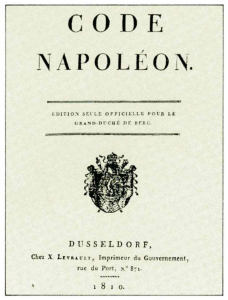Paolo Vignola, ne L’attenzione altrove. Sintomatologie di quel che ci accade, si pone un obiettivo ambizioso: praticare una critica radicale della società e del pensiero filosofico contemporanei, a partire da una prospettiva che l’autore chiama sintomatologica. La società contemporanea, caratterizzata da un’economia capitalistica sempre più pervasiva, ingenera nell’uomo, secondo Vignola, una serie di sintomi, come la sofferenza, la precarietà esistenziale, i disturbi dell’attenzione e un più generale deterioramento dei rapporti interpersonali, che, se diagnosticati con chiarezza, possono aprire la strada a un ripensamento critico del mondo odierno.
Paolo Vignola, ne L’attenzione altrove. Sintomatologie di quel che ci accade, si pone un obiettivo ambizioso: praticare una critica radicale della società e del pensiero filosofico contemporanei, a partire da una prospettiva che l’autore chiama sintomatologica. La società contemporanea, caratterizzata da un’economia capitalistica sempre più pervasiva, ingenera nell’uomo, secondo Vignola, una serie di sintomi, come la sofferenza, la precarietà esistenziale, i disturbi dell’attenzione e un più generale deterioramento dei rapporti interpersonali, che, se diagnosticati con chiarezza, possono aprire la strada a un ripensamento critico del mondo odierno.
Il punto di avvio del libro di Vignola risiede nel rovesciamento di un classico filosofico del Novecento, Il disagio della civiltà. Com’è noto, Freud individua, all’origine della società umana, un processo di sublimazione e regolazione delle passioni umane, che, sebbene provochi una pesante ricaduta sulla salute psico-fisica dell’uomo, risulta in ogni caso inevitabile e necessario. Se con questa intuizione Freud, per Vignola, ha il merito di porre la possibilità di una prospettiva sintomatologica, concentrandosi sui sintomi insalubri che una società è in grado di ingenerare sui suoi individui, la posizione freudiana risulta tuttavia pericolosamente normalizzante, poiché non allarga il proprio discorso dall’individuo alla considerazione critica della società nel suo complesso, limitandosi invece a fornire gli strumenti per una forzata adeguazione dell’individuo a essa. Occorre quindi rovesciare il discorso di Freud, appoggiandosi a chi, nel corso del Novecento, ha praticato, più o meno consapevolmente, una vera e propria sintomatologia. Vignola si confronta così con un gran numero di autori – Foucault, Adorno e Horckheimer, Stiegler, Sloterdijk e Carr, tra gli altri - ibridandone con perizia i concetti: la sintomatologia non è infatti una disciplina nuova, nuovo è forse il tentativo di una sua esplicita sistematizzazione filosofica.
Per poter sfuggire alle secche che caratterizzano la posizione di Freud, serve una sostanziale ridefinizione dei concetti di normale e patologico nei confronti del dato sociale. È qui che Vignola si confronta con Georges Canguilhem e l’idea che il mancato adattamento a un ambiente sociale non sia di per sé patologico, ma che anzi manifesti un diversoorientamento del soggetto, volto a una trasformazione in senso normativo della realtà. Tale trasformazione può essere intesa, in accordo questa volta con Gilbert Simondon, come un processo di individuazione, che, in quanto tale, non riguarda tanto il singolo individuo, quanto una realtà preindividuale e collettiva. Il passaggio dal sintomo alla cura, dalla critica all’adombramento di un’alternativa, come ripete a più riprese Vignola, è infatti pensabile soltanto a partire da un noi che rifugga le componenti individualistiche e narcisistiche tipiche della società contemporanea. Il libro non si limita così a evidenziare la salute precaria che caratterizza la realtà sociale odierna nel suo complesso, ma propone anche una possibile linea di fuga, all’insegna dello stoicismo, nella versione corretta e riveduta da Gilles Deleuze: si tratta di controeffettuare il sintomo, inteso come evento, per rendersi, in questo modo, «degni di quel che ci accade» (p. 36).

Se c’è un protagonista, all’interno de L’attenzione altrove, questi è proprio Deleuze, filosofo che da sempre accompagna la riflessione di Vignola, la cui brillante scrittura sembra ormai averne introiettato il lessico. È poi proprio a partire dal Deleuze di Critica e clinica che nasce il progetto di una prospettiva sintomatologica. Secondo Deleuze, infatti, i grandi scrittori della letteratura mondiale sono al contempo i più grandi clinici e sintomatologi della civiltà a loro contemporanea. Il problema di Vignola è allora quello di traslare la possibilità di una sintomatologia da un ambito profetico-letterario a un campo transdisciplinare, che sappia includere sociologia, antropologia e riflessione filosofica.
Per analizzare i sintomi patologici presenti nella società contemporanea, Vignola si confronta a più riprese con i mezzi di comunicazione digitali. L’esplosione dei social network e, più in generale, del web 2.0 ha portato infatti a una serie di pesanti ricadute sulla capacità di attenzione dell’uomo: la velocità, la dispersione e l’overload di informazioni che caratterizzano la rete hanno infatti trasformato la capacità di concentrazione, non più in grado di sedimentarsi con pazienza, ma brevemente iperstimolata da fonti sempre più varie e disparate. Gli effetti di istupidimento collettivo, soprattutto sui cosiddetti nativi digitali, vanno così di pari passo con una mole di informazioni disponibili sempre in aumento. Da qui una captazione dell’attenzione da parte delle più avanzate strategie di marketing, attive in quella che Stiegler chiama telecrazia.

Accanto a una sintomatologia sociale, Vignola si lancia poi in una vera e propria sintomatologia filosofica: si propone cioè di utilizzare la prospettiva sintomatologica, facendola agire all’interno del pensiero filosofico, che sembra oggi attraversato da una crisi profonda. Mancano infatti uno spazio e un tempo propri al filosofare, attività che ha da sempre richiesto, come sostiene Sloterdijk, uno sguardo differente e allenato. La filosofia deve costituirsi come un esercizio di ascesi teoretica, che necessita di un intenso sforzo di concentrazione. Far agire la prospettiva sintomatologica nei confronti delle teoria filosofica, significa allora chiarire le possibilità della filosofia come disciplina che deve dirigere l’attenzione verso un altrove, verso un nuovo re-incantamento del reale, capace di liberare energie in vista di una trasformazione di se stessa e della realtà sociale.
I sintomi individuati da Vignola non sono in definitiva differenti rispetto a quelli presenti in analisi, anche recenti, che diversi filosofi hanno dedicato al rapporto tra economia capitalistica e società: sfaldamento dei legami interpersonali, individualismo esasperato, consumo reiterato, sfruttamento delle facoltà affettive. C’è da chiedersi se queste analisi, che partono spesso da una premessa empirica – e quindi passibile di un certo soggettivismo –, non insistano troppo sulla pervasività del sistema economico sull’individuo. Non esistono oggi esperienze, realtà e sentimenti autonomi o, comunque, interpretabili sotto un segno positivo? La società contemporanea è soltanto un’escrescenza del neoliberismo capitalista o possiede, al suo interno, elementi che, come l’esplosione della rete, la rendono complessa e difficilmente sistematizzabile? Al netto di questi quesiti, L’attenzione altrove si presenta certamente come un percorso affascinante tra un ricco numero di autori, capace di porre alla società di oggi una serie di domande necessarie e ineludibili, che affondano le loro radici nella richiesta di una vita migliore, a partire dalla quale ci si possa prendere cura, con nuova attenzione, della sfera affettiva.
di Giulio Piatti



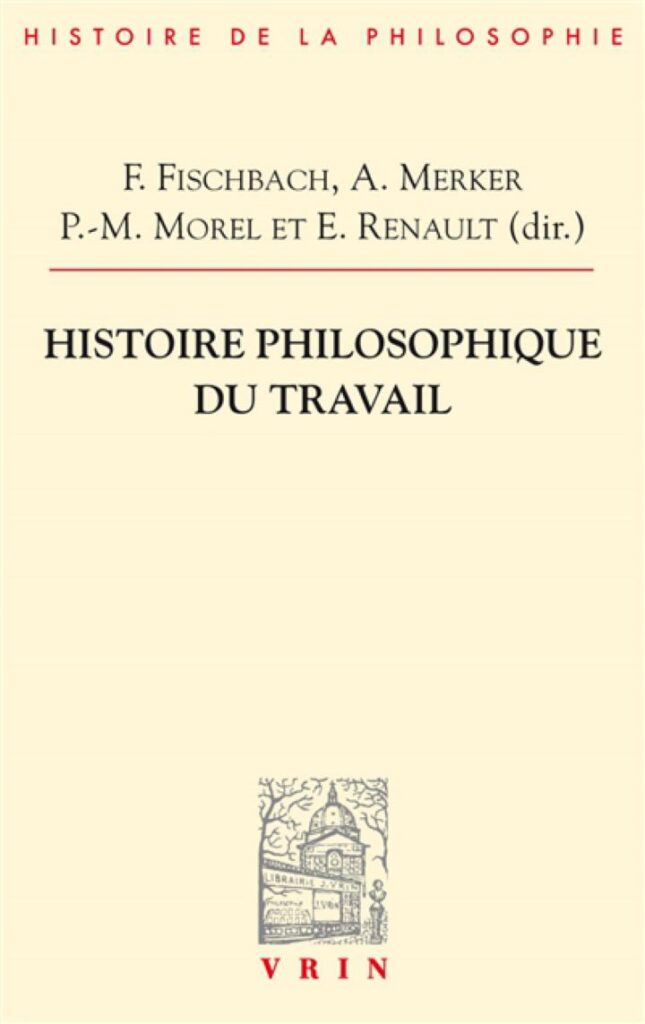







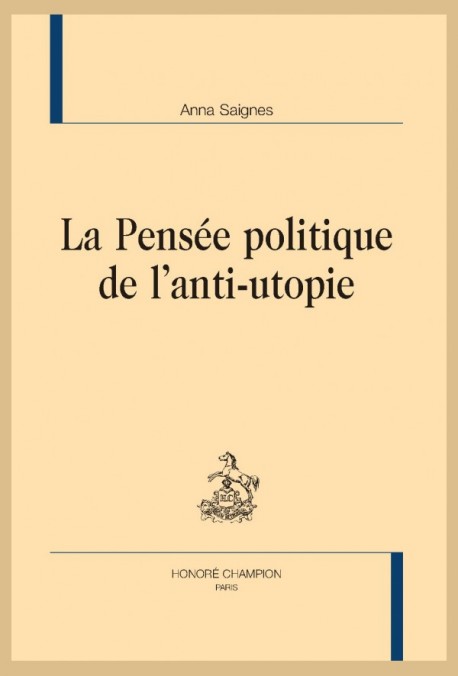







 vendita di quote di società altamente innovative sui mercati azionari, il loro scopo non è certamente attendere di rientrare dell’investimento attraverso il normale flusso di ricavi che il nuovo prodotto garantirebbe. L’orizzonte temporale dei fondi di venture capital non supera i cinque anni, un problema fondamentale se si considera che possono essere necessari anche diversi decenni per commercializzare i risultati di
vendita di quote di società altamente innovative sui mercati azionari, il loro scopo non è certamente attendere di rientrare dell’investimento attraverso il normale flusso di ricavi che il nuovo prodotto garantirebbe. L’orizzonte temporale dei fondi di venture capital non supera i cinque anni, un problema fondamentale se si considera che possono essere necessari anche diversi decenni per commercializzare i risultati di