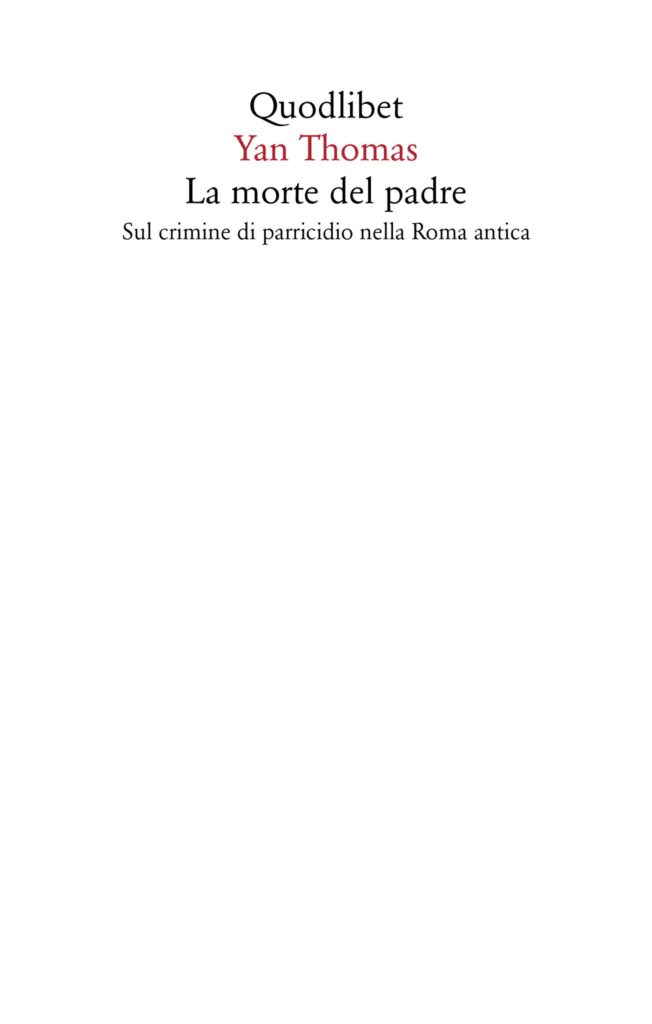-
-
Con Pensiero istituente. Tre paradigmi di ontologia politica (2020) Roberto Esposito porta avanti la riflessione per una filosofia politica affermativa che da tempo muove le sue pubblicazioni. La presa di distanza dalle filosofie che pensano le proprie categorie a partire dal loro rovescio negativo (l’amico a partire dal nemico, la vita a partire dalla morte) è esplicito in Politica e negazione (2018) ma rintracciabile fin da Communitas (1998). D’altra parte in Pensiero istituente si chiarisce anche il distacco dell’autore dalla parte della biopolitica e da quella filosofia affermativa che dimentichi di articolare in maniera produttiva la negatività e il conflitto come caratteristiche imprescindibili del politico. La novità del saggio è proprio la definizione di una terza posizione all’interno della quale Esposito stesso si colloca: egli la delinea tornando a Machiavelli ma soprattutto attraverso l’opera di un autore di cui fin qui poco si era occupato e che, almeno per quel che riguarda la recezione italiana, rientra ancora tra i minori, Claude Lefort. È alla sua posizione, definita appunto istituente, che si riferisce il titolo del nostro testo e che costituisce la proposta positiva di Esposito.
L’articolazione del libro in tre capitoli restituisce la partizione proposta dall’autore tra un paradigma destituente che fa capo alla tradizione heideggeriana, un paradigma costituente fatto risalire all’opera di Deleuze, e infine un pensiero istituente, neo-machiavelliano o conflittualista, lefortiano. Se l’ultimo paradigma è la pars costruens del discorso di Esposito, Heidegger e Deleuze rappresentano invece due tendenze, tra loro opposte ma ugualmente degenerative, che caratterizzano la crisi del pensiero politico contemporaneo. Ripercorrerne le elaborazioni è così un modo per prendere posizione rispetto al dibattito, italiano e non, che ad essi è debitore, si pensi per esempio ad Agamben o a Nancy per il primo ed a Negri e Hardt per il secondo.
Le tre posizioni si collocano all’interno di un orizzonte che Esposito definisce «ontologico politico post-fondazionale» e corrispondono ad altrettante declinazioni possibili del rapporto tra essere, politica e differenza. A caratterizzare questa impostazione sarebbe secondo l’autore la particolare consapevolezza della dipendenza reciproca di ontologia e politica: da una parte la presupposizione di concezioni sull’essere (sullo spazio, sul tempo, sull’uomo) implicita in ogni azione politica, dall’altra il fatto che l’elaborazione di posizioni ontologiche, a partire dalla decisione su ciò che deve o meno essere considerato politico, dipende a sua volta da opzioni politiche. È su questo piano comune che riposa la possibilità di un confronto tra autori che si sono occupati in maniera quanto mai difforme di politica, sia per quel che riguarda la teorizzazione che la sua pratica concreta. L’impressione però è che ad emergere in Pensiero istituente, anche rispetto ad altri interventi dello stesso Esposito più situati rispetto a questioni di politica contemporanea, sia piuttosto l’ontologia della politica che non la concreta esigenza politica di un’ontologia.
Il primo capitolo del saggio è dedicato al paradigma destituente cui fanno capo le filosofie che, pensando la politica a partire dal suo fondamento negativo, hanno come esito una delegittimazione dell’azione politica. In questa prospettiva che vede la politica rinchiusa all’interno dei propri confini mondani, e compromessa con la violenza e il potere che ne fanno parte, ogni tentativo di realizzazione storica di qualsivoglia idea di bene o di giustizia è destinato a fallire. La critica di Esposito al pensiero heideggeriano ed al paradigma che rappresenta è che, a fronte di affermazioni teoricamente rivoluzionarie, essi finiscano per essere praticamente inerti e spoliticizzanti (p. XIII).
Benché Esposito ne ripercorra quasi interamente l’opera, non è tanto l’Heidegger degli anni Trenta a rappresentare nella maniera più chiara questo paradigma. Qui, ancora, l’adesione al regime nazista si accompagna a un discorso positivo sulla messa in opera e quindi a una possibilità positiva di politica, benché Heidegger la immagini guidata dalla filosofia in un primo tempo (cfr. il Discorso del rettorato, 1933), e in seguito la concepisca in analogia alla creazione dell’opera d’arte, condotta da parte degli individui “più unici” in grado di dare unità simbolica e politica a un popolo (cfr. i corsi del 1934-35 su Hölderlin e L’origine dell’opera d’arte, 1935). È piuttosto dagli anni Quaranta che Heidegger comincia a maturare la sfiducia nei confronti dell’azione che andrà consolidando negli scritti del secondo dopoguerra. Già nel corso del ’42 su l’Ister di Hölderlin, Heidegger non pensa più la politica come un’opera da realizzare ma come un evento che emerge dalla polis (p. 46). Se però ancora nella polis una politica sembra possibile, in un mondo sempre più dominato dalla tecnica l’azione politica non è in grado di sottrarsi alla sua razionalità: il passaggio dall’idea greca di una realtà operante alla concezione romana del reale come creato e dell’agire come causa efficiente fa sì che l’azione politica venga a far parte della stessa logica della tecnica e della macchinazione che vorrebbe contrastare (cfr. Scienza e meditazione, 1953). In questo contesto l’unica azione possibile è un lasciar essere, una revoca dell’azione e della volontà che in Heidegger si tinge di tinte poetico meditative (cfr. Gelassenheit, 1983).
Come già accennato, Heidegger non è l’unico autore ascritto al paradigma destituente. In Categorie dell’impolitico (1988), che si può dire si muova all’interno di questa prospettiva, Esposito si era rivolto tra gli altri a Weil, Broch, Bataille che anche in Pensiero istituente non manca di citare. Se la lezione di altri autori «destituenti» non porta a esiti così smaccatamente spoliticizzanti come quelli di Heidegger egli è però portatore dell’opinione condivisa sulla limitatezza, sulla non fondatezza dell’agire umano e sulla sua implicazione nella necessità del mondo. Come commenta Esposito seguendo Schürmann: «A venir meno, con la distruzione metafisica praticata da Heidegger, non è l’agire, ma la possibilità che questo continui a essere legittimato da un principio esterno. Ormai la praxis non è più fondabile da parte della theoria» (p. 65).
Un discorso specularmente inverso vale per il paradigma costituente rappresentato da Deleuze. La filosofia di Deleuze è definita costituente nel senso che essa pensa l’essere come una realtà creativa e produttiva di molteplicità. La critica di Esposito a questa posizione è che, per quanto non pacifica nel percorso di Deleuze, la coincidenza sempre più stretta di essere e differenza tenda a obliterarne la dimensione conflittuale, e il politico, che in questa dimensione si colloca, finisce per confondersi con il flusso del divenire perdendo rilievo specifico e forza critica. «Ciò che manca, in un’ontologia dell’immanenza assoluta, non è la trascendenza del potere, ma una teoria del conflitto politicamente articolata» (p. 115).
Anche in questo secondo capitolo Esposito ripercorre puntualmente l’evoluzione del pensiero di Deleuze. Secondo l’autore, in buona parte in consonanza con Žižek, il pensiero di Deleuze oscilla tra due ontologie divise dalla posizione di fronte al negativo. Ancora in Nietzsche e la filosofia il negativo viene inteso come il risultato dell’aggressività dell’affermarsi della differenza, dotato di una forza propria, e in Marcel Proust e i segni emerge come il segno di ciò che non è più, di ciò che è passato. A partire dagli anni ’60, con l’avvicinamento alle posizioni di Bergson, Deleuze tende invece a mettere da parte il negativo come falso problema. Nonostante qualche eccezione (cfr. per esempio Logica del senso, 1969), la sua ontologia si sposta interamente sul piano di immanenza cosicché l’essere stesso viene a coincidere con la differenza, ovvero con una realtà plurale e articolata in una molteplicità di organizzazioni (p. 107). Proprio quando, nella collaborazione con Guattari, l’interesse e il linguaggio di Deleuze si fa espressamente politico, la politica stessa finisce per perdere i confini del proprio ambito e viene a coincidere con il dispiegarsi del desiderio inteso come azione rivoluzionaria produttiva di realtà (p. 120). In questo contesto la critica al capitalismo che innerva i due volumi di Capitalismo e schizofrenia vede come unica azione politica possibile l’accelerazione degli stessi flussi di desiderio di cui il capitalismo è composto. La schizofrenia, la decodificazione di tali flussi e la dissoluzione degli ultimi vincoli che ancora li trattengono costituiscono l’unica strada per immaginare il superamento del capitale.
Nello stesso ordine di riflessioni si inseriscono, come già notato da Benjamin Noys (cfr. The Persistence of the Negative, 2010), autori come Lyotard e Baudrillard, ma Esposito vi fa convergere anche Negri e Hardt e per altro verso Vattimo. Il tratto che, pur nelle differenze specifiche, li accomuna è il tentativo di contrapporsi al capitale dall’interno, assecondandone la razionalità invece di contrastarla (p. 79). L’esito del paradigma costituente risulta simmetricamente opposto a quello heideggeriano, ovvero un pensiero dalla veste al contempo iperpolitica e spoliticizzante. Una nota a parte meritano invece due testi, Istinti e istituzioni (1955) e Empirismo e soggettività (1973), perché ci portano nella direzione che sarà propria del paradigma istituente. In questi testi, a partire dalla lettura di Hume, Deleuze interpreta l’istituzione come la zona d’incontro tra natura e cultura, ovvero tra il desiderio e la necessità di darvi una forma. Diversamente dalla lettura che ne è stata data dai francofortesi fino a Foucault, in questa prospettiva l’istituzione è l’affermazione di un modello possibile di soddisfazione degli istinti piuttosto che un dispositivo volto a frenarli, com’è invece la legge. Vedremo come ciò sia consonante con alcune posizioni lefortiane.

Claude Lefort A queste ultime si rivolge il terzo e ultimo capitolo di Pensiero istituente. Lefort (1924-2010) è noto per essere stato fondatore insieme a Cornelius Castoriadis di Socialismo o Barbarie. Allievo di Merleua-Ponty, ne è stato anche esecutore testamentario curando e introducendo le edizioni di molti dei suoi testi, come Il visibile e l’invisibile (1964); L’institution. La passivité (2003); e Œuvres (2010). Questa matrice fenomenologica caratterizza fortemente il terzo paradigma delineato da Esposito. Qui l’istituire viene inteso come un processo di stabilizzazione dell’esperienza che si compie su un piano intersoggettivo: se da una parte l’istituzione consiste nelle azioni dei soggetti istituenti, essa ha allo stesso tempo una validità indipendente da ognuno di essi. In questo modo i singoli la tengono in vita modificandola, ma senza per questo crearla ex nihilo né tantomeno trovandola prederminata, ricevendola da altri e restituendola ad altri.
Ad istituire per Lefort è in primo luogo la politica, dove essa consiste nella messa in forma simbolica dei conflitti che dividono il sociale. Questa prospettiva, che segna anche il distacco da Marx, deve molto all’incontro con la letteratura etnografica e con Machiavelli (cfr. Le Travail de l'œuvre Machiavel, 1972). In particolare dal confronto con quest’ultimo, in parte anticipato nel Merleau-Ponty delle Note su Machiavelli (1949) e de Le avventure della dialettica (1955), si delineano due punti centrali dell’ontologia politica di Lefort: il simbolico come luogo del politico e l’ineluttabilità del conflitto. Come ribadisce Esposito «il potere ha a che fare più col discorso – cioè con la sua costruzione rappresentativa – che con i rapporti economici all’interno dei quali s’istituisce» (p. 178), in quanto sua immagine simbolica il politico eccede dal sociale e retroagisce su di esso. Se da una parte non si dà politica al di fuori della società su cui si esercita, infatti, d’altro canto anche la società non esiste propriamente come insieme riconoscibile prima di essere resa visibile tramite la sua rappresentazione politica (p. 169). D’altra parte, la comprensione del conflitto come dato ineluttabile delle società intende affermare che l’ordine politico è sì possibile ma sempre provvisorio, ovverosia che l’operazione di simbolizzazione e di messa in forma della società non è garantita dal suo fallimento proprio perché, se il politico non coincide col sociale, neppure il sociale coincide con se stesso. Ciò che distingue le diverse società è il modo in cui in esse il potere politico rappresenta il conflitto (p. 191). Da una parte, nelle cosiddette “società senza storia” o “stagnanti” la tendenza è quella a escludere e neutralizzare per quanto possibile il conflitto, con lo scopo di mantenere intatto un certo ordine. Diversamente, secondo Lefort, la democrazia moderna è l’unico sistema politico in grado di riconoscere e rappresentare l’essenza conflittuale della società (cfr. Sur la démocratie: le politique et l’institution du social, 1971). Attraverso le sue istituzioni volte non tanto a mantenere un certo potere quanto a salvaguardare la possibilità del suo passaggio di mano tra le parti in gioco, la democrazia dà forma a un potere vuoto, cioè infinitamente contendibile. Contraddicendo una valutazione comune ai più grandi pensatori politici novecenteschi, che intendono la modernità come un’epoca di spoliticizzazione, per Lefort la democrazia moderna è al contrario politica per eccellenza. Nell’istituzione democratica, infine, viene riconosciuto il risultato del ribaltamento dell’articolazione di diritto e potere messa in atto dalle rivoluzioni moderne, dove adesso è il diritto a fondare e a limitare il potere.
Anche in questo caso Lefort non è né il primo né l’unico ad aver tematizzato l’istituzione, egli ne condivide anzi il discorso con autori come Castoriadis, Ricoeur, ma anche Hariou e Santi Romano. In particolare attraverso quest’ultimo, cui Esposito dedica l’ultimo paragrafo del saggio, il discorso istituente viene aperto a una prospettiva che superi la dimensione statale. Romano riconosce l’istituzione anche nelle collettività organizzate alternative o addirittura competitive nei confronti dello Stato, facendo dell’istituire un processo in grado di accogliere le istanze mutevoli della società. Così anche per Esposito «tutt’altro che a un ordine consolidato di regole e leggi, l’istituire rimanda piuttosto a un compito – coincidente con quello della politica – destinato a mutare continuamente il quadro normativo entro cui agisce» (p. XIX).
di Anna Draghi
-
Mariana Mazzucato – Lo stato innovatore
Recensioni / Aprile 2016 Con il libro Lo Stato Innovatore (Laterza, 2014) Mariana Mazzucato ha rotto il silenzio che pervadeva nell’accademia e tra l’opinione pubblica europea circa il ruolo dello Stato in una moderna economia di libero mercato. Il libro ha avuto un’ampia diffusione, soprattutto in Italia e nel Regno Unito, dove Mazzucato insegna Economia dell’innovazione. Se ne è molto dibattuto, perché la tesi centrale dell’autrice è in radicale opposizione sia con le teorie economiche correnti sia con l’atteggiamento della politica europea degli ultimi trent’anni: secondo l’autrice lo Stato dovrebbe intervenire di più e meglio nel sistema economico. Esperta di innovazione tecnologica e del rapporto di quest’ultima con la crescita economica e il tessuto produttivo, Mazzucato sostiene due posizioni fondamentali: la prima è che il contributo attivo dello Stato nel creare innovazione tecnologica è largamente sottostimato e taciuto; la seconda è che il settore privato non è in grado di produrre da solo l’innovazione necessaria per garantire crescita economica e risposte ai più urgenti problemi globali (in primis la crisi ambientale).
Con il libro Lo Stato Innovatore (Laterza, 2014) Mariana Mazzucato ha rotto il silenzio che pervadeva nell’accademia e tra l’opinione pubblica europea circa il ruolo dello Stato in una moderna economia di libero mercato. Il libro ha avuto un’ampia diffusione, soprattutto in Italia e nel Regno Unito, dove Mazzucato insegna Economia dell’innovazione. Se ne è molto dibattuto, perché la tesi centrale dell’autrice è in radicale opposizione sia con le teorie economiche correnti sia con l’atteggiamento della politica europea degli ultimi trent’anni: secondo l’autrice lo Stato dovrebbe intervenire di più e meglio nel sistema economico. Esperta di innovazione tecnologica e del rapporto di quest’ultima con la crescita economica e il tessuto produttivo, Mazzucato sostiene due posizioni fondamentali: la prima è che il contributo attivo dello Stato nel creare innovazione tecnologica è largamente sottostimato e taciuto; la seconda è che il settore privato non è in grado di produrre da solo l’innovazione necessaria per garantire crescita economica e risposte ai più urgenti problemi globali (in primis la crisi ambientale).Mazzucato ha un curriculum di eccezione da economista eterodossa. Ha ottenuto il dottorato alla New School for Social Research, prestigiosa università americana considerata fra le più progressiste d’oltreoceano. Effettivamente i riferimenti teorici del libro sono esplicitamente eterodossi: John Maynard Keynes, Joseph Schumpeter, Karl Paul Polanyi e Hyman Minsky sono tra i nomi che l’autrice evoca per fondare le argomentazioni di policy del libro su solide basi teoriche. L’argomento più convincente in favore del necessario intervento statale per promuovere e realizzare l’innovazione scientifica e tecnologica sarebbe la differenza tra i concetti di rischio e di incertezza, sottolineata dall’economista americano Frank Hyneman Knight negli anni Venti del secolo scorso. Il primo caratterizza la condizione di indeterminatezza rispetto a una serie di eventi che potrebbero verificarsi. Prendiamo per esempio il classico lancio della monetina. Non si può sapere prima del lancio quale sarà il risultato, ma si può calcolare con precisione la distribuzione probabilistica dei due eventi possibili. Da ciò risulta che il rischio è quantificabile e in effetti i moderni mercati finanziari si basano sostanzialmente sulla misurazione del rischio e della sua “commodificazione” sotto forma di assicurazioni, contratti derivati e altri tipi di strumenti economici. L’incertezza invece è la completa incapacità di prevedere un evento futuro, proprio come nel caso di uno scienziato che conduce un esperimento per scoprire una nuova tecnologia. Secondo Mazzucato l’innovazione si basa sul concetto di incertezza ed è per questo che il settore privato – aziende e venture capitalist, cioè quegli investitori specializzati nel finanziare progetti innovativi e altamente rischiosi – dimostra di non avere gli incentivi giusti e quel “capitale paziente” che permetterebbe all’innovazione di fiorire.
Secondo l’autrice le più grandi multinazionali rispondono alla deregolamentazione dei mercati finanziari reinvestendo i loro profitti nel riacquisto delle proprie azioni anziché promuovere il comparto di ricerca e sviluppo (R&S) o proporre progetti innovativi. I fondi di venture capital invece guadagnano dalla
 vendita di quote di società altamente innovative sui mercati azionari, il loro scopo non è certamente attendere di rientrare dell’investimento attraverso il normale flusso di ricavi che il nuovo prodotto garantirebbe. L’orizzonte temporale dei fondi di venture capital non supera i cinque anni, un problema fondamentale se si considera che possono essere necessari anche diversi decenni per commercializzare i risultati di ricerche scientifiche innovative. Per far entrare lo Stato sulla scena, Mazzucato sfata un mito resistente nella teoria economica: il concetto di fallimento del mercato. Questo non rappresenta né l’unica né la più importante ragione del perché lo Stato debba farsi protagonista attivo dei complessi processi dell’innovazione. La teoria sostiene che il mercato dovrebbe essere lasciato libero di autoregolarsi tranne in casi eccezionali, nei quali l’ammontare del bene fornito dal mercato è inferiore all’ammontare ottimale (da qui il fallimento). Per quanto riguarda l’innovazione, però, lo Stato è l’unica istituzione in grado di assumere l’incertezza e di guidare i processi innovativi con un mix di politiche e investimenti mirati. Quel che è chiaro è che lo Stato non dovrebbe semplicemente limitarsi a creare le condizioni migliori affinché siano i privati a condurre i processi di innovazione tecnologica e industriale, ma dovrebbe invece svolgere un attivo ruolo di coordinamento, di finanziamento e di promozione attraverso agenzie pubbliche, centri di ricerca e partnership con il settore privato.
vendita di quote di società altamente innovative sui mercati azionari, il loro scopo non è certamente attendere di rientrare dell’investimento attraverso il normale flusso di ricavi che il nuovo prodotto garantirebbe. L’orizzonte temporale dei fondi di venture capital non supera i cinque anni, un problema fondamentale se si considera che possono essere necessari anche diversi decenni per commercializzare i risultati di ricerche scientifiche innovative. Per far entrare lo Stato sulla scena, Mazzucato sfata un mito resistente nella teoria economica: il concetto di fallimento del mercato. Questo non rappresenta né l’unica né la più importante ragione del perché lo Stato debba farsi protagonista attivo dei complessi processi dell’innovazione. La teoria sostiene che il mercato dovrebbe essere lasciato libero di autoregolarsi tranne in casi eccezionali, nei quali l’ammontare del bene fornito dal mercato è inferiore all’ammontare ottimale (da qui il fallimento). Per quanto riguarda l’innovazione, però, lo Stato è l’unica istituzione in grado di assumere l’incertezza e di guidare i processi innovativi con un mix di politiche e investimenti mirati. Quel che è chiaro è che lo Stato non dovrebbe semplicemente limitarsi a creare le condizioni migliori affinché siano i privati a condurre i processi di innovazione tecnologica e industriale, ma dovrebbe invece svolgere un attivo ruolo di coordinamento, di finanziamento e di promozione attraverso agenzie pubbliche, centri di ricerca e partnership con il settore privato. Nei capitoli centrali del libro, Mazzucato passa in rassegna numerosi esempi storici che dimostrano il ruolo attivo dello Stato nei processi di innovazione. Il suo caso studio più eclatante sono gli Stati Uniti. Qui, molti dei programmi pubblici che finanziarono ricerca di base e applicata nei settori delle biotecnologie e dei farmaci furono approvati dall’amministrazione conservatrice di Ronald Reagan negli anni Ottanta. A tal proposito l’autrice ricorda l’apparente conflitto tra i sostenitori delle politiche interventiste di Alexander Hamilton (1755-1804) e quelli delle politiche del laissez-faire di Thomas Jefferson (1743-1826). Negli Stati Uniti, la posizione ufficiale è sempre stata jeffersoniana mentre la politica economica – adottata silenziosamente – decisamente hamiltoniana. Già nel 1958 il governo creò un ufficio governativo all’avanguardia nella promozione dello sviluppo tecnologico per la difesa nazionale (Darpa). Le caratteristiche del Darpa erano: autonomia dal governo, ingenti finanziamenti e capacità di attrarre le menti più brillanti del paese. Senza il Darpa alcune tra le più importanti innovazioni in campo informatico (per esempio internet) non sarebbero state possibili.
Per spiegare il ruolo decisivo avuto dallo Stato nel potenziare innovazione tecnologica e permettere lo sviluppo di nuovi prodotti, Mazzucato dedica un intero capitolo ad Apple, l’azienda del popolarissimo Steve Jobs. Creata in un garage con pochissimi mezzi e tanto spirito imprenditoriale, Apple rappresenta nell’immaginario comune l’impresa di successo che ha rivoluzionato i mercati con prodotti tecnologicamente all’avanguardia. Peccato che, secondo Mazzucato, Jobs e compagni non sarebbero andati da nessuna parte senza le invenzioni finanziate dal governo americano. Internet, GPS, schermi tattili e le più moderne tecnologie di comunicazione sono state tutte inventate grazie allo Stato e poi utilizzate da Apple. Il segreto del successo dell’azienda di Cupertino starebbe nella capacità di integrare innovazione preesistenti e nella cura del rapporto utente-supporto informatico.

In sostanza la tesi di Mazzucato è che lo Stato debba essere considerato un partner del settore privato nei processi di innovazione tecnologica e non un semplice facilitatore. Al contrario del privato, lo Stato può assumere l’incertezza e coordinare i processi virtuosi che portano le economie capitaliste a crescere. L’autrice condanna le recenti tendenze delle grandi imprese farmaceutiche e high-tech alla socializzazione del rischio – cioè lo sfruttamento della ricerca finanziata dallo Stato – per poi privatizzare i profitti, non remunerando adeguatamente i lavoratori o cercando di eludere il fisco. La ricetta di Mazzucato è riassumibile in un concetto espresso nella parte finale del libro: «quando la distribuzione dei proventi finanziari del processo di innovazione riflette la distribuzione dei contributi al processo stesso, allora l’innovazione tende a ridurre la diseguaglianza». Questa è però anche la debolezza della tesi esposta nel libro: manca un’analisi approfondita delle complesse dinamiche economiche che caratterizzano le moderne economie globali. Un ruolo diverso dello Stato nei processi di innovazione sarebbe il grimaldello per invertire la tendenziale stagnazione delle economie occidentali e per risolvere il problema della riconversione industriale. Troppi elementi vengono ricondotti all’interno del discorso dell’economia dell’innovazione; per esempio il problema delle diseguaglianze crescenti difficilmente può essere affrontato entro tale cornice teorica.
Infine sembra mancare un’indagine dei processi politici che guidano lo Stato. Chi è lo Stato innovatore e come si forma? Quali sono gli incentivi necessari per mettere in moto i virtuosi meccanismi dell’innovazione coordinati dallo Stato? Su questo punto il testo di Mazzucato è deficitario, cosa che, tra l’altro, rende il suo punto di vista facilmente attaccabile: chiedere più Stato affidandosi vagamente a una leadership più forte o a una capacità di visione maggiore rischia di produrre solamente corruzione e sprechi.
di Alberto Fierro
-
Jean-Luc Nancy – Dov’è successo?
Recensioni / Febbraio 2015 Il tema dell'archivio, oggetto dell'intervista di Nathalie Léger a Jean-Luc Nancy qui proposta in traduzione italiana a cura di Igor Pelgreffi, acquista nel corso del Novecento una sempre maggiore autonomia dalle discipline che se ne sono occupate tradizionalmente, in primo luogo la storia e la filologia. Dal punto di vista filosofico, emerge così progressivamente la domanda sul senso dell'archivio e sugli effetti che esso può determinare sulle opere e sull'immagine stessa di un autore. In altre parole, come ricorda il curatore in apertura del saggio introduttivo, «come esaminare il passato del proprio lavoro? Qual è la sua materia, quali sono i suoi oggetti? Qual è la parte della cancellazione e della distruzione? Come iniziare con ciò che resta?» Innanzitutto, ogni archivio è un luogo. Non solo nel senso dello spazio fisico in cui sono raccolte le opere di uno o più autori, ma uno spazio entro cui sono possibili certe operazioni intellettuali: infatti, se da un lato l'archivio rappresenta una risorsa insostituibile nel processo di analisi del pensiero di un filosofo, nella conservazione delle sue opere e nella costruzione della sua immagine futura, dall'altro lato esso apre una serie di interrogativi filosofici inediti, relativi al funzionamento dell'archiviazione, al suo duplice carattere di mantenimento e perdita, al momento a partire dal quale si può dire di aver davvero archiviato qualcosa. In sintesi, dove e a chi (o a cosa) accade l'archiviazione? È questo l'interrogativo di fondo attorno a cui si snoda tutto il discorso di Nancy, d'ispirazione decostruttiva, qui presentato. Come osserva acutamente Pelgreffi, «non possiamo comprendere l'archivio se non immaginiamo un intreccio fra spazio dell'archivio e tempo dell'archivio così come fra spazio dell'archiviazione e tempo dell'archiviazione, cioè quello che, in termini derridiani, potremmo pensare come una différance spazio-temporale, nel senso di una spazializzazione del tempo e di una temporalizzazione dello spazio.» Ed è senza dubbio in consonanza col pensiero di Derrida che Nancy costruisce il proprio discorso sull'arché e sull'istituzione dell'archivio, col risultato - paradossale, come quasi sempre accade seguendo un approccio derridiano o,
Il tema dell'archivio, oggetto dell'intervista di Nathalie Léger a Jean-Luc Nancy qui proposta in traduzione italiana a cura di Igor Pelgreffi, acquista nel corso del Novecento una sempre maggiore autonomia dalle discipline che se ne sono occupate tradizionalmente, in primo luogo la storia e la filologia. Dal punto di vista filosofico, emerge così progressivamente la domanda sul senso dell'archivio e sugli effetti che esso può determinare sulle opere e sull'immagine stessa di un autore. In altre parole, come ricorda il curatore in apertura del saggio introduttivo, «come esaminare il passato del proprio lavoro? Qual è la sua materia, quali sono i suoi oggetti? Qual è la parte della cancellazione e della distruzione? Come iniziare con ciò che resta?» Innanzitutto, ogni archivio è un luogo. Non solo nel senso dello spazio fisico in cui sono raccolte le opere di uno o più autori, ma uno spazio entro cui sono possibili certe operazioni intellettuali: infatti, se da un lato l'archivio rappresenta una risorsa insostituibile nel processo di analisi del pensiero di un filosofo, nella conservazione delle sue opere e nella costruzione della sua immagine futura, dall'altro lato esso apre una serie di interrogativi filosofici inediti, relativi al funzionamento dell'archiviazione, al suo duplice carattere di mantenimento e perdita, al momento a partire dal quale si può dire di aver davvero archiviato qualcosa. In sintesi, dove e a chi (o a cosa) accade l'archiviazione? È questo l'interrogativo di fondo attorno a cui si snoda tutto il discorso di Nancy, d'ispirazione decostruttiva, qui presentato. Come osserva acutamente Pelgreffi, «non possiamo comprendere l'archivio se non immaginiamo un intreccio fra spazio dell'archivio e tempo dell'archivio così come fra spazio dell'archiviazione e tempo dell'archiviazione, cioè quello che, in termini derridiani, potremmo pensare come una différance spazio-temporale, nel senso di una spazializzazione del tempo e di una temporalizzazione dello spazio.» Ed è senza dubbio in consonanza col pensiero di Derrida che Nancy costruisce il proprio discorso sull'arché e sull'istituzione dell'archivio, col risultato - paradossale, come quasi sempre accade seguendo un approccio derridiano o,come in questo caso, post-derridiano - che proprio l'“oggetto archivio”, la cui istituzione è segnata da un luogo e una data, finisce per essere l'elemento meno stabile per determinare la nostra relazione col passato. Piena continuità, dunque, col testo di Derrida Mal d'archive, di cui questo discorso di Nancy rappresenta idealmente la prosecuzione. Infatti, Nancy condivide la preoccupazione derridiana di una possibile riduzione dell'archivio al mito del “ritorno all'origine”, in altre parole l'istituzione di un luogo a cui consegnare il passato dell'autore, il suo tempo perduto. Al contrario, osservano Derrida e Nancy, non esiste alcuna origine piena da poter rendere presente e disponibile, ma soltanto l'archiviazione che permette di rinvenire la traccia dell'origine. Come osserva
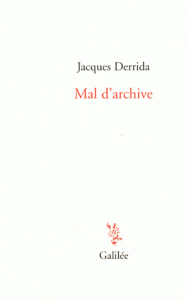 Pelgreffi, da tale confronto con Derrida emerge che il soggetto non è diviso tra due mondi, quello interno e quello sociale, ma è preso nel processo di riassorbimento e rigenerazione delle forme soggettive che dà luogo all'archivio, precedendo dunque ogni dualismo tra interiorità ed esteriorità. Ne consegue che il datum documentale non è un atomo, ma un'unità differenziata, ibrida, divisa originariamente nei suoi elementi giuridici, etici, politici ed esistenziali. Ma se Nancy richiama esplicitamente Derrida, intreccia altresì un dialogo “silenzioso” con Foucault, per il cui pensiero, com'è noto, la nozione di archeologia è di primaria importanza. Dal suo punto di vista, l'archivio permette di chiarire il nesso tra sapere e potere che si manifesta in ogni discorso: in questo senso, l'archivio non è soltanto il luogo fisico dove rinvenire tutte le informazioni su uno o più autori, ma «il sistema generale della formazione e della trasformazione degli enunciati.» In altre parole, secondo Foucault l'archivio si pone a metà strada tra il trascendentale e l'empirico, dà luogo a un ordine terzo rispetto al puramente ideale - la ragione come archetipo perfetto dell'archivio - e all'assolutamente empirico, sciolto da ogni regola discorsiva.
Pelgreffi, da tale confronto con Derrida emerge che il soggetto non è diviso tra due mondi, quello interno e quello sociale, ma è preso nel processo di riassorbimento e rigenerazione delle forme soggettive che dà luogo all'archivio, precedendo dunque ogni dualismo tra interiorità ed esteriorità. Ne consegue che il datum documentale non è un atomo, ma un'unità differenziata, ibrida, divisa originariamente nei suoi elementi giuridici, etici, politici ed esistenziali. Ma se Nancy richiama esplicitamente Derrida, intreccia altresì un dialogo “silenzioso” con Foucault, per il cui pensiero, com'è noto, la nozione di archeologia è di primaria importanza. Dal suo punto di vista, l'archivio permette di chiarire il nesso tra sapere e potere che si manifesta in ogni discorso: in questo senso, l'archivio non è soltanto il luogo fisico dove rinvenire tutte le informazioni su uno o più autori, ma «il sistema generale della formazione e della trasformazione degli enunciati.» In altre parole, secondo Foucault l'archivio si pone a metà strada tra il trascendentale e l'empirico, dà luogo a un ordine terzo rispetto al puramente ideale - la ragione come archetipo perfetto dell'archivio - e all'assolutamente empirico, sciolto da ogni regola discorsiva.Questo duplice dialogo con Derrida e Foucault induce a evidenziare anche un altro fil rouge del testo di Nancy: la questione dell'alterità. Infatti, nell'istituzione dell'archivio è già sempre coinvolto l'altro, in modo tale che la domanda sull'archivio implica anche sempre la questione del rapporto tra archiviazione, estraneità e istituzione. Come ha osservato molte volte Derrida, qualunque processo di istituzione conserva una traccia di ciò che esclude, cioè di quell'estraneità che sceglie originariamente di estromettere dall'istituzione o dall'archiviazione. In sintesi, per dotarsi di una qualche identità, l'archivio, nell'atto della sua istituzione, è costretto a relazionarsi con ciò che sceglie di non archiviare. Deve nominarlo, assumerne le sembianze, in modo tale che può accadere che sia proprio l'escluso dall'archiviazione ad assumersi il compito di conservarne la memoria. Ora, tale intreccio irrisolto tra identità e alterità è continuamente rilanciato da Nancy in questo testo, ad esempio attraverso la questione “che cos'è un'opera?” - come nota il curatore, vero e proprio contrappunto alla domanda di Foucault “che cos'è un autore?”, oggetto di una conferenza al Collège de France del 1969.
Volendo individuare la tesi portante del discorso di Nancy, attorno a cui si annodano tutti i vari temi che egli affronta in questo breve testo, si potrebbe azzardare la seguente affermazione: l'archivio sottrae l'autore stesso a qualunque forma di sapere oggettivo. Il che significa che non si potrà mai raggiungere una qualche conoscenza definitiva e cogente di «chi è diventato questa firma che offre il suo nome, i suoi tratti, il suo carattere»all'archiviazione: quest'ultima resterà sempre un processo che non consente di afferrare concettualmente la natura del proprio rapporto con un certo autore, benché lo riguardi direttamente. In altre parole, chi è diventato l’autore, una volta che transita dal proprio archivio? Nancy risponde: «Nessuno che noi possiamo nominare o circoscrivere in alcun modo. “Gli archivi di X” sono un modo di far indietreggiare X più lontano, più in profondità nei suoi archivi. Noi vediamo i suoi tentativi, le sue note, le sue esitazioni, le sue vergogne forse, le sue dissimulazioni, i suoi oblii: ma lui, “lui”, dov’è?».
di Claudio Tarditi
-
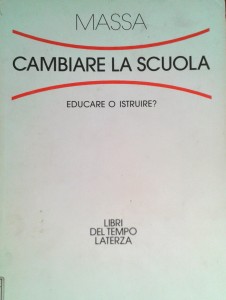 Riccardo Massa è stato un pedagogista capace di interrogare i problemi educativi con la radicalità propria di uno sguardo filosofico. Il suo libro Cambiare la scuola. Educare o istruire? (Laterza, Roma-Bari 1997) è la testimonianza esemplare di un'attitudine di ricerca in grado di tenere insieme la consapevolezza empirica e vissuta dei sommovimenti di un ambiente – quello scolastico – con la profondità e il rigore concettuale. Non a caso, a quasi vent'anni di distanza dalla sua pubblicazione, quest'opera risulta allo stesso tempo persistentemente attuale e marcatamente inattuale. L'attualità è dovuta all'ampiezza della riflessione di Massa, che esamina i problemi e decostruisce le diverse posizioni del dibattito sulla scuola sviscerandone le implicazioni fondanti, spingendo l'interrogazione fino a mettere in discussione le ovvietà inavvertite, i pregiudizi che occludono l'accesso al terreno di discussione più fertile e vitale. Proprio questa attitudine genuinamente filosofica rende il gesto di Massa altrettanto inattuale, apparentemente poco in grado di interagire con la concretezza dei problemi e con il livello dei temi dibattuti dalla politica e dai media. Eppure il testo, composto da una serie di brevi e dense riflessioni prive di note, si presenta come un “esercizio di pensiero” necessario per intraprendere una trasformazione concreta e rigenerante della scuola.
Riccardo Massa è stato un pedagogista capace di interrogare i problemi educativi con la radicalità propria di uno sguardo filosofico. Il suo libro Cambiare la scuola. Educare o istruire? (Laterza, Roma-Bari 1997) è la testimonianza esemplare di un'attitudine di ricerca in grado di tenere insieme la consapevolezza empirica e vissuta dei sommovimenti di un ambiente – quello scolastico – con la profondità e il rigore concettuale. Non a caso, a quasi vent'anni di distanza dalla sua pubblicazione, quest'opera risulta allo stesso tempo persistentemente attuale e marcatamente inattuale. L'attualità è dovuta all'ampiezza della riflessione di Massa, che esamina i problemi e decostruisce le diverse posizioni del dibattito sulla scuola sviscerandone le implicazioni fondanti, spingendo l'interrogazione fino a mettere in discussione le ovvietà inavvertite, i pregiudizi che occludono l'accesso al terreno di discussione più fertile e vitale. Proprio questa attitudine genuinamente filosofica rende il gesto di Massa altrettanto inattuale, apparentemente poco in grado di interagire con la concretezza dei problemi e con il livello dei temi dibattuti dalla politica e dai media. Eppure il testo, composto da una serie di brevi e dense riflessioni prive di note, si presenta come un “esercizio di pensiero” necessario per intraprendere una trasformazione concreta e rigenerante della scuola.L'esperienza della crisi dell'istituzione scolastica è talmente radicale da rendere necessaria l'apertura di uno spazio di pensiero che vada oltre i discorsi politici e istituzionali, fermi alla superficie del problema. Per intraprendere questo esercizio critico e ricostruttivo occorre sgomberare il campo da una falsa dicotomia, che ha contribuito a impigrire e fossilizzare il dibattito: quella tra educazione e istruzione. Il gioco che vuole contrapporre istruzione e educazione favorisce una a discapito dell'altra: è possibile evidenziare la capacità propria dell'educazione di prendere in considerazione i bisogni dei soggetti che vivono la scuola, la dimensione affettiva e relazionale, a fronte dell'aridità e del nozionismo dell'istruzione; oppure rivendicare la portata emancipatrice dell'istruzione in quanto trasmissione laica di competenze e abilità, di contro al dogmatismo, al moralismo e ai rischi di mistificazione ideologica propri dell'educazione. Tuttavia questa contrapposizione appare in gran parte infondata: l'istruzione, quando si presenta come un mito di emancipazione, ha già in sé un orientamento valoriale, e quindi educativo. D'altro canto la densità concettuale di cui l'educazione è portatrice viene perduta nel concepirla come il tentativo di trasmettere valori, a cui si oppone l'istruzione come pratica che insegna conoscenze e competenze.
Massa riconduce l'etimologia di “educare” a educare, che significa nutrire, allevare. Questa derivazione può essere incrociata con la più nota da educere, che vuol dire “tirare fuori”, connotando così l'educazione come un prendersi cura che conduce via, porta oltre. L'avere cura, l'allevare, comporta uno strappare dal luogo protetto dell'allevamento per condurre all'aperto, nella radura. Educere può così essere accostato a seducere, nel senso dello sviare, del portare fuori strada. La ricchezza semantica insita nell'educazione lascia intravedere la possibilità di un'accezione del termine scevra da dogmatismi, indica il gesto di chi, per permettere la costruzione della soggettività, lascia fare esperienza del vuoto.
I tentativi di pensare e cambiare la scuola risultano inadeguati finché si cristallizzano su posizioni

unilaterali e semplicistiche: il cognitivismo assoluto cieco nei confronti della dimensione affettiva, erotica e desiderante dei soggetti che abitano la scuola; il didattismo docimologico che riduce l'insegnamento a una pratica misurabile sul piano dei profitti e dei risultati; il contenutismo che vede il problema in ciò che viene insegnato; lo scolasticismo che propone la scolarizzazione della vita, e l'opposta illusione della descolarizzazione, che crede di poter liberare l'umanità dal giogo oppressivo dell'istituzione scolastica senza immaginare alternative praticabili, e così via. Occorre piuttosto partire dai sintomi di sofferenza e frustrazione che accompagnano l'esperienza scolastica e cercare di risalire allo strato rimosso che essi indicano. Per comprendere le patologie della scuola non basta soffermarsi su uno degli aspetti che la caratterizzano, bisogna tentare di focalizzare la scuola come un dispositivo strutturale, un campo esperienziale.Massa propone una vera e propria fenomenologia della scuola intesa come una porzione non del tutto problematizzata di mondo-della-vita. Ci sono dimensione residuali di essa che non vengono poste al centro dell'attenzione e che invece dovrebbero essere il punto di partenza di analisi e proposte riformatrici volte al cuore del problema. Una dimensione residuale è il tessuto microsociale in cui si struttura l'esperienza scolastica, a cui si collega la dimensione affettiva e relazionale. Inoltre, la materialità propria della vita scolastica nella sua quotidianità, fatta di routine e processi di socializzazione per lo più non tematizzati. C'è poi la dimensione etnografica: la subcultura interna alla scuola come a priori concreto di qualunque apprendimento possibile.

Cogliere queste dimensioni consente di mettere a fuoco dei nuclei irrisolti del dibattito sulla scuola: come ridefinire il mandato istituzionale della scuola, i suoi rapporti con il lavoro e con l'apprendistato sociale? Come ripensare il ruolo formativo della scuola di fronte alla crisi della famiglia? Qual è il suo ruolo di rielaborazione e mediazione del sapere in un contesto in cui le fonti che producono conoscenza sono molteplici, diffuse e per lo più esterne alle istituzioni universitarie? Quale codice comunicativo essa deve veicolare? Quale setting pedagogico è funzionale per la riuscita dell'esperienza formativa, e quindi quale struttura organizzativa? Si tratta di un livello problematico che per lo più soggiace a quello comunemente affrontato nel dibattito pubblico sulla crisi e necessità di riforma del sistema scolastico. Eppure, solo affrontando le implicazioni più profonde che strutturano la scuola è possibile proporre un cambiamento all'altezza delle sfide che emergono dall'esperienza educativa in tutte le sue sfumature.
Qualsiasi tecnologia didattica che pretende di istruire efficacemente e programmare il comportamento degli insegnanti risulta monca e velleitaria se pensata al di fuori del contesto materiale e organizzativo che struttura la vita scolastica, se è cieca di fronte alle componenti affettive e relazionali dell'esperienza educativa. La sfida è riuscire a strutturare un campo autonomo della scuola rispetto al resto della vita sociale, che la renda uno spazio protetto di transizione e mediazione, ma che allo stesso tempo consenta, all'interno di quello spazio, di lasciar fare esperienza diretta della realtà e della vita. La scuola non deve ignorare né fare esperienza diretta dei codici simbolici della verità, del potere, dell'amore e del denaro; deve assumerli e rielaborarli attraverso una curvatura pedagogica. Un setting pedagogico in grado di aprire esperienze educative, di apertura del mondo, non può più essere legato a un dispositivo disciplinare ormai inceppato, legato al voto: deve passare da un principio di prestazione a uno di espressione, azione e creazione; deve riappropriarsi della specificità della forma di vita scolastica come spazio capace di accendere il desiderio, di costruire soggetti, di educare anime e istruire menti. É la realtà delle cose – la trasformazione dei codici e dei linguaggi, la mutazione delle forme di esperienza – che richiede un oltrepassamento della forma-scuola così come la conosciamo. La ricerca di Riccardo Massa indica alcuni degli orizzonti di pensiero che è necessario imparare a frequentare per poter intraprendere questo percorso.
di Luca Pagano