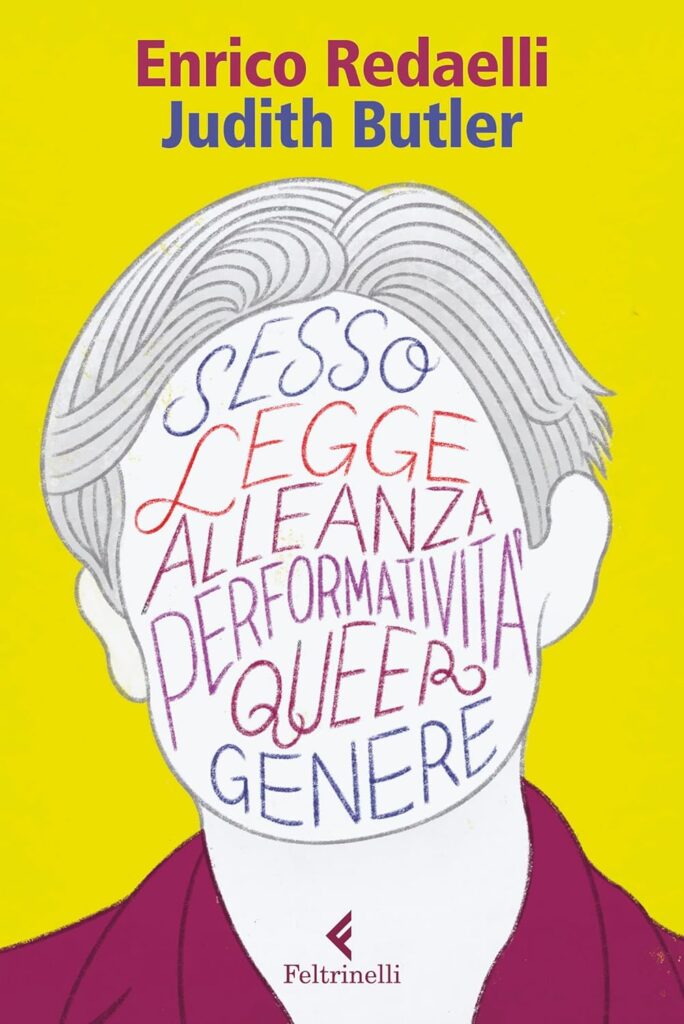-
-
Judith Butler: il sesso e la legge
Recensioni / Novembre 2023Complice la loro denominazione, nell’ambito degli studi di genere sembra che a farla da protagonista sia il genere. Tuttavia, negli ultimi dieci anni il dibattito filosofico su questo tema ha portato alla ribalta il sesso (Žižek, 2012; Zupančič, 2017). In risposta a filosofi e filosofe, in primis Michel Foucault, che sottolineavano la natura culturale del sesso in un’ottica costruttivista, gli studi recenti – tra i quali spicca quello di Lorenzo Bernini in Italia (Bernini, 2019) – rimarcano come non sia possibile liquidare la questione del sesso e della pulsione, la cui materialità non si lascia dissolvere sul piano culturale. A partire da Zupančič, quella sessuale diventa la questione cruciale della filosofia, al crocevia tra ontologia ed epistemologia. Lo studio di Enrico Redaelli (2023) Judith Butler. Il sesso e la legge. si inserisce in questo dibattito, sottolineando la posta in gioco ontologica della domanda sulla differenza sessuale. Al fondo della domanda circa cosa sia e cosa determini la differenza sessuale si cela una domanda alla quale nessun filosofo può sottrarsi: che cos’è il reale? Rispetto agli studi esistenti, il lavoro di Redaelli presenta un aspetto di notevole originalità: se infatti gli studi precedenti hanno la tendenza a trattare la questione di sesso e legge, natura e cultura, o sesso e genere, in termini dialettici, ossia come due poli coimplicantesi di una stessa relazione, la prospettiva di Redaelli supera questa visione, per dirigersi, sulla scorta di Butler, verso un’interpretazione performativa del reale.
L’interrogativo circa la natura della realtà funge da fil rouge nell’analisi di Redaelli, che si divide a mio avviso in due parti. La prima parte comprende i primi tre capitoli, mentre la seconda gli ultimi due. La questione posta nella prima parte potrebbe essere riassunta dalla perifrasi “i corpi contano, ma i conti non tornano” (p. 26), con la quale Redaelli trasla liberamente il titolo del libro di Butler Bodies that Matter (Butler, 1993). Che nella differenza sessuale il problema siano i corpi pare essere abbastanza chiaro, ma perché i conti non dovrebbero tornare? Secondo Redaelli, non è possibile far tornare i conti a causa della “barra”. Si tratta della barra che distingue, e quindi definisce, uomo/donna, istituendo la differenza sessuale. La presenza della barra fa sì che non sia possibile semplicemente, in maniera ontologicamente ingenua, definire cosa sia la differenza sessuale in sé e per sé, “al di là” del contesto culturale in cui i sessi sono impigliati; come se ci fosse un “al di là” che sta fuori della differenza tra natura/cultura.
Questa riflessione, debitrice alla dialettica hegeliana, non è affatto tuttavia l’approdo ultimo del discorso di Butler, secondo Redaelli. Se i corpi contano, è perché non solo la cultura definisce la natura, ma anche il contrario. In una certa misura, la cultura è la natura dell’essere umano, e la materialità dei corpi si impone nonostante tutto, plasmando i processi culturali (p. 38). Emerge qui un tratto distintivo dello stile dell’autore, che definirei “metabolico”, con riguardo alla metabolè di hegeliana memoria: Redaelli è maestro nel mostrare come gli opposti si rovescino di continuo l’uno nell’altro. Come scrive Redaelli, “natura e cultura sono effetti locali della barra, che funzionano l’uno in relazione all’altro entro un campo limitato. Non appena si allarga il campo, per abbracciarlo nella sua totalità, ecco che un polo si rovescia nell’altro e la loro distinzione si sbriciola” (p. 40). Dai due punti della relazione dialettica tra natura/cultura, sesso/genere, ogni polo è completamente tradotto nell’altro. Da un lato, tutto è cultura; il che significa anche che tutto è natura. In relazione al pensiero di Butler, ciò implica che non è possibile appiattire la sua analisi su un mero – e politicamente più accettabile – costruttivismo, secondo il quale “tutto ciò che definiamo naturale è in realtà una costruzione culturale” (p. 25). Il risultato più probabile di tale visione sarebbe quello di ignorare il problema della differenza sessuale, mettendo a tacere la domanda profonda circa la natura del reale ad essa sottesa. La questione è invece più spinosa, come mostra Redaelli, facendo notare che “se il sesso è già da sempre genere, il genere è già da sempre sesso” (p. 39). Per esempio, le differenze nel modo di vestirsi, o la scelta di quale bagno usare, non sono mai riportabili al “mero genere”, ma sono forme in cui la differenza sessuale si esplica: “uno dei modi in cui il sesso si declina, una delle sue concrete manifestazioni” (p. 39).
Il continuo rovesciamento metabolico tra sesso e genere, natura e cultura porta verso la conclusione a cui Redaelli giunge nella prima parte; conclusione che non ha niente di addomesticabile. Per riprendere il passaggio finale del terzo capitolo del libro di Redaelli, questa prima parte del libro porta a comprendere che “non è (semplicemente) la differenza sessuale a essere queer. È la realtà che è queer” (p. 95). Innanzitutto la natura queer del reale è ascrivibile all’effetto della barra che delinea la differenza sessuale. Il gesto, il taglio che istituisce la differenza sessuale non è riducibile a questa stessa distinzione. La barra, o in altri termini l’evento della differenza sessuale, non è tematizzabile a partire da questa stessa distinzione; altrimenti non potrebbe istituirla. Di conseguenza, questo evento, con la sua inafferrabilità, introduce un che di spaesante, o di perturbante nell’orizzonte dell’umano; una distorsione costitutiva, spiega Redaelli, tipica dell’umano.
L’agire umano pare così essere abitato in maniera costitutiva da un vuoto, uno squilibrio che non fa tornare i conti. Come superare tale impasse? Per illustrare tale passaggio, Redaelli riprende il dibattito tra Butler e Žižek (Butler, Laclau, Žižek, 2000), ove quest’ultimo sostiene che il gesto istituente le forme storiche della differenza sessuale sia astorico, mentre invece la prima sostiene che sia anch’esso storico (p. 75). La barra, secondo Žižek, è il limite o l’orlo di ogni differenza, di ogni processo di soggettivazione (p. 76). In altri termini, ciò che segna la differenza tra uomo e donna è la condizione di possibilità di questa stessa differenza, un vuoto di possibilità che può essere riempito di volta in volta in forme storicamente determinate. Nella prospettiva di Žižek la differenza è queer, “è costitutivamente eccentrica: è l’elemento bizzarro, inallocabile nella struttura perché è lo strutturarsi stesso della struttura” (p. 84). Tuttavia con Butler, come suggerisce Redaelli, si abbandonano questi orizzonti, ancora troppo rassicuranti per chi è versato nella tradizione filosofica del secolo scorso. Butler invita ad assumere uno sguardo diverso, “diplopico” (p. 89), attento a guardare, al contempo, le forme e il retroterra da cui emergono, i differenti soggetti e la barra che li differenzia. “Tutto il pensiero di Butler, in fondo”, scrive Redaelli, “invita a questo particolare sguardo, a osservare cioè sotto la trama delle cose e delle loro relazioni dialettiche quella dimensione anonima di interdipendenza e interrelazionalità viscosa da cui soggetti e oggetti emergono come entità distinte” (p. 87). È per questo che è non solo la differenza, ma la realtà stessa a essere queer. La differenza sta al fondo del reale, è il suo agitarsi costante e il prendere di continuo forme diverse, ove ogni elemento determinato fa eco a questo oceano infinito, nel quale la barra si dissolve (p. 91).
Una volta riportata la differenza sessuale al differenziarsi stesso della realtà, al continuo, magmatico emergere di forme determinate, potremmo ancora dire che i conti non tornano? A dire il vero non si capisce più di quali “conti” si tratti. E difatti è qui che comincia la seconda parte del libro di Redaelli. Tale passaggio coincide con l’inizio del quarto capitolo, che sembra introdurre una soluzione di continuità rispetto al precedente, ponendo il problema della natura scandalosa del sesso. Ciononostante, la questione è in ultima analisi la medesima, ossia quella del vuoto che caratterizza ogni attività umana. Qui Redaelli prende in esame varie istituzioni, oggetti e pratiche inerenti all’ambito del sesso e della legge – che dall’alba dei tempi sono connessi – per evidenziare come in ognuna di esse vi sia una sorta di vuoto, che si tenta in tutti i modi di celare. Un esempio paradigmatico è il velo, o in senso moderno i vestiti, adibito a coprire l’oggetto del desiderio. Dapprima Redaelli chiede se il velo sia usato per coprire qualcosa, o piuttosto se non sia atto a celare la mancanza di qualcosa. Pensando in termini dialettici, o trascendentali, saremmo tentati di interpretare questo vuoto come il gesto istituente, come stato di eccezione che serve per fondare la legge (il parricidio che fonda il tabù dell’incesto, il ratto delle Sabine che istituisce la nuova comunità) (pp. 98-100); salvo poi scoprire che questa eccezione non c’è mai stata, e che la legge è senza fondamento (pp. 100-106). Se il vuoto e il pieno di cui sono composti legge e sesso (legge/trasgressione, velamento/disvelamento) sono due poli in relazione dialettica, essi possono essere guardati sia dal lato del pieno sia dal lato del vuoto, ma mutare il punto di vista non scioglie la relazione, né tantomeno il problema dello squilibrio insito nel reale. È qui che Redaelli introduce la questione fondamentale, che porta alla conclusione del libro: e se lo squilibrio non stesse nel reale, ma nell’occhio di chi osserva il reale?
Si comprende così che la chiave di volta della seconda parte è la relazione tra vita e sapere. In tal modo Redaelli mostra il suo debito – che sarebbe invero riscontrabile in vari altri luoghi del libro – verso i lavori dell’associazione Mechrí – Laboratorio di filosofia e cultura, a cui l’autore partecipa come membro del comitato scientifico (si veda Cambria, 2018). La realtà è abitata da uno squilibrio solo per chi l’analizza con gli occhi del sapere, per chi la scompone in oggetti e immagini statiche; indizi di un fare che, una volta separati, appaiono misteriosi. Redaelli espone magistralmente questo problema con l’esempio, che non a caso richiama la Prefazione della Fenomenologia dello Spirito, dello sviluppo di una pianta: come scrive Redaelli, “se scomponiamo fotograficamente il movimento di un bocciolo che diviene fiore e poi frutto, ci ritroviamo con tre istantanee fra loro contraddittorie. Eppure la vita della pianta si svolge tranquillamente, senza problemi, ignara delle fotografie e delle loro contraddizioni” (p. 106). L’oggetto, il velo e il soggetto paiono essere altrettanto misteriosi e manchevoli se presi separatamente. Che cosa manca? La risposta secca di Redaelli, che parafrasa così Butler, è: niente. L’impressione che ci sia un vuoto costitutivo al fondo di legge e sesso, e in generale di ogni agire umano, dipende dalla distorsione dello sguardo del sapere, che analizza e separa laddove vi è un tutt’uno. “La mancanza, la casella vuota”, spiega Redaelli, “non è altro che movimento” (p. 108).
Se concepiamo il mondo come una continua performance, mettendoci dal lato della vita, e non del sapere, non manca proprio nulla. Il punto finale a cui giunge la riflessione di Redaelli è la natura performativa del reale, teorizzata da Butler anche in seguito alle sue riflessioni sul giovane Hegel (Butler, 2012). Con questo ultimo passaggio, Redaelli mostra indirettamente che Butler è ben lungi dal congedare la dialettica hegeliana. Butler – e con lei Redaelli – sembra piuttosto rifiutare una certa interpretazione della dialettica, che la riduce a definizione mutuale dei due poli. Vedere il lato performativo del reale significa invece abbracciare la visione della dialettica come ritmo, movimento continuo e simultaneità (p. 136). Questa prospettiva insegna che la realtà può appare contraddittoria quando la fermiamo in un’immagine, in un oggetto separato, in seguito al desiderio di conoscere. Se invece la guardiamo nel suo continuo movimento, non è mancante di nulla. Nei passaggi conclusivi del libro, Redaelli spiega infatti che “il punto cieco c’è solo per chi ha occhi per guardare. Non per chi è intento a godere. Non per chi è intento a danzare” (p. 163).In questo modo Redaelli mostra di essere pienamente all’altezza degli studi recenti sul tema, nella misura in cui nel suo libro nella questione della differenza sessuale ne va della realtà stessa, in particolare del rapporto tra vita e conoscenza. Capiamo così come la dimensione performativa non sia tipica solo del sesso, ma della vita stessa. Il problema sussiste quando vogliamo conoscere, analizzare il movimento incessante della vita, la quale non pone nessun problema quando viviamo e dunque neanche allorché esercitiamo il sapere. Sorge allora un interrogativo: qual è, se vi è, la specificità del sesso in questo orizzonte? Secondo Redaelli, il sesso occupa in qualche modo un ruolo di rilievo in quanto squisitamente scandaloso, cioè atto a esibire questo cortocircuito del sapere, che costitutivamente non può dire il ritmo della vita senza bloccarlo. Eppure, questo cortocircuito appare sempre quando vediamo che il sapere non è in grado di dire la vita senza analizzarla, e dunque immobilizzarla in un riflesso inerte, in virtù del suo stesso funzionamento. L’analisi di Redaelli ha esteso il problema della differenza sessuale fino a renderlo coestensivo all’intera realtà, nella sua articolazione tra vita e sapere; sicché l’esito più importante del suo libro potrebbe consistere nel porre la questione al di là del sesso stesso, negando ad esso ogni specificità e chiamando in causa piuttosto la pulsione, o quel pulsare tipico del ritmo che anima tanto la vita quanto il sapere.
Eleonora Buono
Riferimenti
Bernini, Lorenzo (2019). Il sessuale politico. Freud con Marx, Fanon, Foucault. Pisa: ETS.
Butler, Judith (2012). To Sense What Is Living in the Other: Hegel’s Early Love/Fühlen, Was im anderen lebendig ist: Hegels frühe Liebe. Ostfildern: Hatje Cants Verlag.
Butler, Judith (1993). Bodies that Matter. On the Discursive Limits of “Sex”. London & New York: Routledge.
Butler, Judith, Laclau, Ernesto, Žižek, Slavoj (2000). Contingency, Hegemony, Universality: Dialogues on the Left. London: Verso.
Cambria, Florinda (ed.) (2018). Vita, conoscenza, Milano: Jaca Book.
Redaelli, Enrico (2023). Judith Butler. Il sesso e la legge. Milano: Feltrinelli.
Žižek, Slavoj (2018). Sex and the Failed Absolute. London: Bloomsbury.
Žižek, Slavoj (2012). Less Than Nothing: Hegel and the Shadow of Dialectical Materialism. London: Verso.
Zupančič, Alenka (2017). What Is Sex?. Cambridge (MA): MIT Press.
-
I mostri di Donna Haraway
Recensioni / Gennaio 2020 Donna Haraway continua a popolare di mostri il mercato editoriale italiano. Dopo la nuova edizione Feltrinelli del Manifesto Cyborg e la recente traduzione di Cthulucene per NERO Editions, DeriveApprodi ha tradotto e pubblicato Le promesse dei mostri. Il testo originale del 1992, apparso sulla rivista Cultural Studies, è accompagnato da un’introduzione di Angela Balzano, la curatrice e traduttrice del volume, e da una postfazione di Antonia Anna Ferrante. In che modo un testo del 1992 può continuare a interpellare il nostro presente? Anzitutto, il testo contribuisce a una generale riconfigurazione nel campo delle scienze umane e sociali: entrano con lentezza nel dibattito alcuni snodi concettuali cruciali nel nascente ambito disciplinare delle environmental humanities; basti pensare a Essere di questa terra, una recente curatela di articoli di Bruno Latour, le cui tesi sono ampiamente discusse in Le promesse dei mostri. Spostandoci dall’editoria italiana al dibattito internazionale, è evidente che l’elaborazione di nuovi paradigmi ecologici stia dando un impulso rilevante alle ricerche sul concetto di natura nelle scienze umane e sociali, che si dimostrano capaci di siglare alleanze transdisciplinari feconde con le scienze dure. Questo rinnovato interesse per la natura reagisce insieme a dei mutamenti epistemologici - ecocriticismo, studi su scienza e tecnologia, epistemologia femminista, nuovo materialismo, etnografia multispecie, studi biopolitici su razza e genere - e a tempi di catastrofi quotidiane, che colpiscono comunità e territori a velocità variabili. È in questo paesaggio teoretico che va collocato questo testo della Haraway.
Donna Haraway continua a popolare di mostri il mercato editoriale italiano. Dopo la nuova edizione Feltrinelli del Manifesto Cyborg e la recente traduzione di Cthulucene per NERO Editions, DeriveApprodi ha tradotto e pubblicato Le promesse dei mostri. Il testo originale del 1992, apparso sulla rivista Cultural Studies, è accompagnato da un’introduzione di Angela Balzano, la curatrice e traduttrice del volume, e da una postfazione di Antonia Anna Ferrante. In che modo un testo del 1992 può continuare a interpellare il nostro presente? Anzitutto, il testo contribuisce a una generale riconfigurazione nel campo delle scienze umane e sociali: entrano con lentezza nel dibattito alcuni snodi concettuali cruciali nel nascente ambito disciplinare delle environmental humanities; basti pensare a Essere di questa terra, una recente curatela di articoli di Bruno Latour, le cui tesi sono ampiamente discusse in Le promesse dei mostri. Spostandoci dall’editoria italiana al dibattito internazionale, è evidente che l’elaborazione di nuovi paradigmi ecologici stia dando un impulso rilevante alle ricerche sul concetto di natura nelle scienze umane e sociali, che si dimostrano capaci di siglare alleanze transdisciplinari feconde con le scienze dure. Questo rinnovato interesse per la natura reagisce insieme a dei mutamenti epistemologici - ecocriticismo, studi su scienza e tecnologia, epistemologia femminista, nuovo materialismo, etnografia multispecie, studi biopolitici su razza e genere - e a tempi di catastrofi quotidiane, che colpiscono comunità e territori a velocità variabili. È in questo paesaggio teoretico che va collocato questo testo della Haraway.Le promesse dei mostri abbozza una mappa geografica e mentale di conflitti locali e globali relativi alla natura, cercando di «rendere più ibridi i Science and Technologies Studies, contaminandoli con i Cultural, i Gender e i Postcolonial Studies» (p. 24). Questo tentativo di contaminazione si nutre della convinzione che sia necessario scandagliare i contesti culturali e sociali di sviluppo delle scienze, e le relazioni di potere alle quali saperi e pratiche scientifiche hanno partecipato: in altre parole, si tratta di porre in evidenza la politicità di qualsiasi epistemologia. Cultura, genere, razza e colonialità offrono quindi la possibilità di interrogare le scienze come prodotti sociali che emergono dalla storia della modernità, con il suo portato criminale e traumatico, ma anche con le sue possibilità di ricomposizione. Questa cartografia viene suddivisa in quattro quadranti che insieme compongono un “Quadrato Cyborg”, ispirato al quadrato semiotico di Greimas: A. Spazio Reale: Terra; B: L’Altro Spazio o l’Extraterrestre; Non-B: Lo spazio interno: il corpo biomedico; e infine Non-A: Lo Spazio Virtuale: Fantascienza.
Questo schema può fornire ancora oggi alcuni riferimenti chiave nel modo in cui le scienze umane e sociali possono parlare di natura secondo almeno tre prospettive: una ontologica, una epistemologica e una politica. Tuttavia, questi tre sguardi non possono essere separati: la Haraway li snoda e annoda costantemente esplorandone le geometrie di rapporto, proprio come nel gioco del ripiglino, una delle figure-guida Cthulucene. Il nome con cui la Haraway chiama il proprio approccio, cioè l’artefattualismo dinamico, ci fornisce alcune note essenziali rispetto a questo groviglio di traiettorie. Secondo l’artefattualismo dinamico, sia le posizioni realiste sia le tesi postmoderne sul mondo naturale dicono qualcosa di vero ma parziale: la natura non sarebbe solo un insieme di dati bruti e di oggetti che risiedono “fuori da noi”, ma neppure un mero avvicendarsi di labirinti di segni senza via d’uscita verso la realtà, di trompe l’oeil semiotici nei quali gli enti sono simbolicamente sublimati senza rimedio. La Haraway è certamente disposta a sostenere sia che gli agenti naturali resistano e non si riducano alle sole pratiche di rappresentazione umane, sia che la natura sia costruita. Occorre però domandarsi chi costruisca la natura, quell’oggetto concettuale impossibile, femminile, coloniale, passivo che tuttavia, secondo la Haraway, non possiamo non desiderare. È nella nozione di sympoiesi che gli sguardi si possono annodare: se il limite del realismo moderno – nel senso in cui Bruno Latour intende la modernità – è di scommettere eccessivamente sulla capacità scopica di un osservatore disincarnato, di un occhio assoluto capace di elevarsi al di sopra del mondo, e se il postmoderno radicalizza questo atteggiamento scomponendo l’oggetto scientifico in una infinita mise en abyme di rimandi sui quali lo sguardo non può mai soggiornare stabilmente, allora l’artefattualismo dinamico tempera entrambe le posizioni, sostenendo che la natura è co-costruita: gli enti naturali e gli oggetti scientifici sono fatti e costruiti discorsivamente da un groviglio di attori umani e non-umani, che collaborano alla costruzione della natura come luogo comune. In altre parole, attrici e attori non si esauriscono in "noi" (p. 46).

Una simile prospettiva sulla natura richiede dunque un nuovo modo di concepire le scienze. In La nuova alleanza, Ilya Prigogine e Isabelle Stengers sostenevano che la scienza fosse un dialogo sperimentale fra l’uomo e la natura, e non – come Koyrè – il monologo che gli umani recitano usando la natura come palcoscenico. Per la Haraway entrambe le metafore sono insufficienti. Oltre il monologo e il dialogo, Le promesse dei mostri propone una scienza materialmente compromessa con il mondo che studia, appassionata partecipante a un chiassoso consesso di agenti umani e non-umani. Ogni scienziato ha dunque a che fare con dei collettivi ibridi, che solo una complessa operazione di purificazione consente di stabilizzare come modelli e dati. Queste considerazioni sono debitrici della lezione di Bruno Latour: citandolo in La vita delle piante Emanuele Coccia ci rammenta che le macchine usate da scienziate e scienziati sono “protesi cosmiche” della sua stessa sensibilità. Esse intensificano e amplificano la capacità di percepire consentendo la costruzione di nuovi modi di relazione con gli attori che popolano il mondo. Natura e Società sono dunque risultati storici del movimento degli attanti, schiume prodotte da onde di azione. Tuttavia, nella tesi di Latour, le coppie oppositive – natura-cultura, soggetto-oggetto, ambiente-tecnica – e i binarismi non scompaiono, ma sono presi in un pozzo gravitazionale che ne fa evaporare i tratti trascendentali. Non ci sono punti di osservazione assicurati una volta per tutte, ma attanti imprevisti e favolosi, nuove storie e relazioni effettuali che fanno e disfano mondi – dato che, come ci ricorda Katie King, le epistemologie sono storie che i saperi raccontano.
Sulle specifiche delle relazioni che gli scienziati intessono con i non-umani vanno però fatte delle importanti precisazioni, che pongono in attrito le tesi della Haraway e di Latour. Se Latour reputa che gli attanti che costellano le sue reti siano anzitutto frutto di un’operazione semiotica, e che dunque agiscano in quanto sono rappresentati, la Haraway invece sostiene che la natura non sia solo un network simbolico, per almeno due ragioni: in primo luogo, gli agenti non-umani non lo sono solo in senso semiotico ma anche in senso pienamente materiale e dinamico; in secondo luogo, Latour sembra voler parlamentarizzare e testualizzare quella che in fondo è un’assemblea disordinata senza principi di ordine netti e dati una volta per tutte: l’azione dei non-umani è invece “negativa”, imprevedibile, ferina, selvatica. Pone in questione obiettività, controllo, disposizioni, ordini e gerarchie. Queste critiche potrebbero essere compresse in un mutamento di lessico: se Latour insiste sulla rappresentazione, la Haraway preme sull’articolazione. Secondo la Haraway «la rappresentazione si fonda sul possesso di una risorsa passiva, l’oggetto silenzioso, l’attante ridotto all’osso» (p. 91): guardare le scienze considerando solo la prospettiva rappresentativa significa esporsi al rischio di confondere nomi e cose, di ripetere l’antropocentrismo adamitico della nominazione originaria, per cui l’ambiente acquisterebbe senso solo al tocco dell’uomo. Inoltre, per lo sguardo che rappresenta la distanza dall’oggetto rappresentato è una virtù: l’altro non è mai ingaggiato nella sua presenza viva, ma è tutelato infinitamente, testualizzato, trattato come un «docile elettore» (p. 91) di cui sono sufficienti le tracce registrate da chi lo guarda. Le relazioni in questo caso sono asettiche, si danno solo sotto la vigenza di una separazione sterile. L’articolazione invece scommette sulla capacità generativa ed energetica degli attori, sui loro movimenti: gli agenti sono tali in quanto scaturigini di azioni, senso e perché formano collettivi. Inoltre, una volta posta la natura semiotica degli attori fra altre caratteristiche, viene a cadere anche la messa in sicurezza della rappresentazione. Ogni articolazione è quindi al contrario sempre precaria, fallibile, e pertanto richiede attaccamenti forti, cura, manutenzione e coinvolgimenti appassionati. In conclusione, una scienza mostruosa non può porsi come osservatrice trascendentale disincarnata al di sopra della mischia, ma come fonte di responsabilità concreta nei confronti del mondo con il quale scienziate e scienziati hanno a che fare.

Lynn M. Randolph e Donna J. Haraway
CyborgNon c’è quindi più spazio né per la modernità né per la post-modernità: i cyborg e i mostri della Haraway sono figure amoderne, che stanno nel mondo in senso critico ma senza oltrepassarlo verso un esterno che le metta al riparo: di qui, il grande interesse della Haraway per alcune lotte chiamate in causa in Le promesse dei mostri. Nel testo si può richiamare in particolare l’esempio dei Kayapo (p. 94), un gruppo indigeno brasiliano. Messi in pericolo da deforestazione e attività minerarie, i Kayapo fecero un uso massiccio dei mass-media per salvaguardare le proprie terre e per guadagnare potere politico, richiamando l’attenzione della comunità internazionale. L’immagine di Paulinho Paiakan di fronte alle telecamere potrebbe far leggere in senso paradossale la scena, come un cozzo fra un registro estetico “primitivo” – i vestiti tradizionali Kayapo, il richiamo alla tutela di un modo di vivere “autentico” legato indissolubilmente alla foresta pluviale – oppure, secondo la proposta della Haraway, come l’effetto di una nuova articolazione: il collettivo in cui i Kayapo si sono mossi ha avuto l’effetto di una nuova produzione di mondo, fatta di indigeni, scienziati, videocamere, foreste, animali, pubblici vicini e lontani. Si potrebbe leggere questo esempio insieme ad altri testi recenti che approfondiscono le cosmopolitiche amazzoniche, come La caduta del cielo di Davi Kopenawa e Bruce Albert; Esiste un mondo a venire? di Eduardo Viveiros de Castro e Deborah Danowski; o Earth Beings di Marisol de la Cadena.
Sembra ovvio che un testo che si muove di figura in figura si concluda con un’immagine: Cyborg, il dipinto realizzato da Lynn Randolph in collaborazione con la Haraway. Una donna indigena è circondata da un paesaggio cosmico, accompagnata da uno spirito animale, con le dita poggiate alla tastiera di un computer. Questa figura chiude il libro materializzando l’implosione dei registri tecnici, testuali, organici, mitici e politici «nel pozzo gravitazionale della scienza in azione» (p. 57) di cui la Haraway non cessa di parlare. Cyborg e mostri dunque promettono alle scienze umane e sociali nuovo alimento, richiedendo però in cambio lo sviluppo di nuove arti dell’attenzione, laddove la cura per gli oggetti di studio diventa un atto politico verso i collettivi in cui si è coinvolti. I mostri della Haraway ci esortano: ibridate i saperi, riannodate il nesso fra scienza e società, tenete i binarismi sotto costante minaccia. In uno slogan, “cyborgs for earthly survival!”.
di Dario Bassani
-
 Nelle sei lezioni che compongono Il senso della possibilità, edito a gennaio per Feltrinelli (2018), Salvatore Veca completa una trilogia di saggi ̶ iniziata nel 1997 con Dell’incertezza e continuata nel 2011 con L’idea di incompletezza ̶ che rappresenta uno dei più complessi itinerari teorici del panorama filosofico italiano degli ultimi vent’anni. Nello specifico, in questo terzo volume, Veca si impegna nella difficile impresa di delineare il senso della nozione di possibilità entro il quadro di un’interpretazione filosofica delle modalità che si dimostri in grado di dar conto della connessione tra l’impiego dei termini modali (attuale, possibile, necessario, contingente) e i nostri atteggiamenti proposizionali ordinari del reputare “come stanno le cose” nel mondo che ci circonda. In altre parole, l’autore muovendo da una prospettiva epistemica prova a far luce sui processi che generano le nostre descrizioni e prescrizioni e, in particolar modo, sulle ragioni del loro trasformarsi nel tempo, imputabili in vario modo ai mutamenti nell’ambito delle teorie e delle pratiche (p. 16).
Nelle sei lezioni che compongono Il senso della possibilità, edito a gennaio per Feltrinelli (2018), Salvatore Veca completa una trilogia di saggi ̶ iniziata nel 1997 con Dell’incertezza e continuata nel 2011 con L’idea di incompletezza ̶ che rappresenta uno dei più complessi itinerari teorici del panorama filosofico italiano degli ultimi vent’anni. Nello specifico, in questo terzo volume, Veca si impegna nella difficile impresa di delineare il senso della nozione di possibilità entro il quadro di un’interpretazione filosofica delle modalità che si dimostri in grado di dar conto della connessione tra l’impiego dei termini modali (attuale, possibile, necessario, contingente) e i nostri atteggiamenti proposizionali ordinari del reputare “come stanno le cose” nel mondo che ci circonda. In altre parole, l’autore muovendo da una prospettiva epistemica prova a far luce sui processi che generano le nostre descrizioni e prescrizioni e, in particolar modo, sulle ragioni del loro trasformarsi nel tempo, imputabili in vario modo ai mutamenti nell’ambito delle teorie e delle pratiche (p. 16).A partire dalle precedenti ricerche sulle nozioni di incertezza e incompletezza, ritenute rispettivamente l’origine della tensione teoretica e il carattere proprio del risultato che ne scaturisce, Veca ci accompagna in un tortuoso itinerario lungo i limiti della pratica filosofica, fino al punto di rottura in cui il necessario diviene contingente e l’inaspettato si manifesta nella forma dello scacco. L’intento però non è soltanto porre l’accento sullo stato di crisi di fiducia o legittimità che investe ciclicamente l’impresa del senso ma di indagarne il ruolo epistemologico. Il ripetersi della crisi, manifestantesi attraverso l’esigenza di impegnarsi in manovre metateoriche, andrebbe interpretato piuttosto come un promemoria antiriduzionistico dovuto a una sorta di inesauribilità propria degli oggetti dell’indagine filosofica. La natura di tali oggetti stimolerebbe l’adozione di una molteplicità di punti di vista in una manovra intellettuale che fa “di necessità virtù” ma che nel contempo rappresenta la possibilità stessa di una relazione conoscitiva con “ciò che c’è”. Si pensi al senso di povertà e angustia che ci assale quando dimostriamo le ragioni irrevocabili di un unico punto di vista rispetto agli enigmi ricorrenti o inaspettati della filosofia, ci ricorda l’autore. Da queste considerazioni preliminari (oggetto della Prima lezione), seguendo una linea che dall’enciclopedia di Husserl porta ai giochi linguistici di Wittgenstein per giungere fino al paradigma della spiegazione di Nozick, Veca torna a chiedersi se «non dovremmo guardare all’attività filosofica come a un ventaglio di stili d’indagine e di scopi e obiettivi di ricerca differenti e alternativi» che, se prendiamo sul serio la storia, ci accorgiamo «persistere quasi nella forma di motivi musicali, nel repertorio o nell’archivio» (pp. 32-33). Ed è proprio qui, all’incrocio tra dimostrazione e spiegazione, che la nozione modale di possibilità diviene elemento cruciale per mettere a fuoco la stretta connessione tra contingenza e verità. Connessione che si manifesta in tre sensi del possibile: 1) reputare qualcosa possibile in senso ampio (epistemico); 2) immaginare e sperimentare mentalmente mondi possibili; 3) pensare se stessi nella durata e dunque nel proprio essere oggetto di trasformazione.
A fornire la struttura portante del saggio è la lunga riflessione rivolta al primo senso del possibile, che si svolge trasversalmente a tutte le sei lezioni ma che diviene protagonista, in particolare, della prima e della quarta. Qui, ripartendo dall’analisi delle categorie e dei giudizi modali svolta da Kant nella Critica della ragione pura, Veca osserva innanzitutto che quando reputiamo possibile, attuale o necessario qualcosa non facciamo riferimento al contenuto proposizionale degli enunciati «quanto piuttosto al tipo di relazione fra l’atteggiamento del soggetto che giudica e l’enunciato corrispondente». Le modalità hanno dunque a che vedere con i nostri atteggiamenti proposizionali, con «la posizione che noi specifichiamo, assegnando epistemicamente modalità alternative agli stessi stati di cose. x è p: possibile, attuale, necessario» (p. 41). Questo genera due problemi per la riflessione kantiana che si rivelano cruciali per l’indagine. In primo luogo, il fatto che le categorie modali risultano distinte nettamente dalle altre categorie in quanto tetiche: esse accompagnano le variazioni del “porre” dando conto del soggetto e non dei modi dell’oggetto. In secondo luogo, diviene centrale la categoria dell’attuale (wirklich) e il giudizio assertorio. Queste assumono un ruolo prioritario poiché chiamano in causa la posizione “in quanto tale” dell’oggetto nello spazio e nel tempo (absolute Setzung) mentre possibilità e necessità di un oggetto indicano soltanto rispettivamente l’accordo con la regola o la posizione secondo una regola. In questo senso l’attuale (nel senso della Wirklichkeit), implicando l’assegnazione di esistenza a qualcosa, «è immerso in un intorno in cui si danno ex ante possibilità e, ex post, necessità» (p. 42). In questo senso, secondo Veca, la priorità dell’attuale così come intesa da Kant indica l’unica via d’accesso per il soggetto al possibile e al necessario e nondimeno implica una gerarchia in cui l’orizzonte di partenza ineludibile è l’esperienza presente. Il problema che tuttavia permane nella prospettiva kantiana è il suo realismo empirico: perché l’esemplificazione esistenziale abbia successo è necessario soddisfare la condizione della percezione nello spazio e nel tempo di un oggetto. Tale componente del sistema kantiano è però inutilmente restrittiva e non tiene conto di una vasta gamma di modi con cui assegniamo esistenza a qualcosa nel nostro linguaggio ordinario. L’autore fa qui riferimento ai recenti sviluppi logici dei temi kantiani elaborati da Hintikka per mostrare come il nostro reputare vero o falso un qualsiasi stato di cose sia implicitamente legato a processi di comparazione tra una serie di stati di cose possibili al fine di classificare quelli che sono compatibili con ciò che viene percepito come stato attuale. Questo significa che quando esploriamo il mondo che ci circonda mettiamo in atto «giochi di ricerca e ritrovamento» sul modello dei giochi linguistici di Wittgenstein che però in questo caso si svolgono tra il ricercatore e la natura. Che qualcosa esista è l’esito riuscito di tale attività che, come sostenuto da Kant, si svolge nell’ambito delle nostre percezioni di oggetti. Gli oggetti nello stato attuale a loro volta vanno intesi come ciò cui possiamo riferirci alla luce dell’esito positivo dei nostri giochi di ricerca e ritrovamento, e fino a prova contraria (pp. 43-44).

Fan Ho - The Lonely Conductor
È bene precisare che l’idea guida di queste analisi non mira a negare l’importanza degli aspetti aletici o deontici al contrario vuole impegnarsi «a connettere l’impiego dei termini modali ai nostri atteggiamenti ordinari e, in particolare, ai nostri atteggiamenti proposizionali, ai nostri giudizi intuitivi di modalità, al nostro reputare» come stanno le cose in una varietà di domini. Questo significa impegnarsi nell’elaborazione di una versione del realismo che integri l’assunzione realistica elementare, secondo cui esiste un mondo là fuori indipendente da noi, e che tenga conto della rilevanza del fatto che all’attuale è possibile riferirsi in più di un modo. Sostenere infatti che qualcosa c’è non è affatto controverso, più complesso è rispondere alla domanda a proposito di ciò che diciamo che vi è (p. 44). In particolare nella quarta lezione, dal titolo Epistemologia, necessità e realismo, Veca si propone di mostrare come la progressiva trasformazione dell’immagine della scienza ̶ dalla visione statica neopositivista della prima metà del secolo all’interesse per la dinamica dell’impresa scientifica dalla seconda metà in avanti ̶ abbia determinato una profonda revisione, non soltanto della nostra concezione del rapporto tra teoria e realtà, ma anche dell’appropriato significato epistemico da attribuire all’operatore modale di necessità (p. 130). La svolta causata nel Circolo di Vienna dal falsificazionismo di Popper prima e dalle Ricerche filosofiche di Wittgenstein dopo ha messo fuoco la dinamica storica che caratterizza il cambiamento concettuale dell’impresa scientifica, ponendo l’accento sulla sua dimensione pragmatica e in un secondo momento sociologica, chiudendo così i conti con le posizioni concernenti la plausibilità di isomorfismo strutturale fra proposizioni e stati di cose. In termini modali, secondo l’autore, questo ha generato l’esigenza di una riformulazione della nozione di necessità che, con le parole di Nozick, da «necessità incondizionata che resiste a qualsiasi controesempio a un tempo dato, connessa alla verità di qualcosa in tutti i mondi possibili» passa a «necessità condizionata […] sino a prova contraria» ovvero fino a che dimostri di resistere a tutti i controesempi concepibili nel tempo (p. 132-133). È facile dunque comprendere come dall’assunzione del carattere condizionato della necessità derivino gravi problemi sul piano ontologico e semantico per quelle prospettive filosofiche che aspirino a prendere sul serio le pratiche scientifiche come vincolo per qualsivoglia programma di ricostruzione concettuale. Qui emerge la tesi di Veca: il riconoscimento del carattere in ogni caso condizionato della necessità ha natura prettamente epistemica quindi «non c’è nulla che ci autorizzi a sostenere che non si diano o non siano definibili relazioni o proprietà necessarie che hanno a che vedere con come sono fatte o stanno le cose» semmai «non sappiamo che farcene di necessità metafisiche» (p. 136). Anche se la necessità dipende dalla serie di circostanze in cui quella relazione è inserita non significa che non sia per noi uno strumento efficace di accesso al mondo. Proprio come avviene per i designatori rigidi di Kripke quando definiamo qualcosa come necessario facciamo riferimento a un oggetto la cui interpretazione riteniamo stabile a un tempo dato e che lo definisce entro un qualche ordine o una qualche ontologia formale. Riconosciamo in esso una certa invarianza rispetto ad almeno alcuni gruppi di trasformazioni. Veca definisce questo tipo di oggetti saturi rispetto all’interpretazione, gli oggetti insaturi sono invece quegli oggetti per cui è disponibile una varietà di interpretazioni divergenti. Ora gli oggetti insaturi sono connessi in qualsivoglia spazio concettuale a oggetti saturi che svolgono il ruolo di limiti per la loro interpretazione, secondo un principio olistico della connessione delle nostre credenze (p. 139). Questo non significa che gli oggetti saturi siano speciali, come le necessità metafisiche: più semplicemente assumono un rilievo particolare a un tempo dato poiché accade che nel loro caso abbiamo una singola interpretazione a fissarne il riferimento. Come per i designatori rigidi, una volta fissato il riferimento «si è liberi di variare in modo puramente combinatorio le proprietà dell’oggetto designato, semplicemente considerandolo come al centro di un insieme di mondi possibili che ruotano intorno ad esso» (p. 143). In tal modo saremo in grado di pensare una varietà di mondi possibili ma tale libertà sarà limitata dalle proprietà essenziali dell’oggetto in quanto saturo. Siamo qui al confine tra epistemico e aletico ed è per questa ragione che «è sensato pensare un mondo possibile in cui Cesare non passa il Rubicone, mentre appare irragionevole pensare un mondo possibile in cui Cesare è un coccodrillo» (p. 143). L’attuale teoria scientifica sarebbe dunque il riferimento iniziale che stabilisce ciò che è saturo fino a prova contraria e in questo modo verrebbe meno la cogenza della celebre distinzione fregeana tra Sinn e Bedeutung: «se il senso di qualcosa attiene al modo con cui ci viene dato l’accesso al riferimento a qualcosa, questo ha luogo entro il dominio epistemico che è certo distinto ma non indipendente dal dominio aletico che ospita solo il riferimento a oggetti. Accettiamo il significato come riferimento, ma non rinunciamo dal punto di vista epistemico alla prospettiva del senso inteso come una tra le possibili vie del riferimento» (p. 145).
Veca giunge a proporre una forma di realismo scientifico dallo sfondo modale fondato sull’equilibrio riflessivo tra l’intuizione empiristica rappresentata dal riferimento fisso, cui pertiene il carattere aletico del significato, e l’intuizione costruttivista rappresentata dalle modalità epistemiche, che garantiscono la possibilità di definire differenti descrizioni nel tempo del medesimo oggetto. La varietà delle vie del riferimento coincide con la possibilità di essere aperti al mondo (con McDowell) nel senso della doppia esigenza di conservare un attrito con esso, in quanto limite per le nostre ragioni, e al contempo di mantenere una certa distanza al fine di rendere possibile quel gioco di ricerca e ritrovamento con un cui miriamo a descrivere la realtà. Tuttavia, come avverte Putnam, il mondo non ci si “rivela”: abbiamo bisogno di un grande lavoro concettuale per metterci nelle condizioni di accedervi. Questo però non equivale a costruire il mondo ma semplicemente a cercarlo nella pratica non epistemicamente ideale di esseri che fanno uso del termine vero (p. 150).
di Alberto Giustiniano