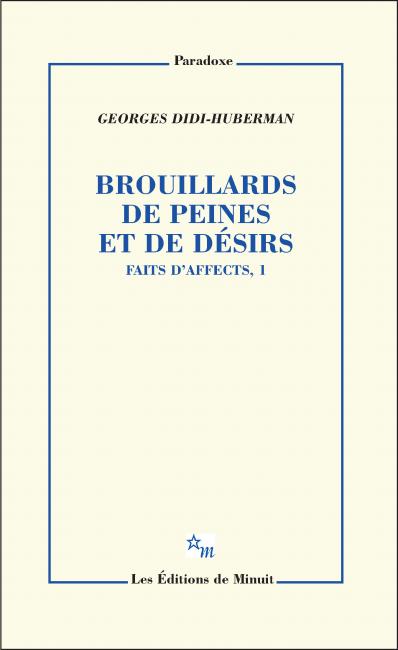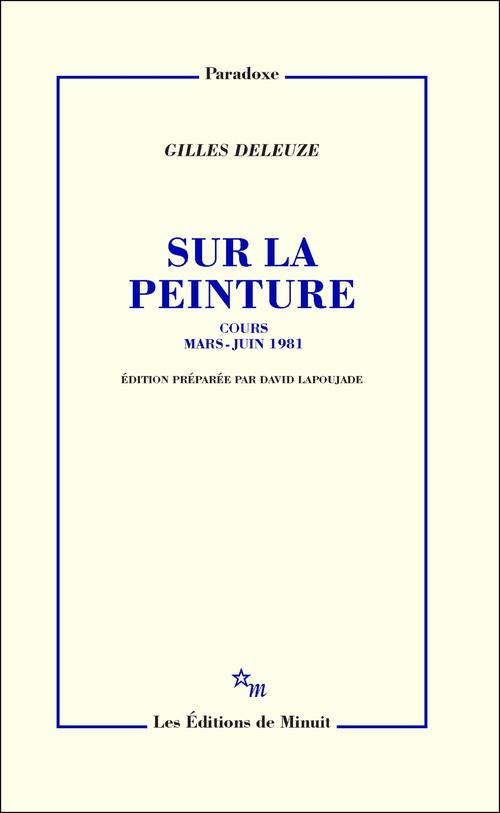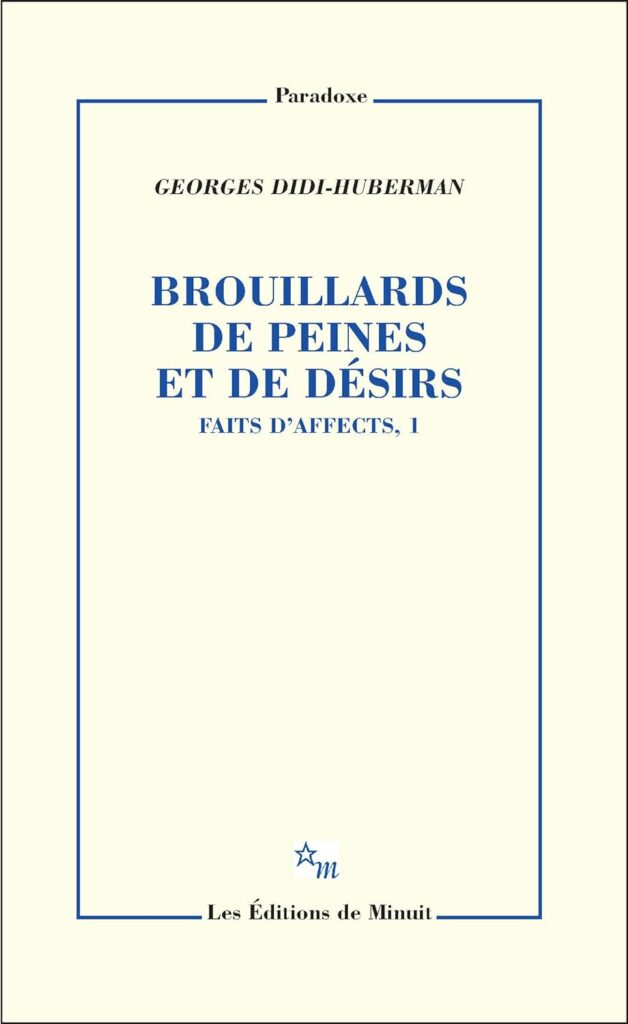Per due anni, dal novembre del 2021 al giugno del 2023, Georges Didi-Huberman ha concentrato il suo abituale seminario all’École des Hautes Études en sciences sociales intorno a un problema che si è condensato nell’espressione «Fatti d’affetti» (Faits d’affects) e che rinvia metaforicamente al nucleo generatore di una ricerca sulla sopravvivenza delle emozioni che lo tiene impegnato almeno dal 1982, la data di uscita del suo primo libro: Invention de l’Hystérie («L’invenzione dell’isteria»).
In quel libro, ormai lontano nel tempo, Didi-Huberman aveva messo in scena – sulla scena del pensiero – il rapporto tra scienza e potere, tra osservatore e osservato, tra sguardo maschile e corpo femminile. Tutto questo, oggi, appare come il tipico modo di procedere di una parte sostanziale della filosofia francese che si può evocare metonimicamente attraverso il nome di Michel Foucault: un modo di procedere tipico che le mani e la mente di Didi-Huberman – mani tenaci come quelle di un artigiano, mente paziente come quella di uno storico, cuore di filologo – hanno torto e ritorto, disassemblato e riassemblato in una configurazione inedita e insolita, cioè «sopravvivente» (survivante). Il concetto di «vita postuma» o «sopravvivenza» (Nachleben) è intimamente legato ad Aby Waburg, il secondo decisivo nome metonimico che, a partire dagli anni Novanta, Didi-Huberman evoca come un fantasma che lo incita (e forse addirittura lo tormenta) perché si incarichi del compito di passare a contropelo – da Vasari a Panofsky, fino a Michael Fried – l’intera storia dell’arte occidentale.
Con Didi-Huberman la scena della storia dell’arte si apre, si riapre, e ricomincia alla Salpêtrière, un luogo simbolico ma anche – e questo è decisivo – uno spazio materiale, concreto, storicamente determinato: un grande ospedale psichiatrico che ancora oggi svetta al centro di Parigi, nel cuore del XIII° arrondissement, e che alla fine del XIX secolo era diventata il teatro di «un incubo nel bel mezzo della belle époque». Su questa scena storica e fantasmatica, Didi-Huberman fa muovere – e anche questo è decisivo – non delle vaghe idee o degli astratti concetti, ma degli autentici personaggi: prima di tutti il direttore di questa «Versailles del dolore», il neurologo Jean-Martin Charcot; e poi Augustine Gleizes, una di quelle «quattro o cinquemila donne infernali» che servirono a Charcot come «materiale» per inventare, cioè per riscoprire quei fatti d’affetti che attraversano le epoche e gli spazi più eterogenei, e a cui quel Napoleone della neurologia decise di dare il nome di «isteria». Scegliendo l’iconografia fotografica della Salpetrière come punto di partenza per costruire il proprio archivio (immagini di pose, di urla, di «atteggiamenti passionali», di «estasi» di «posture del delirio»), Didi-Huberman riscopriva un modo di non proseguire manieristicamente l’ossessione della filosofia e dell’epistemologia francese per il discorso (discours), ma introduceva una variazione che, a posteriori, non smette di essere decisiva. I gesti critici di Didi-Huberman non prendono le mossesolo dal discorso e non si concentrano solo sul linguaggio (in senso verbale), ma traggono la loro forza reattiva dall’immagine e attraverso le immagini (al plurale) agiscono: immagini fotografiche, immagini cinematografiche, immagini pittoriche, immagini di ogni genere e provenienti da ogni tipo di cultura; immagini pittografiche, immagini incise, scolpite o anche solo immaginate, fantasticate, rimemorate. Nella ricerca e nell’opera di Didi-Huberman, l’immagine non assume mai la rigidità sistematica di un concetto, ma diventa un medium, un luogo in cui pensare liberamente (e non per questo meno rigorosamente); un ponte che connette spazi e tempi eterogeni, una zona di prossimità dialettica in cui si deposita la traccia dei nostri gesti, delle nostre emozioni: quei fatti che attraversano i nostri corpi, che scuotono le nostre menti e che rendono sensibili i nostri modi di ridere e di arrabbiarci, di commuoverci o di ribellarci (di «sollevarci», direbbe lui) malgrado tutto – ecco un altro gesto critico, un altro fraseggio, un’altra espressione che si ripete e si riverbera ritmicamente nell’opera di Didi-Huberman, e che come un colpo di reni indica il momento decisivo per pensare, per provare a immaginare, per tentare di aprire uno spazio di azione – per qualcuno o contro qualcosa. Sono emozioni negative e apparentemente private e impolitiche come la tristezza e il lutto che, se espresse, se portate in uno spazio collettivo, non si limitano a commuoverci ma ci muovono, ci spostano verso la polarità opposta, ci trasformano e si trasformano nel loro contrario: dalle lacrime alle armi, dalla tristezza alla rabbia, dall’impotenza alla capacità di azione e di reazione – spiega Didi-Huberman in uno dei momenti più esplicitamente politici del suo pensiero: una sorprendente analisi del film di Ėjzenštejn, La corazzata Potëmkin (Peuples en larmes, peuples en armes. L’Œil de l’histoire, 6, 2016).
Faits d’affects reca la traccia di questa etica delle immagini e di questa poetica delle sopravvivenze: una pratica dell’immaginazione che chiude e riapre un cerchio, e lo fa (per ora) in due tempi (Brouillards de peines et de désirs e La Fabrique des émotions disjointes). Il primo dei due tempi si dispiega in due momenti (per parole e per gesti): un indice minimo per orientarsi in una grande massa di studi, ricerche, conferenze, lezioni, appunti e frammenti(forse è questo il termine decisivo) che si sono condensati in forma di saggi (essais) e di immagini di pensiero (Denkbilder): una forma già praticata da pensatori come Walter Benjamin, Ernst Bloch o Theodor Adorno; una forma di cui Didi-Huberman riprende consapevolmente il carattere esploso e ostinato, rigoroso e localizzato, storicamente determinato da una data e, a volte, dalle menzione del luogo in cui sono sorte e forse sono state catturate e in qualche modo fissate quelle immagini di pensiero. Come già nella raccolta Aperçues (2018), anche in Faits d’affects le immagini di pensiero compongono una sorta di autoritratto, un’autobiografia per frammenti di esperienze: esperienze concrete e non unicamente intellettuali, pensieri che turbano o che destano meraviglia, come il viso di una donna amata, contratto nell’espressione che rende sensibile lo sforzo di generare una nuova vita; o come il senso di stupore e forse di angoscia che si manifesta davanti all’immagine del proprio cuore che batte, che pulsa quando viene toccato dallo strumento che riproduce il sintomo della malattia, e che per questo – forse – indica la via che gli permetterà di essere curato : una via aperta al futuro, la speranza di continuare a vivere. Di tutto questo tiene traccia il movimento dell’immagine: del battere e del fermarsi di un organo; del levarsi e del dissolversi di un’emozione; del vivificarsi e del fossilizzarsi di una vita. Non dev’essere un caso se la scena della nascita è il frammento cronologicamente più antico (29.11.2017) e apre la seconda parte del libro («Per gesti. Tempi per dispiegare»); mentre la scena di morte – di morte possibile, di morte temuta e, malgrado tutto, evitata – è di qualche anno successiva (21.12.2019) e apre la prima parte («Per parole. Tempi per approssimarsi»): come se la possibilità di scrivere saggi, di saggiare una generalità (un pensiero, una cultura, una tradizione) non potesse che scaturire da ciò che ne ha intravisto, percepito, sentito un individuo. Lo stupore e il terrore, la meraviglia e la paura, ancora una volta, all’origine del nostro bisogno di pensare, del nostro desiderio di scriverne.
Giovanni Pontolillo
Il brano tradotto di seguito è un frammento introduttivo del libro Brouillards de peines et de désirs. Faits d’affects, 1, Paris, Éditions de Minuit, 2023. Ringraziamo l’editore per aver concesso la pubblicazione.