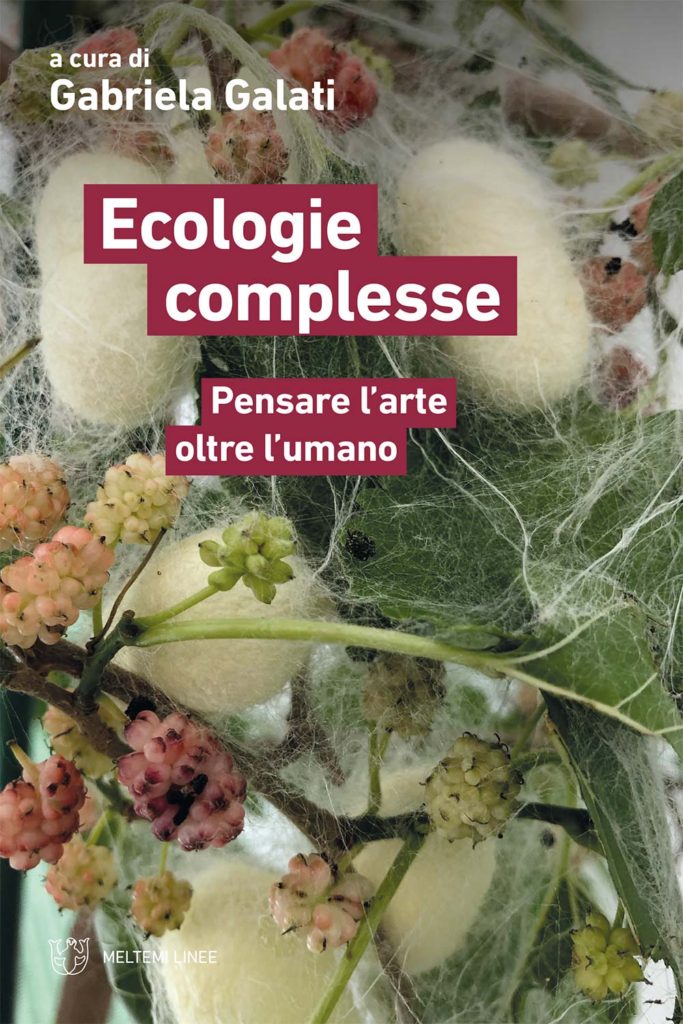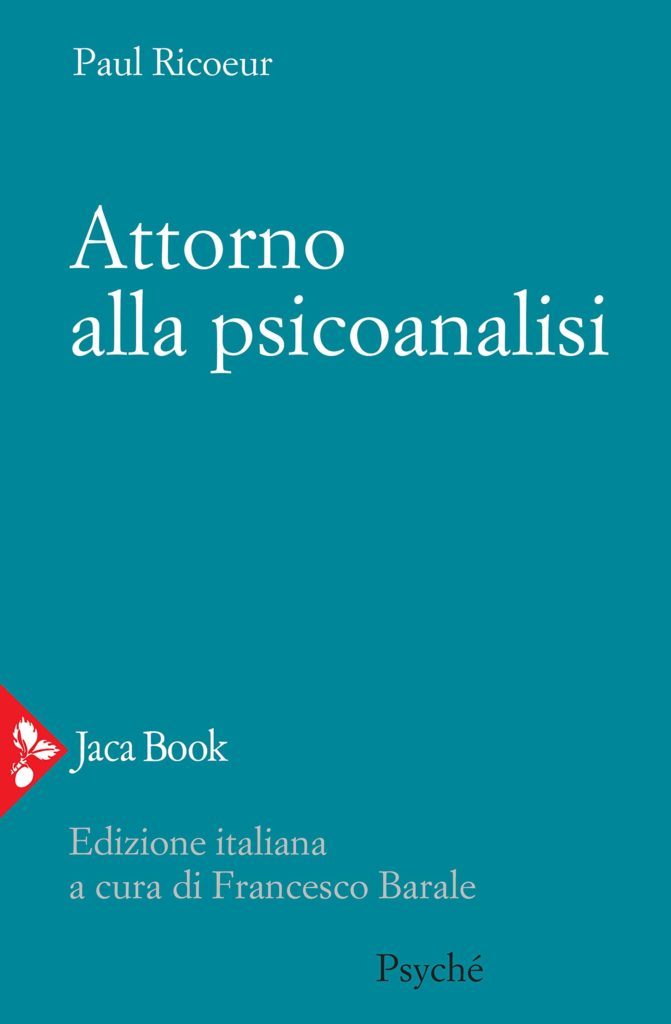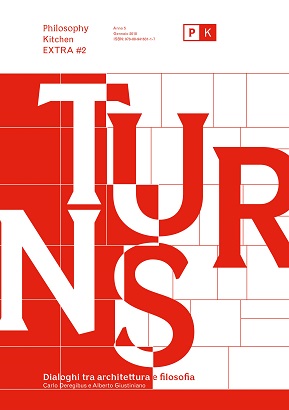-
-
Jacques Derrida-La Disseminazione
Recensioni / Giugno 2019«Non sono giochi di parole. I giochi di parole non mi hanno mai interessato.
Piuttosto, sono dei fuochi di parole: consumare i segni fino alla cenere»
J. Derrida, Posizioni
 È un atto di audacia leggere oggi Derrida. Oggi, in un momento storico in cui, sul piano filosofico, tutto sembra portarci lontano da Derrida e giocare contro di lui. Nel tempo della filosofia come conceptual engineering e iper-specializzazione logico-linguistico-matematica1, del dominio dell’argomentazione come unico viatico di rigore e chiarezza, e della stessa chiarezza-esattezza come assoluto contrassegno di razionalità, non può più esserci posto per un filosofo come Derrida. E così gli atteggiamenti più diffusi nei confronti dell’autore della Grammatologie sono due, esattamente inversi: la diffidenza e l’esclusione dal campo filosofico – con l’inclusione in quello letterario e retorico – o la caricatura, la ripetizione, il banale scimmiottamento di uno stile. Ma rifiutare o adorare Derrida, in realtà, sono solo le due facce del medesimo malessere che vive la filosofia oggi. Derrida è il pensatore dell’effrazione, del rinvio, dell’altrove. Altrove, rispetto a ogni classificazione professionale e istituzionale: ermeneutica, filosofia del linguaggio, filosofia della mente, comunicazione, linguistica, logica, psicologia, ecc. Altrove, rispetto alla scrittura stessa. Leggere testi inaccessibili come Glas, Tympan, La carte postale o La vérité en peinture, distillandone il contenuto propriamente filosofico, è un’operazione molto complessa, una sfida alla filosofia e alla nostra stessa capacità di scrivere e di leggere, che non può essere formalizzata nello spazio di un sillogismo, di una solida connessione di premesse e conclusione. Perché richiede qualcosa di più, l’audacia di abbandonare ogni tutore, ogni appoggio concettuale e la violenza, appunto, di «consumare i segni fino alla cenere».
È un atto di audacia leggere oggi Derrida. Oggi, in un momento storico in cui, sul piano filosofico, tutto sembra portarci lontano da Derrida e giocare contro di lui. Nel tempo della filosofia come conceptual engineering e iper-specializzazione logico-linguistico-matematica1, del dominio dell’argomentazione come unico viatico di rigore e chiarezza, e della stessa chiarezza-esattezza come assoluto contrassegno di razionalità, non può più esserci posto per un filosofo come Derrida. E così gli atteggiamenti più diffusi nei confronti dell’autore della Grammatologie sono due, esattamente inversi: la diffidenza e l’esclusione dal campo filosofico – con l’inclusione in quello letterario e retorico – o la caricatura, la ripetizione, il banale scimmiottamento di uno stile. Ma rifiutare o adorare Derrida, in realtà, sono solo le due facce del medesimo malessere che vive la filosofia oggi. Derrida è il pensatore dell’effrazione, del rinvio, dell’altrove. Altrove, rispetto a ogni classificazione professionale e istituzionale: ermeneutica, filosofia del linguaggio, filosofia della mente, comunicazione, linguistica, logica, psicologia, ecc. Altrove, rispetto alla scrittura stessa. Leggere testi inaccessibili come Glas, Tympan, La carte postale o La vérité en peinture, distillandone il contenuto propriamente filosofico, è un’operazione molto complessa, una sfida alla filosofia e alla nostra stessa capacità di scrivere e di leggere, che non può essere formalizzata nello spazio di un sillogismo, di una solida connessione di premesse e conclusione. Perché richiede qualcosa di più, l’audacia di abbandonare ogni tutore, ogni appoggio concettuale e la violenza, appunto, di «consumare i segni fino alla cenere».Per questo motivo, la recente ripubblicazione della traduzione italiana di La disseminazione (a cura di Silvano Petrosino, Milano, Jaca Book) è un evento degno di nota. Rileggere testi come “La farmacia di Platone”, “La doppia seduta” e “La disseminazione” – scritti tra il 1968 e 1970 – significa non soltanto chiedersi che cosa ne è oggi della “decostruzione”, precisamente nel senso che Derrida attribuiva a questa espressione, ma anche cercare di collocare storicamente questa domanda. Collocarla storicamente, non soltanto nel quadro della filosofia francese contemporanea – ammesso che tale espressione indichi una reale continuità di pensiero e non un semplicemente un gruppo di autori o un “clima”, ma questo è un altro problema –, bensì rispetto alla profonda trasformazione che la società occidentale ha subito negli ultimi quarant’anni con lo sviluppo della tecnologia digitale, quella che è stata definita la softwarizzazione della società. Evento, questo, connesso alla scrittura nel suo senso più proprio, cioè la trace, la messa in questione della linearità della scrittura alfabetica e quindi della metafisica della presenza, del logocentrismo e del fallo-logocentrismo.
Ma guardiamo al libro, anzitutto. Leggere La disseminazione è un’operazione complessa, che richiede tempo e fatica, nonché il coraggio di fare i conti con un pensiero molteplice, in cui sfugge il punto di inizio. «Nessun inizio offre le garanzie necessarie di neutralità» scrive Sollers in Dramma, frase collocata da Derrida nel cuore del saggio “La disseminazione”, tessuto di citazioni a metà strada tra il commento e il testo originale, autentico “avvenire” della decostruzione che si riflette in uno stile preciso. La decostruzione si presenta come lavoro sul testo che viene dal testo, che “avviene” nel testo, «una fase indispensabile di capovolgimento» (p. 50). Non è concettualizzazione selvaggia, insensata, fantasiosa. È un paziente scavo nel testo scritto, a contatto con la scrittura come esperienza del linguaggio che mette in questione il linguaggio stesso. Attraverso tale scavo ogni elemento del testo è animato da «una rotazione velata» (p. 353) che ne sprigiona l’energia nascosta, cioè il mitogramma, citando l'antropologo Leroi-Gourhan, autore molto importante per Derrida. Questo significa risalire, nel testo, dalla scrittura alfabetica al mitogramma come scrittura non-lineare ma radiale, polinodale, visiva, spaziatura, «una grafica che agisce nella stessa sequenza detta fonetica, elaborandola, traducendosi in essa ancor prima di comparire, di lasciarsi infine riconoscere, nel momento in cui cade in coda al testo, come un resto e come una sentenza» (p. 362). L’operazione derridiana assomiglia così a quelle «radiografie che scoprono, sotto l’epidermide dell’ultima pittura, un altro quadro nascosto: dello stesso pittore o di uno diverso, poco importa, che avrebbe, non disponendo di altre tele o ricercando un nuovo effetto, utilizzato la base di un vecchio dipinto o conservato il frammento di un primo schizzo. […] un’altra geometria futura» (p. 363-370).
La scrittura come «altra geometria futura» sfugge alla rappresentazione e si afferma quale condizione di ogni verità e di ogni pensiero. È questo il filo conduttore di “La farmacia di Platone”, così come di un altro testo, ormai anch’esso un classico, “La doppia seduta”, lungo “braccio di ferro” con Platone, e dietro di lui Hegel, e con il concetto di mimesis a partire da Mallarmé, dove l’obiettivo della lettura non è più “una semplice rilevazione di concetti o di parole», bensì «ricostruire una catena in movimento, gli effetti di una rete e il gioco di una sintassi» (p. 218). Anche qui Derrida guarda verso un'altra scrittura, non lineare, ovvero la mimique del Pierrot di Mallarmé, «un intaglio che apre ancora su un altro testo e pratica un’altra lettura» (p. 227) poiché «il Mimo […] non rappresenta niente, non imita niente, non deve conformarsi a un referente anteriore in un disegno di adeguazione o verosimiglianza. […] [Il Mimo è] un doppio che non raddoppia alcun semplice, che non è prevenuto da nulla, nulla che non sia già in ogni caso doppio» (p. 228).

Mi fermo a queste poche citazioni. Di che cosa ci sta parlando Derrida? Del movimento della significazione, la semiosi essenziale all'essere umano, quella necessità di dare un significato che rende possibile il linguaggio, il pensiero, la coscienza e infine la presenza stessa. Questo movimento è la materialità e l'iterabilità della traccia: il “fuori” è nel “dentro”. Il che non significa affatto affermare il primato della retorica sulla logica, come sosteneva Habermas in un celebre saggio. Derrida ci spinge invece a guardare oltre la logica e la retorica, oltre il “fuori” e il “dentro”, interrogandosi sulla contaminazione essenziale e originaria tra i due poli, «la complicità essenziale dell'empirismo e del formalismo» (p. 55). Questa è precisamente l’operazione trascendentale che la decostruzione ci insegna: mostrare la complementarietà dinamica degli opposti. Non c’è presenza piena o essere pieno o coscienza piena: la différance, nella sua mancanza di sonorità, è questo perenne movimento di superamento, questa oscillazione tra presenza e assenza, identità e differenza, rinvio infinito, ammissione dell’impossibilità della genesi, dell’origine assoluta. Su questa tesi Derrida costruisce il nodo teorico essenziale del suo pensiero, destinato a ripetersi secondo modalità sempre diverse, fino agli scritti più recenti sul dono, sull’ospitalità, sull’universalità, sulla pena di morte o sulle «politiche dell’amicizia».
Se questo è il punto nodale di La disseminazione, tracciarne un bilancio critico è cosa molto più difficile e certamente non può essere fatto in poche pagine. È una banalità dirlo, ma in questo caso è vero: siamo ancora troppo storicamente vicini all’opera del filosofo algerino per poterne avere una visione completa, apprezzandone la complessità in modo positivo – e anche in modo diverso da come Derrida stesso ha l'ha pensata. Dobbiamo procedere per tentativi. Uno di questi – a mio avviso – può essere quello di cercare di far fruttare la creatività del pensiero di Derrida mettendola a contatto con la filosofia analitica, con l'informatica e con le scienze cognitive. Può essere una strada utile non solo per rinnovare le chiavi interpretative che applichiamo a Derrida, ma anche per “disarmare” questi due ambiti, in un senso propriamente filosofico, cioè abituandoli alla torsione concettuale e linguistica della decostruzione che è «l’esporsi – come ha detto Derrida in un'intervista alla fine della sua vita – a ciò di cui non ci si può appropriare: a quel che c’è, prima di noi, senza di noi; c’è qualcuno, qualcosa che (ci) avviene, e che non ha bisogno di noi per avvenire». Compiere un'operazione di questo tipo significherebbe rispettare anche un'altra dimensione cruciale per Derrida: la destinazione, l'invio, la tensione, l'apertura del segno verso il futuro. Leggere Derrida come una lettera inviata alla filosofia futura.
Luca M. Possati
-
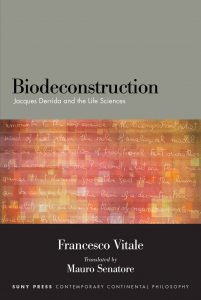 Tra le scuole di pensiero marcatamente connotate dalla presenza di un capostipite fondatore – si pensi alla fenomenologia di Husserl, all’ermeneutica di Heidegger, e alla biopolitica di Foucault – oggi è forse la decostruzione a godere della più vasta pervasività; e non tanto per intensità e clamore mediatico, quanto piuttosto in termini di tacita assunzione e di capillarità. A nostro modo di vedere, ciò è potuto accadere poiché, situandosi a cavallo di istanze epistemologico-metodologiche e di ipotesi ontologiche forti, il pensiero di Derrida ha raggiunto lo statuto di referente teorico ineludibile, sia dal punto di vista dei detrattori sia da quello dei più strenui fautori. Equipaggiando la filosofia di un metodo critico di lettura e riscrittura, così come, al contempo, drenando dai bacini delle filosofie decostruite operatori concettuali dormienti, la decostruzione ha fornito strumenti e spazi di disputa. È divenuta cioè il teatro ideale di animate discussioni, tanto interne, volte ad affinare la lettura degli stessi testi derridiani, quanto esterne, ossia vertenti sulla possibilità o meno di applicare le procedure e le nozioni decostruttive in relazione a prospettive di diverso lignaggio. Ora, è esattamente in direzione di questo doppio binario che si inserisce il recente lavoro di Francesco Vitale, Biodeconstruction. Jacques Derrida and Life Sciences (Suny Press, 2018). Frutto di un’attenta ricerca filologica, capace di coordinare l’approccio storico-ricostruttivo con quello più spiccatamente propositivo, il testo di Vitale si situa a pieno titolo tra i lavori della “scuola” decostruttiva progressista, intendendo con questa espressione quel filone di studi derridiani – di cui Rodolphe Gasché è probabilmente il nume tutelare – impegnati a manifestare fedeltà metodologica alla decostruzione, tramite un’espansione della sua area di operatività. Dopotutto il volume di Vitale, come si vedrà, cerca di assecondare quello che fu l’auspicio stesso di Derrida: preservare la singolarità del gesto decostruttivo tradendone però, di volta in volta, i limiti epistemici.
Tra le scuole di pensiero marcatamente connotate dalla presenza di un capostipite fondatore – si pensi alla fenomenologia di Husserl, all’ermeneutica di Heidegger, e alla biopolitica di Foucault – oggi è forse la decostruzione a godere della più vasta pervasività; e non tanto per intensità e clamore mediatico, quanto piuttosto in termini di tacita assunzione e di capillarità. A nostro modo di vedere, ciò è potuto accadere poiché, situandosi a cavallo di istanze epistemologico-metodologiche e di ipotesi ontologiche forti, il pensiero di Derrida ha raggiunto lo statuto di referente teorico ineludibile, sia dal punto di vista dei detrattori sia da quello dei più strenui fautori. Equipaggiando la filosofia di un metodo critico di lettura e riscrittura, così come, al contempo, drenando dai bacini delle filosofie decostruite operatori concettuali dormienti, la decostruzione ha fornito strumenti e spazi di disputa. È divenuta cioè il teatro ideale di animate discussioni, tanto interne, volte ad affinare la lettura degli stessi testi derridiani, quanto esterne, ossia vertenti sulla possibilità o meno di applicare le procedure e le nozioni decostruttive in relazione a prospettive di diverso lignaggio. Ora, è esattamente in direzione di questo doppio binario che si inserisce il recente lavoro di Francesco Vitale, Biodeconstruction. Jacques Derrida and Life Sciences (Suny Press, 2018). Frutto di un’attenta ricerca filologica, capace di coordinare l’approccio storico-ricostruttivo con quello più spiccatamente propositivo, il testo di Vitale si situa a pieno titolo tra i lavori della “scuola” decostruttiva progressista, intendendo con questa espressione quel filone di studi derridiani – di cui Rodolphe Gasché è probabilmente il nume tutelare – impegnati a manifestare fedeltà metodologica alla decostruzione, tramite un’espansione della sua area di operatività. Dopotutto il volume di Vitale, come si vedrà, cerca di assecondare quello che fu l’auspicio stesso di Derrida: preservare la singolarità del gesto decostruttivo tradendone però, di volta in volta, i limiti epistemici. -
Extra#2 \ TURNS. Dialoghi tra architettura e filosofia
Extra / Febbraio 2018TURNS. Dialoghi tra architettura e filosofia è la traccia di un dialogo spesso acceso, ricco di incomprensioni e riconciliazioni, che coinvolge architetti e filosofi, docenti e professionisti, e ancora biologi, dottori di ricerca, studenti. È il racconto di due discipline, architettura e filosofia, che si voltano per guardarsi reciprocamente, provando a innescare una svolta concettuale che deve divenire un nuovo punto di partenza. Precisamente questo è il doppio significato del termine “Turns”.
Da un lato infatti, il filosofo ha sempre avuto difficoltà a interloquire con l’architetto, sia per ragioni storiche sia per ragioni strettamente legate al suo metodo e ai suoi obiettivi. L’architetto sembra infatti presentarsi allo sguardo del filosofo come un personaggio al contempo perturbante e conturbante, in un misto di attrazione e biasimo, di invidia e ammirazione: una figura tanto sfuggente da investire la riflessione filosofica con effetto retroattivo, facendo scricchiolare le sue fondamenta concettuali e mettendo in dubbio nozioni fondamentali quali verità, libertà, realtà, conoscenza, invenzione, possibilità, necessità, che hanno rappresentato per secoli il lessico base del pensiero occidentale. L’interesse verso una simile figura sembrerebbe ovvio. Eppure, quasi sempre è il filosofo che viene interpellato, utilizzato o coinvolto nel lavoro dell’architetto, in molti casi con l’intento di distillare spazialmente il senso dei suoi discorsi nel progetto. Non che ciò sia impossibile, ma, forse, dovremmo domandarci se è proprio questo quello che vogliamo: o se invece non sia compito del filosofo esercitare una sistematica e implacabile strategia di provocazione interessata, al fine di produrre un effetto, una particolare condizione dello sguardo. Creare la crisi, mettendo in discussione ciò che è dato, sapendo che, come spesso accade, l’apertura verso un nuovo oggetto di conoscenza lascia insoluti quei quesiti che lo vedono direttamente implicato per produrre un effetto retroattivo di chiarificazione nel soggetto indagatore, impegnato a leggersi ora attraverso una nuova forma di mediazione.
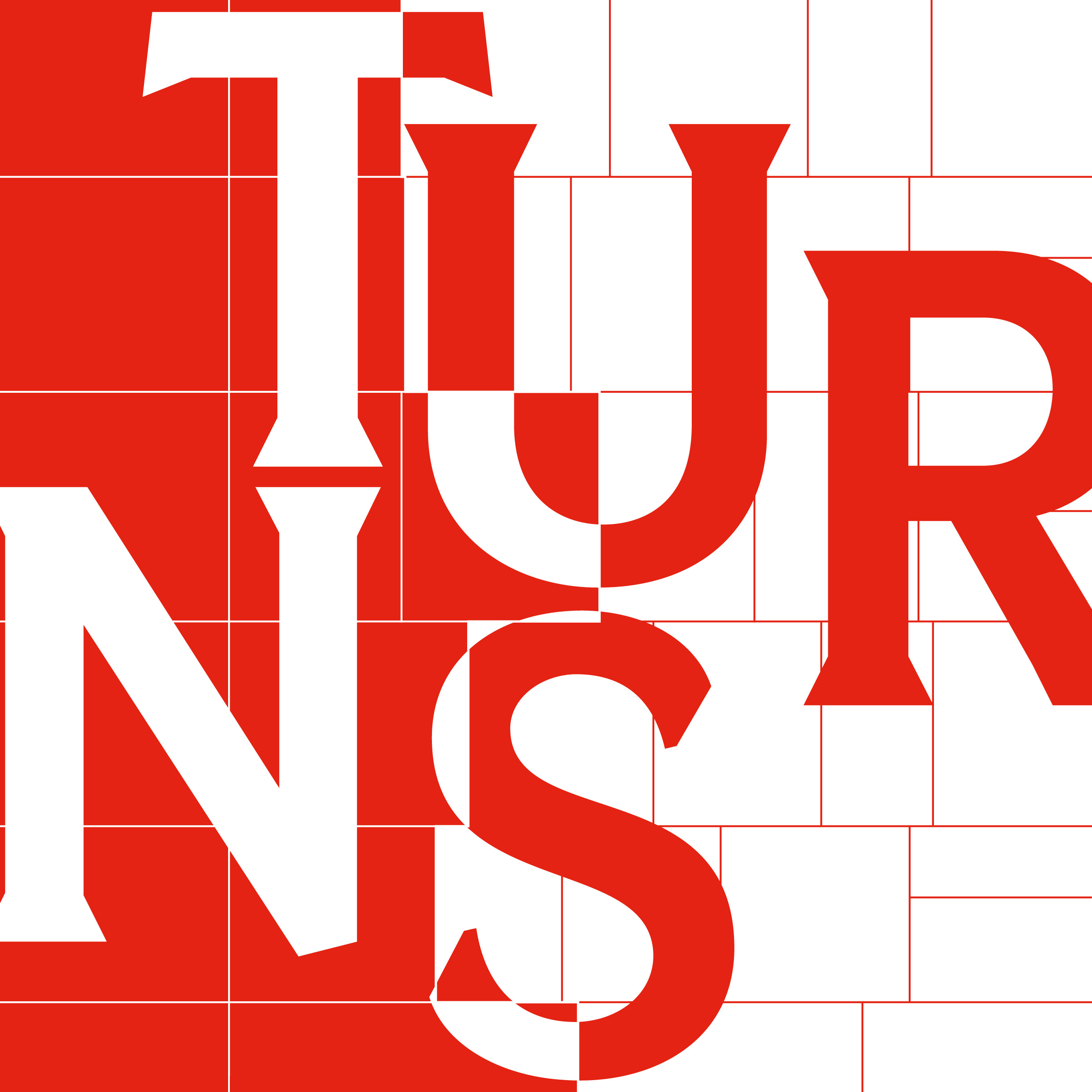
Dall’altro lato, per l’architettura il rapporto con la filosofia è storicamente naturale, quasi che questa fosse una visione complementare sul mondo rispetto al suo operato: questo era possibile perché la società si evolveva in modo relativamente lento, attraverso sedimentazioni di usi che diventavano convenzioni sociali, di pensiero, di stile. Così andava nell’architettura egizia, in quella classica, nel medioevo, nel rinascimento, finanche nel Modernismo: i significati erano decifrabili perché si condivideva un sostrato convenzionale. Ma qualcosa è cambiato. Le correnti durano pochi anni: poi passano, come le mode, spesso senza lasciar traccia – tranne edifici già superati, ovviamente. Così, spariscono le teorie dell’architettura, cioè sistemi che dicano cosa sia giusto costruire. E senza una teoria che legittimi le scelte, fioriscono le retoriche e le poetiche personali, spesso così ridicole da essere persino (e giustamente) oggetto di satira. La condizione di fragilità dell’architettura contemporanea è ormai fisiologica. Ed è qui che la filosofia diventa non solo utile, ma necessaria. A patto, certo, di non usarla in senso analogico, con derivazioni dirette che trasformano concetti in forme e pensieri in stili. Dialogare con i filosofi serve perché essi ragionano su temi che, in qualche modo, toccano gli architetti – ad esempio, lo spazio, l’invenzione, la città, la generazione della forma, il potere. Capire qualcosa di quei temi aiuterà a progettare con una maggior consapevolezza, o una più approfondita convinzione sulle ragioni del progetto, e a capirne meglio effetti ed esiti.
A cura di Carlo Deregibus e Alberto Giustiniano
Scarica PDF
English version
DOI: https://doi.org/10.13135/2385-1945/1.2018
Pubblicato: gennaio 2018
Indice
Alberto Giustiniano - ARCHITECTURAL TURN. Il filosofo e le sfide del progetto [PDF It]
Carlo Deregibus - PHILOSOPHICAL TURN. Fragilità dell’architettura contemporanea [PDF It]
(S)Block-Seminar
.
DA LASCAUX AI JUNKSPACE
Giovanni Leghissa - Da Lascaux ai junkspaces (passando per Ippodamo da Mileto) [PDF It]
Giovanni Durbiano – Descrivere il progetto dello spazio [PDF It]
Riccardo Palma – Molteplicità e non naturalità degli spazi nella produzione del progetto di architettura [PDF It]
RIFERIMENTI di Andrea Dutto [PDF It]
.
DECOSTRUZIONE, IMMANENZA, ILOMORFISMO
Giulio Piatti – Simondon e Deleuze di fronte all’ilomorfismo. Appunti sul rapporto forma-materia [PDF It]
Carlo Deregibus – Appunti su Chōra, spazio e architettura. Da Platone a Derrida [PDF It]
Paola Gregory – Le nuove scienze e la conquista dell’informale [PDF It]
Riccardo Palma – L’assenza necessaria dell’architettura [PDF It]
RIFERIMENTI di Andrea Canclini [PDF It]
.
FENOMENOLOGIA E PROGETTO
Claudio Tarditi – Fenomenologia e architettura. Introduzione al problema della percezione spaziale in Edmund Husserl [PDF It]
Alberto Giustiniano – Tempo, forma, azione. Il senso del progetto nel dialogo tra Enzo Paci e Ernesto Nathan Rogers [PDF It]
Silvia Malcovati – Per un razionalismo relazionale [PDF It]
Carlo Deregibus – L’orizzonte del progetto e la responsabilità dell’architetto [PDF It]
RIFERIMENTI di Federico Tosca [PDF It]
.
MORFOGENESI E AUTOORGANIZZAZIONE
Veronica Cavedagna & Danilo Zagaria - Quale spazio per la morfogenesi e l'auto-organizzazione? [PDF It]
Paola Gregory – Morfogenesi architettonica e “vita artificiale” [PDF It]
Carlo Deregibus – Progetto e complessità. Fascino dell’analogia e libero arbitrio [PDF It]
RIFERIMENTI di Edoardo Fregonese [PDF It]
.
ANTROPOGENESI E COSTRUZIONE DELLO SPAZIO
Roberto Mastroianni – Regimi dello sguardo. Sloterdijk e la metafora spaziale [PDF It]
Alessandro Armando – La scrittura del futuro e la promessa del progetto [PDF It]
Daniele Campobenedetto – Leggibilità e materialità dello spazio [PDF It]
RIFERIMENTI di Federico Cesareo [PDF It]
.
POTERE E SPAZIO
Luigi Giroldo – Genealogie dello spazio contemporaneo. Utopie moderne e nascita dell’urbanistica [PDF It]
RIFERIMENTI di Andrea Canclini [PDF It]
BIBLIOGRAFIA
.
-
Una questione di scarpe. Derrida e Van Gogh
Sconfinamenti, Serial / Maggio 2016 Il capitolo finale del volume di Jacques Derrida La vérité en peinture reca l’etichetta Restitutions – de la vérité en pointure. Essa ovviamente implica un calembour sul titolo del libro: infatti i due termini peinture e pointure sono quasi omofoni, anche se si differenziano sul piano del significato, dato che il secondo indica in francese la misura di un paio di scarpe. Questo testo derridiano è costruito in maniera inusuale, ossia come un dialogo a più voci, in cui i parlanti restano indeterminati. Si inizia con qualcuno che osserva: «Non ricordo più chi diceva “non ci sono fantasmi nei quadri di Van Gogh”? Invece qui c’è proprio una storia di fantasmi». Per dimostrare ciò, Derrida mette a confronto due autorevoli interpretazioni di un dipinto dell’artista olandese che raffigura un paio di scarpe slacciate. Gli interpreti in questione, Heidegger da un lato e lo storico dell’arte americano Meyer Schapiro dall’altro, sono accomunati dal fatto di chiedersi a chi appartengano tali scarpe, quasi fosse necessario restituirle al legittimo proprietario. Per il filosofo tedesco, che evoca il dipinto nel saggio L’origine dell’opera d’arte, a essere in causa è senz’altro «un paio di scarpe da contadino». Ma poiché egli non ha indicato con precisione nel suo testo a quale fra i vari quadri di Van Gogh raffiguranti scarpe si riferisse, Schapiro glielo ha chiesto per via epistolare, appurando che si trattava dell’opera (databile alla seconda metà del 1886) che reca il numero 255 nel catalogo compilato da Jacob Baart de la Faille. Basta questo a Schapiro per dedurre che le calzature raffigurate nel quadro non appartenevano a un qualche contadino bensì al pittore stesso, che in quel periodo risiedeva in città, a Parigi...Scarica il PDF
Il capitolo finale del volume di Jacques Derrida La vérité en peinture reca l’etichetta Restitutions – de la vérité en pointure. Essa ovviamente implica un calembour sul titolo del libro: infatti i due termini peinture e pointure sono quasi omofoni, anche se si differenziano sul piano del significato, dato che il secondo indica in francese la misura di un paio di scarpe. Questo testo derridiano è costruito in maniera inusuale, ossia come un dialogo a più voci, in cui i parlanti restano indeterminati. Si inizia con qualcuno che osserva: «Non ricordo più chi diceva “non ci sono fantasmi nei quadri di Van Gogh”? Invece qui c’è proprio una storia di fantasmi». Per dimostrare ciò, Derrida mette a confronto due autorevoli interpretazioni di un dipinto dell’artista olandese che raffigura un paio di scarpe slacciate. Gli interpreti in questione, Heidegger da un lato e lo storico dell’arte americano Meyer Schapiro dall’altro, sono accomunati dal fatto di chiedersi a chi appartengano tali scarpe, quasi fosse necessario restituirle al legittimo proprietario. Per il filosofo tedesco, che evoca il dipinto nel saggio L’origine dell’opera d’arte, a essere in causa è senz’altro «un paio di scarpe da contadino». Ma poiché egli non ha indicato con precisione nel suo testo a quale fra i vari quadri di Van Gogh raffiguranti scarpe si riferisse, Schapiro glielo ha chiesto per via epistolare, appurando che si trattava dell’opera (databile alla seconda metà del 1886) che reca il numero 255 nel catalogo compilato da Jacob Baart de la Faille. Basta questo a Schapiro per dedurre che le calzature raffigurate nel quadro non appartenevano a un qualche contadino bensì al pittore stesso, che in quel periodo risiedeva in città, a Parigi...Scarica il PDFA cura di:
Giuseppe Zuccarino è critico e traduttore. Ha pubblicato vari saggi: La scrittura impossibile, Genova, Graphos, 1995; L’immagine e l’enigma, ivi, 1998; Critica e commento. Benjamin, Foucault, Derrida, ivi, 2000; Percorsi anomali, Udine, Campanotto, 2002; Il desiderio, la follia, la morte, ivi, 2005; Il dialogo e il silenzio, ivi, 2008; Da un’arte all’altra, Novi Ligure, Joker, 2009; Note al palinsesto, ivi, 2012; Il farsi della scrittura, Milano-Udine, Mimesis, 2012. Tra i libri da lui tradotti figurano opere di Mallarmé, Bataille, Klossowski, Blanchot, Caillois e Barthes.
-
Ancora troppo umani. Il postumano di Giovanni Leghissa
Recensioni / Ottobre 2015 Nel suo saggio Postumani per scelta. Verso un’ecosofia dei collettivi, ospite della collana “Spiritualità senza Dio?” diretta da Luigi Berzano, Giovanni Leghissa dà unitarietà a un tema che ormai lo vede occupato da alcuni anni (La fondazione, la fondazione dell’umano, il post-umano, 2013; Il postumano: un nuovo paradigma?, 2013; curatela di aut aut, La condizione postumana, 2014). Nonostante la brevità del saggio, l’autore si propone di soddisfare la duplice esigenza teorica di inquadrare da più vicino lo sfuggente dibattito sulla questione postumana e, insieme, di estrarne una possibile interpretazione critica. Così, alla messa in ordine di linee guida di una discussione spesso frammentaria, si affianca l’argomentazione di una tesi, frutto dell’incontro di assi di ricerca eterogenei ma convergenti. Le fonti e le questioni interpellate sono infatti numerose e provenienti dalle più disparate aree del sapere filosofico. Tra i “maestri” e le tradizioni di pensiero che vediamo avvicendarsi figurano l’illuminismo, l’evoluzionismo, la filosofia francese del dopoguerra, l’epistemologia, la fenomenologia husserliana, l’idea di un sapere enciclopedico alla Enzo Paci, la decostruzione e l’antropologia filosofica di Hans Blumenberg. Come dichiara l’autore, si tratterà allora di seguire questi molteplici stimoli nell’intento di definire la condizione postumana in termini filosofici, individuando e descrivendo schematicamente gli atteggiamenti caratteristici del suo approccio.
Nel suo saggio Postumani per scelta. Verso un’ecosofia dei collettivi, ospite della collana “Spiritualità senza Dio?” diretta da Luigi Berzano, Giovanni Leghissa dà unitarietà a un tema che ormai lo vede occupato da alcuni anni (La fondazione, la fondazione dell’umano, il post-umano, 2013; Il postumano: un nuovo paradigma?, 2013; curatela di aut aut, La condizione postumana, 2014). Nonostante la brevità del saggio, l’autore si propone di soddisfare la duplice esigenza teorica di inquadrare da più vicino lo sfuggente dibattito sulla questione postumana e, insieme, di estrarne una possibile interpretazione critica. Così, alla messa in ordine di linee guida di una discussione spesso frammentaria, si affianca l’argomentazione di una tesi, frutto dell’incontro di assi di ricerca eterogenei ma convergenti. Le fonti e le questioni interpellate sono infatti numerose e provenienti dalle più disparate aree del sapere filosofico. Tra i “maestri” e le tradizioni di pensiero che vediamo avvicendarsi figurano l’illuminismo, l’evoluzionismo, la filosofia francese del dopoguerra, l’epistemologia, la fenomenologia husserliana, l’idea di un sapere enciclopedico alla Enzo Paci, la decostruzione e l’antropologia filosofica di Hans Blumenberg. Come dichiara l’autore, si tratterà allora di seguire questi molteplici stimoli nell’intento di definire la condizione postumana in termini filosofici, individuando e descrivendo schematicamente gli atteggiamenti caratteristici del suo approccio. -
La macchina ineludibile
Longform / Aprile 2015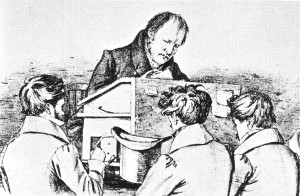 In un testo apparso nel 1992 in un volume collettivo, «Nous autres Grecs», Jacques Derrida, riferendosi all’intero gruppo dei filosofi oggi noti come post-strutturalisti, osserva che essi si raccolgono «sotto il segno della differenza, e di una differenza, così come di un simulacro, non dialettizzabile». Dopo aver sottolineato quella che definisce «tale resistenza, io direi quasi tale allergia, ma non opposizione, tale risposta testarda (differenziale, non dialettica) alla dialettica», conclude:
In un testo apparso nel 1992 in un volume collettivo, «Nous autres Grecs», Jacques Derrida, riferendosi all’intero gruppo dei filosofi oggi noti come post-strutturalisti, osserva che essi si raccolgono «sotto il segno della differenza, e di una differenza, così come di un simulacro, non dialettizzabile». Dopo aver sottolineato quella che definisce «tale resistenza, io direi quasi tale allergia, ma non opposizione, tale risposta testarda (differenziale, non dialettica) alla dialettica», conclude:Questa resistenza è in comune non soltanto a Deleuze e a me […], ma anche a Foucault, Lyotard e altri ancora. È stata conquistata, si potrebbe dire strappata, sempre senza fine, a un dialetticismo ereditato. Ciò che essa ha – piuttosto che rovesciato – spostato, deformato, non è stata soltanto la dialettica hegeliana, neo-hegeliana o marxista, è stata in primo luogo la dialetticità di provenienza platonica. (Derrida, 1992a, p. 257-258).[1]
-
Jean-Luc Nancy – Dov’è successo?
Recensioni / Febbraio 2015 Il tema dell'archivio, oggetto dell'intervista di Nathalie Léger a Jean-Luc Nancy qui proposta in traduzione italiana a cura di Igor Pelgreffi, acquista nel corso del Novecento una sempre maggiore autonomia dalle discipline che se ne sono occupate tradizionalmente, in primo luogo la storia e la filologia. Dal punto di vista filosofico, emerge così progressivamente la domanda sul senso dell'archivio e sugli effetti che esso può determinare sulle opere e sull'immagine stessa di un autore. In altre parole, come ricorda il curatore in apertura del saggio introduttivo, «come esaminare il passato del proprio lavoro? Qual è la sua materia, quali sono i suoi oggetti? Qual è la parte della cancellazione e della distruzione? Come iniziare con ciò che resta?» Innanzitutto, ogni archivio è un luogo. Non solo nel senso dello spazio fisico in cui sono raccolte le opere di uno o più autori, ma uno spazio entro cui sono possibili certe operazioni intellettuali: infatti, se da un lato l'archivio rappresenta una risorsa insostituibile nel processo di analisi del pensiero di un filosofo, nella conservazione delle sue opere e nella costruzione della sua immagine futura, dall'altro lato esso apre una serie di interrogativi filosofici inediti, relativi al funzionamento dell'archiviazione, al suo duplice carattere di mantenimento e perdita, al momento a partire dal quale si può dire di aver davvero archiviato qualcosa. In sintesi, dove e a chi (o a cosa) accade l'archiviazione? È questo l'interrogativo di fondo attorno a cui si snoda tutto il discorso di Nancy, d'ispirazione decostruttiva, qui presentato. Come osserva acutamente Pelgreffi, «non possiamo comprendere l'archivio se non immaginiamo un intreccio fra spazio dell'archivio e tempo dell'archivio così come fra spazio dell'archiviazione e tempo dell'archiviazione, cioè quello che, in termini derridiani, potremmo pensare come una différance spazio-temporale, nel senso di una spazializzazione del tempo e di una temporalizzazione dello spazio.» Ed è senza dubbio in consonanza col pensiero di Derrida che Nancy costruisce il proprio discorso sull'arché e sull'istituzione dell'archivio, col risultato - paradossale, come quasi sempre accade seguendo un approccio derridiano o,
Il tema dell'archivio, oggetto dell'intervista di Nathalie Léger a Jean-Luc Nancy qui proposta in traduzione italiana a cura di Igor Pelgreffi, acquista nel corso del Novecento una sempre maggiore autonomia dalle discipline che se ne sono occupate tradizionalmente, in primo luogo la storia e la filologia. Dal punto di vista filosofico, emerge così progressivamente la domanda sul senso dell'archivio e sugli effetti che esso può determinare sulle opere e sull'immagine stessa di un autore. In altre parole, come ricorda il curatore in apertura del saggio introduttivo, «come esaminare il passato del proprio lavoro? Qual è la sua materia, quali sono i suoi oggetti? Qual è la parte della cancellazione e della distruzione? Come iniziare con ciò che resta?» Innanzitutto, ogni archivio è un luogo. Non solo nel senso dello spazio fisico in cui sono raccolte le opere di uno o più autori, ma uno spazio entro cui sono possibili certe operazioni intellettuali: infatti, se da un lato l'archivio rappresenta una risorsa insostituibile nel processo di analisi del pensiero di un filosofo, nella conservazione delle sue opere e nella costruzione della sua immagine futura, dall'altro lato esso apre una serie di interrogativi filosofici inediti, relativi al funzionamento dell'archiviazione, al suo duplice carattere di mantenimento e perdita, al momento a partire dal quale si può dire di aver davvero archiviato qualcosa. In sintesi, dove e a chi (o a cosa) accade l'archiviazione? È questo l'interrogativo di fondo attorno a cui si snoda tutto il discorso di Nancy, d'ispirazione decostruttiva, qui presentato. Come osserva acutamente Pelgreffi, «non possiamo comprendere l'archivio se non immaginiamo un intreccio fra spazio dell'archivio e tempo dell'archivio così come fra spazio dell'archiviazione e tempo dell'archiviazione, cioè quello che, in termini derridiani, potremmo pensare come una différance spazio-temporale, nel senso di una spazializzazione del tempo e di una temporalizzazione dello spazio.» Ed è senza dubbio in consonanza col pensiero di Derrida che Nancy costruisce il proprio discorso sull'arché e sull'istituzione dell'archivio, col risultato - paradossale, come quasi sempre accade seguendo un approccio derridiano o,come in questo caso, post-derridiano - che proprio l'“oggetto archivio”, la cui istituzione è segnata da un luogo e una data, finisce per essere l'elemento meno stabile per determinare la nostra relazione col passato. Piena continuità, dunque, col testo di Derrida Mal d'archive, di cui questo discorso di Nancy rappresenta idealmente la prosecuzione. Infatti, Nancy condivide la preoccupazione derridiana di una possibile riduzione dell'archivio al mito del “ritorno all'origine”, in altre parole l'istituzione di un luogo a cui consegnare il passato dell'autore, il suo tempo perduto. Al contrario, osservano Derrida e Nancy, non esiste alcuna origine piena da poter rendere presente e disponibile, ma soltanto l'archiviazione che permette di rinvenire la traccia dell'origine. Come osserva
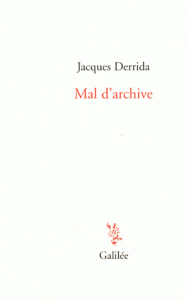 Pelgreffi, da tale confronto con Derrida emerge che il soggetto non è diviso tra due mondi, quello interno e quello sociale, ma è preso nel processo di riassorbimento e rigenerazione delle forme soggettive che dà luogo all'archivio, precedendo dunque ogni dualismo tra interiorità ed esteriorità. Ne consegue che il datum documentale non è un atomo, ma un'unità differenziata, ibrida, divisa originariamente nei suoi elementi giuridici, etici, politici ed esistenziali. Ma se Nancy richiama esplicitamente Derrida, intreccia altresì un dialogo “silenzioso” con Foucault, per il cui pensiero, com'è noto, la nozione di archeologia è di primaria importanza. Dal suo punto di vista, l'archivio permette di chiarire il nesso tra sapere e potere che si manifesta in ogni discorso: in questo senso, l'archivio non è soltanto il luogo fisico dove rinvenire tutte le informazioni su uno o più autori, ma «il sistema generale della formazione e della trasformazione degli enunciati.» In altre parole, secondo Foucault l'archivio si pone a metà strada tra il trascendentale e l'empirico, dà luogo a un ordine terzo rispetto al puramente ideale - la ragione come archetipo perfetto dell'archivio - e all'assolutamente empirico, sciolto da ogni regola discorsiva.
Pelgreffi, da tale confronto con Derrida emerge che il soggetto non è diviso tra due mondi, quello interno e quello sociale, ma è preso nel processo di riassorbimento e rigenerazione delle forme soggettive che dà luogo all'archivio, precedendo dunque ogni dualismo tra interiorità ed esteriorità. Ne consegue che il datum documentale non è un atomo, ma un'unità differenziata, ibrida, divisa originariamente nei suoi elementi giuridici, etici, politici ed esistenziali. Ma se Nancy richiama esplicitamente Derrida, intreccia altresì un dialogo “silenzioso” con Foucault, per il cui pensiero, com'è noto, la nozione di archeologia è di primaria importanza. Dal suo punto di vista, l'archivio permette di chiarire il nesso tra sapere e potere che si manifesta in ogni discorso: in questo senso, l'archivio non è soltanto il luogo fisico dove rinvenire tutte le informazioni su uno o più autori, ma «il sistema generale della formazione e della trasformazione degli enunciati.» In altre parole, secondo Foucault l'archivio si pone a metà strada tra il trascendentale e l'empirico, dà luogo a un ordine terzo rispetto al puramente ideale - la ragione come archetipo perfetto dell'archivio - e all'assolutamente empirico, sciolto da ogni regola discorsiva.Questo duplice dialogo con Derrida e Foucault induce a evidenziare anche un altro fil rouge del testo di Nancy: la questione dell'alterità. Infatti, nell'istituzione dell'archivio è già sempre coinvolto l'altro, in modo tale che la domanda sull'archivio implica anche sempre la questione del rapporto tra archiviazione, estraneità e istituzione. Come ha osservato molte volte Derrida, qualunque processo di istituzione conserva una traccia di ciò che esclude, cioè di quell'estraneità che sceglie originariamente di estromettere dall'istituzione o dall'archiviazione. In sintesi, per dotarsi di una qualche identità, l'archivio, nell'atto della sua istituzione, è costretto a relazionarsi con ciò che sceglie di non archiviare. Deve nominarlo, assumerne le sembianze, in modo tale che può accadere che sia proprio l'escluso dall'archiviazione ad assumersi il compito di conservarne la memoria. Ora, tale intreccio irrisolto tra identità e alterità è continuamente rilanciato da Nancy in questo testo, ad esempio attraverso la questione “che cos'è un'opera?” - come nota il curatore, vero e proprio contrappunto alla domanda di Foucault “che cos'è un autore?”, oggetto di una conferenza al Collège de France del 1969.
Volendo individuare la tesi portante del discorso di Nancy, attorno a cui si annodano tutti i vari temi che egli affronta in questo breve testo, si potrebbe azzardare la seguente affermazione: l'archivio sottrae l'autore stesso a qualunque forma di sapere oggettivo. Il che significa che non si potrà mai raggiungere una qualche conoscenza definitiva e cogente di «chi è diventato questa firma che offre il suo nome, i suoi tratti, il suo carattere»all'archiviazione: quest'ultima resterà sempre un processo che non consente di afferrare concettualmente la natura del proprio rapporto con un certo autore, benché lo riguardi direttamente. In altre parole, chi è diventato l’autore, una volta che transita dal proprio archivio? Nancy risponde: «Nessuno che noi possiamo nominare o circoscrivere in alcun modo. “Gli archivi di X” sono un modo di far indietreggiare X più lontano, più in profondità nei suoi archivi. Noi vediamo i suoi tentativi, le sue note, le sue esitazioni, le sue vergogne forse, le sue dissimulazioni, i suoi oblii: ma lui, “lui”, dov’è?».
di Claudio Tarditi
-
 Quando Karl Marx si interrogò sul ruolo che la legge occupava nelle dinamiche della società moderna, scelse di risolverlo, come ben noto, negandole qualsiasi specifica autonomia: il diritto – come d’altronde la religione, la filosofia e la politica – non sarebbero nient’altro che il riflesso passivo, ossia una sovrastruttura, di quella concreta base economica che ben più attivamente si agita nel cuore della società. L’antica tradizione ebraica, di certo non sconosciuta allo stesso Marx, insegnava invece che la legge è stata data agli uomini perché questi la custodissero e la salvaguardassero dall’oblio, rendendo così tanto il Testo quanto la Voce dei suoi interpreti il suo sigillo imperituro. Chiunque osservi il funzionamento della società attuale, delle sue regole e dei suoi vincoli, dei suoi flussi e dei suoi varchi, può domandarsi se queste note affermazioni mantengano ancora qualcosa delle proprie antiche verità. Nella recente pubblicazione di Pier Giuseppe Monateri tali stringenti interrogativi si uniscono a un’analisi inedita e originale, in cui attraverso un approccio comparatistico si indaga sull’origine del fenomeno giuridico nella tradizione Occidentale e sugli effetti che le memorie normative suscitano negli attuali processi economici e produttivi.
Quando Karl Marx si interrogò sul ruolo che la legge occupava nelle dinamiche della società moderna, scelse di risolverlo, come ben noto, negandole qualsiasi specifica autonomia: il diritto – come d’altronde la religione, la filosofia e la politica – non sarebbero nient’altro che il riflesso passivo, ossia una sovrastruttura, di quella concreta base economica che ben più attivamente si agita nel cuore della società. L’antica tradizione ebraica, di certo non sconosciuta allo stesso Marx, insegnava invece che la legge è stata data agli uomini perché questi la custodissero e la salvaguardassero dall’oblio, rendendo così tanto il Testo quanto la Voce dei suoi interpreti il suo sigillo imperituro. Chiunque osservi il funzionamento della società attuale, delle sue regole e dei suoi vincoli, dei suoi flussi e dei suoi varchi, può domandarsi se queste note affermazioni mantengano ancora qualcosa delle proprie antiche verità. Nella recente pubblicazione di Pier Giuseppe Monateri tali stringenti interrogativi si uniscono a un’analisi inedita e originale, in cui attraverso un approccio comparatistico si indaga sull’origine del fenomeno giuridico nella tradizione Occidentale e sugli effetti che le memorie normative suscitano negli attuali processi economici e produttivi.Innegabilmente, vi fu un tempo nella storia del pensiero giuridico in cui la riflessione sulla norma non era soltanto oggetto di un pensiero tecnicistico o economicistico, ma al contrario interrogazione profonda sui meccanismi che governavano l’umano, il divino e lo spazio politico. Nel nuovo ordine mondiale, tuttavia, sembra che la scienza giuridica stia attraversando un processo di inesorabile declino, un lento tramonto che si acuisce vieppiù a causa della crescente predominanza di discipline “altre”, quali l’economia e la finanza, che nella loro costante rincorsa verso un nuovo paradigma di pensiero paiono sbarazzarsi con fermezza di qualsiasi scrupolo culturale.
Pier Giuseppe Monateri affronta criticamente la perdita di considerazione del fenomeno
 giuridico, compiendo una nuova e accurata riflessione genealogica sul medesimo, la quale si dimostra – proprio alla luce dell’attuale contesto neoliberista – emblematicamente necessaria. La tesi principale sostenuta dall’Autore è che in un mondo tendente ovunque all’uniformità politica ed economica, la legge persiste a differenziare e a contrassegnare i diversi corpi politici, formalizzandosi in un elemento di caratterizzazione che se a prima vista appare assente o mancante, si rivela in realtà quale matrice storica delle istituzioni occidentali. La legge, così prosegue l’Autore, possiede una riserva di senso più profonda della politica stessa e la prova di ciò consiste nel fatto che se nell’attuale crisi globale la sovranità appare disperdersi e la politica neutralizzarsi, proprio il fenomeno normativo mantiene al contrario la propria incatturabile identità, che si dispiega così nei luoghi, negli stili e nelle forme politiche dell’Occidente.
giuridico, compiendo una nuova e accurata riflessione genealogica sul medesimo, la quale si dimostra – proprio alla luce dell’attuale contesto neoliberista – emblematicamente necessaria. La tesi principale sostenuta dall’Autore è che in un mondo tendente ovunque all’uniformità politica ed economica, la legge persiste a differenziare e a contrassegnare i diversi corpi politici, formalizzandosi in un elemento di caratterizzazione che se a prima vista appare assente o mancante, si rivela in realtà quale matrice storica delle istituzioni occidentali. La legge, così prosegue l’Autore, possiede una riserva di senso più profonda della politica stessa e la prova di ciò consiste nel fatto che se nell’attuale crisi globale la sovranità appare disperdersi e la politica neutralizzarsi, proprio il fenomeno normativo mantiene al contrario la propria incatturabile identità, che si dispiega così nei luoghi, negli stili e nelle forme politiche dell’Occidente.Sintetizzando brevemente l’ampia analisi sviluppata nel testo, è oramai constatazione abituale suddividere i sistemi giuridici mondiali in due distinte famiglie: da un lato la tradizione giuridica di common law, diffusa soprattutto nei paesi anglosassoni, dall’altro quella di civil law, tipica al contrario della tradizione giuridica continentale di scuola romanista (Francia, Germania, Italia, Spagna).
Tale suddivisione – se interpretata nella particolare ottica efficientistica propugnata dal sistema WTO-FMI-Banca Mondiale – diviene immediatamente un fattore problematico. L’armonia potenzialmente “irenica” di una sola regola juris, paradiso in terra per la massimizzazione delle transazioni commerciali, è infatti bruscamente osteggiata proprio dalla persistenza di diverse culture giuridiche, di differenti (e antitetici) modi di statuizione delle regole, e – cosa che maggiormente interessa – di diversi linguaggi normativi nell’amministrazione della giustizia. Nei Diktat degli organismi internazionali, tuttavia, il diritto non può permettersi di essere vario: esso deve farsi uniforme.
Fu così, come illustra Pier Giuseppe Monateri, che si diede avvio a un’aspra lotta culturale, tutt’oggi in pieno svolgimento, testimoniata da alcuni rapporti emessi dalla Banca Mondiale nel 2004 e nel 2005. Tali report sancirono definitivamente l’inefficienza dei sistemi giuridici di origine romanista rispetto agli opposti modelli giuridici di common law, in ciò coadiuvati anche da quel movimento internazionalmente noto come Law and Finance, a sua volta propugnatore della diffusione del tipo anglosassone a discapito di quelli “rivali”.
Chiaramente, proprio sul punto della pretesa superiorità di una tradizione rispetto a un’altra tali correnti di pensiero mostrano vistosamente la più chiara debolezza. Ciò non soltanto in un’ottica – come si diceva – culturale, ma prim’ancora in una di tipo storico-narrativo.
Il percorso logico che Pier Giuseppe Monateri individua si giova, così, tanto della riflessione politica classica quanto di uno spiccato approccio letterario, teso alla critica delle procedura di sponsorizzazione delle regole giuridiche. Se infatti la globalizzazione ha come fine il dissolvimento puro e totale dei corpi politici con il preciso obiettivo di realizzare uno spazio politico liscio, privo di resistenze e dagli effetti sconfinati, occorre, come necessaria forma di critica, evidenziare proprio quelle differenze, quelle singolarità e quegli scarti che persistono nell’esistenza attuale di ciascuna tradizione normativa. Ciò diviene tanto più essenziale se si considera l’importanza di una decostruzione delle rappresentazioni offerte dalla Banca Mondiale, dal FMI e dal WTO, che sulla base di indagini genealogiche finalisticamente orientate operano per imporre un solo linguaggio globale.
Come sottolinea Pier Giuseppe Monateri, da questo passaggio emerge in realtà la vera “ragione” del contendere: essa non risulta più semplicemente la questione di quale tipo di regola giuridica da utilizzare, o di quale sistema di giustizia imbastire. La vera questione diviene quella sulla natura duale o unitaria dell’Occidente, ossia sul problema dell’esistenza o meno di due diversi modelli di società (come si ricordava, quello di civil law e quello di common law), e quindi anche di quale dei due rendere concretamente operativo su scala internazionale. Proprio attraverso questo varco, l’indagine dell’Autore da giuridica si fa geopolitica e ha il pregio di sviluppare una ricostruzione spaziale dei meccanismi di origine del politico tanto in Europa, quanto nel continente americano.
Certo, nella suesposta presa di posizione del WTO, ciò che emerge è la polemica concreta verso ogni forma di socialismo e di sovranità statale, oramai ampiamente messa in scena attraverso innumerevoli strategie. Secondo questa vulgata, il diritto continentale (in primis quello francese e quello dei suoi più stretti imitatori europei) viene considerato storicamente statalista, pertanto inadatto a garantire le flessibilità normative spesso richieste dai grandi investitori globali. Inoltre, la burocratizzazione della magistratura continentale – considerata completamente sottomessa agli ordini dello stato centrale –garantisce ancora diritti e privilegi che si oppongono strutturalmente all’operare dei mercati finanziari. Tuttavia, ciò che in realtà tali organismi sovranazionali mirano ad attaccare è proprio il politico nelle sue forme di manifestazione istituzionali; un attacco che viene condotto, per di più, attraverso la pretesa ricostruzione storica delle origini della legge.
In questo senso, diviene dunque fondamentale condurre un nuovo tipo di esame che si giovi anche degli strumenti della critica letteraria, della filosofia politica e della storia delle tradizioni giuridiche. In accordo con ciò, la nozione che nel saggio viene precisamente individuata è quella, giuridico-letteraria, di “stile” della tradizione. Lo stile, secondo la ricostruzione di Pier Giuseppe Monateri, non attiene ai fronzoli della scrittura, o alla sua composizione manieristica. Esso non indica nemmeno un semplice giudizio di gusto sulla bellezza o sulla piacevolezza di un determinata scrittura. Lo stile è in realtà una vera e propria ontologia che differenzia ciascun corpo politico nella sua rispettiva esistenza storica, marcando quindi lo spazio sconfinato neoliberale con precise striature che distinguono, interrompono e oppongono gli stati nazione. I diversi stili della legge e della giustizia sono, così, gli elementi pregnanti per una geopolitica del diritto in cui lo “spazio” diviene quella soglia attraverso cui la legge ottiene una determinata visibilità.
A primo avviso, ciò potrebbe sembrare assai distante dagli scopi del diritto comparato, inteso quale disciplina finalizzata esclusivamente a evidenziare le differenze dei molteplici sistemi giuridici e le rispettive regole operative. Eppure, ogni problema di diritto comparato è anche, in ultima istanza, un problema che investe il politico e la sua identità. Cos’è allora, oggi, il diritto comparato? In Europa, come si accennava, esso è un mezzo per realizzare un diritto unico (esemplarmente, il codice europeo); nell’esperienza statunitense è invece lo strumento che consente di creare ranking tra le diverse tradizioni giuridiche, le quali divengono così dei veri e propri “oggetti” forniti di indici e valori numerici. In breve, attraverso un certo uso della disciplina, si staglia netto il pericolo di una tentazione riduzionistica, che considera il complesso corpus politico e istituzionale di una nazione alla pari di un indice aritmetico incasellato in una classifica, passibile quindi di essere sostituito, cancellato e modificato senza particolari problematiche.
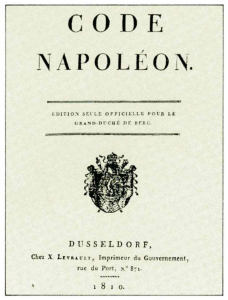 È su questo piano politico-giuridico che insiste, con rigore, l’opera di Pier Giuseppe Monateri. La nuova funzione che egli individua, infatti, è proprio quella del diritto comparato inteso appunto quale disciplina volta allo studio delle differenze e alla comprensione degli spazi nomici. Forse, è proprio attraverso tale passaggio che è possibile rilevare il vero paradosso della classificazione economicistica voluta dai grandi organismi sovranazionali: nonostante la preminenza dei modelli matematici e dei loro calcoli marginali, la legge continua a occupare il centro degli interessi economici odierni. L’idea che domina tali pratiche è che le riforme e il progresso siano possibili, dopotutto, soltanto attraverso riforme giuridiche. In questo senso, è allora il governo della legge, inteso come cattura del mezzo giuridico, a interessare alle grandi organizzazioni, e a spingerle così a scontrarsi e a imbastire narrazioni che mostrano, qualora accuratamente analizzate, il proprio fine affabulatorio. L'importante giurista statunitense Robert Cover scrive nell'articolo intitolato Nomos and Narrative (in “Harvard Law Review”, 97, 1983) che noi abitiamo una legge, un nòmos, e questo nòmos occupa sempre uno spazio specifico, che si volge quindi in spazio giuridicamente organizzato. Se lo spazio è allora quella soglia in cui la legge si rende visibile, tale forma di visibilità ricade proprio nella pratica degli stili in quanto rappresentazioni visibili della legge: il diritto comparato può allora divenire quella disciplina che conferisce un senso globale alla legge, disvelandone in ultima istanza la sua “misteriosa” presenza.
È su questo piano politico-giuridico che insiste, con rigore, l’opera di Pier Giuseppe Monateri. La nuova funzione che egli individua, infatti, è proprio quella del diritto comparato inteso appunto quale disciplina volta allo studio delle differenze e alla comprensione degli spazi nomici. Forse, è proprio attraverso tale passaggio che è possibile rilevare il vero paradosso della classificazione economicistica voluta dai grandi organismi sovranazionali: nonostante la preminenza dei modelli matematici e dei loro calcoli marginali, la legge continua a occupare il centro degli interessi economici odierni. L’idea che domina tali pratiche è che le riforme e il progresso siano possibili, dopotutto, soltanto attraverso riforme giuridiche. In questo senso, è allora il governo della legge, inteso come cattura del mezzo giuridico, a interessare alle grandi organizzazioni, e a spingerle così a scontrarsi e a imbastire narrazioni che mostrano, qualora accuratamente analizzate, il proprio fine affabulatorio. L'importante giurista statunitense Robert Cover scrive nell'articolo intitolato Nomos and Narrative (in “Harvard Law Review”, 97, 1983) che noi abitiamo una legge, un nòmos, e questo nòmos occupa sempre uno spazio specifico, che si volge quindi in spazio giuridicamente organizzato. Se lo spazio è allora quella soglia in cui la legge si rende visibile, tale forma di visibilità ricade proprio nella pratica degli stili in quanto rappresentazioni visibili della legge: il diritto comparato può allora divenire quella disciplina che conferisce un senso globale alla legge, disvelandone in ultima istanza la sua “misteriosa” presenza.Forse, è proprio in questi termini (come già rilevato da von Hayek) che è possibile abbozzare una conclusione: la legge è molto più ineffabile, molto più sublime e molto più ingovernabile di quello che crediamo. Essa non può divenire oggetto di ranking o di classifiche. Eppure, evitare la tentazione di ridurre il diritto a un oggetto misurabile non significa affatto affermarne l’inesistenza: al contrario, la legge esiste e ci governa molto più di quanto riusciamo noi stessi ad amministrarla. Ciò è tanto più curioso se si considera che spesso, nella tradizione giuridica di common law, i grandi commentatori ripetevano l’adagio per cui il giudice, nell’atto di decidere, “scopre” la legge. Ironicamente, considerare la legge come esistente ben al di là degli oggetti che la presentificano è proprio l’idea di fondo che si oppone al modello della disponibilità assoluta voluta dagli apparati finanziari: un’idea, come si sarà notato, che è tratta da quella stessa cultura giuridica che la Banca Mondiale e il FMI vorrebbero invece imporre al globo intero.
Il merito ultimo del saggio di Pier Giuseppe Monateri è allora quello di illustrare le diverse immagini della legge che continuano, inesorabilmente, a segnare le differenze e gli scarti all’interno dell’attuale spazio globale. Solo con un’effettiva e rinnovata conoscenza di tali meccanismi, uniti a un approccio critico e vigile verso gli stringenti Diktat internazionali, sarà forse possibile smascherare le narrative mendaci e le subliminali pratiche egemoniche del nuovo ordine neoliberale.
di Mauro Balestrieri