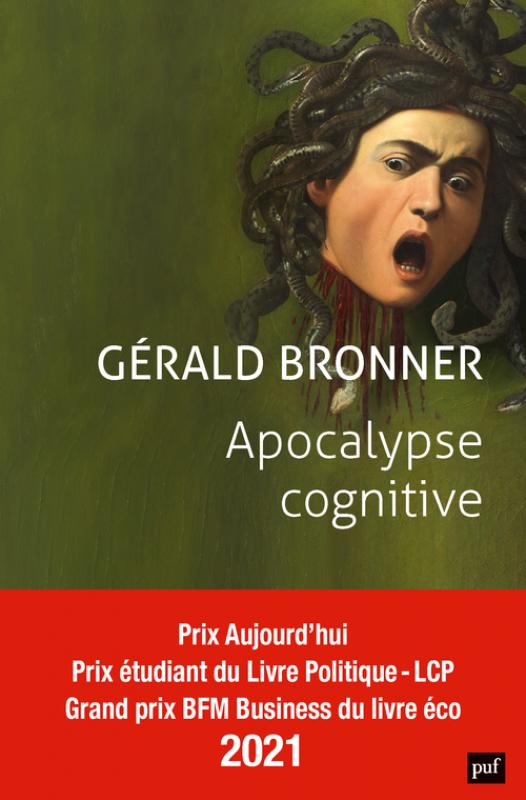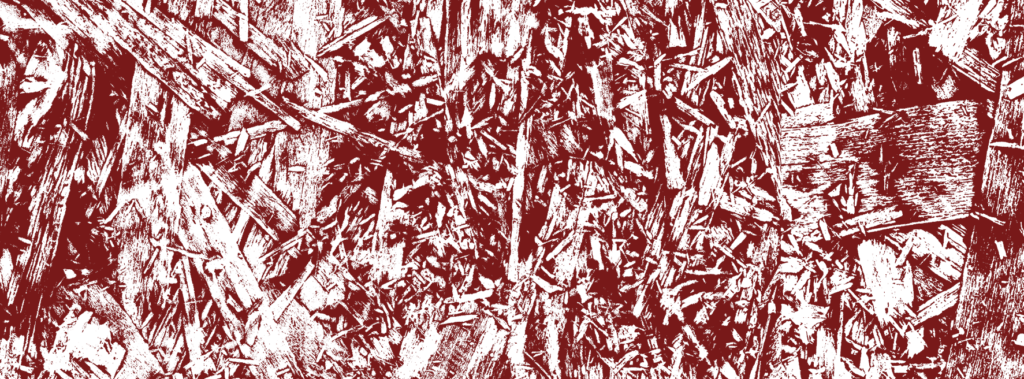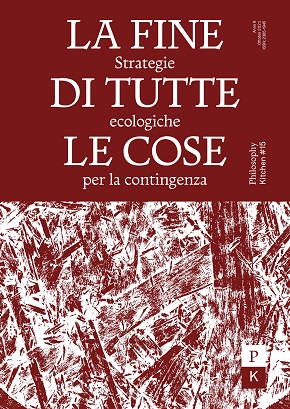“Quando l’Agnello aprì il quarto sigillo, udii la voce del quarto essere vivente che diceva: “Vieni”. Ed ecco, mi apparve un cavallo verdastro. Colui che lo cavalcava si chiamava Morte e gli veniva dietro l’Inferno.”
Apocalisse (6, 7-8)
-
-
Ernesto De Martino: un’altra fine del mondo
Recensioni / Gennaio 2020“Qui dit crise te dit monde”
Paul Van Haver Quella proposta da Einaudi con la riedizione de La fine del mondo di Ernesto De Martino, è un’operazione editoriale coraggiosa e assolutamente singolare. Pubblicato inizialmente nel 1977, il volume ci consegna riflessioni che De Martino (1908-1965) fu costretto a interrompere da una morte prematura, e che andavano allora concentrandosi sul tema escatologico della fine del mondo, inteso tanto nella sua dimensione storico-culturale – le “apocalissi culturali” di cui fa menzione il sottotitolo – quanto nel suo angoscioso orizzonte individuale – proseguendo il tema, già lungamente indagato in precedenza dall’autore, della “crisi della presenza”. Più che un libro, quello edito già allora da Einaudi era un cantiere nel quale il lettore veniva invitato a intrufolarsi e rovistare, prezioso archivio a cielo aperto del confronto corpo a corpo tra De Martino e il tema angoscioso su cui egli era giunto a concentrare le proprie ricerche – corpo a corpo del quale Clara Gallini, sua allieva a Cagliari, si sarebbe sobbarcata il compito decennale di selezionare e raccogliere le carte sparse, dando alla luce nel 1977 la prima edizione del volume (riproposta poi nel 2002 corredata da una nuova introduzione). Oggi, la casa editrice torinese ci presenta, volta all’italiano, la traduzione francese del volume pubblicata nel 2016 dalle edizioni dell’EHESS. Sarebbe estremamente riduttivo, tuttavia, parlare di quella francese come di una mera traduzione del testo originale italiano – e a farlo si perderebbe di vista la menzionata unicità di questa nuova Fine del mondo. I curatori – Giordana Charuty, Daniel Fabre e Marcello Massenzio – ne hanno piuttosto disposto una riedizione, accompagnata passo a passo da una serie di seminari, che li ha visti reimmergersi nell’archivio demartiniano per ricomporre nuovamente questo libro impossibile, rivedendo il canone istituito dalla prima edizione, con l’obiettivo di farci tutti, così, “divenire suoi contemporanei” (Charuty 2019, 29).
Quella proposta da Einaudi con la riedizione de La fine del mondo di Ernesto De Martino, è un’operazione editoriale coraggiosa e assolutamente singolare. Pubblicato inizialmente nel 1977, il volume ci consegna riflessioni che De Martino (1908-1965) fu costretto a interrompere da una morte prematura, e che andavano allora concentrandosi sul tema escatologico della fine del mondo, inteso tanto nella sua dimensione storico-culturale – le “apocalissi culturali” di cui fa menzione il sottotitolo – quanto nel suo angoscioso orizzonte individuale – proseguendo il tema, già lungamente indagato in precedenza dall’autore, della “crisi della presenza”. Più che un libro, quello edito già allora da Einaudi era un cantiere nel quale il lettore veniva invitato a intrufolarsi e rovistare, prezioso archivio a cielo aperto del confronto corpo a corpo tra De Martino e il tema angoscioso su cui egli era giunto a concentrare le proprie ricerche – corpo a corpo del quale Clara Gallini, sua allieva a Cagliari, si sarebbe sobbarcata il compito decennale di selezionare e raccogliere le carte sparse, dando alla luce nel 1977 la prima edizione del volume (riproposta poi nel 2002 corredata da una nuova introduzione). Oggi, la casa editrice torinese ci presenta, volta all’italiano, la traduzione francese del volume pubblicata nel 2016 dalle edizioni dell’EHESS. Sarebbe estremamente riduttivo, tuttavia, parlare di quella francese come di una mera traduzione del testo originale italiano – e a farlo si perderebbe di vista la menzionata unicità di questa nuova Fine del mondo. I curatori – Giordana Charuty, Daniel Fabre e Marcello Massenzio – ne hanno piuttosto disposto una riedizione, accompagnata passo a passo da una serie di seminari, che li ha visti reimmergersi nell’archivio demartiniano per ricomporre nuovamente questo libro impossibile, rivedendo il canone istituito dalla prima edizione, con l’obiettivo di farci tutti, così, “divenire suoi contemporanei” (Charuty 2019, 29).Una consapevolezza ha accompagnato la cura de La fine del mondo sin dalla prima edizione: non sarebbe stato possibile ‘completare’ il progetto per cui De Martino aveva cominciato gli scavi, e portare a compimento le intenzioni dell’autore; si poteva solo presentarne gli appunti, invitando il lettore, per così dire, a navigarli. Ed è questa consapevolezza che si trova riproposta, e rivendicata, anche in questa nuova edizione, che fa tesoro della storia del volume e ne segna una nuova decisiva tappa. Il setaccio della traduzione, la lingua nuova a cui è stato proposto di ospitare l’intricato testo demartiniano, è colta quale occasione per rilavorare le struttura del volume, reinterrogando i criteri che avevano soprinteso alla prima selezione dei materiali, e rinnovando in tal modo l’attualità dell’opera. Non, come si diceva, al fine di chiudere il cantiere, presentarlo in forma finalmente definitiva, risolverne gli enigmi e le contraddizioni: quanto piuttosto per manifestarne nuovamente l’evento e proporci d’incontrarlo daccapo.
Gli scritti sparpagliati – appunti, note di lettura, piani di progetti futuri, che talvolta evolvono in paragrafi più consistenti di cui l’edizione curata da Gallini ci presentava le faticose riscritture successive – raccolti in questo volume trovano sistematicità nella radicalità del tema che li chiama a raduno: la fine del mondo. Mondo e crisi sono temi su cui De Martino aveva lavorato sin dagli anni Quaranta: dapprima su fonti etnologiche di seconda mano, nel Mondo magico (1948), nel quale la consistenza del mondo è indagata là dove essa è il prodotto del sortilegio; e poi etnograficamente, con la trilogia meridionalista (Morte e pianto rituale, del 1958; Sud e magia, del 1959; e La terra del rimorso, del 1961), per raccontare un mondo, al cuore del nostro – le “Indias de por acá” –, che recalcitrava ad arrendersi di fronte al progetto razionalizzante della modernità. A questo mondo, De Martino guardava non con la nostalgia di che innervava in quegli anni tanta antropologia, bensì con la ferma decisione di non sottrarsi al dramma – esistenziale e politico al tempo – di questo stentato finire. “Carmela balla. Venite” (De Martino 2013, 115) è il grido, impossibile da sopire, che aveva animato l’intrufolarsi di De Martino nei mondi agonizzanti, e che pur parevano resistere alla traiettoria lineare della modernizzazione, della magia del Mezzogiorno italiano; un grido che lo aveva investito dell’urgenza e della responsabilità del suo ruolo di ricercatore, e sulla scia del quale anche il progetto incompiuto de La fine del mondo è da comprendersi.

Questo progetto, cui sarebbe toccato agli eredi dell’etnologo napoletano dar forma, conduceva De Martino lontano da scene esotiche, vicine o lontane che fossero da un punto di vista strettamente geografico, per aprire invece una breccia al cuore della modernità occidentale stessa, al fine di mostrare come il dramma dell’apocalisse risieda anche lì. Esso vi risiede, anzi, in una condizione che, nel panorama etnologico scandagliato dall’autore, ha dell’eccezionale: credendo di assicurare il mondo, i moderni ne hanno invece, da un lato, moltiplicato le capacità distruttive (aprendo il campo, che da allora ha saputo solo ampliarsi, della “fine del mondo come gesto tecnico della mano” [De Martino 2002, 119]), mentre dall’altro deridevano – o alternativamente “tolleravano” (Stengers 2005) –, credendo di ‘spiegarli’, i molteplici dispositivi di cui le comunità umane non occidentali – e “nonmoderne” (Latour 1995) – si erano dotate per avervi a che fare. L’analisi conduceva De Martino a una conclusione: l’apocalisse dei moderni è apocalisse senza eschaton, priva di un orizzonte di reintegrazione possibile. Nelle parole dell’autore: “il momento dell'abbandonarsi senza compenso al vissuto del finire costituisce innegabilmente una disposizione elettiva della nostra epoca” (De Martino 2019, 355). Di fronte a questa constatazione, tuttavia, l’autore non cercava un posizionamento che della modernità tentasse di disfarsi. Anche i tratti che del pensiero demartiniano sono stati tacciati d’intrattenere un flirt con l’irrazionalismo, in questo senso, sono da apprezzarsi in realtà quali esperimenti – esistenziali e scientifici al tempo – realizzati lungo il percorso che doveva condurlo a elaborare la proposta di un nuovo umanesimo, “etnografico”, di cui l’etnologia veniva proposta quale animatrice fondamentale.
Insomma, davanti alla crisi che investiva il mondo moderno e occidentale, e che nel proprio nel presentarsi “nuda e disperata” trovava il suo carattere specificamente moderno, De Martino non si arrendeva alla contemplazione. Lo sforzo in cui l’autore si produceva nel progetto de La fine del mondo era piuttosto clinico, terapeutico: il compito che gli si parava dunque di fronte – e di cui gli scritti consegnatici rimangono, pur nella loro densità e ampiezza di respiro, esercizio preliminare – era quello di “individuare l’esatto significato dei sintomi, l’estensione del contagio, il condizionamento della malattia, le forze della guarigione” (De Martino 2019, 356). Nei preparativi a questo compito, freudianamente “impossibile”, de Martino convocava risorse molteplici: l’antropologia, certo, e con essa la filosofia e la storia delle religioni, al crocevia delle quali l’autore si era formato sin dagli inizi della propria carriera intellettuale; ma insieme a quelle anche la psichiatria fenomenologica di marca tedesca, la psicoanalisi, la storia, la riflessione marxista, cui gli appunti raccolti ne La fine del mondo sono costellati di rimandi puntualissimi. Così, il volume letteralmente emerge dalle letture dell’autore; commenti fugaci, note di lettura, osservazioni a caldo si sviluppano in paragrafi densi, che approcciano il tema escatologico nei contesti più disparati: nel fragile mondo sorretto dal celebre campanile di Marcellinara, in Calabria, per esempio; nella filosofia della storia marxista, di cui De Martino individua una vera e propria apocalittica; nei movimenti millenaristici in diffusione all’epoca nel Sud del mondo, di cui De Martino coglieva appieno la portata anticoloniale; oppure nelle “apocalissi psicopatologiche”, di cui il documento clinico, minuziosamente analizzato da De Martino, dischiudeva l’originalissimo campo d’analisi.
Come accennato, l’edizione curata da Gallini esponeva la fatica di quel labor limae, impossibile da ridurre a mero sforzo stilistico, tramite cui De Martino rinegoziava minuziosamente, nelle scritture successive, il proprio posizionamento di fronte ai problemi che di volta in volta lavorava. Questa nuova versione, invece, rinuncia all’apertura sinottica sugli strati successivi dello scavo, preferendo selezionare di volta in volta una singola versione di ciascun paragrafo. Il beneficio, da lettori, è evidente: abbiamo a che fare con un testo che ci si presenta come definito, ‘deciso’, e il suo procedere risoluto di fronte ai temi trattati si staglia con più nettezza rispetto al contesto di provvisorietà e parzialità da cui il progetto, bruscamente interrotto dalla morte di De Martino, rimane caratterizzato. Una scelta, questa, che va compresa all’interno della storia di questo volume; scelta, cioè, che non ‘corregge’ la precedente, producendo un’edizione finalmente definitiva di questo testo travagliato; ma che la supplementa, invece, predisponendosi per ereditarne nella maniera più proficua. Rimane infatti lungo l’insieme della sua storia – storia inevitabilmente aperta – più che in ciascuna delle sue singole versioni editoriali – nella vicenda, cioè, di una sintesi che, pur necessaria, non può mai compiersi per davvero – che la potenza speculativa de La fine del mondo può dispiegarsi appieno.
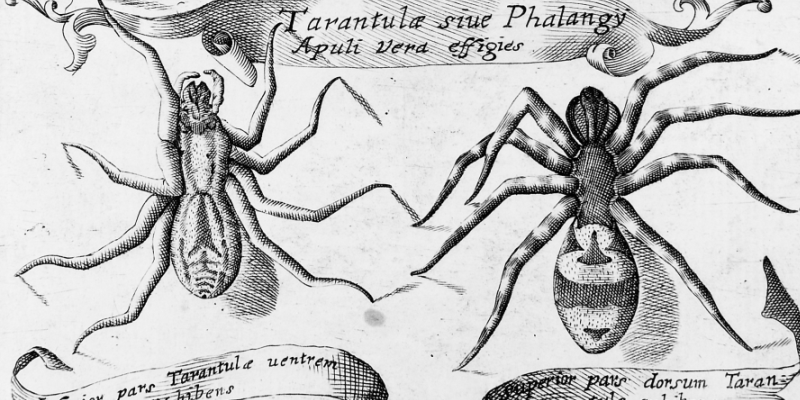
Archivio Ernesto De Martino È sufficiente leggere qualche paragrafo de La fine del mondo per rendersi conto di come il corpo a corpo che De Martino vi intrattiene con l’apocalisse, il suo rischio e le sue lavorazioni esistenziali e culturali non rimanga confinato al solo piano intellettuale. De Martino – che sempre si muove, proprio come pretendeva di essere trattato dai suoi interlocutori, da “persona intera” – si pone di fronte al rischio della fine (al “rischio di non poterci essere in nessun mondo culturale possibile”, secondo una celebre formula che ricorre più volte nel libro) con tutto il suo corpo: lo avverte e lo combatte, lo analizza e vuole disinnescarlo. La lucidità dell’argomentazione non cede mai il passo ai vezzi di una prosa pure a tratti barocca e per il lettore odierno antiquata, e soprattutto non deriva all’autore dallo sforzo di allontanare da sé l’oggetto della propria ricerca, quanto piuttosto dal riconoscerne e accettarne l’intima prossimità – una prossimità di cui, si è ipotizzato, era forse complice l’epilessia di cui soffriva, che costante gli ricordava la fatica della presenza e il perenne rischio della sua crisi.
Crisi del mondo e crisi della presenza sono infatti una crisi sola: crisi di quella soglia, ogni volta rinegoziata, che presenza e mondo istituisce come realtà distinte, piano di consistenza – “magia” avrebbe detto De Martino (1948; cfr. Leoni 2012) – che si spezza. Ecco allora che l’intimità di questa crisi, la precarietà di questa soglia, forza l’autore a una prosa lontana da quelle “equivoche castità del sedicente discorso oggettivo” (De Martino 2002, 91) che pretendono il mondo sia là fuori, solido, risolvibile, garantito. Per la persona intera che De Martino è, insomma, il mondo è affare indistinguibilmente epistemologico ed esistenziale: ‘ontologico’, a voler trovare una parola sola, non priva, per gli antropologi, di un’eco contemporanea.
Sotto la scorza di un gergo evidentemente influenzato in maniera decisiva da Heidegger, e proprio perciò a lungo ritenuto obsoleto, allora, si celano in realtà, nelle pieghe del discorso demartiniano, intuizioni perfettamente contemporanee, e che nella loro contemporaneità ancora attendono di essere sviluppate appieno: il mondo è fatto, istituito, patchy – ha bisogno di cure. A seguire queste intuizioni, l’avventura intellettuale cominciata con Il mondo magico e che si compie, pur senza compiersi, con La fine del mondo sembra invocare, naturale, una messa in dialogo con studiose e studiosi che in anni recenti hanno eletto la questione ecologica a sfida politico-esistenziale-epistemologica decisiva del presente, e che proprio sotto il segno della sua essenziale precarietà hanno iniziato a interrogare la consistenza del mondo (per esempio Stengers 2009; Tsing 2015; Danowski e Viveiros de Castro 2017; Latour 2019).
Quelle che condurrebbero a questo dialogo, sono tracce che, dobbiamo constatare, rimangono inesplorate anche nei pur validissimi testi critici che corredano questa nuova edizione. La fine del mondo, però, l’abbiamo già detto, è un testo che non si lascia leggere passivamente; se questi nuovi testi introduttivi – insieme a quelli classici di Clara Gallini e Marcello Massenzio che avevano accompagnato le edizioni precedenti del volume – sono essenziali nel porgerci questo libro-archivio nella sua viva complessità, rendendoci possibile incontrarlo, essi ci ricordano anche che, con un calembour, un’altra Fine del mondo è possibile – e spetta a noi immaginarla.
Opere citate:
Charuty, G. (2019), “‘Tradurre’ La fine del mondo”, in De Martino (2019), 5-29.
Danowski, D. e Viveiros de Castro, E. (2017), Esiste un mondo a venire? Saggio sulle paure della fine, Nottetempo, Milano.
De Martino, E. (1948), Il mondo magico. Prolegomeni a una storia del magismo, Einaudi, Torino.
De Martino, E. (2002), Furore Simbolo Valore, Feltrinelli, Milano.
De Martino, E. (2013), La terra del rimorso, il Saggiatore, Milano.
De Martino, E. (2019), La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali, a cura di G. Charuty, D. Fabre e M. Massenzio, Einaudi, Torino.
Latour, B. (1995), Non siamo mai stati moderni. Saggio di antropologia simmetrica, elèuthera, Milano.
Latour, B. (2019), Essere di questa terra. Guerra e pace al tempo dei conflitti ecologici, a cura di N. Manghi, Rosenberg & Sellier, Torino.
Leoni, F. (2012), “La magia degli altri, e la nostra. Ernesto de Martino e le tecniche della presenza”, in Paradigmi. Rivista di critica filosofica, XXXI, 2, 67-78.
Stengers, I. (2005), Per farla finita con la tolleranza, in Id., Cosmopolitiche, Luca Sossella Editore, Roma, 599-729.
Stengers, I. (2009), Au temps des catastrophes. Résister à la barbarie qui vient, Les Empêcheurs de penser en rond/La Découverte, Paris.
Tsing, A. (2015), The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins, Princeton University Press, Princeton (NJ).di Nicola Manghi
-
Manifesto Cyborg. Ieri e oggi
Recensioni / Dicembre 2018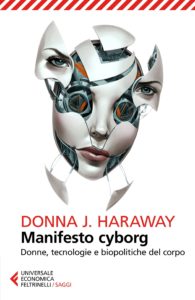 La nuova edizione di Manifesto cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo (Feltrinelli, 2018) raccoglie tre saggi di Donna Haraway, teorica femminista e storica della scienza allieva di Georges Canguilhem. I saggi in questione sono stati pubblicati la prima volta nel 1991, in Italia nel 1994, all’interno di una raccolta dal titolo Simians, Cyborgs and Women. The Reinvention of Nature (Routledge). L’importanza della riedizione di un testo considerato ormai un classico può ricercarsi nella necessità di rivalutare la portata teorica e filosofica della riflessione di Haraway, portata che fino ad ora sembra essere stata scarsamente considerata. Ciò che andrebbe messo in discussione è un inquadramento “specialistico” del testo, che lo vorrebbe di interesse unicamente per chi si occupa di “questioni legate al genere” e, ancora più nello specifico, per chi nella cornice degli studi di genere riflette sui problemi della scienza e della tecnologia. Nella rivalutazione delle implicazioni teoretiche di Manifesto Cyborg è in gioco, più in generale, la riconsiderazione dell’importanza filosofica dei cosiddetti studi di genere e postcoloniali, che normalmente trovano legittimazione solo se inseriti nella cornice dei cultural studies. Il testo di Haraway eccede queste cornici disciplinari, e con le sue incursioni “spregiudicate” nel terreno delle scienze biologiche, biomediche e delle teorie dei sistemi, può essere considerato un’argomentazione a favore della contaminazione come importante strumento di produzione e creatività teorica.
La nuova edizione di Manifesto cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo (Feltrinelli, 2018) raccoglie tre saggi di Donna Haraway, teorica femminista e storica della scienza allieva di Georges Canguilhem. I saggi in questione sono stati pubblicati la prima volta nel 1991, in Italia nel 1994, all’interno di una raccolta dal titolo Simians, Cyborgs and Women. The Reinvention of Nature (Routledge). L’importanza della riedizione di un testo considerato ormai un classico può ricercarsi nella necessità di rivalutare la portata teorica e filosofica della riflessione di Haraway, portata che fino ad ora sembra essere stata scarsamente considerata. Ciò che andrebbe messo in discussione è un inquadramento “specialistico” del testo, che lo vorrebbe di interesse unicamente per chi si occupa di “questioni legate al genere” e, ancora più nello specifico, per chi nella cornice degli studi di genere riflette sui problemi della scienza e della tecnologia. Nella rivalutazione delle implicazioni teoretiche di Manifesto Cyborg è in gioco, più in generale, la riconsiderazione dell’importanza filosofica dei cosiddetti studi di genere e postcoloniali, che normalmente trovano legittimazione solo se inseriti nella cornice dei cultural studies. Il testo di Haraway eccede queste cornici disciplinari, e con le sue incursioni “spregiudicate” nel terreno delle scienze biologiche, biomediche e delle teorie dei sistemi, può essere considerato un’argomentazione a favore della contaminazione come importante strumento di produzione e creatività teorica.Fin dalle prime pagine di Manifesto Cyborg è chiara l’urgenza teorica e politica che muove la riflessione dell’autrice: la necessità per il femminismo socialista e in generale per gli allora nuovi movimenti di sinistra di ripensarsi, alla luce del confronto con le profonde trasformazioni globali che segnavano il contesto dell’elezione di Reagan alla presidenza degli Stati Uniti negli anni ’80. Il cyborg, protagonista dell’opera, rappresentava provocatoriamente quella peculiare “creatura” contraddistinta da un’intrinseca necessità di evadere ogni forma di pensiero dicotomico, ogni forma di razionalità strutturata intorno a stringenti dualismi, in favore di un nuovo punto di vista in grado di rendere conto di una realtà infinitamente complessa ed eccedente che il suo stesso apparire metteva prepotentemente alla ribalta. A quasi trent’anni di distanza, in cui la modalità dominante di gestione della complessità (sociale, psichica, politica, scientifica) sembra ancora rimanere il riduzionismo, in cui lo scenario pare ancora caratterizzato dal riproporsi di un pensiero dicotomico e dall’intensificarsi delle logiche di dominazione patriarcale, razzista e capitalista connaturate a esso, provare a immaginare un modello di razionalità che non evade la complessità ma che se ne fa carico non si rivela meno urgente. La posta in gioco è l’elaborazione di modalità alternative e sfaccettate di gestione della complessità, rifiutando quindi anche quel pensiero che vedrebbe nella postmodernità il terreno in cui si consuma la crisi della razionalità dominante che non lascia spazio a null’altro se non alla contingenza e alla “differenza” irriducibile, intese come negazione dell’elaborazione teorica e della prassi. Manifesto Cyborg riapre invece con forza l’elaborazione teorica, etica e politica, al cuore della postmodernità e lo fa oggi non meno di ieri.
Lo sguardo attraverso cui Haraway analizza le trasformazioni che segnano il suo tempo è quello che deriva dalla sua storia in quanto biologa: in particolare, l’autrice mette in luce la profonda rielaborazione e ripensamento della biologia in relazione all’emergere di nuovi saperi, quali la cibernetica, le teorie dei sistemi, le scienze della comunicazione e dell’informazione.
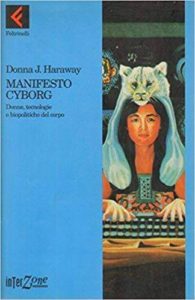 Il ripensamento della biologia in seguito alla contaminazione con nozioni, teorie e concetti provenienti da queste scienze è stato profondo al punto che, secondo Haraway, si può sostenere che l’“organismo” biologico, come oggetto della scienza, abbia cessato di esistere, e sia stato sostituito da sistemi di comunicazione completamente denaturalizzati. Gli organismi sono quindi diventati artefatti, sempre contingenti, le cui modalità di costruzione non sono vincolate da nessun’architettura naturale. Contemporaneamente, le macchine hanno preso vita: se quelle pre-cibernetiche potevano essere ancora distinte dagli organismi in quanto pensate e costruite dall’uomo, le macchine cibernetiche rendono completamente ambigua la distinzione tra autosviluppo e progettazione esterna (p.43).
Il ripensamento della biologia in seguito alla contaminazione con nozioni, teorie e concetti provenienti da queste scienze è stato profondo al punto che, secondo Haraway, si può sostenere che l’“organismo” biologico, come oggetto della scienza, abbia cessato di esistere, e sia stato sostituito da sistemi di comunicazione completamente denaturalizzati. Gli organismi sono quindi diventati artefatti, sempre contingenti, le cui modalità di costruzione non sono vincolate da nessun’architettura naturale. Contemporaneamente, le macchine hanno preso vita: se quelle pre-cibernetiche potevano essere ancora distinte dagli organismi in quanto pensate e costruite dall’uomo, le macchine cibernetiche rendono completamente ambigua la distinzione tra autosviluppo e progettazione esterna (p.43).Le ondate di denaturalizzazione e de-essenzializzazione che secondo N. Katherine Hayles definiscono il postmodernismo hanno quindi investito anche i corpi biologici: se le prime teorizzazioni degli organismi come sistemi cibernetici riposavano ancora su una concezione olistica e mantenevano intorno a questi un certo involucro, le teorie sociobiologiche di uno scienziato dalla sensibilità postmoderna come Richard Dawkins hanno radicalizzato questa tendenza, rompendo definitivamente con i paradigmi olistici e ripensando l’individualità biologica come costrutto contingente ad ogni livello. Come mettono in luce le escursioni di Haraway nel territorio delle moderne biologie della comunicazione, i processi di decostruzione e ricostruzione dei corpi occupano il centro del discorso, non solamente dal punto di vista del critico culturale o dell’archeologo delle scienze umane, ma anche dello scienziato postmoderno: le biologie moderne si occupano di tecnologie d’inscrizione e codici, di processi di disassemblaggio e riassemblaggio, di sistemi di controllo altamente tecnologizzati. La centralità delle tecnologie di scrittura emerge in modo evidente se si considerano i lauti investimenti direzionati a progetti come quello di mappatura e ricostruzione del genoma umano. Questo progetto emblematizza un “umanesimo postmoderno” in cui la ricerca biologica segnata dalla rilevanza sempre maggiore delle tecnologie d’inscrizione è messa al servizio della tradizionale ideologia umanista e del sogno ad essa associato di poter finalmente definire l’umano, di poter finalmente tracciare un confine netto e chiaro, privo di ambiguità e porosità tra il sé e il non-sé.
Il cyborg, segnalando importanti cedimenti di confine come quello tra macchina e organismo e tra umano e animale, si presenta come figurazione non dicotomica della nostra realtà sociale e corporea, che consente quindi di rompere con i dualismi che hanno strutturato la razionalità occidentale: naturale/artificiale, natura/cultura, uomo/donna, mente/corpo, materia/forma, umano/animale, soggetto/oggetto. Come ci ricorda Haraway, queste non sono mai solo opposizioni dicotomiche: attraverso questi dualismi, la razionalità occidentale ha intrecciato il suo destino a pratiche di dominio e di oppressione legate al genere, alla razza e alla specie.
D’altra parte, il cyborg in occidente è anche espressione di una cultura maschilista e guerrafondaia, che concepisce la vulnerabilità che contraddistingue la dimensione corporea come segno di una “mancanza” costitutiva, a cui far fronte attraverso un progressivo miglioramento delle strategie di difesa. Se le individualità cyborg sono per definizione contingenti e instabili, l’immagine della corsa agli armamenti e della guerra perenne lascia trasparire in filigrana il “telos apocalittico” (p. 41) di un sé finalmente libero da ogni forma di dipendenza. La realizzazione di un sé autonomo e integro, che ha “disassemblato” e digerito ogni forma di eterogeneità e alterità si accompagna al dispiegamento di un apparato di controllo diffuso e capillare, che Haraway indica come “informatica del dominio” (p. 55). Con questa figurazione si vogliono mappare i nuovi inquietanti meccanismi di controllo che attraversano il nostro tempo: alle gerarchie che contraddistinguono il “patriarcato capitalista bianco” (p. 57) si sostituisce un sistema polimorfo e reticolare, che agisce attraverso l’allacciamento di connessioni multiple. Ai vecchi sistemi di controllo centralizzato si sostituisce la delocalizzazione, la decentralizzazione, la diffusione e la moltiplicazione dei centri.

Ma il cyborg è anche un costrutto femminista, e in questo senso elicita possibilità oppositive e liberatorie. Cyborg è quel particolare oggetto di conoscenza e pratica femminista, l’esperienza delle donne, che proprio in quanto fatta oggetto di sapere, è ricostruita come aperta, non finita, contestata, vulnerabile, presa in un gioco di perenne decostruzione e riscrittura. Haraway a questo proposito da particolare importanza ai processi di decostruzione e di de-naturalizzazione che hanno interessato il femminismo in seguito al prendere voce di quelle soggettività, come le donne nere, che sfuggono al sistema di categorie attraverso cui i teorici e le teoriche occidentali hanno tentato di rappresentare il mondo degli oppressi. Questi processi hanno consentito al soggetto femminista di riarticolarsi lungo assi inediti, di immaginare e di praticare nuove forme di unità e di identità al di fuori dell’impianto dicotomico e oppositivo che ha strutturato i miti politici occidentali. La critica post-coloniale ha ricostruito le identità femministe come identità sempre parziali, contraddittorie e problematiche, definite dal non poter essere naturalizzate o essenzializzate. Haraway legge in questo senso la Sister outsider della poetessa nera Audre Lorde (p. 74), ovvero come ricostruzione letteraria dell’identità attraverso l’esclusione, la non appartenenza in quanto eccedenza rispetto a categorie prestabilite. Le identità ricostruite nelle pratiche di scrittura delle donne di colore sono identità sempre contraddittorie e frantumate, prive del privilegio dell’identità a sé, prerogativa dei corpi non marcati come quelli maschili e bianchi. Se i processi decostruttivi e de-essenzializzanti impediscono di radicare la politica nelle identità “naturali”, questo non significa che sia stata minata radicalmente la possibilità di legami: la loro ricostruzione implica politiche dell’affinità, che non ripristinano unità naturali, ma non per questo impediscono legami (parziali ma potenti) e comunità per soggetti postmoderni.
Con l’elaborazione della nozione di “saperi situati” Haraway si inserisce in un altro dibattito che attraversa il femminismo: il rapporto con l’epistemologia e la scienza e, strettamente connesso a questo, il dibattito circa lo statuto dell’oggetto di conoscenza. Proponendo “saperi situati” Haraway intende pensare una versione femminista di oggettività scientifica, che consenta di uscire dalla polarizzazione del dibattito attuale, caratterizzato dal contrapporsi di posizioni radicalmente costruzioniste ed empiriste. La rielaborazione della nozione di oggettività che Haraway propone si appoggia a un ripensamento della metafora della visione. Se quest’ultima ha significato, nella storia della razionalità occidentale, la capacità di alcuni corpi (quelli maschili, benestanti e occidentali) di “smaterializzarsi” in uno sguardo venuto dal nulla mentre si inscrivevano i corpi marcati nel mito, con la nozione di saperi situati assume un significato opposto. L’oggettività e la visione non significano più neutralità e distanza, ma corporeità, parzialità, localizzabilità, impegno e coinvolgimento. (p. 115) L’oggettività ha a che fare non con la scoperta distaccata, ma con la strutturazione reciproca e di solito ineguale; solo saperi parziali, vulnerabili e impegnati garantiscono una conoscenza oggettiva, ovvero che non sia un’illusione. Oggettività e visione non segnalano più un “trucco da dio”, che consente di scomparire arrogandosi il potere di rappresentare senza essere rappresentati, ma diventano modi per stare nel corpo, pratiche di assunzione corporea.

In How we became posthuman, Katherine Hayles sostiene che l’affermarsi di quell’entità chiamata informazione si sia accompagnata a processi di “smaterializzazione” dei corpi, di progressivo abbandono e trascendimento dei vincoli della materialità. L’approccio di Haraway ai mondi alto-tecnologici mostra una realtà più complessa: i corpi radicalmente decostruiti e ricostruiti dalle moderne biotecnologie e dalle scienze informatiche non comportano tanto la smaterializzazione di questi in puri flussi informativi, problemi di codifica e di ricerca di un linguaggio comune che permetta la perfetta comunicazione. Anche l’informazione per Haraway ha una specifica dimensione materiale, così come i testi e i codici, che dovrebbero venire ripensati attraverso la nozione di embodiment. Facendo riferimento alla dimensione corporea, Haraway non si riferisce quindi a una dimensione prettamente biologica: le tecnologie di visualizzazione sono ripensate come sistemi di percezione attivi, nelle quali siamo immersi e con le quali siamo inestricabilmente intrecciati nella costruzione di specifiche forme di vita: un aspetto del nostro embodiment.
Il ripensamento della nozione di corporeità consente ad Haraway di riprendere e al tempo stesso di andare oltre l’analisi biopolitica inaugurata da Michael Foucault, ovvero dell’analisi che fa del corpo l’entità bioculturale per eccellenza e che consente di indagare i rapporti di potere che si concentrano direttamente sul soggetto in quanto entità corporea. La decostruzione della corporeità come sistema di comunicazione tecnologico consente di indagare gli effetti del biopotere oltre la sfera organismica: oggetto delle relazioni di potere non è più un corpo organico e organizzato gerarchicamente, ma sistemi cibernetici completamente decostruiti, assemblaggi ricomposti in modo sempre parziale, costrutti contingenti. Le biopolitiche che interessano corpi ricostruiti come sistemi di comunicazione non sono quelle del sesso e della riproduzione, ma dell’immunità, legate ai processi di replicazione di un sé estremamente vulnerabile e contingente (p.159). Quali tipi di sé vengono costruiti dal discorso sul sistema immunitario? L’intento di Haraway è di risignificare il paradigma immunitario: da dispiegamento di una guerra diffusa e capillare, in cui la replicazione del sé è funzione delle sue strategie di difesa e di attacco di fronte a una minaccia costante di “invasione”, a sistema che “apre” il sé e lo mantiene aperto. In quanto dispiegamento di una rete capillare di blackout e crolli delle comunicazioni, di confusione di confini, il sistema immunitario continuamente “disfa” il sé, mantenendolo contraddittorio ed eterogeneo, impedendone la chiusura e l’autonomizzazione. In questa dimensione riposa la “promessa illegittima” (p. 42) del cyborg: la sua natura artefatta, saltando il gradino dell’unità originaria, impedisce la realizzazione del suo telos apocalittico. In quest’ottica, inoltre, la differenza irriducibile con cui obbligano a fare i conti la postmodernità e i processi a essa inestricabilmente connessi, come quelli di decolonizzazione, non segnala tanto la “morte del soggetto”, come vorrebbero alcuni, ma piuttosto ci costringe a ripensare il soggetto come non isomorfico, auto-contraddittorio e multidimensionale.
di Ambra Lulli