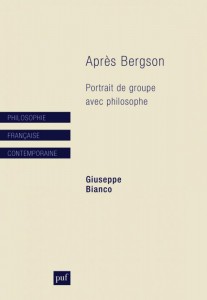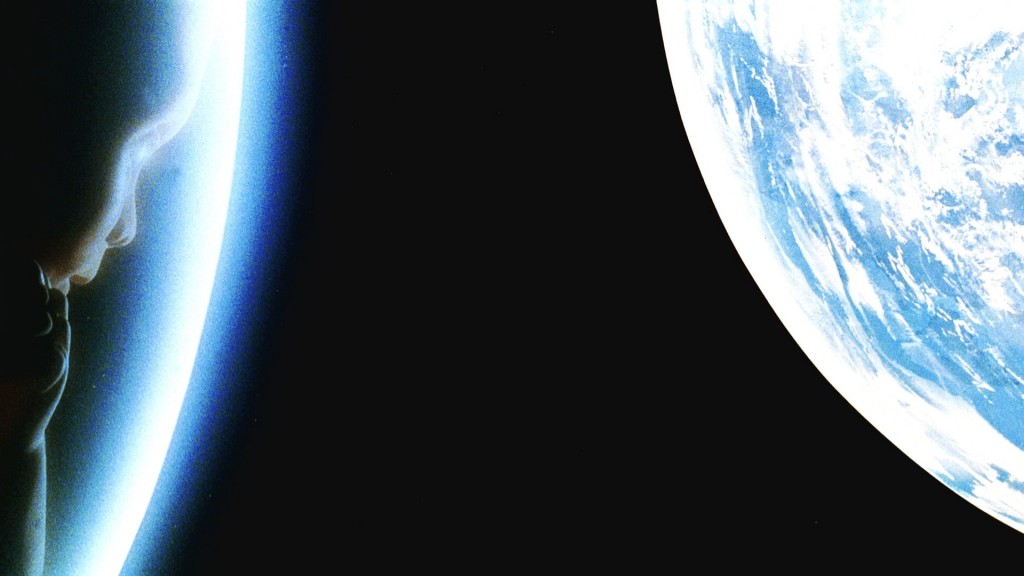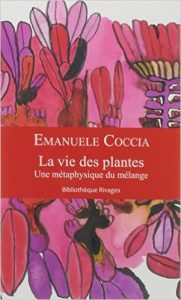 La problematizzazione dell’antropocentrismo è ormai uno dei topoi più frequentati della letteratura filosofica (come culturale, sociologica, ecologica, ecc.) contemporanea, al punto che – facendo il verso al noto Linguistic Turn del Novecento – si è recentemente preso a parlare in modo esplicito di un Non-Human Turn (R. Grusin). Non è questa l’occasione per discutere portata e natura di una simile “svolta”, né tantomeno per valutare il modo in cui è stata tradotta e soprattutto gli slogan che appare avere generato: bisogna comunque notare che, di fatto, si è giunti a una situazione in cui l’anti-antropocentrismo si è declinato pressoché univocamente in una forma di zoocentrismo, o – se si preferisce – in un vitalismo pensato a partire dall’equazione “vita = organismo (animale)”.
La problematizzazione dell’antropocentrismo è ormai uno dei topoi più frequentati della letteratura filosofica (come culturale, sociologica, ecologica, ecc.) contemporanea, al punto che – facendo il verso al noto Linguistic Turn del Novecento – si è recentemente preso a parlare in modo esplicito di un Non-Human Turn (R. Grusin). Non è questa l’occasione per discutere portata e natura di una simile “svolta”, né tantomeno per valutare il modo in cui è stata tradotta e soprattutto gli slogan che appare avere generato: bisogna comunque notare che, di fatto, si è giunti a una situazione in cui l’anti-antropocentrismo si è declinato pressoché univocamente in una forma di zoocentrismo, o – se si preferisce – in un vitalismo pensato a partire dall’equazione “vita = organismo (animale)”.
Sotto questo riguardo, il libro di Coccia (La vie des plantes. Une métaphysique du mélange, Payot & Rivages, Paris 2016) ha un innegabile merito: mettere in discussione questo più o meno esplicito slittamento dal “non umano” all’“animale”, e non certo per riaffermare la preminenza dell’uomo o dell’organismo umano, bensì per indicare la possibilità di una genuina metafisica o filosofia della natura. Con ciò, Coccia non si limita a sostenere le ragioni di quel Plant Turn che pur richiama (p. 155), ossia a reclamare spazio per quelli che sono già stati prontamente battezzati come Critical Plant Studies (H. Stark), che fanno anche diventare a pieno titolo le piante protagoniste di una “storia naturale” – a partire dalla loro origine, il seme (J. Silvertown).
Infatti, la posta in palio è filosofica ad ampio raggio: è possibile trovare un accesso al problema della vita, ossia della natura e del cosmo, che non sia inficiato da una forma di «snobismo metafisico» (p. 15) per cui si finisce per assumere come superiore e privilegiato il punto di vista supposto essere più “complesso”? La risposta di Coccia è radicale: è possibile se si dismette l’abito zoocentrico che ha rivestito quello antropocentrico, ossia se si comprende che l’antispecismo non ha fatto altro che estendere il narcisismo umano al regno animale (p. 16).
L’esito è a questo punto conseguenziale (senza dubbio problematico, come indicherò): andare ancora più a fondo e “riabilitare” quello che è stato da sempre ritenuto il grado più basso della vita, ai limiti della sua assenza, ossia la “vita vegetativa”, il regno vegetale. In questo modo, si potrà riconoscere che ogni punto di vista (point de vue) non è altro che un punto di vita (point de vie): non qualcosa di distaccato e separato, ma quanto esprime una modalità di immersione e commercio.
Per Coccia, c’è una ragione ben precisa a rendere praticabile questa riabilitazione: la vita vegetale si presenta come la vita nella sua esposizione integrale, in continuità assoluta e in comunione globale con l’ambiente. Le piante sono esseri di pura superficie, che aderiscono costitutivamente al mondo: la loro assenza di movimento fa tutt’uno con la loro adesione integrale a ciò che arriva a loro e al loro ambiente. Le piante sono insomma inseparabili (fisicamente come metafisicamente: il passaggio filosofico avanzato da Coccia sta tutto qui) dal mondo che le accoglie: rappresentano la forma più intensa, radicale e paradigmatica dell’essere al mondo, perché intrattengono il legame più stretto ed elementare con il mondo, quasi una forma di assorbimento contemplativo privo di dissociazioni, una fusione e una coincidenza prive di separazioni (pp. 17-18).
Troviamo in opera – esplicitato – un importante presupposto di fondo: il pensiero si fa filosofico nel momento in cui si confronta con la natura del mondo, ossia con la natura, vale a dire che la filosofia sorge nel mondo naturale e dal confronto col mondo naturale, inteso come nascitura, come ciò che permette a tutto di nascere e divenire, esprimendosi in tutto ciò che è. Il mondo, la natura, è insomma una forza, non un insieme di cose o una totalità astratta di esseri: la natura è un processo in atto, e la filosofia è tale soltanto in quanto è filosofia della natura, solo nel momento in cui smette di essere «fisiocida» per cogliere la natura nella sua veste dinamico-processuale. L’unica forma di filosofia che può essere considerata legittima è insomma la cosmologia (pp. 31-36).
L’idea di Coccia è semplice (nonché nuovamente problematica, lo vedremo), come tutte le idee fondamentali: vivere significa vivere della vita d’altri, o – persino – esigere la relazione con ciò che precede e rende possibili gli organismi stessi (pietre, acqua, aria, luce), e le piante sono paradossalmente il luogo in cui questo fatto – il fatto della vita – si manifesta eminentemente. Se la natura è un campo aperto di relazioni trasformative, il metabolismo e il trofismo delle piante presentano esattamente l’emblema della capacità di fare di elementi dispersi e disparati un’occasione di consistenza e tenuta: le piante sono cosmogonia in atto (p. 22).
La pianta diventa così il “modello” per un generale ripensamento dell’essere al mondo e così della cosmologia, articolato in tre principali momenti.
1) La foglia consente di mettere a fuoco l’atmosfera come fluidità cosmica o luogo metafisico di mescolanza radicale in cui tutto comunica e si tocca. L’atmosfera è il soffio o respiro che tutti condividiamo, inteso quale movimento ritmato che precede le distinzioni e però le rende possibili, essendo il principio di circolazione, trasmissione e traduzione: tutto è dentro tutto e tutto comunica con tutto; ogni cosa è immanente a ogni altra; non c’è azione senza retroazione. La cosmologia è una pneumatologia (pp. 37-96).
2) Le radici permettono di ribaltare il modo in cui intendiamo il fondamento: non il ritrovamento di ciò che vi è di essenziale e originario (di fondamentale, di radicale, appunto), ma la fecondità di un processo di networking. Siamo insomma abituati a pensare al radicamento come all’emblema del riferimento saldo, dell’ergersi a partire da un principio dato e ben fermo, dell’edificarsi al di sopra di una base solida, di un suolo sicuro, mentre in realtà le radici ci presentano un dinamismo ambiguo, ibrido, anfibio e doppio. Si tratta di quello della ramificazione, che mette in comunicazione “il basso” e “l’alto”, il “più profondo” e il “più superficiale”, la notte e il giorno, la Terra e il Sole. È allora in gioco una prospettiva più eliocentrica che geocentrica, che fa spazio alle ragioni della contingenza, dell’imprevisto, dell’irregolarità e dell’inabitabilità. La cosmologia è un’astrologia, l’ecologia è un’uranologia (pp. 97-122).
3) I fiori fanno comprendere la natura puramente espressiva e dimostrativa (sessuale) degli attrattori, ossia di ciò che non definisce una natura o comunica un’essenza, bensì apre uno spazio di congiunzione e mescolamento, di moltiplicazione e variazione di forme – di alterazione. La logica dell’organismo individuale si rovescia: ci si trova nel pieno dell’esposizione alle possibilità della mutazione, del cambiamento (come della morte), nel pieno dell’espropriazione. La razionalità si converte nella ragione seminale, che si presenta come luogo di indifferenza e transizione tra “psichico” e “materiale” (come tra biologico e culturale, intensivo ed estensivo). In questo modo, la ragione diventa una forza moltiplicativa che “ripete” la stessa dinamica trasfiguratrice del cosmo: non restituisce un esistente a se stesso, attestandone l’identità, non riconduce a unità; piuttosto, apre al rinnovamento dei possibili, potenzia le connessioni, moltiplica e differenzia gli elementi, si sforza di mescolare gli incomparabili e gli incompossibili. La ragione è sessuale nella misura in cui fa tutt’uno con il processo attraverso il quale avviene un prolungamento e un rinnovamento delle sue istanze mediante un’invenzione di nuove forme di mescolamento: pensare significa rivolgersi alla sfera delle apparenze, non per rivelarne l’interiorità o per dirne l’essenza, bensì per metterle in comunicazione nella loro eterogeneità. La cosmologia è una cosmetica (pp. 123-138).

Come si sarà colto da questo rapido affresco, in chiave concettuale abbiamo a che fare con una generale problematizzazione del nesso tra forza e relazione, o tra dinamismo effettivo e pura soglia. Troviamo infatti discusso in generale il superamento di una gerarchia topologica che distingue tra luoghi in base a interiorità ed esteriorità, che pone posizioni fisse e non riesce così a cogliere – per esempio – le compenetrazioni e proiezioni reciproche, la reversibilità, le transizioni, l’immersione senza resti, la fluidità cosmica, la permeabilità, l’inclusione di tutto dentro tutto, l’amalgama perfetto, l’immediatezza della metamorfosi, l’intimità assoluta, i mediatori produttivi, la circolazione universale, l’identità formale tra passività e attività e tra essere e fare, l’esistenza come atto cosmogonico, le interpenetrazioni e influenze diffuse.
Un simile tentativo metafisico, com’è naturale, non solo non nasconde, ma fa anzi presto affiorare in superficie i propri tratti problematici (e non: le proprie contraddizioni), che mi sembrano essere principalmente due.
Il primo si potrebbe ribattezzare il rischio di “vegetocentrismo” o “plantocentrismo”, che di per sé è abbastanza chiaro: perché le piante offrirebbero l’accesso privilegiato al cosmo rispetto agli uomini e agli animali, e non potrebbero a quel punto farlo i sassi, o i batteri, e così via? O, detta altrimenti, siamo davvero sicuri che sia possibile prendere il fenomeno della vita come fenomeno per eccellenza cosmologico o cosmogonico? Insomma, fino a che punto la natura coincide con la vita (sappiamo infatti che non è così)? Queste questioni possono sembrare oziose, e il punto forse ancora più dirimente sta altrove: non è che le piante, più che essere la forma paradigmatica dell’essere al mondo, sono la forma paradigmatica di un determinato modo di essere al mondo? In particolare, qualcuno potrebbe notare, la totale aderenza, la completa immersione, la spiccata fluidità. la piena indistinzione tra “sé” e “mondo” che contraddistinguerebbero le piante, sembrano rappresentare l’affermazione di un orizzonte in cui non ci si può distinguere dal proprio ambiente e non si può modificarlo, ossia di una vita vegetativa nel senso (deleterio) comune del termine. Ancor più, qualcuno direbbe che si tratta dell’ipostatizzazione della forma di vita neoliberale o neocapitalistica o capitalista tout court, incentrata sull’esigenza di un adeguamento assoluto agli imperativi della flessibilità, della mobilità, della relazionalità, della deindividualizzazione, e via discorrendo.
Sotto questo punto di vista, l’uranologia di Coccia, nel suo sforzo di emanciparsi dalla subordinazione alla logica terrestre, mostra in effetti un fianco debole. Di per sé, si potrebbe anche sostenere che in realtà la condizione contemporanea (al di là dell’etichetta con cui si sceglie di connotarla) non fa altro che (finalmente) rivelare dei tratti che da sempre hanno fatto parte della realtà umana o naturale, liberandosi di una postura demistificatrice rispetto ai processi in atto. Ma, allora, bisogna proprio per questo anche evitare di assumere acriticamente come posizioni metafisiche “pure” ciò che altro non è che il tentativo di rendere concepibile un dato orizzonte, ossia di “trasporlo” in concetti adeguati a comprenderlo o figurarlo. Altrimenti, il rischio è di presentare idee e concetti filosofici come se piovessero dal cielo, mentre essi sono davvero un fatto relazionale, che concerne il nostro rapporto con il mondo. Detta diversamente, non si tratta tanto di imputare a Coccia di aver terminato per offrire una lettura apologetica dell’esistente, bensì – al limite – di evidenziare che non si è ancora spinto fino in fondo nel riconoscere la ramificazione (a valle come a monte) dei concetti e problemi a partire da cui articola la propria prospettiva.
Il secondo tratto problematico è correlato: riguarda il modo in cui intendere e praticare la conoscenza in generale e la filosofia in particolare. Coccia assume una posizione ben delineata in merito (pp. 141-151): il regionalismo specialistico è animato da intenti “morali” (ossia organizzativi, istituzionali, ordinativi, disciplinari, corporativi, ecc.) più che gnoseologici, e produce di fatto una limitazione della volontà di sapere, una messa a freno degli eccessi della curiosità. In questo modo, si perderebbe di vista il fatto che cose e idee sono molto meno disciplinate degli uomini: si mescolano di continuo, in modo eterogeneo, disparato e imprevedibile. Di conseguenza, la filosofia dovrebbe rapportarsi a esse senza mediazioni disciplinari e canoni normalizzanti, senza procedure, protocolli e metodi prestabiliti, senza lo scopo di ricondurle a un’unità superiore, alla comunanza di una forma, una natura o un ordine. La filosofia cercherebbe di cogliere e restituire quell’unità senza fusione sostanziale che è il clima, l’atmosfera, ossia il mondo, nel quale niente è ontologicamente separato dal resto – anzi, dovrebbe creare tale unità: la filosofia dovrebbe con ciò svolgere un’operazione di autotrofia speculativa, per cui anziché trarre nutrimento sempre ed esclusivamente da idee e verità che hanno già ricevuto il sigillo ufficiale di una qualche disciplina, anziché costruirsi a partire da elementi cognitivi già strutturati e ordinati, si devono invece trasformare in idee materie, oggetti o eventi di qualsiasi tipo. Proprio come fanno le piante, capaci di trasformare in vita qualsiasi frammento di terra, aria e luce: «una cosmologia proteiforme e liminare, indifferente ai luoghi, alle forme, alle maniere in cui viene praticata» (p. 147).
Ora, questa concezione “meteologica” o “atmosferica” della filosofia, per la quale essa è una sorta di condizione atmosferica che può sorgere all’improvviso in ogni luogo e momento, ha senza dubbio un elemento di rilevanza: suggerire che la filosofia dovrebbe essere considerata non come la costruzione di un campo di conoscenza specifico superiore che si “sovrimpone” su altri campi, ma come un costante movimento di sorvolo, ogni volta attento a tutto ciò che sta accadendo e mutando nel campo della ragione e della conoscenza, per giungere a modificare il modo in cui idee e conoscenze si concatenano e i saperi sono attraversati. Insomma, Coccia ha – a mio parere – il merito di ricordare che la filosofia deve essere coraggiosa, e accettare di essere impegnata nell’attraversamento concettuale del mondo, non nel commento di libri, nella discussione di soggetti astratti, nella ripresa di argomenti tradizionali, facenti perlopiù parte di un canone riconosciuto come “propriamente filosofico”. Ed è persino brillante quando osserva che la filosofia non potrà mai essere una disciplina per la semplice ragione che è ciò che diventa il sapere una volta che si è riconosciuto che non c’è nessuna disciplina – morale come epistemologica – possibile, nessuna dottrina scolastica da sancire.
Né, va aggiunto, ci si deve lasciare distrarre dai toni del discorso e dalle sfumature retoriche per connotarla come una posizione “irrazionalista” o “letteraria”, perché si tratta di una visione che anche un filosofo strettamente analitico come R. Casati ha presentato (lasciando ora da parte le evidenti diversità tra i due approcci): la filosofia come pratica “artistica” diffusa ovunque e pronta ad affiorare nel momento in cui occorre e viene sollecitata una qualche forma di negoziazione concettuale che permetta di attraversare diversi punti di vista o pratiche o discipline.
Ciononostante, resta sempre vero – cosa che l’esposizione di Coccia sembra lasciare troppo sullo sfondo – che non può esservi tale «autotrofia speculativa» senza un lavoro faticoso e certosino di rifinitura concettuale, rischiaramento tematico, affinamento problematico e articolazione sistematica, pena il pericolo di esaurire l’elaborazione in prese di posizione accorate ma euforiche, convinte ma entusiastiche, originali ma fideistiche.
In definitiva, questo lavoro di Coccia, al di là di un certo – si può letteralmente dire – afflato “pantemistico” (una sorta di mistica a sfondo panteista, per intenderci), pone delle questioni filosofiche che non possono essere ignorate, e le pone portandole ai loro esiti più estremi, forse proprio per questo esprimibili prevalentemente in termini più evocativi e in senso lato poetici – soprattutto se pensiamo alle circostanze biografiche e personali che hanno mosso l’autore (gli studi in un liceo agricolo e la scomparsa del fratello gemello nel pieno della giovinezza).
Ma, appunto, ciò non toglie che siano temi che hanno una notevole portata filosofica. Prendiamo per esempio il fatto decisamente banale della presenza del mio corpo nel mondo: esso segna i miei confini rispetto al mondo, mi individua, fa sì che sia proprio “io” a essere nel “mondo”. Eppure, da un certo punto di vista (lo notava già Whitehead), dove cominciano i confini del “mio” corpo, in realtà sta cominciando la natura in me, il mondo in me, sta cioè cominciando il mio essere del mondo (che il corpo sia “naturale” significa semplicemente questo). Il lavoro di Coccia consente di esplicitare molto bene l’insieme di aspetti connessi a una simile condizione: ormai è persino scontato riconoscere che non si può separare l’uomo dalla natura, come la mente dal corpo, ma una simile affermazione quanto può essere presa alla lettera? Che cosa davvero può significare? Essere in rapporto significa che non c’è distinzione? Detta sinteticamente, lo snodo filosofico che si profila è affermare il legame di tutto con tutto e insieme lo slancio della forza differenziatrice: le cose effettivamente si separano, ma lo fanno soltanto perché sono in rapporto.
Si potranno dunque imputare al lavoro di Coccia i limiti sopra riscontrati, ma un testo filosofico – alla fine – merita tanta più considerazione quanto più rende possibile l’articolazione di problemi al contempo genuini e difficili: sotto questo prospetto, questo libro dunque va decisamente tenuto in conto e preso come termine di confronto.
di Giacomo Pezzano