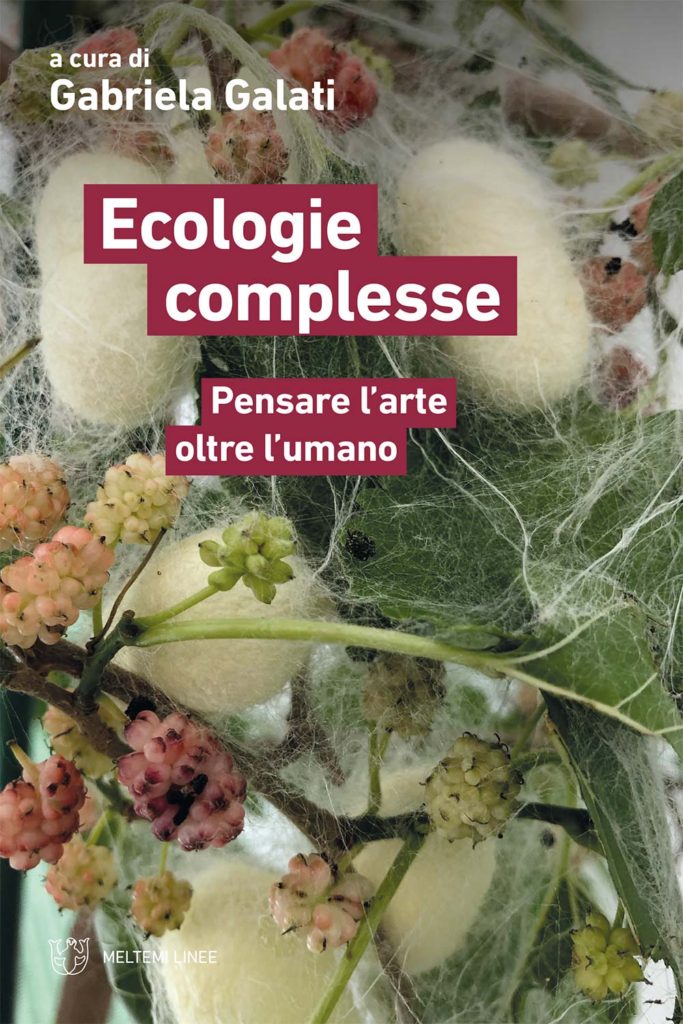Ciò che più si avvicina all’idea di consapevolezza ecologica è un senso di intimità, piuttosto che il senso di appartenere a qualcosa di più grande: la sensazione di essere vicini, anche troppo vicini, ad altre forme di vita, di averle sottopelle. (Timothy Morton)
I saggi raccolti nella pubblicazione Ecologie complesse. Pensare l’arte oltre l’umano (Meltemi, 2021) a cura di Gabriela Galati, tracciano possibili strade per accordarsi al non-umano, offrendo spunti per un superamento della visione antropocentrica che riguarda nello specifico l’arte, la pedagogia, la musica, la pratica curatoriale e quella archivistica.
La raccolta si apre con “Il curatore animale”, testo in cui Edith Doove propone un curioso rovesciamento di prospettiva: esplorare l’attività umana della curatela di mostre come pratica animale, collocando l’essere umano a livello dell’animale e non viceversa. L’esempio citato dall’autrice è quello dell’uccello giardiniere che assembla rami per costruire pergolati, decorandoli con materiali e scarti variopinti. Diversi zoosemiotici riconoscono infatti che alcuni uccelli hanno un senso estetico, sia visivo sia musicale, che permetterebbe di rompere la presa antroposemiotica sull’arte (G. Genosko, 2002). Questo spostamento è proposto dall’autrice attraverso un’analisi della questione del linguaggio, passando per Jacques Derrida e Cary Wolfe, per approdare al concetto di infrasottile - una presenza che c’è ma sfugge -derivato da Marcel Duchamp e qui suggerito come possibile approccio all’alterità: uno strumento per “vedere artisti e curatori come uccelli”. Il concetto di infrasottile in relazione al mondo animale non-umano mi riporta agli studi sul mimetismo di Roger Caillois. Tra i comportamenti classificati dall’accademico francese, il mascheramento (differenziato dal travestimento e dall’intimidazione) è individuato come l’atteggiamento attraverso il quale l’animale giunge a confondersi con l’ambiente. Particolarmente suggestivo è il caso delle conchiglie della famiglia Xenophoridae (xénos, straniero, estraneo; phéro, portatore) la cui caratteristica è quella di inglobare altri gasteropodi, bivalvi, sassolini e detriti vari, raccolti sul fondo del mare, assumendo su di sé elementi dell’ambiente circostante. Il gasteropode Xenophora attua un comportamento mimetico le cui finalità rimangono ipotetiche, certa è invece l’intenzionalità – potremmo dire la cura - con cui l’animale unisce e dispone sul proprio corpo i materiali scelti.
Non stupisce che sia proprio la tecnica del collage a caratterizzare la ricerca artistica di Eva Kot’átková (Praga, Repubblica Ceca, 1982) citata nel saggio di Federica Fontana: l’artista assembla e ricombina materiali - frammenti di corpi, animali, elementi architettonici, oggetti, sogni – aprendo uno spazio su mondi non antropocentrici. La ricerca di Eva Kot’átková esplora le dinamiche di controllo e di istruzione, il potenziale comunicativo dei gesti e il mondo infantile, trasformando spesso forme oppressive (dispositivi contenitivi o correttivi) in espressive. La capacità di creare e diffondere conoscenza attraverso la comunicazione è da sempre considerata una facoltà esclusiva dell’uomo: l’educazione è ciò che ha distinto l’uomo dal resto del vivente. Federica Fontana suggerisce alcune strade per un decentramento antropologico al fine di sostenere una pedagogia postumanista, che richiede innanzitutto una nuova concezione di soggettività. Il saggio Per un’educazione non antropocentrica. Elementi di postumanesimo nell’arte di Eva Kot’átková ne delinea i tre aspetti fondamentali: la crisi del soggetto-persona, un’inclusione del non umano che non sia più subordinante o strumentale ma paritetica e interconnessa, e una prospettiva che tenga conto delle relazioni simboliche e materiali che l’uomo instaura con ambiente e oggetti. L’idea che sostiene tutte queste teorie è quella di un’educazione concepita come «un assemblaggio socio-materiale complesso e imprevedibile di umano e non umano che genera effetti di strutturazione e de-strutturazione della personalità» (A. Ferrante, 2013). Emblematico in questo senso è il processo di umanizzazione di utensili di uso quotidiano che Eva Kot’átková propone attraverso il lavoro Theatre of speaking objects (2013), un’installazione di oggetti in grado di comunicare con la voce.
L’idea di oggetto come entità transitoria e mutevole è parte della ricerca artistica di Pierre Huyghe (Parigi, 1962), la cui produzione espositiva è concepita come una presentificazione, un esaudirsi, di sistemi viventi: la mostra diviene un organismo pulsante su cui l’artista cessa di avere controllo, aprendo all’incidentale e all’imprevisto. Nel saggio L’esposizione oltre l’umano, coesistenza e simpoiesi nel lavoro di Pierre Huyghe, Vincenzo Di Rosa indaga quella “grammatica” dell’exhibition-making in grado di superare l’antropocentrismo e di abbracciare una forma di relazionalità pienamente postumana. L’autore definisce innanzitutto il concetto di mostra come “dispositivo” in grado di generare un vero e proprio potere espositivo, attraverso la capacità di modellare e orientare l’esperienza spettoriale. Ripercorrendo la definizione di “regime di separazione” di Dorothea Van Hantelmann, come netta opposizione tra soggetti e oggetti all’interno dello spazio-mostra, Vincenzo Di Rosa individua le premesse che hanno condotto a un modello antropocentrico dell’esposizione. Emblema di questo regime è il white-cube modernista, basato sull’esclusione del mondo esterno e sull’annullamento della relazione spazio temporale. La decostruzione del “regime di separazione” è possibile mediante un’opposizione non più gerarchizzata tra i vari elementi dell’esposizione e assegnando al soggetto-spettatore solo un posto tra gli altri (D. V. Hantelmann, 2011). Vincenzo Di Rosa individua nella produzione espositiva dell’artista francese un esempio di superamento del “regime di separazione” e di affermazione di una “scrittura ecologica”, in cui si realizza un generale principio di coesistenza tra entità. La pratica di Huyghe mi consente un breve collegamento con quella “pedagogia del non volere” (Daniel Charles, 1972) argomentata e sperimentata da John Cage attraverso il tema del lasciar-essere, sostenendo un distacco progressivo nei confronti della volontà. Nel settembre 1958 Cage avvia la stesura di un testo per un convegno a Bruxelles, che concepisce come una conferenza di soli aneddoti della sua vita (l’idea è di leggere ciascuna storia in un minuto):
«Mettendo insieme questi aneddoti in maniera non programmata, intendevo suggerire che tutte le cose, le storie, i suoni casuali dell’ambiente, e per estensione gli esseri, sono collegati, e che questa complessità è più evidente quando non è ipersemplificata da un’idea che alberga nella testa di una persona».
Questa riflessione, applicata a qualsiasi interrelazione tra entità, consente di esprime quella condizione di coesistenza su cui si edifica anche il lavoro di Pierre Huyghe, definito da Vincenzo Di Rosa come «un universo senza cose, un enorme campo di eventi a intensità variabile».
Potremmo dire che gli artisti tentano una riconfigurazione dell’esistente permettendoci di accedere a nuove possibilità di relazione con l’altro da noi. Quale ruolo assume la materia all’interno di questo processo di riconfigurazione? Alberto Micali e Nicolò Pasqualini, nel saggio Estetica Posthuman. Percezione e relazionalità, mappare il campo tramite la lente del postumanesimo critico, propongono un approccio all’ambito delle pratiche artistiche da una posizione postumanista attraverso un’analisi guidata dai concetti di relazionalità e percezione.
«Il nostro principale obiettivo è quello di proporre una narrazione, un percorso di possibilità, una mappa per un’estetica posthuman. Una mappa che sia capace di intuire le modalità chiave mediante cui, nel processo artistico-creativo, la materia non-umana trasmuti in un componente attivo e co-determinante anziché passivo e accessorio».
Citando l’indagine di Donna Haraway e di Karen Barad sulla distanza concettuale tra riflessione e diffrazione, Micali e Pasqualini enucleano quelle fondamentali differenze che permettono di non inciampare in un’estetica umanista del post-human, ovvero in un’estetica riflessiva che rifortifica la superiorità dell’animale umano evadendo una possibile contaminazione e mescolanza con l’alterità. Un atteggiamento diffrattivo, anziché rappresentazionalista e riflessivo, permette di evitare il solo apparire delle differenze tra noi e l’altro non umano al fine «di pensare le pratiche socio-culturali in modo performativo» (K. Barad, 2007). Il processo artistico, da manipolazione demiurgica, trasmuta divenendo il deposito enattivo ed emotivo dello stratificarsi, del contaminarsi e del congiungersi di molteplici alterità in rapporto fra loro; molteplicità in relazione che restituiscono una concezione postumanista dell’accoppiarsi tra homo e res (A. Micali, N. Pasqualini).

Massimiliano Viel, nel saggio Musica umana, ascolto postumano, pone un quesito fondamentale: cosa riconosciamo come musica che ci parla di un possibile senso del postumano musicale? Partendo da una prima ipotesi di accostamento tra postumano ed extramusicale - in quanto “irruzione della diversità, nella forma di oggetti del mondo introdotti attraverso un processo mimetico sonoro nella pratica musicale” – l’autore smonta e rimonta le possibili strade per un approccio non umanista, attraverso la citazione del lavoro di Eric Satie, Brian Eno, Murray Schafer, Oliver Messiaen, Iannis Xenakis, Karlheinz Stockhausen e uno studio dell’etnomusicologo Anthony Seeger. Ma è svincolandosi dalla definizione di musica – attraverso la pratica di John Cage - che Massimiliano Viel individua un possibile approccio in termini postumani, identificando nel processo di ascolto l’elemento caratterizzante di «tutte le pratiche musicali e di comunione con soggetti di culture lontane, bambini in età prelinguistica e animali non umani». Essendo inoltre l’ascolto un processo di riconoscimento, è intrinsecamente legato al concetto di attenzione e memoria. Ecco allora che un ascolto come eredità della musica umanista, se vuole avvicinarsi al postumano, deve evitare di adagiarsi sulle esperienze d’ascolto accumulate: si tratterà quindi di ricercare un ascolto intransitivo, in grado di riconfigurare attenzione e memoria. Come esempio di una pratica d’ascolto aperta alle tematiche del postumano viene citata la passeggiata sonora (soundwalk) in grado di stimolare nei partecipanti lo sviluppo di una sensibilità verso i suoni circostanti: qui si esaudisce ed esplora la relazione tra orecchio, il nudo orecchio, e ambiente (H. Westerkamp, 2006). Torno qui a Marcel Duchamp e al concetto di infrasottile: tra gli esempi che l’artista cita nel definire questa categoria di elementi al limite del percettibile, vi si ritrovano anche «il rumore o la musica prodotti da un pantalone di velluto a coste mentre si respira».
Il saggio L’archivio come pratica etica del vivente di Gabriela Galati, chiude la raccolta con un’argomentazione attorno al concetto di archivio come pratica che modella la vita (a life-making practice) e strumento di relazione. Il ragionamento si sviluppa attraverso una lettura dei fenomeni di estinzione e di de-estinzione, citando l’approccio femminista di Joanna Zylinska e il suo concetto di “controapocalisse”, per proporre l’archivio come un modo per comprendere la de-estinzione in chiave etica. Citando le considerazioni di Cary Wolfe e di Ashley Dawson, Gabriela Galati articola una riflessione che muove dall’impossibilità di definire il concetto di natura, identificando nella condizione di finitudine legata alla morte l’elemento che accomuna tutti gli esseri senzienti. La precarietà e l’idea di finitudine conducono al pensiero di Jacques Derrida, di cui l’autrice cita nello specifico i due articoli Freud e la scena della scrittura e Mal d’archivio. Un’impressione freudiana, associando archivio-inconscio e ripercorrendo i concetti di “domiciliazione” (che segna la possibilità di accedere all’archivio passando da privato a pubblico) e di “potere di consegna”, non nel senso di depositare ma nel senso di “consegnare riunendo segni” (ovvero di archivio come ri-unione). Il saggio si conclude con un ulteriore passaggio derridiano, volto a riflettere sull’esternalizzazione dell’archivio in termini di memoria protesica, e con un invito dell’autrice a valutare la scena di responsabilità entro cui ci muoviamo: una responsabilità verso la memoria che stiamo preservando e l’agentività dell’archivio stesso, da intendersi come strumento di modellamento della realtà passata, presente e futura.

Vorrei concludere con una breve riflessione che mi permetta di ricapitolare – e di rilanciare - alcune delle tematiche proposte, attraverso un campo di ricerca non espressamente trattato nella pubblicazione: la fotografia. Quale ruolo assume la riproduzione del reale, attraverso il mezzo fotografico, nel nostro relazionarci con ambiente e oggetti? Riprendendo gli studi di Elio Grazioli sulla relazione tra opera d’arte e immagine, e nello specifico il rapporto tra Duchamp e la fotografia, quest’ultima – accanto al readymade - viene indicata come quel medium capace di “interrogare lo statuto del reale stesso” (E. Grazioli, 2017). In questi termini è molto prezioso il pensiero di Jean-Christophe Bailly (2010), ripreso dallo stesso Grazioli, in merito alla fotografia, definita come «Fragile segno di esistenza, fragile segno indicante che qualcosa è esistito prima che marcasse, la fotografia (…) agisce direttamente e silenziosamente come ciò che sa o può far echeggiare l’intimo delle cose».
L’arte, la pedagogia, la musica, la pratica curatoriale e quella archivistica, la fotografia, sono campi di ricerca e attitudini discrete: come presenze “vicine” ci affiancano, partecipando al quotidiano scambio con l’alterità. Problematizzare, decostruire e ripensare queste pratiche in termini postumani, come proposto nella pubblicazione qui recensita, significa innanzitutto riposizionarsi all’interno di questi sistemi ecologici, con uno sguardo che sappia coglierne la complessità fino a restringere il campo sul piccolo, il microscopico, l’intimo, l’infrasottile.
di Roberta Perego