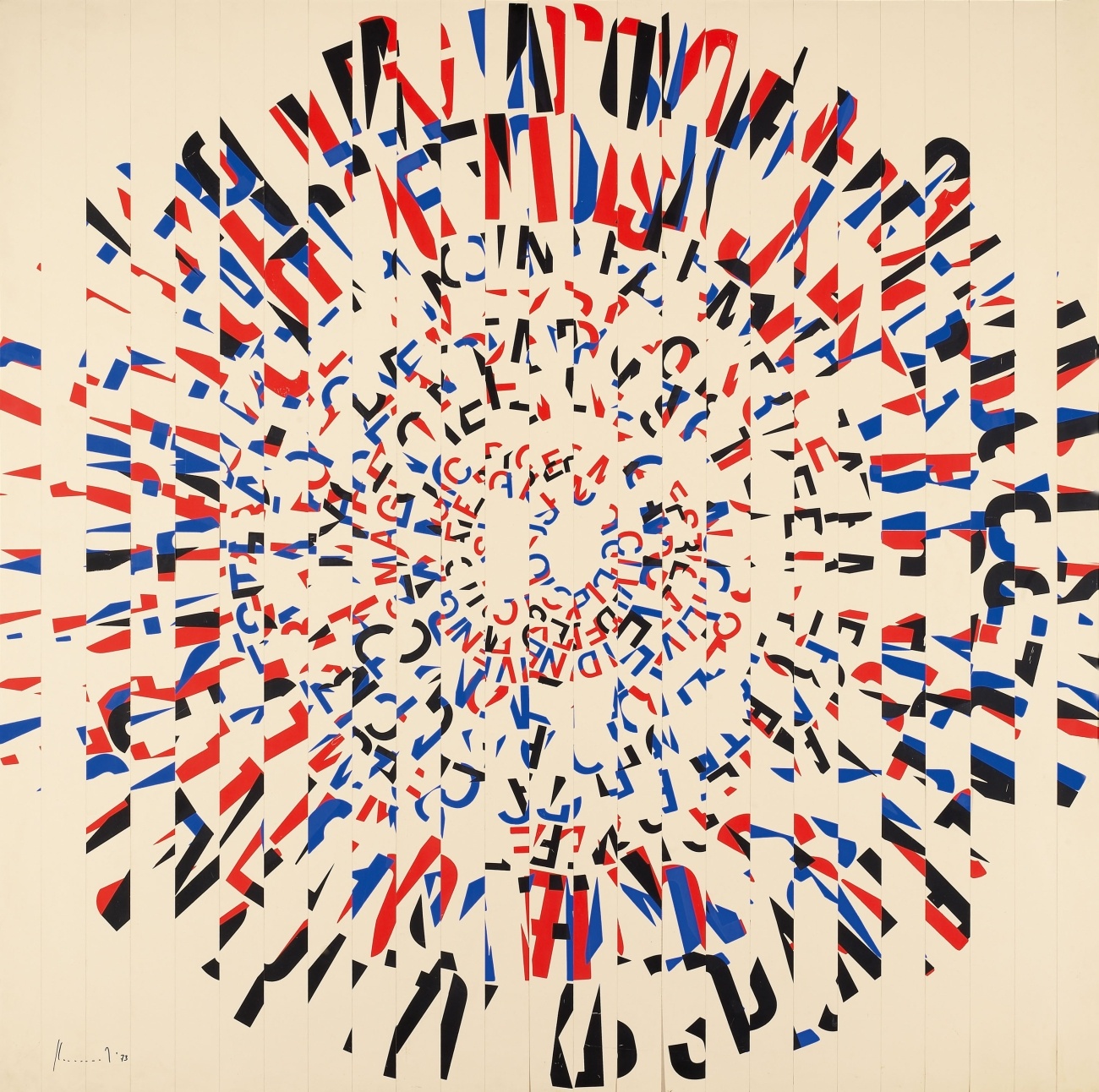-
Estesie – A cura di Pasquale Fameli
Estesie, Serial / Marzo 2016Estesie. Forme e idee del Novecento è uno spazio di riflessione sui rapporti tra l’arte e la filosofia, un banco di prova dei loro possibili intrecci e un laboratorio in cui testarne le loro forze magnetiche. Tra i molti settori della cultura di una determinata epoca vengono infatti a stabilirsi delle connessioni spontanee, delle sintonie inattese o non necessariamente cercate, che contribuiscono tuttavia ad avvalorarne i tratti somatici e a farne emergere le peculiarità. Prendendo spunto dalle poetiche, dalle teorie o dai fatti artistici ed estetici più rilevanti del Novecento, nello spazio di Estesie vengono testate le loro molteplici aperture connettive, secondo una concezione rizomatica della cultura che vede nell’intersezione e nella trama reticolare le più efficaci forme di comprensione dell’oggi.
Pasquale Fameli (1986) è dottorando in Arti visive, performative e mediali presso l'Università di Bologna. Si occupa di ricerche extra-pittoriche del Novecento, con particolare attenzione ai fenomeni sonori e sinestetici.
-
 Si tratta di una delle storie più note a chi frequenta i territori filosofici: la filosofia nasce come superamento del mito, costruisce il proprio spazio negando e lasciandosi alle spalle il mito, sforzandosi di superare il suo linguaggio, anche quando – Platone lo testimonia per primo – si ritrova a farne ancora uso. Da qui la convinzione che, in fondo, pensare significhi non raccontarsi storie, ma anche che conoscere sia l’operazione anti-mitologica per eccellenza (la finzione narrativa del mito che fa spazio alla verità razionale della scienza). A fronte di tutto ciò, un volume che ha il coraggio di riaprire il discorso sul rapporto tra mito e filosofia merita la più assoluta considerazione. Sarebbe ingeneroso pretendere di riassumere in pochi capoversi i trenta fitti saggi che compongono il testo, in cui il dibattito antropologico, storico-religioso, sociologico e psicologico si intreccia felicemente alle riflessioni teoriche e all’opportuna ricostruzione di casi storici; per questo, mi limiterò a presentare quelli che mi sembrano i due assi principali dell’opera, legati a loro volta a un’idea fondamentale che fa da basso continuo a tutti gli interventi: il mito non tanto “è qualcosa”, ma piuttosto “fa qualcosa”. La prospettiva funzionalista deve sostituire quella sostanzialista.
Si tratta di una delle storie più note a chi frequenta i territori filosofici: la filosofia nasce come superamento del mito, costruisce il proprio spazio negando e lasciandosi alle spalle il mito, sforzandosi di superare il suo linguaggio, anche quando – Platone lo testimonia per primo – si ritrova a farne ancora uso. Da qui la convinzione che, in fondo, pensare significhi non raccontarsi storie, ma anche che conoscere sia l’operazione anti-mitologica per eccellenza (la finzione narrativa del mito che fa spazio alla verità razionale della scienza). A fronte di tutto ciò, un volume che ha il coraggio di riaprire il discorso sul rapporto tra mito e filosofia merita la più assoluta considerazione. Sarebbe ingeneroso pretendere di riassumere in pochi capoversi i trenta fitti saggi che compongono il testo, in cui il dibattito antropologico, storico-religioso, sociologico e psicologico si intreccia felicemente alle riflessioni teoriche e all’opportuna ricostruzione di casi storici; per questo, mi limiterò a presentare quelli che mi sembrano i due assi principali dell’opera, legati a loro volta a un’idea fondamentale che fa da basso continuo a tutti gli interventi: il mito non tanto “è qualcosa”, ma piuttosto “fa qualcosa”. La prospettiva funzionalista deve sostituire quella sostanzialista.Il primo asse ruota attorno alla convinzione che ripensare la contrapposizione tra mito e ragione non significa semplicemente dire che il mito sia ovunque, che tutto sia mito, che in realtà anche la filosofia e la scienza sono in qualche modo “mitiche”. Il punto è piuttosto riconoscere che il mito non è stato semplicemente superato una volta per tutte, né deve essere lasciato alle spalle, perché non è una modalità di rapporto con la realtà imperfetta, incompiuta e difettosa rispetto a quella razionale: è piuttosto una modalità altra con delle proprie specificità e – soprattutto – con la propria utilità. Si tratta infatti di comprendere che le ambiguità e le contraddizioni del mito, capace di generare fascino e seduzione come repulsione e rinnegamento, sono legati al fatto che il mito è innanzitutto una prassi, che si colloca cioè in una dimensione performativa che si avvale di peculiari materiali e pratiche: il mito rappresenta la tessitura – in termini foucaultiani – di un vero e proprio ordine discorsivo, di un dispositivo di sapere-potere. In questo senso, esso ha persino una propria “razionalità”, nella misura in cui possiede una struttura e delle modalità di funzionamento e dispiegamento irriducibili ad altro e – soprattutto – insubordinabili a quelle proprie della ragione in senso stretto. Senza che ciò debba tradursi nella celebrazione della narrazione mitica a discapito della discorsività argomentativa, evidentemente; anzi, occorre proprio cominciare a vederle come complementari piuttosto che dirette antagoniste.
In particolare, il mito gioca un ruolo decisivo nella messa in opera della realtà politica e nella costruzione dell’identità sociale: il mito è produzione di memoria, di coesione, di immaginario, è fondazione del legame socio-culturale e dell’articolazione storico-temporale, offre un punto di riferimento per la stabilità di un gruppo. Il mito produce tutto ciò proprio mentre è da tutto ciò prodotto e riprodotto: il mito orienta. È per questo che esso non può essere semplicemente “demistificato”, in nome della ragion pura come della denuncia delle ideologie: il mito non è un vestito che ricopre una supposta realtà originaria e fatto proprio da una determinata classe sociale per tenerne sotto scacco un’altra; è – piuttosto – una modalità di accesso alla realtà che accomuna le diverse (supposte o effettive) classi sociali, che consente loro di far parte della medesima società. In poche parole, il mito ha una peculiare funzione soprattutto sociale, fonda la socialità umana, è un fattore di coesione e condensazione rispetto alla vita associata: il mito istituisce proteggendo e preservando – immunizzando. Ed è proprio qui che la sua funzione stabilizzatrice diventa indisgiungibile dal rischio di tradursi in un fattore di sclerotizzazione o eccessiva solidificazione; è perciò che il mito può essere tanto un orizzonte di condivisibilità quanto una cornice intrascendibile, che la sua macchina può generare forme di conoscenza e di circolazione linguistica, immaginale e simbolica che si autocertificano come verità naturali e immodificabili.
Il secondo asse attorno a cui si costruisce il volume consente però proprio di spiegare meglio il senso di questa utilità e il motivo profondo per cui il mito non può essere superato. Infatti, riprendendo soprattutto la lezione di Blumenberg, la funzione simbolico-performativa del mito va letta in chiave antropogenetica, vale a dire che l’utilità del mito è antropologica: il mito è uno dei modi tramite cui l’animale umano articola il senso della propria esistenza e il rapporto al proprio ambiente. Più specificamente, il mito consente di addomesticare il mondo e di dare così stabilità all’esistenza, è una forma di metaforizzazione della realtà e della propria posizione al suo interno che consente di dare a entrambe una figura. In altri termini, per quell’essere – quale l’uomo è – esposto, vulnerabile e consegnato al compito di dar attivamente forma al proprio rapporto con il mondo e di condurre esplicitamente la propria esistenza, il mito rappresenta un sistema di prevenzione da un’eccessiva prossimità con il reale e conseguentemente un meccanismo di misurazione delle giuste distanze da esso: troppe domande sull’origine del mondo generano angoscia, certo, ma la medesima angoscia si produrrebbe qualora non venisse prodotto nessun tipo di risposta. Il mito è proprio il tentativo di fornire una risposta che, pur non rifiutando la domanda sul senso del mondo, cerca però di limitarne la proliferazione indefinita, di interromperne il regresso all’infinito: finché l’uomo dovrà orientarsi nel mondo – a dire: finché l’uomo esisterà – il mito interverrà a offrire sostegno e supporto. In breve: il suo spettro di variazioni storiche e culturali fa dunque da controcanto all’invariante antropologica del bisogno di metafore capaci di far fronte all’assolutismo della realtà. Certamente, si potrebbe sostenere che il richiamo a Blumenberg comporti un eccessivo ricorso a quel “paradigma dell’incompletezza” o “fiction dell’essere carente” che gli sviluppi contemporanei dell’antropologia filosofica hanno cercato di ripensare (a partire da Sloterdijk, non a caso uno degli autori comunque chiamati in causa dagli interventi), così come implicherebbe di conseguenza anche un’eccessiva insistenza sul bisogno di protezione e riduzione del rischio e meno su quello di esplorazione e soddisfazione della curiosità. Come a dire che il mito può o deve essere considerato anche un dispositivo di scoperta di possibilità, oltre che di contenimento della loro dispersività, ossia che – pensando soprattutto alla dimensione sociale – al mito va riconosciuta più nettamente una dimensione simbolico-espressiva a fianco di quella contenitivo-stabilizzante. Tuttavia, ciò nulla toglie al punto di fondo da tener fermo: riconoscere che il mito è un paradossale “zero efficiente”, un nulla performativo, in ragione della stessa costituzione umana, e non il residuo di un passato oscuro da scrostarsi di dosso una volta per tutte. Ed è da questo punto fermo che il volume chiede di ripartire e di pensare.
Per chiudere, come viene pregevolmente evidenziato dai curatori, padroneggiare totalmente le problematiche scientifiche come le dimensioni pratiche connesse al mito è un’impresa ai limiti dell’insormontabilità: mito si dice e si fa senza dubbio in molti modi. Ma l’altrettanto indubbio pregio dell’opera è sforzarsi di mostrare questa molteplicità, è offrire un quadro insieme complessivo e articolato di quel solo apparente ossimoro che è la “filosofia del mito”, al fine di contribuire a rendere meno cogente la sottile violenza con cui tende a presentarsi ciò che è ovvio e a indicare così nuovi spazi di libertà possibili. Siamo insomma di fronte alla piena assunzione del compito forse più peculiare e controverso di cui la filosofia tenta di farsi carico: pensare il proprio tempo in rapporto al suo trascorrere.
di Giacomo Pezzano
-
La modernità di NietzschePer capirci qualcosa di più del mondo in cui viviamo bisogna leggere Nietzsche.
 Sapere che il Fascismo di Mussolini e il Rock psichedelico di Jim Morrison sono nati nel segno del filosofo tedesco – se coerentemente o meno è un altro discorso – spinge in questa direzione, ed è il motivo dell’interesse di Maurizio Ferraris per questa figura e la ragion d’essere di Spettri di Nietzsche. Un’avventura umana e intellettuale che anticipa le catastrofi del Novecento (anche se i Doors più che una catastrofe sono una benedizione). Non c’è dubbio, il Novecento (ma anche questo primo scampolo di nuovo millennio) è un secolo nietzscheano, il secolo della volontà di potenza, quella volontà, essenza dell’individualismo, che contraddistingue i contemporanei – che cosa sarebbero altrimenti i Talent Show? È Ferraris stesso ad aprire il suo libro con questa precisazione, umanizzando e attualizzando – che più attuale non si può – il pensiero di un uomo che ha vissuto sulla sua pelle e sui suoi nervi il tempo che annunciava: «fuori dalle trincee la volontà di potenza è anzitutto volontà di presenza e ansia di riconoscimento. Nietzsche coglie, esprime e anzitutto incarna una caratteristica essenziale della modernità, l’aspirazione collettiva a essere straordinari» (p. 15). Perché «aveva ragione sua sorella Elisabeth, Fritz voleva diventare famoso, e lo desiderava con la stessa mancanza di decoro di un ammalato di celebrità» (p. 7). In una lettera a Paul Deussen dell’11 dicembre 1888 egli scrive che si sentiva «come se il destino dell’umanità fosse nelle [sue] mani» (p. 9). In un certo senso ci aveva preso. Considerato che oggi siamo ancora qui a parlare di lui, se avesse pensato e agito diversamente forse in questo momento ragioneremmo altrettanto diversamente.
Sapere che il Fascismo di Mussolini e il Rock psichedelico di Jim Morrison sono nati nel segno del filosofo tedesco – se coerentemente o meno è un altro discorso – spinge in questa direzione, ed è il motivo dell’interesse di Maurizio Ferraris per questa figura e la ragion d’essere di Spettri di Nietzsche. Un’avventura umana e intellettuale che anticipa le catastrofi del Novecento (anche se i Doors più che una catastrofe sono una benedizione). Non c’è dubbio, il Novecento (ma anche questo primo scampolo di nuovo millennio) è un secolo nietzscheano, il secolo della volontà di potenza, quella volontà, essenza dell’individualismo, che contraddistingue i contemporanei – che cosa sarebbero altrimenti i Talent Show? È Ferraris stesso ad aprire il suo libro con questa precisazione, umanizzando e attualizzando – che più attuale non si può – il pensiero di un uomo che ha vissuto sulla sua pelle e sui suoi nervi il tempo che annunciava: «fuori dalle trincee la volontà di potenza è anzitutto volontà di presenza e ansia di riconoscimento. Nietzsche coglie, esprime e anzitutto incarna una caratteristica essenziale della modernità, l’aspirazione collettiva a essere straordinari» (p. 15). Perché «aveva ragione sua sorella Elisabeth, Fritz voleva diventare famoso, e lo desiderava con la stessa mancanza di decoro di un ammalato di celebrità» (p. 7). In una lettera a Paul Deussen dell’11 dicembre 1888 egli scrive che si sentiva «come se il destino dell’umanità fosse nelle [sue] mani» (p. 9). In un certo senso ci aveva preso. Considerato che oggi siamo ancora qui a parlare di lui, se avesse pensato e agito diversamente forse in questo momento ragioneremmo altrettanto diversamente.Nietzsche, un’interpretazione
Ferraris – si avverte pagina dopo pagina – nutre un certo affetto per Nietzsche, come fosse un amico, forse vecchio rivale, comunque molto stimato. D’altronde non c’è filosofo del Novecento che non abbia fatto i conti con quest’uomo geniale. I conti, questo libro ne è la resa: Ferraris ripercorre l’intera vita filosofica del collega tedesco, i suoi lasciti, le sue micce, poi accese da qualcun altro, e la dinamite che è esplosa lontana dai suoi occhi. È lui, in fin dei conti, il padre del postmoderno, l’autore di quella frase: “non ci sono fatti, solo interpretazioni”, contro cui lotta il nuovo realismo ferrarisiano. Con questo concetto Ferraris ci mostra come per Nietzsche «la realtà [sia] socialmente costruita, nulla esiste fuori dal testo, il sapere è solo un effetto di potere, il mondo si guarda da infinite prospettive che corrispondono ai nostri bisogni vitali in conflitto tra loro, non ci sono cose in sé, ma solo in relazione a osservatori» (p. 83). È questo cambio di paradigma la vera catastrofe di cui parla Ferraris nel sottotitolo del libro? Quella da cui sono potute nascere tutte le catastrofi reali che hanno segnato il XX° secolo? E sarà davvero giunto il tempo di voltare pagina? Difficile a credersi. Ma come la mettiamo allora con il global warming, lo spread, il cancro, l’Olocausto? Sono solo interpretazioni?

Volontà di potenza e di politica
Anzitutto bisogna fare i conti col Nietzsche politico, una storia che non finirà mai, perché impossibile da chiarificare. Chi lo vuole di destra, ideologo del nazionalsocialismo di Hitler – o colui che contribuì alla sua nascita – e della sua sfrenata volontà di dominio; chi lo vuole invece di sinistra, rivoluzionario – non a caso le sue opere, oltre che in quella di Hitler, comparivano nella biblioteca di Mitterrand. Dice Lukács che gli «intellettuali potranno sostituire al socialismo l’annuncio di Zarathustra, cioè la promessa di un cambiamento ancora più grande e più indeterminato, di un futuro e di un dio a venire» (p. 45). Chi considera la sua nazificazione un errore dettato dal travisamento del suo pensiero allegorico o semplicemente dalle interpolazioni faziose apportate all’opera dalla sorella Elisabeth. Una cosa è certa, Nietzsche è morto nel 1900 e non ha mai sentito parlare di Hitler. Ciò, ovviamente, non significa che i nazisti non abbiano avuto alcun appiglio per rifarsi al padre di Zarathustra: Ferraris, considerate l’opera di Nietzsche, ci dice che era davvero reazionario, e che i pensieri di cui si appropriarono i nazisti non provenivano dalla tanto discussa e postuma Volontà di potenza, ma soprattutto dalle opere edite. In realtà ci dice anche che l’unica vera falsificazione della sorella è stata quella di spacciarsi per principale interlocutrice del fratello, quando invece lui la odiava. Come si sa, l’unica obiezione di Nietzsche all’eterno ritorno erano proprio loro, la madre e la sorella.
Per Ferraris «Nietzsche è stato tutto, tranne che un impolitico», i suoi «principi risultano iper-fungibili dal punto di vista politico, appunto perché l’essere diviene anzitutto un fare, un combattere, un trasformare. Il che, in una fase rivoluzionaria, può risultare allettante sia per una squadra di spartachisti che per dei Freikorps antibolscevichi» (p. 43). Inoltre «il pensiero di Nietzsche non porta a un prospettivismo radicale, bensì a una gerarchizzazione dei valori» (p. 130), perché per lui «[…] il vero filosofo è colui che forgia nuovi valori» (p. 131). Zarathustra/il superuomo ha trovato la verità, ovvero che non esiste verità, ma solo volontà di potenza. Di qui la sua autorità.
Nichilismo e imipramina
Il libro di Ferraris, che si muove a salti spaziali e temporali, in una connessione di idee trasformata in elegante opera letteraria, a un tratto ci proietta nel 1956, all’interno dell’ospedale di Münsterlingen, dove lo psichiatra Roland Kuhn stava scoprendo, per caso, l’effetto antidepressivo dell’imipramina. E se quello che Nietzsche chiamava “nichilismo” fosse stata solo una sorta di depressione curabile coi farmaci, si chiede provocatoriamente Ferraris? E se Nietzsche avesse incontrato Kuhn, oggi cosa leggeremmo sui libri di storia della filosofia? Di sicuro nel nichilismo di cui parla il filosofo tedesco c’è molto di suo, di quello che avvertiva dentro di sé – e qui siamo di nuovo a fare i conti con la modernità nietzschena di cui si parlava all’inizio.
Eterno ritorno, eterno disguido
A Silvaplana sulla soglia di una casa, nel 1993, Ferraris scoprì questa scritta in retoromanzo: “Tieu destin tũ poust amer e perfin sch’el es amer”. Bisogna amare il proprio destino anche se amaro. Ecco qui l’eterno ritorno, “la suprema formula dell’affermazione che possa mai essere raggiunta”, frutto della profonda trasformazione spirituale nietzscheana avvenuta nel 1881, appunto, a Silvaplana, vicino Sils Maria, in Svizzera. Ma quest’idea, ripresa dai greci e dal pensiero orientale, può avere una qualche scientificità?
 Borges, in Storia dell’eternità (1936), rifacendosi alle teorie degli insiemi di Cantor, prova a rispondere a questa domanda, concludendo che «se l’universo consta di un numero infinito di termini, è rigorosamente capace di un numero infinito di combinazioni; e la necessità di un ritorno viene annullata» (p. 135). Ferraris sembra concordare con Borges. Va però detto gli atomi dell’universo sono oggi valutati dalla scienza in 10 alla 80: numero altissimo, ma pur sempre finito, che non smentisce quindi l’ipotesi nietzscheana. Tuttavia l’eterno ritorno rimane una contraddizione all’interno del pensiero di Nietzsche, e questo Ferraris lo spiega bene: da una parte vuol essere l’abbandono di ogni finalismo, contro la teleologia occidentale, una proclamazione della libertà di movimento della Terra, astro tra gli astri; dall’altra però «propugna un finalismo iperbolico, per il quale il filosofo, in veste di istitutore di valori, “crea” – leggiamo nello Zarathustra, “Di antiche tavole e nuove” – “la mèta dell’uomo e dà alla terra il suo senso e il suo futuro”» (p. 140).
Borges, in Storia dell’eternità (1936), rifacendosi alle teorie degli insiemi di Cantor, prova a rispondere a questa domanda, concludendo che «se l’universo consta di un numero infinito di termini, è rigorosamente capace di un numero infinito di combinazioni; e la necessità di un ritorno viene annullata» (p. 135). Ferraris sembra concordare con Borges. Va però detto gli atomi dell’universo sono oggi valutati dalla scienza in 10 alla 80: numero altissimo, ma pur sempre finito, che non smentisce quindi l’ipotesi nietzscheana. Tuttavia l’eterno ritorno rimane una contraddizione all’interno del pensiero di Nietzsche, e questo Ferraris lo spiega bene: da una parte vuol essere l’abbandono di ogni finalismo, contro la teleologia occidentale, una proclamazione della libertà di movimento della Terra, astro tra gli astri; dall’altra però «propugna un finalismo iperbolico, per il quale il filosofo, in veste di istitutore di valori, “crea” – leggiamo nello Zarathustra, “Di antiche tavole e nuove” – “la mèta dell’uomo e dà alla terra il suo senso e il suo futuro”» (p. 140).Che cos’è allora, per Nietzsche, l’eterno ritorno? È anche questo frutto della sua modernità, del suo essere interiore che non può che traboccare nel mondo per renderlo a sua immagine? Ferraris, candidamente, risponde: l’eterno ritorno è «una religione per il mondo secolarizzato, un mito qualunque, quasi un pretesto per predicare, di certo un gesto per scacciare l’orrore un po’ più in là» (p. 144).
Illuminismo + LSD = catastrofe
Un mito, appunto. Proprio come scrivono Adorno e Horkheimer in Dialettica dell’illuminismo (1947), l’“illuminismo nietzscheano” è un ritorno al mito, alla tragedia, al dionisiaco, volto a distruggere il nesso sapere-progresso-felicità figlio del racconto socratico riproposto nella modernità proprio dall’illuminismo “classico”, quello di Kant e Rousseau. Nietzsche, che detestava Rousseau, invece, guarda più a Sade, a Laclos, a Crébillon. La volontà di potenza è tutto quello che c’è da sapere per capire il mondo: «ogni forma di sapere va guardata con sospetto, appunto in quanto espressione di una qualche forma di potere» (p. 152), e quindi il sapere, che dovrebbe emancipare, produce allo stesso tempo potere, cioè subordinazione e dominio. La soluzione? Non sapere (ovviamente non alla maniera socratica), rituffarsi nel mito, nel dionisiaco perduto. Insomma, il Nietzsche che emerge qui non è un illuminista, ma un dispensatore di segreti per “imparare a vivere” secondo la sua “dottrina”. Altro che spronare a pensare con la propria testa!
E questo dionisiaco dove lo troviamo? Ferraris, ancora una volta, immagina gli effetti che avrebbe prodotto l’LSD, sintetizzato soltanto nel 1943 a Basilea (stessa città in cui venne concepita La nascita della tragedia) da Albert Hoffman, su Nietzsche. Ma dovremo accontentarci degli effetti, non affatto malvagi, prodotti su Jim Morrison, ma anche su Foucault.
Qui Ferraris azzarda e finalmente fa esplicito riferimento a quello a cui tutti noi pensiamo quando sentiamo pronunciare la parola catastrofe in riferimento al Novecento. Ovvero Hitler. Il sottotitolo del libro significa proprio quello che intuitivamente credevamo. È però al plurale – catastrofi – per cui riempitelo come preferite, avete l’imbarazzo della scelta. Ad ogni modo i nazisti, a Nietzsche, non “rubarono” solo concetti, ma anche la necessità dell’esperienza del superamento del limite razionale, verso l’immortalità (o la morte): «tra la patria mitica e la catastrofe il passo è breve, e se Hitler ha saputo incantare i tedeschi, e non solo loro, è perché nel suo orizzonte c’era qualcosa di straordinariamente simile al “corteo dionisiaco” di cui parla Nietzsche» (p. 179).
Ma le responsabilità di Nietzsche e di Hitler sono molto diverse fra loro; Ferraris lo mette in luce citando le parole di un uomo che ripugnava entrambi, Primo Levi: «[in Nietzsche] mi pare che non compaia mai il desiderio della sofferenza altrui. L’indifferenza sì […], ma mai […] la gioia per il danno del prossimo, né tanto meno la gioia del far deliberatamente soffrire. Il dolore del volgo […], degli informi, dei non-nati-nobili, è un prezzo da pagare per l’avvento del regno degli eletti; è un male minore […]; non è desiderabile in sé. Ben diversi erano il verbo e la prassi hitleriani» (p. 196).
***
Spettri di Nietzsche non è un libro per chi è digiuno del pensiero del filosofo tedesco, che non saprebbe come raccapezzarsi tra gli sbalzi temporali di Ferraris, il quale mostra una profonda conoscenza delle tematiche che tratta. In realtà è proprio questo che rende la lettura stimolante: lo star dietro a un brillante incedere tra connessioni di idee di cultura “alta”, prettamente filosofico-accademica, e cultura pop. D’altronde, abbiamo imparato a conoscerlo, è esattamente questa la cifra di Ferraris.
di Stefano Scrima