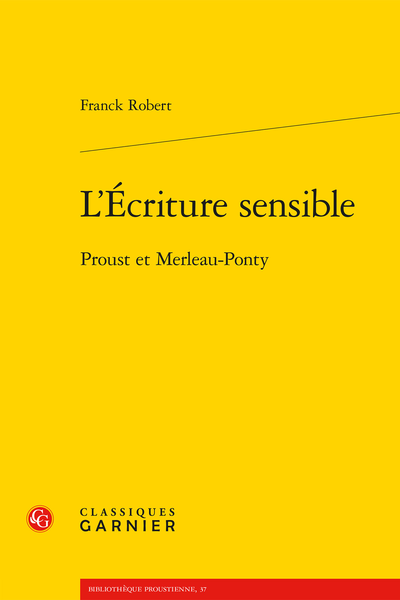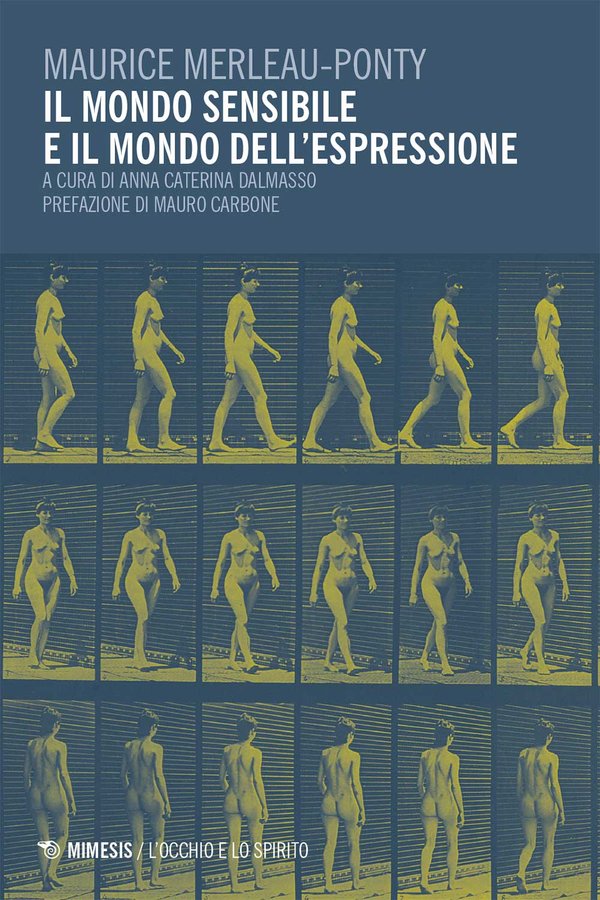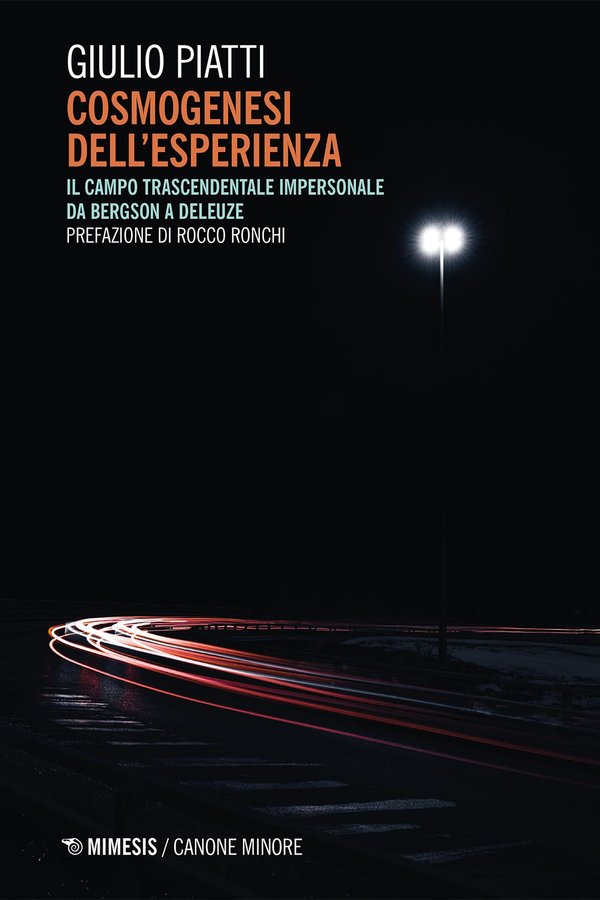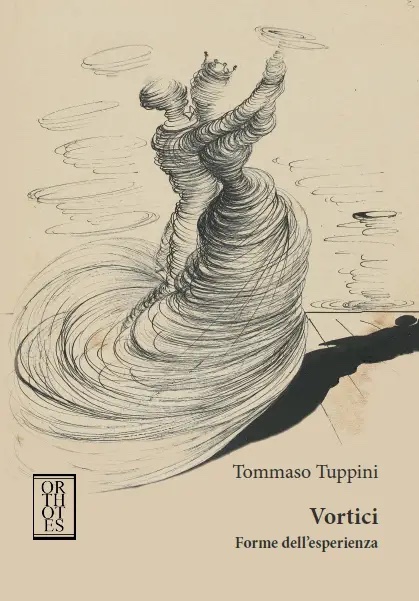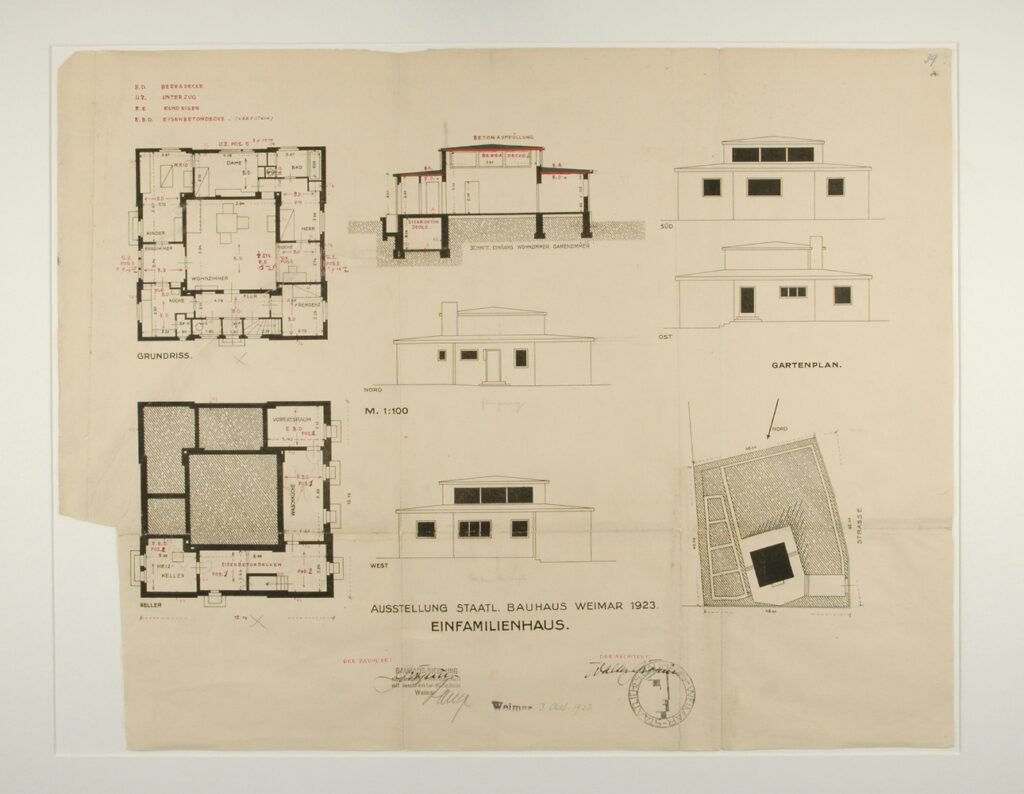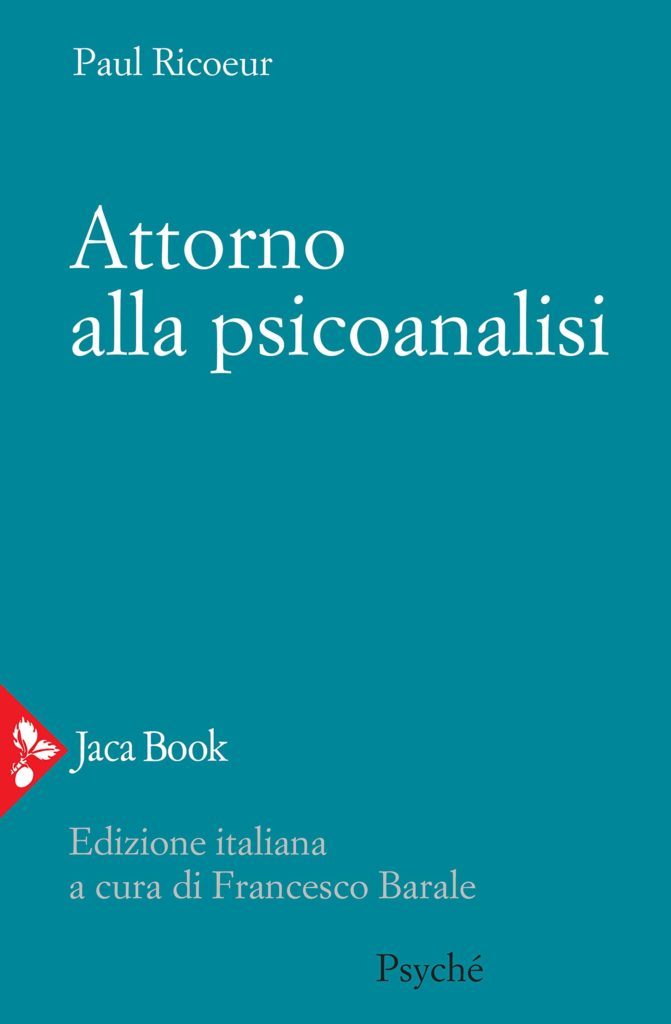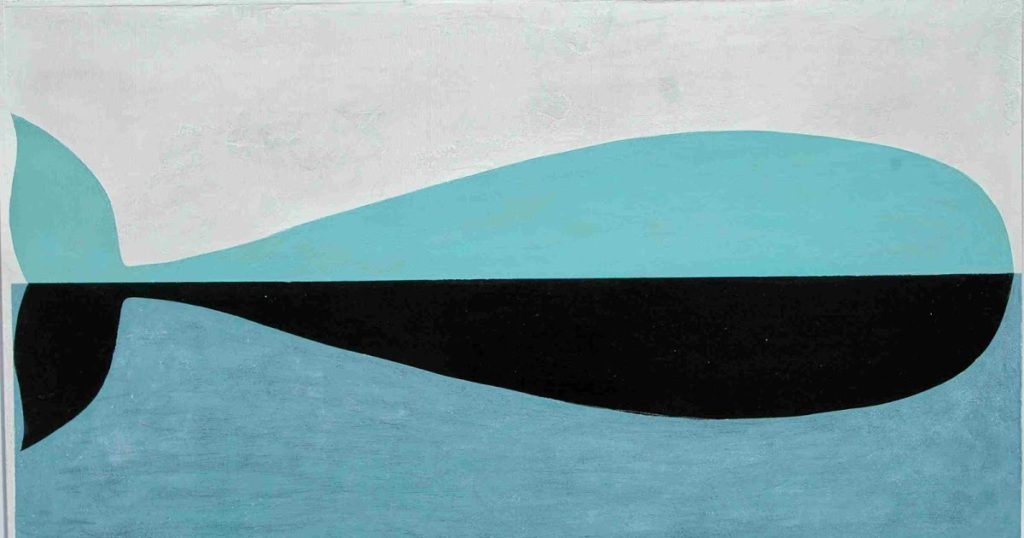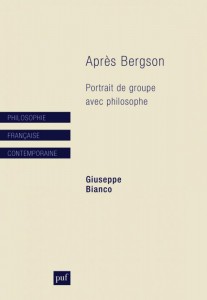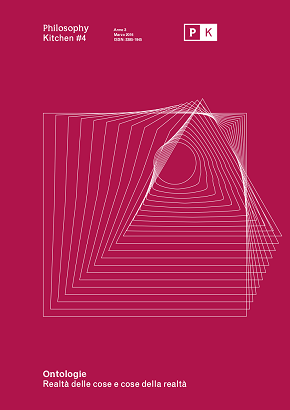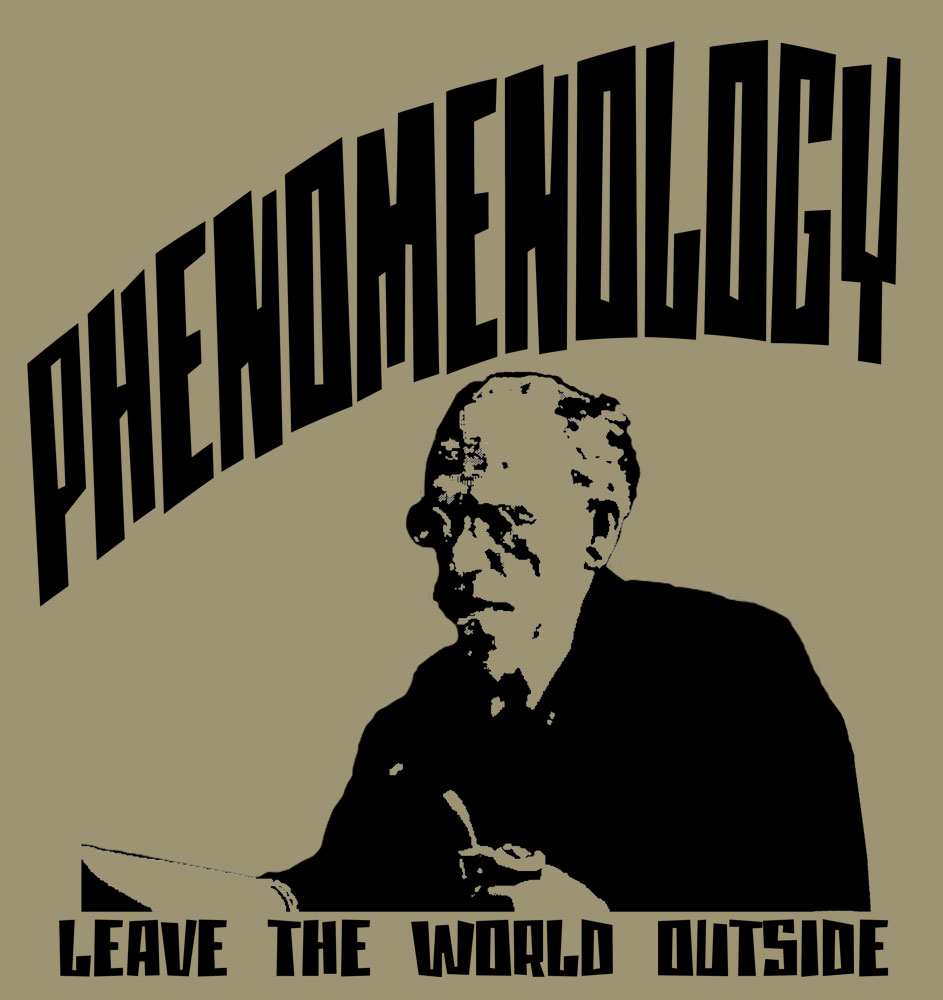-
-
Esattamente vent’anni dopo la prima pubblicazione nell’originale francese (Éditions Belin, 2003), L’istituzione, la passività. Corso al Collège de France (1954-1955) di Merleau-Ponty è ora disponibile anche nella traduzione italiana, edita da Mimesis (2023) e curata da Giovanni Fava e Riccardo Valenti. Il testo rende accessibili al pubblico italiano gli appunti redatti da Merleau-Ponty per i corsi tenuti al Collège de France tra il 1954 e il 1955; corsi che, come ricorda Claude Lefort nella prefazione alla prima edizione francese, «si sovrappongono […] e al contempo scelgono vie divergenti in direzione di una nuova ontologia» (Merleau-Ponty 2023, p. 7). Difatti, nonostante sia la fenomenologia a contrarre il debito maggiore con l’opera di Merleau-Ponty – in primo luogo per la fedele lettura del testo husserliano e, correlativamente, per la sua decisiva promozione nel panorama filosofico francese – è il problema ontologico a coronare la riflessione teoretica del filosofo. A partire dalla presa d’incarico al Collège de France (1953), tale problema diviene per Merleau-Ponty sempre più urgente. Di conseguenza, a dispetto della ricezione tardiva per il pubblico italiano, tali appunti ricoprono un ruolo cruciale nella produzione del filosofo, essendo in grado di restituirci una preziosa istantanea di quella che fu la virata filosofica che interessò Merleau-Ponty a partire degli anni Cinquanta, da una prima fase più autenticamente fenomenologica – marcata dalla sua opera principale, Fenomenologia della percezione (1945) – agli ultimi scritti, in cui Merleau-Ponty prepara il terreno per la sua ontologia.
In queste pagine, è possibile, infatti, partecipare a quel cambio di prospettiva che si stava man mano consolidando nella riflessione di Merleau-Ponty, muovendo da un’analisi fenomenologica del corpo vivo (Leib) verso il carattere necessariamente anonimo o disumano dell’essere carne (chair), al di là della stessa distinzione tra soggettivo e oggettivo. Tale ristrutturazione teoretica prende le mosse da una riconfigurazione generale del contesto in cui Merleau-Ponty operava, e nel quale i presenti corsi si collocano, cronologicamente, a metà: tra la presa d’incarico come docente al Collège de France – periodo che ha come opera di riferimento il testo della sua lezione inaugurale, Elogio della filosofia (1953) – e la rottura definitiva con Sartre e con l’ideologia marxista, la quale legava i due intellettuali fino a quel momento, e che fu segnata dalla pubblicazione dell’Avventure della dialettica (1955). A partire da questi anni, le ricerche del filosofo si orientano sempre più all’interrogazione del senso e dell’espressione, al tema della verità e del rapporto tra linguaggio e mondo, nella ricerca di un terreno esistenziale originario che Merleau-Ponty, comunque, non rinuncia a voler indagare attraverso la lente fenomenologica, coniando, per l’appunto, l’espressione di “ontologia fenomenologica” o indiretta (Merleau-Ponty 2003, p. 203).
Contrariamente ad alcune letture che accusano Merleau-Ponty di ricadere nello stesso impianto metafisico o sostanzialistico che per primo criticava, è importante precisare che anche nella deriva ontologica lo sguardo fenomenologico non viene affatto abbandonato. Piuttosto, Merleau-Ponty evidenzia l’importanza di una ridefinizione dei rapporti tra fenomenologia e ontologia, nell’ottica di una loro reciproca integrazione. L’ambizioso progetto merlopontiano, che si preannuncia come uno degli itinerari filosofici più complessi e stimolanti del Novecento, rimarrà purtroppo nella forma di un discorso interrotto prematuramente a causa della morte improvvisa del filosofo. Rimettere in circolazione questi appunti risulta, perciò, un passaggio determinante per avvicinarsi maggiormente a quell’eredità che Merleau-Ponty ha lasciato in forma incompiuta e frammentaria, in modo da proseguire lungo quella traccia che avrebbe portato alla pubblicazione del suo più grande progetto redazionale, Il visibile e l’invisibile (1964), pubblicato postumo sottoforma di note di lavoro, dando così avvio a quello che appare come un cantiere ancora – e sempre – aperto.
Il perché del rinnovato interesse dopo all’incirca un ventennio per questa fase transitoria e trasformativa di Merleau-Ponty – che si evince, oltre che nel presente volume, anche nel recente progetto di traduzione del corso appena precedente, Il mondo sensibile e il mondo dell’espressione (Mimesis, 2021) – è probabilmente da attribuire al rinnovato stato di buona salute di cui gode il concetto di istituzione nel dibattito scientifico contemporaneo [1], concetto che torna ricorsivamente nelle pagine di Merleau-Ponty e che, presente fin dalle sue prime pubblicazioni, viene posto in queste lezioni come impalcatura portante di tutta la sua riflessione filosofica a venire. In particolare, è nella prima parte del volume, corrispondente al corso sull’Istituzione nella storia personale e pubblica, che si può constatare «la portata filosofica di questa riformulazione del concetto di istituzione» (p. 9), come evidenzia, con sostanziale anticipo, Lefort. In primo luogo, perché Merleau-Ponty, a discapito dell’erronea e fin troppo diffusa sinonimia, mostra come l’accezione fenomenologica di costituire risulti persino l’opposto dell’istituire: «l’istituito ha senso senza di me, il costituito ha senso soltanto per me e per il me di questo istante» (p. 61). Inoltre, un aspetto tra i più interessanti e innovativi della sua proposta filosofica risulta essere il legame imprescindibile che il concetto di istituzione intrattiene con la questione della passività. Difatti, sebbene «non dobbiamo intendere passivo e istituito come equivalenti» (p. 7), tali concetti vengono trattati da Merleau-Ponty in quanto concetti operativi strettamente connessi – indice di ciò la scelta del filosofo francese di inserire una sola introduzione a incipit di entrambi i corsi. Concetti che prendono strade diverse e, al tempo stesso, risultano in grado di chiarirsi reciprocamente, nel processo di comprensione di quella che, in quegli anni, rappresenta l’unica verità ontologica per Merleau-Ponty, a cui in seguito egli darà tanti nomi, anzitutto quello di reversibilità.
Osservando la questione da una prospettiva più estesa, ciò che, di primo acchito, accumuna istituzione e passività è la loro funzione retorica di rintegrare nel discorso tutto quello che la filosofia occidentale per secoli aveva mantenuto sullo sfondo – l’opacità del corpo, la passività istituente, l’inconscio – o, meglio, “al loro posto”, un posto subordinato a quello della trasparenza del concetto, del primato dell’attività e della coscienza intenzionale. In questo senso si configurano gli obiettivi polemici di entrambi i corsi, condensabili in quell’assolutismo del soggetto costituente che viene promosso, in primis, dal criticismo kantiano e che risulta mantenuto, in parte, dalla fenomenologia husserliana. A prescindere dalla legittimità o meno delle obiezioni teoretiche avanzate da Merleau-Ponty alla fenomenologia di Husserl – argomento vagliato ampiamente nella letteratura italiana sul filosofo, fra cui ricordiamo l’importante lavoro di Sandro Mancini [2]–, è rilevante sottolineare come uno dei principali motori dei corsi sull’Istituzione, la passività sia la volontà di Merleau-Ponty di rompere con un certo aspetto della fenomenologia, inerente, nella fattispecie, la nozione di attribuzione del senso (Sinngebung) e, correlativamente, al primato della coscienza intenzionale come coscienza costituente.
Ciò non toglie il grande debito che Merleau-Ponty riconosce a Husserl e a quello che, altrove, definisce il suo «impensato» (Merleau-Ponty 2015, p. 193), il quale sembra coincidere, in qualche modo, con ciò che lo stesso Husserl aveva formulato, anche se con poca convinzione. D’altronde, è proprio Merleau-Ponty ad affermare che, «se dobbiamo molto allo stesso Husserl, non siamo in grado di vedere esattamente ciò che gli appartiene» (Merleau-Ponty 2015, p. 187). In particolare, ciò da cui Merleau-Ponty prende le mosse per formulare la sua idea di istituzione è la nozione husserliana di Stiftung – che, significativamente, Merleau-Ponty sceglie di non usare nella traduzione più diffusa di “fondazione” –, la quale riposa a sua volta sui concetti fenomenologici di sedimentazione e sintesi passive. A tale ripresa segue subito, però, un distacco di Merleau-Ponty da Husserl e da quella che egli evidenzia essere l’incapacità di quest’ultimo di andare fino in fondo alle sue stesse intuizioni, rimanendo imbrogliato fino alla fine in quella che Merleau-Ponty definisce una «analitica degli atti» (Merleau-Ponty 2003, p. 256). A favore, cioè, di una logica della costituzione soggettiva. Al contrario, come fa notare giustamente il co-curatore Giovanni Fava nella prefazione alla prima parte del volume, per Merleau-Ponty è necessario mostrare che «l’istituzione è anzitutto istituzione di un tra, di una giuntura tra esterno e interno, ed è per questo che la parola ‘istituzione’ non ha senso per la coscienza» (p. 48). È necessario, perciò, riconoscere il carattere impersonale della genesi del senso: proprio come il cuore continua il suo battito senza di me, ossia senza che io lo voglia o lo intenzioni – esempio caro a Merleau-Ponty –, allo stesso modo il senso si istituisce, passivamente e pre-soggettivamente, a prescindere dal gesto inaugurale soggettivo e intenzionale. «Affinché ci sia coscienza di qualcosa, occorre che non si dia coscienza di tutto» (p. 202), scrive nelle ultime pagine dei suoi appunti Merleau-Ponty, il quale, prendendo sul serio lo stesso concetto husserliano di coscienza intenzionale, deve ammettere l’impossibilità di una sua universalizzazione. Restituire il carattere non-intenzionale alla coscienza significa, allora, introdurre, anzitutto, un’idea di coscienza che non si riduca al processo di Sinngebung e, poi, una costituzione del senso che non dipenda dall’attività soggettiva. Il soggetto perde così il ruolo privilegiato di agente costituente il senso, e diviene colui a cui il senso delle cose accade, marginalizzandosi rispetto a un’attività pre-teoretica e temporale, «dove non si sente più la pulsazione della coscienza costituente» (Merleau-Ponty 2015, p. 194). Proprio il tempo risulta essere il modello stesso dell’istituzione, che viene descritta efficacemente da Merleau-Ponty nel riassunto del corso come tutti quegli eventi capaci di dotare l’esperienza di dimensioni durevoli, in rapporto alle quali tutta una serie di altre esperienze avranno senso, formeranno un seguito pensabile o una storia, oppure gli eventi che depositano in me un senso […] come appello a un seguito, come esigenza di un avvenire (p.176).
È, quindi, nella struttura fenomenologica del tempo che l’istituzione si esplica, ossia nell’istituirsi del futuro attraverso il passato che «conserva nell’istituito un’efficacia dell’istituente» (p.8), di modo che, «se l’istituzione è apertura a, quest’ultima si produce sempre a partire da» (p.9). La sedimentazione fenomenologica svolge, in questo senso, un ruolo fondamentale nell’economia dell’intero discorso, permettendo un circolo continuo tra passato-presente-futuro che, per Merleau-Ponty, ha la forma della simultaneità, in cui il pensare è, al tempo stesso, sempre un ri-pensare, alla luce di quell’archivio di pensieri già istituiti.
Nell’intima non-coincidenza tra produzione e ri-produzione, si immette quella tra attività e passività, concetti che convivono nella stessa definizione ambigua di istituzione, a un tempo stato di cose stabilite e atto di cominciamento. Al chiasmo passività-attività Merleau-Ponty decide di dedicare il corso del lunedì parallelo a quello sull’istituzione che, in questo volume (analogamente all’edizione francese), si colloca nella parte seconda. Come ricorda Riccardo Valenti – a cui si deve la prefazione al corso su Il problema della passività, arricchita da riferimenti cinematografici che, nell’ottica di un’ibridazione tra filosofia e non-filosofia, rimane piacevolmente coerente con l’insegnamento di Merleau-Ponty – il tema della passività «permea non solo le poche ma densissime pagine che compongono questa lettura, ma anche l’intera opera e riflessione – precedente e posteriore – del filosofo francese» (p. 180).
La passività, infatti, non si limita a rappresentare uno stato del soggetto, ma corrisponde, invece, alla sua propria modalità di relazionarsi con il mondo; rivelazione, questa, di «un genere dell’essere in relazione al quale il soggetto non è sovrano, senza tuttavia che vi si trovi inserito» (p. 333). Tale modalità risulta particolarmente evidente in quei casi limite da cui Merleau-Ponty sceglie di prendere le mosse nel suo discorso: il sonno, il sogno, la memoria e l’inconscio, dimensioni che «sembrano, per principio, escludere la ‘decisione’ di un Soggetto» (p. 22).
Se nel corso dedicato al tema dell’istituzione Merleau-Ponty compie il passaggio dalla frontalità del rapporto soggetto costituente/oggetto costituito alla lateralità propria del soggetto in quanto coscienza incarnata, istituente-istituita, è nella seconda parte delle sue lezioni che si interroga sulla morfologia di tale lateralità soggettiva. In questo contesto il sonno ha un ruolo fondamentale, in quanto è proprio nello stato di coscienza del dormiente-sognante che risulta evidente come il senso si produca autonomamente rispetto a una presa della coscienza intenzionale. La questione che emerge a questo punto è se tale autonomia nella genesi del senso onirico debba essere comunque rimessa a un agire soggettivo, quindi a un’attività di coscienza, oppure no. Interessandosi a tale tematica, Merleau-Ponty è consapevole di inserirsi in un dibattito già aperto, rispetto al quale richiama, nei suoi appunti, le posizioni di Freud e di Sartre (a cui seguiranno Bergson e Proust in merito alla questione, a questa connessa, della memoria involontaria). Sartre e Freud, pur partendo da presupposti teorici differenti, risultano concordi nel riconoscere nello stato assopito della coscienza una spiccata attività soggettiva, che, essendo lontana dal mondo, risulterebbe libera di agire al di là delle sue predeterminazioni fattuali. Non d’accordo con questa tesi, Merleau-Ponty rinviene, sia nella psicoanalisi freudiana sia nella filosofia coscienzialistica sartriana, un presupposto errato, che riguarderebbe, ancora una volta, l’indiscusso monopolio della coscienza: in Sartre, nell’assenza del mondo percettivo, che sarebbe soppiantato da un mondo onirico immaginario o irreale; in Freud, attraverso la traduzione della produzione passiva del senso inconscio e onirico nell’attività sotterranea di un “secondo io”. È chiaro come la questione del sonno, negazione o conservazione del mondo, si traduca, in tal senso, nel problema più generale del rapporto tra immaginario e reale, che per Merleau-Ponty risultano ambiti intrecciati nel campo comune dell’essere in quanto carne, nella contemplazione tanto di una “veglia del sonno” – data dal legame indissolubile tra corpo e mondo – quanto di un “onirismo della veglia”, dato in primis dalla nostra capacità immaginativa [3]. L’immaginario, quindi, non ha una minore rilevanza ontologica rispetto al reale, ma diviene esso stesso trama della realtà percettiva, invisibile tessitura di ogni visione possibile. È proprio in questo clima di “riabilitazione ontologica” dell’immaginario che Merleau-Ponty crea un legame tra fenomenologia e psicoanalisi, attribuendo a Freud il merito di aver scoperto un «simbolismo positivo» passando dall’idea di una trasparenza della verità all’idea di una sua stratificazione, per la quale «l’analisi di una condotta vi trovi sempre più livelli, più strati di significato, i quali hanno tutti una loro verità» (p. 336). Utilizzando lo stesso resoconto delle sedute che Freud riporta a sostegno della propria concezione di psiche, Merleau-Ponty mostra, con e oltre Freud, come la questione dell’inconscio si risolva attraverso la questione del corpo: «l’inconscio come coscienza percettiva è la soluzione che Freud cerca» (p. 263). Per Merleau-Ponty, infatti, è il corpo in quanto luogo dell’inconscio a dettare quel simbolismo primordiale di cui parlava Freud e che per il fenomenologo si articola sempre a partire da un campo percettivo, collocandosi quindi non più dietro o al di sotto dello stato cosciente, ma davanti a noi, come modalità del nostro vivere nel mondo, non prima ma tra gli atti intenzionali, «come l’intervallo degli alberi fra gli alberi, o come il loro livello comune» (Merleau-Ponty 2003, p. 205).
In una coincidenza quasi paradossale, per Merleau-Ponty l’inconscio non è altro che l’essere della coscienza corporea e percettiva, per mezzo di cui facciamo esperienza del mondo, la quale si origina sempre da quel puntum caecum, o in-conscio, dato dall’essere incarnato della coscienza in un corpo. Il contatto tra istituzione e passività è stabilito, in definitiva, dal materiale inconscio come “sedimentazione percettiva” che si radica nel nostro schema corporeo, venendo a costituire, secondariamente, una sedimentazione di matrici simboliche in grado di influenzare la stessa genesi del senso del mondo percepito.
In conclusione, questi appunti ci parlano della necessità di Merleau-Ponty di attingere alla teoria dell’inconscio come via d’accesso privilegiata per parlare di quella passività della nostra attività che, in quegli anni, lo costringeva alla riflessione. La passività si installa nel cuore della attività attraverso il riconoscimento dell’inconscio come modalità del nostro fare esperienza del mondo in modo essenzialmente corporeo e percettivo. Questa idea – introdotta da Merleau-Ponty nei corsi che, grazie a questa traduzione, sono ora disponibili in italiano – resterà fino alla fine della sua riflessione, rappresentando uno dei guadagni teoretici più importanti della sua ontologia.
Guardare ancora una volta ai corsi del Collège de France rappresenta, allora, un passaggio imprescindibile per gli attuali studi su Merleau-Ponty. Da un lato, questo è dovuto al fatto che L’istituzione, la passività consente di mettere in discussione gli assolutismi di un Merleau-Ponty fenomenologo o di un Merleau-Ponty onto-metafisico, per guardare a quella che fu l’idea rivoluzionaria di filosofia ambigua, fondata sulla reversibilità tra il piano ontologico e quello fenomenologico. Dall’altro, questo testo permette di evidenziare l’importanza che ebbe il contatto tra fenomenologia e psicoanalisi per costruire quella che ad oggi possiamo considerare una filosofia dell’immaginario e dell’invisibile, sforzandoci di intravedere la direzione che, da queste premesse, Merleau-Ponty avrebbe dato alla sua ontologia fenomenologica.
Marta Gailli
Note
[1] Dell’ampia letteratura sul tema, ci limitiamo a citare il recente fascicolo dal titolo Il problema dell’istituzione. Prospettive ontologiche, antropologiche e giuridico politico, a cura di E. Lisciani-Petrini e M. Adinolfi, in “Discipline filosofiche”, 29, n. 2, 2019; e il penultimo numero della rivista “Humamente” curato da F. Buongiorno e X. Chiaramonte e dedicato proprio al tema dei nostri corsi, Institution and Passivity: Rethinking Embodiment and Social Practices in the Contemporary Debate, in “Humanamente. Journal of Philosophical Studies”, 41, 2022.
[2] Su questo tema in particolare, si veda S. Mancini (2001). Sempre di nuovo. Merleau-Ponty e la dialettica dell’espressione. Milano: Mimesis.
[3] Sul medesimo terreno battuto da Merleau-Ponty si muoverà circa vent’anni dopo il filosofo greco-francese Castoriadis, nella sua ricerca teoretica-politica – che chiama in causa la stessa psicoanalisi – intorno al concetto di istituzione, legato intimamente al tema dell’immaginario. Cfr. C. Castoriadis (2022), L’istituzione immaginaria della società. Milano-Udine: Mimesis.
Bibliografia
Merleau-Ponty, M. (2003). Il visible e l’invisibile. Milano: Bompiani.
Id. (2015). Il filosofo e la sua ombra in id., Segni. Fenomenologia e strutturalismo, linguaggio e politica. Costruzione di una filosofia. Milano: Il Saggiatore.
Id. (2023). L’istituzione, la passività. Corso al Collège de France (1954-1955). Milano-Udine: Mimesis.
-
La scrittura sensibile. Proust e Merleau-Ponty
Recensioni / Febbraio 2023Nel film Magnifica presenza (Fandango, Faros Film) del regista turco Ferzan Özpetek, il giovane Pietro (Elio Giordano), vive un’esperienza singolare. Egli si accorge infatti, col tempo, di soggiornare in un appartamento infestato da fantasmi. Le misteriose entità, dapprima sfuggenti e timorose, trovano in Pietro un confidente, una figura amica, un tenero protettore. Lo stesso Pietro, che tra gli spiriti incontra Luca, vede in quest’uomo l’espressione più genuina ed autentica del sentimento amoroso, il candore delle prime volte. Sia Pietro che i membri della ‘compagnia Apollonio’ scoprono così un altro modo di vivere, di abitare il tempo, insieme, un tempo ‘ritrovato’, ben distante dalla mera cronologia, dal riepilogo del record quotidiano. I fantasmi che popolano la casa di Pietro non sono infatti ‘invenzioni’, per dirla con Bioy Casares. Non sono nemmeno il frutto di proiezioni sinistre, di spaventose allucinazioni. Lo svolgimento del film mostra che anche Pietro, come i suoi coinquilini, deve perdersi per poi ritrovarsi, per rivedersi, in senso autentico. Rivedere opinioni, correggere i propri giudizi su cose e persone: anche Pietro è un fantasma. Proprio di questa rettifica, di questa rilettura consta l’essenza più segreta della Ricerca.
Di Proust filosofo e della sua relazione con la fenomenologia merleau-pontyana si è scritto molto, nel corso negli anni passati. All’interno del vasto panorama offerto da questi studi, la recente pubblicazione del testo di Franck Robert va ad occupare una posizione di sicuro rilievo, e questo per più di una ragione. In primissimo luogo a colpire è l’ampiezza e la profondità, fisica e tematica, del volume in questione: composto da tredici capitoli (Proust philosophe; Percevoir, le rapport sensible au monde; De l’art; Modernité de Proust; Littérature et réalité; L’homme et l’œuvre; Art et vie; Le style; Vérité et institution; Approche phénoménologique. Temps et subjectivité; Le temps sensible; Écriture et vérité ed Ouvertures)che si dispongono su oltre quattrocentocinquanta pagine di testo, il lavoro di Robert rappresenta, a mia personale conoscenza, lo studio ad oggi più completo dedicato specificamente al confronto tra l’opera di Proust ed il pensiero di Merleau-Ponty, quest’ultimo da sempre affascinato, per confessione del filosofo stesso, dalla prosa dello scrittore e dalla sua ricchissima eredità concettuale. Un ulteriore e pregevole aspetto formale che mi preme rimarcare, in apertura, è la presenza constante, nell’argomentazione di Robert, di richiami teorici e testuali al corso merleau-pontyano Le problème de la parole, tenutosi al Collège de France tra gli anni 1953 e 1954, recentissimamente edito in lingua francese (Métis Presses, 2020, di questo testo mi permetto di segnalare una mia recensione pubblicata in «Studi di Estetica. Italian Journal of Aesthetics», vol. 19, 2021, pp. 237-242). Questa peculiarità, questa scelta speculativa, rappresenta senza dubbio un elemento meritorio e di originalità del già di per sé ricco lavoro di Robert.
La tesi fondamentale del libro è l’affermazione della centralità del ruolo della scrittura al cuore dell’esperienza sensibile. La scrittura non è slegata dalla pratica percettiva, anzi: ne è elemento costitutivo, compimento essenziale, sublimazione. Grazie alla scrittura l’uomo può ritrovare il senso autentico del tempo e dello spazio: tornando sui suoi passi, ripercorrendo a ritroso il cammino della conoscenza, ritrovandosi. Si tratta di un’opinione sostenuta sia da Proust che da Merleau-Ponty, sebbene sia stata comprovata in campi e discipline affatto diverse. Sia lo scrittore che il filosofo, però, hanno fatto della scrittura una vocazione, un mestiere, un modo di vivere ed interpretare il mondo e la propria epoca. Per entrambi la scrittura si spinge, si inoltra dove la percezione sensibile, la nostra prima e fondamentale porta d’accesso al mondo percepito, non può arrivare. Ma perché quest’insufficienza? Cosa serve a giustificare la sua comparsa della ‘grafia’, il suo richiamo, la sua fantasmagoria? Quale logica comanda la dimenticanza, e quale ancoraggio impone, in senso contrario, il percorso, la rotta del ricordo? Robert tenta di rispondere in questo testo a tali domande.
La scrittura, lungi dall’essere banale, sterile, ripetizione del senso, ne sancisce invece la ‘raccolta’, la ‘fissazione’, l’istituzione che non è, però, da intendersi quale esercizio di una qualsivoglia facoltà intellettuale, superiore, di ‘sorvolo’. La scrittura, dice Robert, «apre su di un’universalità che non presuppone, ma che, viceversa, inaugura» (p. 16). Tale affermazione prescrive la primarietà dell’espressione sull’espresso, della comunicazione sul contenuto della comunicazione stessa, facendo allusione ad un’universalità che non può – più – essere quella del concetto (p. 433). La parola non deve essere compresa come «esercizio del concetto, ma rivolta verso l’intersezione dei mezzi espressivi di una pienezza che essi delimitano [qu’ils jalonnent] ma che non contengono», recita Il problema della parola (p. 420; Merleau-Ponty 2020, 143).

Henri Michaux - Untitled (1959) (Flickr: Pedro Ribeiro Simões) Per mezzo dell’espediente letterario proustiano, «la verità che si rivela al narratore nelle reminiscenze della sensazione e nella scrittura – dice Robert – non è un accesso ritrovato a un mondo di idee che l'esperienza sensibile avrebbe coperto, poiché le arti che aprono la strada a questa verità, che abbozzano ciò che la letteratura realizzerà in altro modo, attraverso la scrittura, sono proprio le arti meno concettuali, più vicine al sensibile» (ibid.). Non è la filosofia che conduce alla filosofia, dice Robert, il sapere non si nutre di sapere, autenticamente, in modo univoco, ma è la ‘non-filosofia’, l’esperienza concreta, vissuta, ad indicare la via per il suo superamento non concettuale, laterale. L’intera opera di Proust, sostiene Robert facendo parlare le pagine Merleau-Ponty, può essere intesa allora come un tentativo di rovesciamento del platonismo, dell’idealismo cartesiano e delle sue derive teoreticamente più pericolose. Citando nuovamente Il problema della parola, in questo caso, «l’idea non precede l’espressione, ma è l’espressione ad essere responsabile dell’avvento dell’idea» (p. 108; Merleau-Ponty 2020, 160).
L’ambizioso compito della scrittura, e con essa del linguaggio letterario, è quello di restituire «la modalità di apparizione del mondo sensibile» (p. 221). E proprio «restituendo questo mondo vissuto, pre-nozionale, è possibile effettuare il passaggio all’idea: ovvero, è possibile costruire un ‘equivalente spirituale’ dell’esistenza» (Merleau-Ponty 2020, 178-179). Dunque, ‘spirituale’ ed ‘ intellettuale’ non sono termini coincidenti. Soprattutto, scrive Merleau-Ponty, «le essenze vere – e non quelle intellettuali – si trovano esclusivamente attraverso il chiaroscuro del vissuto, che noi provvediamo a costruire attraverso la nostra vita» (ibid.). La ‘modernità’ proustiana, la sua ‘ricerca’e la sua successiva realizzazione, sta, per Merleau-Ponty, nella sua capacità di rompere con la complicità idealistica con la conoscenza di ‘sorvolo’, la quale «sostituirebbe alle cose allo stato nascente l’idea delle cose», approdando alla dimensione più propria di ricerca dell’«idea sensibile» (p. 419). Quest’indagine si alimenta della proliferazione di «significati nascenti» (p. 435), designati dal criterio della «denominazione» (Merleau-Ponty 2020, pp. 153, 181-182; cfr. Merleau-Ponty 1996, pp. 106-108) e del suo eventuale capovolgimento ‘algoritmico’, – del quale il pittore Elstir è daimon proustiano né A l’ombre des jeunes filles en fleurs, così come, a ben vedere, lo è della reversibilità carnale merleau-pontyana – ovvero di quella logica del rinvio che, nella letteratura latu sensu, consentirebbe alla verità di raggiungere quell’universalità dettata da una progressiva ed inesauribile crescita «laterale» (Merleau-Ponty 2013), contributiva ed intersoggettiva.
Di questo consta la sintesi, passiva, delle ‘cose’ che la prosa di Proust sarebbe in grado di raccogliere, di riunire: la sintesi «risiede – allora – nel modo in cui il corpo riceve il mondo, nella capacità di tracciarvi delle linee che costituiscono un senso, degli assi che il soggetto segue, e che accompagna nel suo modo di abitare il mondo» (p. 435). Menzionando indirettamente il lavoro di Jacques Garelli, la ‘ricerca’ si occupa della raccolta del «logos del mondo estetico (…) delle idee prime che sono sensibili perché, all’interno del sensibile stesso, ne tracciano il senso pur senza apparirvi esteriormente» (ibid.).
Già, ma perché – come anticipato – si continua a parlare insistentemente, nelle pagine di Robert, di raccolta, di recupero del senso? Cosa è andato perduto nella delicata transizione tra percezione ed espressione, seguendo questa volta l’itinerario storico e teorico dell’opera merleau-pontyana? Cosa è andato ‘storto’? La replica a queste domande, sebbene ponderata e testualmente fondata, non può che risultare ambigua. A pagina 255, Robert sostiene che « [m]entre nell'opera di Proust la scrittura ha origine nella perdita, è una ricerca di un significato sepolto nell'esperienza del narratore, una raccolta e uno svelamento del passato, una ricerca di un senso della vita perduta, una vita superiore a qualsiasi vita vissuta, nell'opera di Stendhal la scrittura è identica alla vita stessa, un progetto di esistenza sempre già superato da questa stessa esistenza, un eccesso, un'apertura su un futuro che si inventa mentre si realizza, un'avventura». È una prima risposta, di primo acchito soddisfacente: vi sono molti modi di vivere, di interpretare, e quindi di scrivere il mondo circostante.
Ciò che, a mio parere, Merleau-Ponty individua ed apprezza nell’opera proustiana, ed è un aspetto che Robert coglie appieno, è il ruolo positivo della dimenticanza, dell’oblio, della capacità di allontanarsi dal mondo senza perderlo mai dal personale ‘orizzonte ermeneutico’, direbbe Collot, senza perderlo mai del tutto di vista. Per Proust ogni opera, ogni sforzo, mira ad «accogliere e a raccogliere l’esperienza», attraverso una «conquista differita e sospesa del senso dei fenomeni», la quale si attua per mezzo del «ritorno incessante al concreto, al sensibile» (p. 36). Secondo Proust, e a parere di Merleau-Ponty, l’esperienza, l’erranza avventurosa e, segnatamente, l’errore, la maldestrezza, è necessaria al fine di raggiungere la verità (p. 39). Questo punto è cruciale: il narratore non sarebbe tale senza la distanza, senza la contrarietà, senza la trascendenza che lo allontana da persone e cose, come l’istituzione del sentimento amoroso e la gelosia provata per Albertine nel corso su Istituzione e passività attestano con chiarezza. È come dire che sbagliando si impara o che il viaggio conta almeno quanto la destinazione, il che è condivisibile, detto anche in modo triviale.

Maurice Merleau-Ponty (Wikimedia)La posta in gioco è altissima. Non si tratta più solo, a ben vedere, di riconoscere il proprio favore ad un modo di raccontare le cose, ad un determinato tipo di restituzione degli eventi: ciò che si ridiscute, in queste pagine, è nientemeno che lo statuto dell’idealità, della razionalità, dell’epistemologia platonico-aristotelica che tradizionalmente sostiene l’architettura del pensiero occidentale.
Cercando di riassumere, queste sono le domande che ci si pongono, nuovamente: che tipo di relazione c'è tra l'eternità e la temporalità? La temporalità è un fatto primitivo o derivato? Può qualcosa essere ‘eterno’ e ‘temporale’ allo stesso tempo? Può qualcosa di originariamente ‘temporale’ assurgere al rango di essere ‘eterno’? Intuitivamente, ciò che è temporale può durare ‘per sempre’. Ciò che dura può essere ‘sempiterno’, ma è ancora situato ‘nel tempo’, in quanto radicato in una cornice strettamente temporale, chiariranno le lezioni di Merleau-Ponty su L’origine della geometria husserliano. Ciononostante, a quanto pare, per conferire all'azione temporale un valore autentico, positivo, abbiamo bisogno di una nuova definizione di memoria e di oblio, superando la lezione dello schiavo del Menone.
Nell’ontologia di Merleau-Ponty, «l'oblio ha la priorità» sul ricordo, perché «senza oblio non sarebbe possibile alcun ricordo» (Waldenfels, Calandrella 2000, 114). Dimenticare significa in un certo senso lasciare andare qualcosa, rinunciare al pieno possesso intellettuale del mondo, per conservarlo in altro modo. Il mondo sfugge perché il flusso del tempo influisce sulle capacità del soggetto vivente di trattenere tutte le possibili esperienze che passano, che scorrono, che si confondono l’una nell’altra. Il soggetto a cui pensa Merleau-Ponty non detiene più le prerogative di una coscienza assoluta poiché rivela un'apertura naturale, una disposizione ad accogliere il divenire del tempo e quindi a concedere «una sorta di passività» (Morris 2018, 86). Contestando il concetto di «ritenzione» di Husserl, Merleau-Ponty rimprovera a questi di non aver ammesso con sufficiente chiarezza che la memoria «implica l'oblio», afferma Gallagher (2005, 107).
Questo è un punto essenziale, poiché Merleau-Ponty non può sostenere il fatto che l'oblio possa essere concepito come «un passaggio nel nulla, – come ha fatto il tedesco – (...) ma – al contrario, – un modo di essere a... nell'allontanarsi da...» (Merleau-Ponty 1964, 250). Riprendendo le parole di Gallagher, «l'oblio permette la possibilità dell'intenzionalità; è il necessario rovescio dell'intenzionalità. Se l'intenzionalità è intesa come differenziazione, uno scarto, l'oblio è indifferenziazione» (2005, 107). Nell'ontologia di Merleau-Ponty, nulla è completamente perso, dal momento che nulla è assolutamente guadagnato, acquisito una volta per tutte. La presenza o l'assenza effettiva dell'uomo in questo mondo, la sua presa su di esso è, a ben vedere, solo una questione di variazione tra un modo di agire consapevole, intenzionale, e una modalità involontaria e inconsapevole di indifferenza vitale, un abbassamento, una regressione in qualche modo controllata.
La ritenzione è l'inarrestabile «affondamento graduale» della percezione presente, come hanno sottolineato Waldenfels e Giuliani (2019, 50), ma essa non comporta un eventuale, sciagurato naufragio della memoria. Conservare qualcosa significa invero non lasciar andare, trattenere ciò che l'oblio disperderebbe. Il processo di dimenticanza, proseguono i due studiosi, è «l'inverso dell'attenzione e, in quanto impercettibile, appartiene alla percezione stessa» (ibid.). La ritenzione entra in gioco in qualsiasi momento, poiché l'oblio vero e proprio «inizia ora» (ibid.), nel ‘tutto’ che è ‘ogni’, corrisponde cioè all'ineliminabile lato oscuro della percezione, di ogni atto percettivo. Ma come funziona questo processo di allontanamento? Come può Merleau-Ponty sostenere che la dimenticanza non porta alla completa, diciamo, cancellazione del ricordo, della presenza? Infine, come può il filosofo francese salvare l’essere dal nulla, dall’irrecuperabile?
Ecco che allora l’erranza proustiana insegna propriamente a Merleau-Ponty che è il corpo a custodire i segreti della memoria, ad esserne lo scrigno del tempo il cui sigillo può essere divelto solo a determinate condizioni, che non sono quelle dettate dalle logiche dell’intelletto. L’esperienza principe che testimonia la sussistenza, sotterranea, silenziosa, di questa memoria di permanenza, è offerta già dalle primissime pagine proustiane della Ricerca, dedicate alla descrizione del processo di addormentamento e di risveglio dal sonno del narratore. È la «descrizione del risveglio – dice Robert – e la scoperta della continuità tra il mio essere ed il mondo, che consentono di pensare la memoria del corpo» (p. 372). Questo lungo passo della Ricerca è commentato da Robert all’interno del capitolo Le temps sensible, collocato verso la conclusione del libro, e che ne rappresenta, a parere dello scrivente, uno degli estratti più vividi e riusciti circa l’analisi della comunanza tra i due intellettuali.
Nelle pagine proustiane, Merleau-Ponty coglie infatti quell’onirismo, quell’elemento immaginario, simbolico, proiettivo e retrospettivo, quella poesia o ‘poetica’ della coscienza, quell’affaiblissement dello spirito che stava cercando, quell’«indice» (Merleau-Ponty 1945, 479) che segnala un problema, che, filologicamente, lo interessava già dal 1945: mi riferisco all’attività nella passività, ai movimenti avversi e pur inerenti alla vita stessa, il chiaroscuro che, come detto, costruiamo giorno per giorno (e notte per notte). Quella peculiare azione-passione che è l’addomentarsi, l’‘endormissement’ è la migliore prova, illustra Robert, che una coscienza può perdersi e ritrovarsi «rimanendo se stessa», che essa non è mai pienamente presenza à sé, e che il sogno non incarna l’assenza di ogni coscienza» (p. 366). Al contrario, il sonno, come la veglia, incarna «un modo in cui il corpo dispone per incontrare il mondo» (ibid.).
Assodata la virtualità del sonno, quella cavità che è una possibilità interna all’essere, perché la coscienza «scivola, senza una transizione chiara, nel sonno» (p. 367), altrettanto importante appare il risveglio, nel quale il corpo effettivamente si ‘ritrova’. In Proust, «il tempo ritrovato (…) si delinea innanzitutto nel modo in cui il corpo conserva la memoria del passato (...) il corpo – prosegue Robert – è innanzitutto ciò che riceve, che raccoglie il mondo, ciò che è sensibile al mondo; in esso, nel sonno, come nella vita percettiva, si radica un senso che non proviene dall'attività della coscienza di veglia» (p. 366). Il corpo è un qualcuno, è colui che mantiene e salvaguarda il legame con il cosmo, il tempo e lo spazio. Proprio come Merleau-Ponty, anche Sartre si è cimentato nell’analisi del sonno proustiano, insistendo però grandemente – e colpevolmente, rimarca Robert – «sull’immobilità del corpo, sull’annullamento di ogni motricità e l’abbandono di ogni fascinazione dei pensieri» (p. 370).
È un versante interpretativo che Merleau-Ponty non condivide, e che si impegna a confutare proprio sulla base della lettera proustiana. L’immobilità ipnotica cui pensa Proust, dice Robert leggendo Merleau-Ponty, ricalca infatti di una soppressione diversa, che non è concepita come degradazione, diminuzione della vita della veglia. Nel sonno, si vive in un altro modo, secondo rinnovate coordinate etologiche: l’immobilità è infatti «una possibilità del corpo che si relaziona a delle possibilità altre rispetto alla motricità» (ibid.) e che non è affare di coscienza. Nel sonno, il corpo si ritrova: nel riassorbimento letargico, il dormiente ri-scopre, potremmo dire, la ‘religione’ ed il culto primitivo di un passato carnale dal carattere enigmatico, una liturgia per la quale l’ancoraggio alla profondità, alla stasi del riposo personifica già, forse curiosamente, le virtualità di un progetto, una specifica «iniziazione cinetica» (p. 67), l’attributo di un «movimento imminente» (Merleau-Ponty 2020, 139).
L’esperienza di Pietro perciò si ‘scrive’, si ‘raccoglie’. Nel sonno, nel sogno, in questa dimensione non meglio precisata dell’immaginario, la ‘compagnia Apollonio’ rivive, e Pietro con lei: le sue vicende riecheggiano per i muri dell’appartamento, le voci dei suoi protagonisti lo accompagnano nelle vicissitudini quotidiane, ed il recupero, la raccolta del senso, ‘ritrovato’, la sera, ha il sapore dolce dell’intimità, dell’appuntamento. L’auspicio è che la ricerca possa, in futuro, concentrarsi su quest’ambiguità teorica, quest’anfibolia interna alla vita cosciente, rappresentata dalla dualità sonno-veglia, un aspetto che il libro di Robert ha messo in mostra con singolare fulgore.
di Riccardo Valenti
Bibliografia
Opere merleau-pontyane
M. Merleau-Ponty (1945). Phénoménologie de la perception, Paris, PUF
M. Merleau-Ponty (1964). Le visible et l’invisible. Suivi de Notes de travail, Paris, Gallimard
M. Merleau-Ponty (1996). Sens et non-sens, Paris, Gallimard
M. Merleau-Ponty (2013). Recherches sur l’usage littéraire du langage. Cours au Collège de France. Notes 1953, Genève, Métis Presses,
M. Merleau-Ponty (2020), Le problème de la parole. Cours au Collège de France. Notes, 1953-1954, Genève, Métis Presses
Bibliografia secondaria
S. Gallagher (2005) «Disrupting Seriality. Merleau-Ponty, Lyotard, and Post-Husserlean Temporality», in L. Hass; D. Olkowski (ed.), Rereading Merleau-Ponty. Essays Beyond the Continental-Analytic Divide, New York, Humanity Books
D. Morris (2018). Merleau-Ponty’s Developmental Ontology, Evanston, Northwestern University Press
B. Waldenfels; D. Calandrella (2000), Time Lag: Motifs for a Phenomenology of Time, in «Research on Phenomenology», vol. 30, Leiden, Brill
B. Waldenfels; R. Giuliani (2019) «Vortex of Time: Merleau-Ponty on Temporality», in E. Alloa; F. Chouraqui; R. Kaushik (ed.), Merleau-Ponty and Contemporary Philosophy, Albany, Suny
-
Non è certo facile restituire la complessità e la densità del volume di Maurice Merleau-Ponty, Il mondo sensibile e il mondo dell’espressione (Mimesis 2021), recentemente tradotto e curato per il pubblico italiano da Anna Caterina Dalmasso, senza dubbio una delle studiose più autorevoli del pensiero del filosofo francese (suo l’importante saggio di Introduzione, pp. 17-52). Non è facile innanzitutto per la stessa natura di questo (non) libro, che raccoglie il materiale del filosofo prodotto in vista del suo primo corso al Collège de France dell’a.a. 1952-53. Il volume contiene tanto l’effettivo materiale utilizzato dal filosofo nelle sue esposizioni orali, quanto appunti che ne ampliano e approfondiscono l’orizzonte teoretico.
L’opportunità per il pubblico italiano di studiare e apprezzare il pensiero di Merleau-Ponty svolto al Collège si amplia così, dopo la traduzione di altri corsi avvenuta a cavallo tra la fine del secolo scorso e l’inizio del millennio: La nature (Seuil, 1995, tr. it. Cortina, 1996) e Notes de Cours 1959-1961 (Gallimard, 1996; tr. it. Cortina, 2003). Quello che qui discuteremo è stato pubblicato nel 2011 dall’editore svizzero MētisPresses[1] sotto la direzione scientifica di E. de Saint Aubert e di S. Kristensen e la traduzione italiana permette di accedere a un materiale teorico molto fecondo, sia per chi si occupa direttamente di Merleau-Ponty sia per chi sia interessato al pensiero francese del Novecento. In queste quattordici lezioni, infatti, si anticipano o si sviluppano in modi originali piste che attraversano, carsicamente a volte, altre in superficie, una tradizione di pensiero gravida ancora oggi di ampi sviluppi teorici. Lungi dall’essere una pubblicazione per soli addetti ai lavori, questo volume può essere di grande aiuto a chi volesse comprendere meglio alcuni intrecci - sia detto solo a titolo di esempio non esaustivo — tra Gestaltpsychologie e filosofia dell’esistenza, tra bergsonismo e fenomenologia, nonché — come segnala la Prefazione di Mauro Carbone (pp. 9-16) foriera di stimolanti riflessioni sull’arte e l’estetica. Insomma, pur non essendo di facile accesso — e tuttavia l’ottimo lavoro di Dalmasso aiuta chi non fosse specialista — il volume non potrà che trovare interesse in molti ambiti degli studi filosofici contemporanei.
Qui ci proponiamo di tracciare una possibile via d’accesso in questo universo filosofico ancora da esplorare anche da parte di chi, da molti anni, vi si dedica con studio attento. Come ogni pista d’accesso, non ne impedisce di altre e non può essere pienamente esaustiva della ricchezza contenuta nelle quasi trecento pagine del volume. Tuttavia, può essere utile a meglio orientarvisi. Come segnala la curatrice, il volume ha il merito di offrire «un punto di vista privilegiato» (p. 17) sul back-office della produzione di Merleau-Ponty, un vero e proprio laboratorio artigianale di concetti situato al fondo del lavoro pubblicato in vita dall’autore.
A differenza degli altri corsi già tradotti per il lettore italiano, la peculiarità de Il mondo sensibile e il mondo dell’espressione consiste nel fatto che esso ci mostra un Merleau-Ponty sul punto di farsi, che non è più quello della Fenomenologia della percezione e non è ancora quello de Le avventure della dialettica, un Merleau-Ponty per così dire “intermedio”, in divenire (Lanfredini 2011): «Le note del corso del ’53 — continua Dalmasso — offrono un insieme di argomentazioni e di fonti in grado di gettare luce su alcuni punti più oscuri o anelli mancanti della riflessione merleau-pontiana successiva» (p. 18). Insomma, il corpus magmatico di questo volume permette, a chi voglia avventurarvisi, di «cogliere “un filosofo al lavoro” e di “accompagnare Merleau-Ponty” nel farsi del suo lavoro» (p. 20). Una vera e propria avventura filosofica che permette al lettore di oggi di risemantizzare molte antinomie che nel nostro presente appaiono ovvi se non addirittura vetusti. Del resto, non siamo noi oggi figli di quella temperie culturale che genericamente potremmo definire post-moderna e che ha fatto della lotta al manicheismo dualistico la sua pars destruens ? È un pensiero non dualistico, senza per questo, vedremo, rinunciare alla duplicità, quello che l’autore — che ovviamente di post-moderno non sapeva nulla — prova a mettere in forma, e che noi abbiamo occasione di studiare proprio nell’atto del suo generarsi.
Mondo sensibile e mondo dell’espressione definiscono un’antinomia che trova le proprie radici, a voler estremizzare, quanto meno nella distinzione platonica tra mondo ideale e mondo sensibile. Se si volessero fissare delle tappe a noi più vicine — come sempre troppo semplicistiche, ma utili a orientarsi — sensibile ed espressione rimandando alle distinzioni moderne di Descartes (quella tra materia estesa e pensiero inesteso) e di Kant (mondo sensibile della natura e mondo intelligibile dei valori) generalizzabile nella distinzione del pensiero antropologico tra natura e cultura (Lévi-Strauss 1969 pp. 39-52; Descola 2005). Già dunque nel tema stesso delle lezioni contenute in questo volume si comprende lo sforzo teorico che le sottende, un lavoro filosofico e fenomenologico che chiama in causa le principali architravi del nostro sensus communis moderno.
Potrebbe essere utile contestualizzare brevemente queste note di corso (si rimanda all’introduzionedella curatrice per i dettagli). L’anno accademico, come detto, è il 1952-53 ed è l’esordio di Merleau-Ponty al Collège de France, dopo che ha già tenuto il suo Elogio della filosofia nella lezione inaugurale (Merleau-Ponty, 2008) e mentre sta aprendo il cammino che lo consacra ai livelli più alti della cultura e della filosofia francese e forse mondiale. Non sono anni facili, gli anni Cinquanta, sia a livello storico (sono gli anni della guerra fredda, delle prime notizie in occidente del regime staliniano, della guerra di Corea, ecc.) sia a livello personale (Merleau-Ponty ha in cantiere La prosa del mondo che resterà incompiuto, sta rivedendo le sue posizioni rispetto all’URSS espresse in Umanismo e terrore del 1948, ma, soprattutto, sta per rompere il grande sodalizio filosofico e affettivo con J.-P. Sartre). Sul piano scientifico ha qualche sassolino nelle scarpe dopo la conferenza del 1946 presso la Société de philosophie dal titolo Il primato della percezione e le sue conseguenze filosofiche (Merleau-Ponty2004) nella quale presentava davanti a un pubblico composto dalle migliori menti filosofiche del tempo i risultati conseguiti con Fenomenologia della percezione. Amici e colleghi (Hyppolite, Bréhier, Lachièze-Rey per citarne alcuni) accolgono in maniera polemica e critica la tesi di fondo di quel libro accusandolo in alcuni casi di sensismo e positivismo. La sensazione di non essere stato compreso si radica nel filosofo e sette anni dopo è proprio da quella discussione che, con certosina attenzione, riparte (p. 61). Il primato della percezione diventa un punto di partenza ottimale per penetrare nel fitto bosco del sensibile e dell’espressione.
Sin dalla prima lezione, quasi un brevissimo compendio di Fenomenologia della percezione, emerge il tema cruciale con un gusto programmatico. Si tratta, cioè, di pensare l’unità del mondo percepito tale che questa unione non sia la “sintesi determinante”, la sintesi intellettuale, cioè, di una molteplicità sensoriale di stimoli empirici. L’unità cercata nella sua opera principale (ma anche in La struttura del comportamento del 1942) non era una sintesi del giudizio, ma di ordine “percettivo”. Si può dunque capire come qui emergano molte ambiguità che il filosofo dovrà in qualche modo dipanare.
Primato della percezione non significa postulare l’esistenza delle cose fuori di me o la corrispondenza oggettiva di mondo e conoscenza né di opporre a una filosofia intellettualista un empirismo sensista à la Hume, bensì di «fare una teoria concreta dello spirito» (p. 59). Il primato della percezione non postula «un primato del sensoriale, del dato naturale» (p. 60), ma è ricerca di un piano originario che non sia né empirico né trascendentale in cui il sensibile e l’espressione possano divenire indiscernibili: è lo statuto stesso della fenomenologia a modificarsi con questo primato. Fenomenologia della percezione non sta ad indicare solo che è possibile trattare la percezione come “noema”, ma che nel farlo si segue il divenire della percezione nel suo stesso attuarsi, ossia che la percezione indica un piano ontologico intermedio tra l’essere oggettivo e l’essere soggettivo. Si può trattare fenomenologicamente la percezione solo se essa non è né l’oggetto di un sapere né il soggetto della sensazione. È questo né né a non essere stato compreso alla Société nel ’46 (pp. 61-62). Il punto è che la percezione non rimanda solo al mondo del sensibile, ma implica anche un carattere espressivo: «Intenderemo qui per espressione o espressività la proprietà che ha un fenomeno, per la sua organizzazione interna, di farne conoscere un altro che non è dato o che non è mai stato dato. […] È in questo […] senso che la percezione è espressione, espressione del mondo» (pp. 62-63).
Fare una fenomenologia della percezione è studiare il farsi del mondo, una fenomenologia che acquista sempre più caratteristiche “hegeliane” (Vuillerod, 2018) risemantizzando il concetto di coscienza. Se c’è percezione, infatti, non è detto che vi sia necessariamente soggetto (nel senso del Cogito trascendentale che accompagna ogni io empirico), ma vi è senz’altro coscienza, che non è il pieno possesso di sé che la tradizione cartesiana e kantiana ci ha consegnato. La coscienza percettiva non è esterna alle cose, si situa tra di esse, ma non è cosa estesa tra cose estese: essa si fa negli scarti, nelle differenze (cromatiche, uditive, sensibili…) tra le cose, è trans-individuale (Ruyer 2018; Simondon 2011), passività creativa (Ménasé 2003). A differenza di quella trascendentale, essa «non ha a che fare con valori […], ma con esseri esistenti» (p. 64). Potremmo dire, cioè, che attraverso il primato della percezione Merleau-Ponty intraveda la possibilità di emancipare la coscienza percettiva dalla sovranità dell’intelletto dell’estetica trascendentale e di riscoprire nella materialità il suo proprio valore/valere.
L’espressività della percezione — il suo “primato” — è dunque ontogenetico, essa non è la facoltà inferiore della coscienza — come all’origine dell’estetica riteneva, ad esempio, A.G. Baumgarten (1993: 41) — ma la sua espressione “sensibile”, è «configurazione, struttura» (p. 65). Ecco un secondo termine fondamentale nel lessico merleau-pontiano che richiama il suo primo grande libro, La struttura del comportamento. Il primato della percezione implica una materialità della coscienza percettiva da intendersi come processo di strutturazione. Se la percezione non è (solo) la passività di un soggetto empirico, ma l’attività — quantunque “passiva” — di una coscienza “materiale”, allora essa è a tutti gli effetti concepibile nei termini di un comportamento (nel senso, ad esempio, in cui quantisticamente una particella ha un comportamento), un’attività vincolata ad un mondo-ambiente. L’espressione percettiva non è un atto puro, ma una prassi “situata” in uno “sfondo” di passività. Il richiamo è qui alla Gestaltpsychologie, che Merleau-Ponty aveva studiato attentamente nel libro del 1942 (e che nel corso affronta tra la settima e la nona lezione). Ogni coscienza percettiva è una figura (Gestalt) che emerge da uno sfondo e «vi è sempre qualcosa di inarticolato e di sottinteso in ciò di cui vi è coscienza» (p. 67). Lungi dall’essere un’astratta sensazione senza soggetto, l’espressione sensibile è un processo di figurazione (Gestaltung) e la coscienza percettiva è una figura o forma materiale. La coscienza percettiva non è un cogito ma un corpo, non un’anima che emerge e s’innalza dalla materia, ma l’individuazione, l’attività immanente, la configurazione sensibile e materiale di un corpo. Il primato della percezione è il primato del corpo sull’anima, non nel senso “empiristico-naturalistico” di un primato dell’esteso sull’inesteso, ma di una indiscernibilità tra il mondo sensibile della corporeità e la sua espressione animale.
Allora fenomenologia diviene sinonimo di strutturazione ontologica — «non vi è differenza tra ontologia e fenomenologia» (p. 61) — e il primato della percezione conduce a una ontologia dinamica e processuale (Vanzago, 2001). Il mondo dell’espressione non è riducibile a un mondo formale, ha una sua materialità; il sensibile non è inerte o passivo. C’è espressività sensibile tanto quanto vi è sensibilità “spirituale”. Né inerte né formale: l’espressività del sensibile è movimento e la fenomenologia della percezione è manifestazione non richiudibile negli steccati formali dell’estetica trascendentale, poiché non vi è più un primato del formale estetico (dello spazio e del tempo formali). Si avvia qui quello che con Husserl (1991) potremmo chiamare rovesciamento della rivoluzione copernicana: è il movimento a determinare le forme del tempo e dello spazio, non il contrario. Anzi: spazio e tempo non sono più forme, ma figure (Gestalten). Il movimento (si veda in particolare la sesta lezione) è il fenomeno espressivo per eccellenza, tutt’altro dunque che l’esito di una rappresentazione soggettiva. Come la percezione, esso non è l’oggetto di un sapere né l’attributo di un cogito (p. 99), ma è qualcosa che può essere solo sentito, in cui si manifesta il movente. Non è neppure un mero accidente che capita a un oggetto empirico, non è, cioè, la variazione di luogo nel tempo di una “cosa” (Sache), ma il fenomeno per il quale “qualcosa” (Ding) si esprime, emerge spazialmente e temporalmente (geograficamente e storicamente) in quanto figura su sfondo.
Il movimento espressivo è l’installazione sensibile di una coscienza percettiva nel cuore dello spazio e del tempo, il suo modo di abitare lo spazio e il tempo (p. 103), i quali non sono relazioni formali né empiriche, bensì modali. C’è movimento, ovvero qualche cosa appare, c’è della percezione, c’è del comportamento, c’è della coscienza, c’è figurazione: espressione di un’immagine materiale. Il movimento espressivo (siamo alla quarta lezione del corso) è «spirito che si fa corpo e corpo che si fa spirito […] una logica del funzionamento percettivo» (p. 105). Rovesciamento della fenomenologia hegeliana: fenomenologia e logica della percezione; il corpo è lo spirito, il mondo sensibile esprime il mondo spirituale; l’unione non è sintesi assoluta, ma l’affinità trascendentale (p. 107) dello spirito col sensibile in sopravanzamento (overlapping) l’uno sull’altro, «sintesi di enjambement» (p. 109).
Il movimento espressivo è la sintesi senza concetto di spazio e tempo. La mente va a Bergson che più di chiunque altro nel Novecento si è sforzato di pensare il soggetto implicato nel movimento (pp. 119-125). Dopo aver esposto, all’inizio della sesta lezione, gli «argomenti di Zenone» (p. 118) sull’impossibilità ontologica del movimento, Merleau-Ponty vi si richiama: «Per lui quello che rende impossibile il movimento nel pensiero di Zenone è la divisione infinita e attuale del tempo e dello spazio, […] per rendere possibile il movimento occorre che il tempo e lo spazio siano divisibili, ma non divisi, che, posti a partire dal tutto, ammettano uno spazio “tra” le posizioni e gli istanti, cosa che non è possibile nell’in sé. È quindi necessario che il movimento , che è fatto del mondo, sconfini su di me come durata, sia anche fatto di coscienza» (p. 119). Tuttavia, Bergson nel cercare un tout indivisé del movimento è ancora troppo intellettualista, «resta coscienziale» (p. 121). Occorre essere, si legge tra le righe delle note di lavoro, più bergsoniani di Bergson, il quale «trionfa su Zenone mostrando che il tempo non è fatto di istanti né lo spazio di limiti di spazio, ed è vero. Ma resta da esplicitare la conseguenza […] crede che il problema sia concluso» (p. 239). Diventa necessaria «una teoria del corpo percipiente» (p. 240), un paradigma del corpo (Iofrida 2019) che troviamo tra l’undicesima e la tredicesima lezione (nel cuore, dunque, del corso): il movimento è sì un dato immediato della coscienza, ma di una coscienza percettiva, una coscienza-immagine che sia la sintesi esistenziale (materiale) della durata, la quale viene così reinterpretata come espressione sensibile, immagine-spaziotempo, figurazione espressiva.
La durata bergsoniana è “astratta” e manca, agli occhi di Merleau-Ponty, la “e”tra sensibilità ed espressività, una unità (dodicesima lezione) non teoretica, ma pratica, «unità dello schema corporeo […] unità di un’azione sul mondo, di una prassi» (p. 187), non nel senso di un pragmatismo utilitaristico (che per Merleau-Ponty manterrebbe la sussunzione dell’azione sensibile a uno scopo sovrasensibile), ma come attività passiva di creazione di immagini, una prassi che «comporta una teoria [Theoria] o gnosis che ne è lo sfondo, che essa modifica e che a sua volta la modifica» (ibidem). La durata espressiva è unità di teoria e di prassi, una praktognosia che non è un pragmatismo — esiste una materialità dei valori — né un empirismo — c’è, come rileva Dalmasso, una intenzionalità del sensibile (pp. 46-52). La durata come congiunzione del mondo sensibile e del mondo dell’espressione, una unità che si può a buon diritto definire estetica (se con Kant intendiamo “estetica” l’unità senza concetto, pre-logica).
Non è un caso che i corsi del ’53 si chiudano (quattordicesima lezione) con delle considerazioni sull’Arte in generale, e sul cinema in particolare. Le considerazioni estetiche di Merleau-Ponty sul cinema meriterebbero ben altre analisi (si rimanda ai lavori di Carbone e di Dalmasso), qui ci limitiamo solo a trarre una brevissima conclusione. Il cinema è la “prova ontologica” del primato della percezione e del movimento espressivo. Esso è una ritmologia della durata dell’immagine, un contrappunto di punti di vista, di immagini che sopravanzano l’una sull’altra. Nell’arte cinematografica si realizza l’unità di sensibile ed espressione, il vinculum substantiale di una molteplicità di immagini sensibili senza sussunzione entro i decreti formali dell’intelletto trascendentale. Nel movimento cinematografico appare una vera e propria monadologia sensibile (p. 64) che si insinua nel mezzo dei due mondi, che sono “separabili” ma non separati e nelle cui pieghe emergono molteplici mondi intermedi. Come scrive Carbone, nel cinema «si celebra il venire ad espressione […] del mondo sensibile» (p. 16).
Questi mondi intermedi sono il legame tra mondo sensibile e mondo dell’espressione e costituiscono l’ambiente originario nel quale la nostra capacità creativa di corpi animali o anime materiali riesce a trovare spazio per esprimersi e manifestarsi attraverso un’inaspettata fenomenologia dello spirito-carne che solo un primato della percezione può rendere visibile. Già solo questa breve conclusione a cui perviene Merleau-Ponty nei corsi dedicati alla duplicità sensibile/espressione, forse, vale da sola lo studio attento di questo volume.
di Gianluca De Fazio
[1] L’editore continua ancora oggi il suo lavoro di pubblicazione dei corsi al Collège de France di Merleau-Ponty. Si segnala il numero monografico dedicato al Mondo sensibile e mondo dell’espressione della rivista Chiasmi International (n. s. 12-2010).
Bibliografia
Baumgartem, A.G. (1993), Progetto dell’estetica, in A.G. Baumgarten, I. Kant, Il battesimo dell’estetica, a cura di L. Amoroso, ETS, Pisa.
Descola, P. (2005), Par-delà nature et culture, Gallimard, Paris.
Husserl, E. (1991), Rovesciamento della dottrina copernicana della corrente visione del mondo, «Aut-Aut», 245, pp. 3-18.
Iofrida, M. (2019), Per un paradigma del corpo: una rifondazione filosofica dell’ecologia, Quodlibet, Macerata.
Lanfredini, R. (2011, a cura di), Divenire di Merleau-Ponty. Filosofia di un soggetto incarnato, Guerini, Milano.
Lévi-Strauss, C. (1969), La struttura elementare della parentela, a cura di A.M. Cirese, Feltrinelli, Milano.
Ménasé, S. (2003), Passivité et création. Merleau-Ponty et l’art moderne, PUF, Paris.
Merleau-Ponty, M. (2004), Il primato della percezione e le sue conseguenze filosofiche, a cura di R. Prezzo, F. Negri Medusa, Milano.
Merleau-Ponty, M. (2008), Elogio della filosofia, a cura di C. Sini, SE, Milano.
Ruyer, R. (2018), Neofinalismo, a cura di U. Ugazio, V. Cavedagna, G. Vissio, Mimesis, Milano-Udine.
Simondon, G. (2011), L’individuazione alla luce delle nozioni di forma e d’informazione, a cura di G. Carrozzini, Mimesis, Milano-Udine.
Vanzago, L. (2001), Modi del tempo: simultaneità, processualità e relazionalità tra Whitehead e Merleau-Ponty, Mimesis, Milano-Udine.
Vuillerod, J.B. (2018), Merleau-Ponty hégélien?, «Chiasmi International», n.s. 19, pp. 101-114.
-
PK#16 \ Meditazioni sull’amore
Rivista / Maggio 2022Come l’essere, anche l’amore si dice in molti modi. Diverse sono le grammatiche dell’amore, e diverse sono le fenomenologie dell’esperienza amorosa. Complicati sono pure i fili che annodano le grammatiche dell’amore, che permettono cioè di raccontare le storie d’amore, con le esperienze amorose, le quali, anche quando si dicono nella parola non pronunciata dell’estasi erotica o nel silenzio che accompagna il lutto dovuto alla perdita dell’oggetto amato, sono sempre tese verso il loro dirsi, verso una narrazione possibile. Purificare, o emendare, tali grammatiche non è impresa facile, ma, riconoscendo che in molte di esse si cela la presenza – a volte nemmeno tanto nascosta – del dominio maschile o patriarcale, è per lo meno auspicabile fornirne una decostruzione.

Like being, love is said in many ways. There are different grammars of love, and different phenomenologies of love experience. The threads that bind the grammars of love are also complex, and even when they are said in the unspoken words of erotic ecstasy or in the silence that accompanies the mourning due to the loss of the beloved object, they are always stretched towards their own saying, towards a possible narration. Purifying or amending these grammars is not an easy task, but recognising that many of them conceal the presence - sometimes not even so hidden - of male or patriarchal domination, it is at least desirable to provide a deconstruction.
A cura di Veronica Cavedagna e Giovanni Leghissa
Scarica PDF
English version
DOI: https://doi.org/10.13135/2385-1945/16.2022
Pubblicato: marzo 2022
Indice
EDITORIALE
I. TEORIE D'AMORE
Nicoletta Cusano - Amor, ch’a nullo amante amar perdona… [PDF It]
Sergio Benvenuto - Una sfida per la filosofia [PDF It]
Mara Montanaro - Uno scambio di fantasmi [PDF It]
Andrea Zoppis - L’amore al vaglio della contingenza. Note sulla relazione amorosa a partire da Merleau- Ponty e Simondon [PDF It]
Prisca Amoroso - Custodire la distanza. Una riflessione sulla profondità come dimensione amorosa a partire da François Jullien [PDF It]
Benoît Monginot - Figures, désir, dérive. Eros et poétique dans « Sed non satiata » de Charles Baudelaire [PDF Fr]
II. GLI SPAZI DELL'AMORE
Chiara Piazzesi - Towards a Sociological Understanding of Love: Insights from Research [PDF En]
Francesca Caiazzo - La temporalité de l’expérience amoureuse moderne à partir des apports d’Eva Illouz [PDF Fr]
Carlo Deregibus - Gli spazi dimenticati dell’eros. Progettare occasioni di spontaneità [PDF It]
III. RESISTENZE
Manon Garcia - Dall’oppressione all’indipendenza. La filosofia dell’amore nel "Il Secondo sesso" di Simone de Beauvoir [PDF It]
Veronica Maio - Amore clitorideo. Esperienza amorosa e sovversione dell’identità sessuale nell’autocoscienza di Carla Lonzi [PDF It]
Floriana Ferro - Beauty and Possession. Reversible Eros [PDF En]
IV. MODI DI SIGNIFICARE
Gianni Pellegrini - Chiodo scaccia chiodi! Spigolature dalle tradizioni intellettuali sud-asiatiche sull’amore e/o desiderio (kāma) come antidoto ai desideri [PDF It]
V. LETTURE, RILETTURE E TESTIMONIANZE
Chiara Pignatti, Marco Xerra - Godere di dio. La posizione mistica tra devastazione e amore [PDF It]
Noemi Magerand - « Se faire la complice d’un ordre qui nous opprime » : comment Réinventer l’amour avec Mona Chollet [PDF Fr]
Emilia Marra - De gli erotici furori: amore e relazioni nel nuovo abitare [PDF It]
-
L’Universo come cinema in sé
Recensioni / Settembre 2021Ogni appassionato di cinema lo sa: quello che cerca, guardando un film, non è soltanto una fuga dal proprio quotidiano – magari attraverso l’intermediazione delle vite altrui, immaginarie o meno che siano –, ma una certa, difficilmente definibile estraneazione dal “sé”, un modo per disaderire sic et simpliciter da quel centro gravitazionale per il resto onnipresente che è il proprio stesso “io”. Ciò che insomma seduce, sino al fanatismo, nella settima arte, non è tanto o solamente la capacità di raccontare storie, ma di immettere piuttosto lo spettatore in uno svincolamento possibile dalla sua prospettiva personale, di, in altre parole, autorizzarlo per un certo tempo ad abbandonare le rive tumultuose del proprio monologo interiore in favore di una partecipazione tendenzialmente assoluta al divenire delle cose (‘cose’ di cui faranno parte, a questo punto, persino le persone rappresentate). È per questo motivo che Gilles Deleuze, proseguendo un’intuizione che era già stata prima, perlomeno, di André Bazin («Il cinema come mummia del tempo») e di Pier Paolo Pasolini («Il cinema come lingua scritta della realtà»), ha riconosciuto nel cinema la facoltà di pensare, a tutti gli effetti, e anzi di permetterci di riconoscere come lo stesso universo possa essere a sua volta pensato alla stregua di un «cinema in sé». In quei due capolavori che sono L’immagine-movimento (1983) e L’immagine-tempo (1985), il dispositivo cinematografico assurge infatti a metodo di indagine cosmologico e persino cosmogenetico, rivelando a tutti noi che il mondo è tutto fuorché un semplice tutto, dato e costituito come un «Grande Oggetto» (Roger Chambon), ma si configura piuttosto come un complesso cangiante di processi infinitamente prolungati gli uni negli altri, come uno specchio mutevole, insomma, del pensiero in atto.
È questa allora la tesi che campeggia al centro di Cosmogenesi dell’esperienza. Il campo trascendentale impersonale da Bergson a Deleuze (Mimesis 2021, pp. 314), primo e importante libro di Giulio Piatti. Pur dedicando soltanto una parte della sua indagine al cinema (pp. 217-37), questo studio permette infatti di reperire nel cuore di una certa tradizione filosofica novecentesca una tendenza sempre più precisa e acuminata a vedere nel reale la sua stessa messa in immagine e anzi a cercare in un reale liberato di ogni ipoteca antropocentrica l’origine tanto della nostra prerogativa a rappresentarci il mondo quanto della predisposizione del mondo a divenire rappresentazione, secondo un modello di intelligibilità che eleva la genesi a forma vera dell’ontologia.
Un campo trascendentale impersonale non è quindi soltanto un concetto, ma una serie generativa di (altri) concetti. Si tratta di qualcosa che Henri Bergson interpreta, sia pure non servendosi dell’espressione, come insieme di immagini in sé e per sé (immagini di niente e per nessuno), assimilandolo a una materia in cui la percezione, ricondotta al suo stadio più puro, spogliata di ogni ricordo interpretativo, sarebbe come «già scattata» nelle cose stesse (pp. 31-72). È da qui che l’esperienza propriamente soggettiva sorgerebbe, nel momento in cui un corpo vivente comincia a deflettere un movimento materiale che altrimenti si propaga senza sosta in tutte le direzioni e su tutte le superfici. Ma si tratta anche di ciò che Raymond Ruyer, contestando a sua volta Bergson, è costretto comunque a rintracciare nella stoffa della sensazione, da pensarsi come modello di ogni coscienza e dunque di ogni essere veramente unitario (dall’elettrone all’universo). Da pensarsi come, in altre parole, una superficie che, senza poter prendere le distanze lungo una qualche perpendicolare, è comunque in presa diretta su di sé, quasi che il soggetto della sensazione fosse diffuso senza velocità limite in ogni punto del suo sentire e del suo essere al contempo la sensazione che ha (pp. 160-164). Ancora, è quanto Maurice Merleau-Ponty si troverà a ipotizzare per correggere in corso d’opera la rigidezza bipolare dell’intenzionalità husserliana e riuscire a pensare un percepire che è già sempre incarnato e co-implicato con il mondo, secondo un chiastica convergente-divergenza o divergente-convergenza che spariglia una volta per tutte la correlazione lineare tra soggetto e oggetto (pp. 149-153). E, infine, sarà il piano d’immanenza che Deleuze stesso e Félix Guattari evocheranno nella loro ultima opera, Che cos’è la filosofia? (1991), come operazione archetipale che ogni filosofo deve compiere per resistere a quel caos che dissipa altrimenti ogni pensiero e che pure bisogna poter frequentare per trarne nuova linfa, sia essa filosofica, artistica o scientifica (p. 213 e ss). Lo stesso piano che il solo Deleuze aveva già identificato appunto come la prestazione più tipica del cinema (soprattutto in alcune delle sue espressioni più tipicamente anti-narrative), quale sua capacità di restituirci a una visione che, per quanto strano possa sembrare, ci fonda senza mai essere stata nostra e senza poterlo mai essere del tutto.
Il campo trascendentale impersonale altro non è, insomma, che il cinema come reale o il reale come cinema, in quanto fattore di radicamento immediato della gnoseologia nell’ontologia, del sapere nell’ente, della ricerca nel mondo. La peculiarità di un trascendentale desoggettivizzato consiste infatti nel mettere in comunicazione, rivelandone l’irriducibile simmetria, il fulcro centripeto della conoscenza con quello centrifugo, vale a dire, nel mostrare come il presupposto di ogni apprensione conoscitiva sia anche il terminus ad quem ultimo della stessa.
Persino nei nostri traffici meno teorici, non possiamo fare a meno infatti di basarci su una cieca «credenza» nel reale che nessuno meglio di Deleuze ha saputo tematizzare, una credenza che la dialettica altrimenti interminabile di «comprensione» e «incontro», declinata in termini fenomenologici da Jean Hyppolite nel corso di un convegno Husserl delle 1957 a Royaumont (p. 155 e ss.), impone di ricollocare appunto sullo sfondo di un campo trascendentale a-soggettivo. È questa credenza che il nome di “trascendentale” significa, in ultima istanza, e che un certo gesto filosofico converte in questione esplicita, conferendogli per l’appunto lo statuto di un’implicatura a doppio senso tra pensiero ed essere, tra conoscenza e mondo, tra logica ed esistenza. Cosa altro sta ad indicare, infatti, la questione posta da Kant circa la legittimità dei giudizi sintetici a priori se non lo sforzo di un pensiero che, legiferando in maniera necessaria e universale su una materia interna al suo medesimo operare, costituisce nondimeno un incremento effettivo di conoscenza? Che cosa sta a segnalare, appunto, quest’intreccio se non la possibilità per il pensiero di toccare l’essere almeno quanto si lascia toccare da esso, restando in se stesso? Sia pure in maniera ancora insufficiente, perché troppo ancorata allo stampo dell’empiria (sostanzialmente, della coscienza), il pensatore di Könisberg ha proiettato comunque la conoscenza al di sopra di sé, nell’incrocio in cui il suo guardare si costella insieme al suo fare e in cui non si dà più alcun altro reale oltre un differire da sé intrinsecamente «autopoietico» (così lo definisce efficacemente Piatti).

Henri Bergson A parte allora la sibillina previsione foucaultiana circa l’avvenire del suo pensiero (che avrebbe dovuto informare di sé il XXI secolo), c’è forse un motivo poco avvertito all’origine dell’interesse con il quale la filosofia del presente continua, con un grado di ossessività altrimenti incomprensibile, a rivolgersi all’opera di Deleuze. La sua riflessione non si limita infatti a proporre un’ontologia tra le altre, fondata magari sul ruolo auto-costitutivo della differenza e/o su quello sovversivo dei divenire (con Guattari), ma conferisce alla stessa esigenza filosofica di totalizzazione dell’esperienza la sua ultima giustificazione. Deleuze, in altre parole, è il filosofo che più di ogni altro ha fatto della necessità in quanto tale di filosofare l’architrave della propria concezione del reale, rendendo così particolarmente arduo, ai suoi successori, proseguire su questa strada senza rendergli un ripetuto omaggio. C’è insomma una sorta di esplosione proiettiva, nella sua opera, che, per quanto per lo più non vista, ne fa uno dei luoghi in cui la filosofia, pur conservandosi del tutto realista, si ritrova comunque a contemplare la propria immagine, a vedersi insomma nel mondo come la superficie cangiante nella quale prende forma ogni realtà. La sua insistenza sulla scaturigine esternalista del desiderio di filosofia, come riposta a una sollecitazione che costringe letteralmente a pensare, è a tale proposito sintomatica: ne va della stessa situazione in cui si ritrova ciascun filosofo, quando sperimenta l’azione di un appello incessante di cui non coglie mai del tutto il senso, a meno che non ne faccia la cifra decisiva del reale stesso. Si capisce dunque il tenore quasi ossimorico di molte delle nozioni capitali della sua concezione. “Empirismo trascendentale”, “piano di immanenza”, “sintesi disgiuntiva”, solo per prendere tre esempi tra gli altri, realizzano una sorta di fusione a freddo di quanto per natura sarebbe dovuto rimanere separato: l’a posteriori e l’a priori, il liscio e lo striato, l’unario e il molteplice, ritrovando così nella “cosa stessa” la logica che anima da sempre la sua ricerca in-finita.
Per quanto si tratti infatti di una locuzione di Jean-Paul Sartre, escogitata in La trascendenza dell’ego (1936) per distanziarsi dalla piegatura egologica presa dalla fenomenologia husserliana, il “campo trascendentale impersonale” assume subito la portata di una meta-questione, atta a dare forma al gesto filosofico in quanto non si distingue più dal suo correlato paradossale. Nella prefazione, Rocco Ronchi la definisce appunto, con un’espressione di Arthur O. Lovejoy, un’«idea-unità» (p. 9), nozione distinta tanto dal singolo concetto, quanto dal principio generale, proprio dal fatto di avere una «carriera» (p. 10), un cursus specifico attraverso i pensieri di coloro che in modi sempre eterogenei pure vi si richiamano. Questo correlato non ha perciò più nulla dell’oggetto contrapposto a un osservatore, né tantomeno del soggetto che si ripiega su di sé per guardarsi guardare il mondo, come avviene per lo più in ambito fenomenologico, ma si presenta piuttosto sotto la forma di un mondo che si vede e che si costituisce mentre si vede, senza avere però mai alcun centro privilegiato da cui accedere a questa ‘visione’ che non sia il proprio stesso esistere. Leggendolo, assistiamo insomma a una lunga e sempre più decisa emersione di questa istanza teorica attraverso un corteo di filosofi che, nel corso del Novecento, si sono chiesti che cosa rendesse effettivamente possibile l’incontro conoscitivo, non più assimilabile semplicemente, dopo la débâcle kantiana della metafisica, alla forma paradigmatica di una relazione tra poli numericamente distinti e ontologicamente difformi (il soggetto e l’oggetto, la rappresentazione e la cosa, l’archetipo e il simulacro). Ne va insomma della stessa questione, come l’Autore si premura di sottolineare (pp. 288-9), sollevata da Menone, nel dialogo eponimo di Platone e che un Socrate stupefatto riassume con queste parole: «non è possibile per l’uomo ricercare né ciò che sa [perché lo sa già] né ciò che non sa [perché non saprebbe come riconoscerlo]!» (Men., 81a). In questa celebre aporia si profila un dubbio che, se spinto alle sue conseguenze più radicali, fa tremare non soltanto i polsi dei filosofi, in quanto disconnette per sempre ricerca e sapere, ma anche le fondamenta del nostro commercio quotidiano con il mondo.
L’ontologizzazione del Filosofico (con la maiuscola a capolettera) da parte della filosofia medesima è allora il vero oggetto della trattazione di Piatti. Il percorso proposto in queste pagine, nella sua ricchezza di riferimenti, è insomma una meditazione reiterata sull’inclinazione del pensiero a fare corpo con il suo altro – l’essere – e a ritrovarsi quindi nel proprio altro in forza della sua essenziale estraneità. Si badi, infatti, sotto il nome iper-tecnico di «campo trascendentale impersonale» non si intende qualcosa di adeguabile o di avvicinabile attraverso un movimento che lo supponga esistente al di là di sé. L’esperienza si rivela nella sua fattura cosmogenetica, e quindi non più come l’attributo di un qualche genere di soggettività, soltanto nel momento in cui si mostra nella sua natura pressoché artificiale, nel suo essere il prodotto di una genesi pre-individuale che la pone insieme, simultaneamente, a tutti i suoi altri prodotti (in senso stretto individuali e persino personali). L’effettuarsi dell’esperienza rimane lo stesso, che lo si trovi dal lato del soggetto o da quello dell’oggetto.
L’enunciato chiave della prospettiva di Piatti è perciò il seguente: «L’esibizione delle strutture cosmogenetiche del reale coincide insomma con la costruzione stessa del mondo che si abita» (p. 286). Questo enunciato ha infatti un’implicazione cruciale: esso stabilisce una corrispondenza tra il metodo filosofico e quello scientifico che ci permette di aggirare molte delle difficoltà che affliggono ancora il dibattito speculativo contemporaneo, caratterizzato spesso da una certa, residuale diffidenza nei confronti della scienza o da una simmetrica resa totale nei suoi confronti. Tale enunciato, in altre parole, si pone come il titolo di un programma filosofico che trova la propria scientificità, si parva licet, nel suo prestarsi a una in-finita serie di riformulazioni, ogni volta più approfondite. Il «costruzionismo» di questa concezione fa tutt’uno allora con il carattere a sua volta costruttivo del dispositivo discorsivo scientifico, il quale riconosce nel reale soltanto ciò che può ri-produrre grazie agli apparati formali e materiali delle tecnologie matematiche e sperimentali di cui si dota. Esso si identifica insomma con il non plus ultra del «naturalismo» (p. 287), ovvero, con la sostanza mutevole di una natura non-umana accessibile solo trasformandola. Ecco dunque che la ricognizione condotta da Piatti ci porta su una soglia critica con la quale la filosofia stessa ha da confrontarsi oggi, se non vuole rinunciare al suo compito propulsivo non tanto di scientia scientiarum (ruolo intenibile per tanti motivi) ma, si potrebbe dire, di tecnica delle tecniche, nella loro insindacabile e indispensabile pluralità.
Al di là della maggiore o minore confidenza che si può avere con il dibattito che il libro ricostruisce accuratamente – transitando anche attraverso l’ampia diatriba sulle aporie dell’intenzionalità fenomenologica dipanatasi tra gli anni ‘20 e gli anni ‘50 dello scorso secolo e le traversie del bergsonismo riletto da Vladimir Jankélévicth, Georges Canguilhem, Gilbert Simondon, Bento Prado Jr. e Victor Goldschmidt –, la questione in ballo è quindi immediatamente tangibile. Si sta parlando di vita – cos’altro dovrebbe essere infatti una tecnica delle tecniche? –, una vita da intendersi tanto in termini esistenziali che biologici, a questa altezza inscindibili. Si sta concependo una vita, in breve, che si concreta in una operazione sempre fallita eppure mai veramente evacuata come impossibile, una vita risolta in un tentativo di essere qualcosa di definito, e al limite di definitivo, coincidente però a sua volta con la propria costante messa in questione e quindi con la sua costante trasmutazione. Il vitalismo ostinatamente rivendicato da Deleuze (p. 240 e ss.) è in questo senso oltremodo rivelativo.
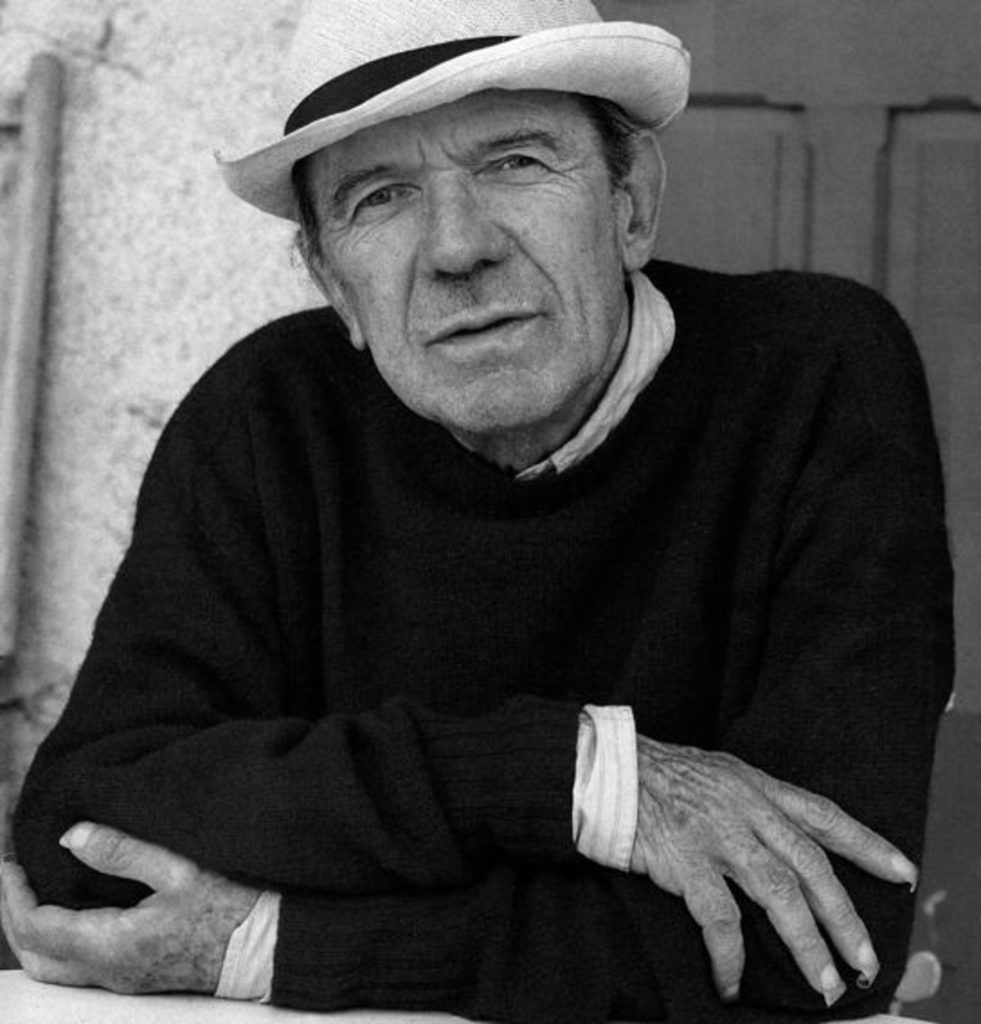
Gilles Deleuze La messa a fuoco del virtuale, nella vicenda allestita da Piatti, assume perciò un valore emblematico, capace di portare alla luce l’agentività stessa del Filosofico e della vita in generale. Il «ricordo puro» di cui parla Bergson in Materia e memoria (1896) e al quale non attribuisce nessuna efficacia determinata, se non quella di un’ipotesi teorica simmetrica a quella altrettanto «di diritto» della percezione pura, si rivela, nel prosieguo dei riarrangiamenti che subisce arrivando nelle mani di Deleuze, dotato di una sua specifica operosità, riconducibile al tentativo di fondare un’esperienza propriamente filosofica, distinta da tutte le altre esperienze di cui la nostra specie è capace. Un’esperienza che ha come sua cifra paradigmatica una certa auto-progressione, un lento procedere non verso qualcosa d’altro, ma verso se stessa, nel suo restare comunque parzialmente opaca al proprio medesimo sapere (come accade d’altronde a tutte le altre nostre attività, almeno sin quando non se ne fa carico, appunto, la filosofia). Un’esperienza che ci rivela inerenti, insomma, al cosmo in quanto è una genesi e non uno stato di cose, più o meno articolato che sia. Ecco perché Piatti, con sottile quanto significativa decisione, insiste col chiamare l’insieme delle immagini bergsoniano un «sistema» (p. 32) delle immagini. Il “sistema” (dal greco synistemi, “raccolgo”) è l’elemento elettivo dell’esperienza filosofante, in quanto resta al di qua (o al di là) di se stessa, nel mentre che ne ricava sempre ulteriori prospezioni. Il virtuale si mostra insomma quale statuto della filosofia, in quanto non riesce mai del tutto nel compito al quale non può comunque rinunciare: istruire un sistema in cui tutte le altre esperienze possano tenere e fare uno. Un’esperienza delle esperienze, insomma, che le raccordi lasciandole essere per quello che sono (e per quello che stanno diventando, soprattutto). In tal senso, le analisi di Piatti sono rilevanti anche nella misura in cui riconoscono una sorta di andamento a soffietto che contraddistingue tanto la metafisica di Bergson, quanto quella dei suoi variegati prosecutori, e che scandisce la stessa forma dinamica dell’universo come cinema in sé. Questo andirivieni conservativo e cumulativo tra presupposto e risultato, tra premessa e conclusione, dà la misura dell’estendersi delle considerazioni bergsoniane da un nucleo soggettivo-interiore (nel Saggio sui dati immediati della coscienza, del 1889) a uno sempre più apertamente cosmologico-evolutivo [in L’evoluzione creatrice e Durata e simultaneità, innanzitutto, (1907, 1922)], con un procedere che mima di fatto la vitalità dello stesso campo trascendentale impersonale. L’archetipo diventa qui simulacro del suo simulacro almeno quanto l’inverso e l’immagine si sutura infine senza scarti al suo referente. È così che viene in chiaro insomma la forma logica della progressività filosofica, manifesta soltanto allo sguardo di chi, con ritrovata consapevolezza del proprio mestiere, non si limita a guardarsi guardare, ma si si impegna a «vedersi vedersi» (Paul Valéry). Di colui, in breve, che tenta di cogliere non solamente il mondo nello specchio della sua apprensione soggettiva, ma come immagine cangiante della medesima dislocazione di sé che è necessario compiere per reperirsi nel mondo, quale essere già da sempre immerso in esso. Per dire la cosa altrimenti, che si scopre quale effetto di un’auto-differenziazione che coincide immediatamente con il divenire delle cose, quali che siano, e che le mette in comunicazione, senza alcun grado gerarchizzato o stratificato di partecipazione, con un principio sempre anche immanente a ciascuna di esse. Donde le splendide osservazioni riservate al processo di cristallizzazione (p. 250 e ss.), come modello di qualsivoglia genesi.
Allo stesso modo in cui è allora possibile leggere nella fisica relativistica un colpo di sonda nelle condizioni di osservabilità empirica del reale (fissate una volta per tutte dal valore-limite della velocità della luce) e nella meccanica quantistica un’insorgenza di quelle relative alla spiegazione scientifica in generale (come ha notato di recente Sergio Benvenuto su Philosophy Kitchen, identificandole nei paradossi della localizzazione che caratterizzano quella disciplina), così è possibile rintracciare nella direttrice di pensiero ripercorsa da Piatti un chiarimento sempre più dirimente di che cosa significa pensare e di come il pensiero non pensi mai altro che se stesso, pensando anche sempre qualcosa di altro da sé. È qui che il filosofo, guardandosi allo specchio, raggiunge il mondo stesso, esce fuori di sé e si confonde con la polvere di stelle di cui è fatto (il) tutto. Per provare quindi a rispondere a Menone, secondo questo impianto teorico, si dovrebbe dire che si cerca sempre quello che non si sa, ma solo perché si crede, si crede solamente, di saperlo già.
Ora, l’uso della scienza da parte della filosofia avviene quasi sempre sul crinale malfermo delle difficoltà incontrate dalla prima. Non è in forza delle convergenze tematiche oggettive tra funzioni scientifiche e concetti filosofici che il filosofo è chiamato a sua volta a dare una sistematizzazione di risultati per altro tra loro non necessariamente (e anzi, necessariamente non) comunicanti, ma grazie appunto alle scuciture, alle esitazioni e alle impasse che caratterizzano e forse caratterizzeranno per sempre il discorso scientifico. Il filosofo ha insomma l’ambizione di ‘curare’, per dir così, l’esperienza efficace della scienza dalla sua pur inevitabile dispersione, di farne il punto di partenza di una qualche sintesi integrale, in cui ci si possa riconoscere anche il famigerato “senso comune”.
Non è vero però l’inverso. Lo scienziato ha sì bisogno di filosofia, ma, come è stato notato per esempio da Canguilhem, non alla stregua di un ausilio finalizzato alla contestualizzazione metafisica delle proprie asserzioni. È piuttosto nella funzione di un’ideologia da scardinare, di un sistema di credenze da far saltare, che la filosofia interviene all’interno del lavorio continuativo dei saperi positivi; è come errore da emendare, insomma, che il palinsesto teorico volto alla “totalizzazione dell’esperienza” può funzionare fruttuosamente nel procedimento della ricerca scientifica, pronta a istruirsi nello spazio vuoto (nello spazio svuotato) lasciato dal primo. Anzi, quando ci si serve di ritrovati filosofici in ambito scientifico si corre spesso il rischio di dogmatizzare inutilmente quanto invece fa la forza dell’impresa scientifica moderna – la sua fallibilità esibita senza vergogna e il suo tenore auto-critico organizzato tecnologicamente e collettivamente. La scienza pretende insomma di curare a sua volta l’intelletto umano dalla sua peraltro irresistibile tendenza alla totalizzazione. A meno che, con una piroetta meta-filosofica degna di un acrobata del pensiero, il filosofo non si chieda che cosa rende concretamente possibile la sua stessa pratica e faccia persino di questa domanda, portando la propria vocazione riflessiva al suo punto critico, l’oggetto privilegiato e inesauribile della propria interrogazione. A meno che, insomma, il filosofo non arrivi a lambire direttamente il cuore della pratica che lo riguarda, cuore isomorfo, nel suo chiedere conto della possibilità medesima del filosofare, alle virtù della scienza in senso stretto, perché esposto, infine, a un continuo e felice fallimento.
Per quanto allora non si fondi su un confronto circostanziato con i risultati scientifici della contemporaneità, il lavoro di Piatti fornisce una perlustrazione preziosa tanto da un punto di vista metafisico quanto, a ben vedere, da uno epistemologico e, quindi, meta-filosofico. È infatti in questo nodo – in questo sovrapporsi vertiginoso di immagine e reale o di interrogazione e genesi – che scienza e filosofia si incontrano a loro volta, alla luce, reciprocamente, delle loro insufficienze e dunque del loro (de-)completarsi, per così dire, a vicenda. Tanto il filosofo che lo scienziato scoprono qui di aver a che fare con uno sfondo fungente di processi che li travalica, insediandoli però nella loro postura interrogativa, istituendoli anzi come interrogazione continuata che il mondo opera su se medesimo. L’universo come cinema in sé appare insomma in forma di una domanda che le cose pongono a se stesse, incessantamente (donde la deleuziana attribuzione di statuto del reale al «problematico» in quanto tale). La nostra credenza inossidabile nel reale può perciò coincidere infine con la sua incessante ri-costruzione e la cura scientifica dalla totalità diventare la stessa cosa della cura filosofica dalla disseminazione.di Daniele Poccia
-
Vortici, forme dell’esperienza
Recensioni / Aprile 2021Inevitabilmente, la considerazione più immediata che ci assale quando pensiamo ad un vortice è quella di un fenomeno caratterizzato da un movimento incontrollato, un flusso o un risucchio in un evento in cui non si può trovare ordine o fine. Anche la letteratura ci ha lasciato tale concezione del vortice, si pensi al turbine di anime lussuriose descritte da Dante nel V canto della Divina Commedia, scosse eternamente in tutte le direzioni dai venti infernali a espiazione del loro peccato.
Il lavoro di Tuppini però si propone di trasformare tale concezione del vortice, presentandolo invece come un modello esperienziale proprio dell’uomo e, più generalmente, come uno schema ontologico riscontrabile in più aspetti del reale. Il libro, infatti, analizza il concetto di vortice sotto vari punti di vista: culturale, artistico, psichico e fisico, mostrando come noi, volenti o nolenti, siamo costantemente trascinati in un vortice.Tommaso Tuppini è professore associato di filosofia teoretica presso l’Università di Verona. I suoi campi di studio si muovono dalla filosofia morale, nello specifico il criticismo kantiano, all’ontologia, specialmente in ambito americano e fino al post-strutturalismo francese. Questa varietà di interessi viene espressa in Vortici: si coglie molto bene come l’autore sappia far dialogare tra loro diverse correnti e aspetti del pensiero.
Il testo inizia con una disamina ontologica e teoretica del concetto di vortice, prendendo subito le distanze dalla teoria definita del “trascendentalismo”, cioè quel pensiero che ricerca costantemente un fondamento altro (trascendentale) su cui fondare la realtà, affermando invece come il vortice sia una messa in discussione di tale paradigma. Tuppini, rifacendosi alla Object Oriented Ontology americana, afferma che la critica principale da muovere al trascendentalismo è quella di un’impropria assunzione dell’uomo come unico ente-soggetto in grado di ordinare la realtà, mentre l’intera esistenza non è altro che un’interdipendenza di relazioni tra soggetti che popolano il mondo, piante, animali e computer, che formano una rete, un vortice di esperienze e legami tra di essi: «se l’essere è partizione, è sbagliato pensare che qualcuno o qualcosa eserciti un possesso esclusivo su un tratto ontologico qualsiasi» (p.7). Perciò non è solamente l’esistenza umana ad essere esperienziale, ma lo sono tutte, in opposizione alle teorie che esaltano un accesso privilegiato ed esclusivo all’ente, quali il soggettivismo estremo, il relazionismo radicale e il sostanzialismo. L’autore conia in queste pagine un’analogia che tornerà continuamente nel corso del testo, quella della rete. L’esistenza infatti si può esprime con la figura della rete e gli enti-soggetti mondani come i fili che costituiscono tale tessuto, creando nodi e intrecci nel loro relazionarsi. L’incontro dato dai fili è casuale, senza fine o programmazione e questo intreccio non è altro che l’interdipendenza tra i vari soggetti dell’esistenza che in tal modo possono individuarsi. Questo è il vortice: «Le cose si individuano secedendo da un ambiente con il quale però non smettono di comunicare. Individuarsi significa stringere un nodo che si distingue dall’ambiente nel quale è immerso, cioè dai fili con i quali il nodo è stato tessuto» (p. 10). Così il vortice si presenta come un punto di non determinazione del reale, il quale sfugge da mere classificazioni teoriche, mantenendosi e cancellandosi per via dei suoi stessi elementi costitutivi. Esso è sempre in bilico tra organizzazione e disorganizzazione dell’esperienza, essendo l’instabilità, l’esser turbolenza, l’aspetto più insito e profondo del vortice. Ma esso, in tale processo, genera anche degli effetti che sono stabili, cioè delle relazioni. Pertanto, il vortice è un tessuto di nodi che formano il reale, il quale regola gli scambi energetici tra le parti che lo costituiscono mettendo il tutto in reciproca comunicazione. Il vortice è «un vuoto, una soglia di passaggio, uno spazio di articolazione» (p.20), un canale tra passato e futuro, senza sostanza o individualità in sé, che genera un movimento spiralico del reale.

Queste sono dunque le basi teoriche su cui si muove il testo di Tuppini: mostrare come il vortice sia una struttura energetica che attraversa la realtà, il virtuale, la società, le arti e la psiche, e come esso si possa utilizzare come strumento analogico per interpretare il mondo e dar ragione delle sue differenze. Il lavoro svolto nelle pagine introduttive consiste nel mostrare il piano concettuale sul quale si intende lavorare e dal quale creare, nei successivi capitoli, le varie esemplificazioni del vortice, realizzando una rete che tiene insieme i testi di De Sade e Merleau-Ponty, la mescalina e il gioco degli scacchi, arrivando fino alle particelle atomiche e alla cinematografia contemporanea.
Il primo confronto con un vortice che viene presentato nel libro è quello presente nel De Sade letto da Bataille. Questi autori si oppongono a ciò che viene definita la “società omogenea”, cioè il mondo in cui viviamo, riassumibile dal binomio lavoro-consumo. Gli scritti di De Sade, secondo Bataille, sono un solvente per tale società. Egli, nei testi del nobile francese, trova quel lato recondito che non ha espressione in altri posti. L’autore sintetizza questo fenomeno con il concetto di scarto o «escrezione» (p.27), cioè la produzione di impulsi ambivalenti dati dall’incontro con un corpo estraneo, sul quale agiamo e che al contempo agisce su di noi. L’escrezione è l’atto finale di un vortice in cui oggetto e soggetto fuoriescono come esausti e dal quale emergono gli aspetti più nascosti di entrambi. Questo è un bisogno che non riusciamo a controllare e a spiegare, ma a cui diamo il nome di godimento, cioè «la condizione di massima intensità ed eterogeneità di cui il vortice umano può fare sperienza» (p.34). Il capitolo si conclude con la presentazione dei due tipi di vortici presenti nei testi di De Sade, la rivoluzione e l’apatia. Il primo viene definito come l’articolazione esterna e interna del godimento, data dall’intreccio di potenza tra individui, un accrescimento del singolo nel piacere, un vortice che si diffonde e si perpetua. L’altro vortice è invece quello dell’apatia, cioè dell’indifferenza, la solitudine che muove gli uomini nel mondo tra un godimento e l’altro, e che esemplifica la chiusura e l’oppressione presente dentro di noi. Ma unicamente dal contatto tra queste due entità, conclude Tuppini, si sprigiona il vortice dell’energia che De Sade ci descrive e dal quale siamo travolti.
Il vortice però non è appannaggio esclusivo della letteratura. Un altro campo nel quale esso si dà è quello psichico-percettivo, come espresso nel capitolo Sensazione e sonno e in quello denominato Mescalina. Nelle pagine di Sensazione e sonno viene analizzato il rapporto che oggigiorno noi abbiamo con il dormire e di come esso sia in simbiosi con la percezione. Infatti, non solo un corretto ciclo del sonno influisce sulla nostra sensazione, ma la stessa esperienza onirica è da considerare come un evento sensitivo. Bisogna specificare, però, che la sensazione non è percezione, poiché non è chiara e distinta, come direbbe Cartesio, ed ha, secondo Merleau-Ponty uno «statuto pre-intenzionale» (p.46). Con la sensazione, come nel sonno, noi abbiamo davanti a noi delle qualità sensibili non ben specificate, mai definitive o definite: la sensazione è quel senso di vaghezza prima di una percezione-comprensione. Perciò la sensazione è un vortice, un flusso di elementi differenti che appena vengono elaborati svaniscono, un movimento o una distonia, come viene chiamata nel testo. Questo fenomeno è analogo a quello del sonno, della confusione onirica notturna, in cui i flussi di pensieri sono in perenne movimento senza mai darsi completamente, dispiegando una nuova dimensione in cui l’asse del vortice è il soggetto assopito nel quale nuove relazioni si danno e si disfano continuamente. Così anche il sonno, il più tranquillo dei momenti, cela in realtà un quieto trambusto di sensazioni che termina con il destarsi del corpo e la lucidità del risveglio.
Ma non solo nel riposo è possibile alterare la nostra comprensione, anche nel mondo fattuale è praticabile una distorsione della percezione, ad esempio con l’utilizzo di droghe psichedeliche come la mescalina. Ovviamente Tuppini non intende fare un’apologia di tali sostanze, vuole invece esporre come gli allucinogeni siano una droga-vortice per l’accesso ad un campo extrasensoriale. Di fatto quello della mescalina non è propriamente un vortice, ma una turbolenza, poiché non presenta ordine ma solo dis-ordine, «La turbolenza mescalinica è uno stato incoativo che si prolunga oltre ogni limite dentro uno spazio che rigurgita, spazio di gestazione, di trasformazione, di moltiplicazione, proliferazione sterile» (p.67). Colui che assume tale sostanza perde la sua soggettività intenzionale, esso non sa più distinguere i confini spaziali diventando un flusso continuo con l’esperienza. Il risultato è un movimento che non si può fermare ma, a differenza del sonno, non è un vagare confusionario, bensì uno scendere nel profondo della realtà, un vagliare le varietà di forme del mondo con un cambio prospettico su di queste. Il trip derivante dall’allucinogeno è come un’onda che si espande per poi dissolversi, un vortice che crea un altro vortice, un giramento infinito senza causa.Il vortice però ha anche un fascino artistico, il suo movimento fluido è stato d’ispirazione per moltissime correnti culturali ed esso «diventa immagine quando il nodo di cui è fatto riesce a catturare l’immagine» (p.82). Questo concetto lo fece proprio il Vorticismo inglese, nato sotto l’influenza del futurismo italiano agli inizi del 1900, ed è, come l’ispiratore italiano, un’avanguardia non solamente pittorica, ma anche poetica e sociale. Tuppini si sofferma in particolare sull’interesse di molti esponenti di questo movimento per il gioco degli scacchi, mostrando come anche un gioco così estremamente codificato celi dentro di sé un vortice. Esso è un gioco di movimento e torsi, di incontro e di scontro tra pezzi, un annodarsi di mosse che crea la rete della scacchiera.
Tale idea di vortice come struttura viene poi ripresa e approfondita nel capitolo successivo, Atomo, dove l’autore illustra in che modo il costituente basilare dell’esistenza, il mattone più piccolo dell’universo, cioè l’atomo, per via analogica si possa interpretare come un vortice che trasversalmente attraversa, con il suo movimento vorticoso, ogni ordine e grandezza. Tuppini avvalora queste sue tesi sull’atomo come forma energetica riprendendo gli esperimenti di inizio Novecento sul mulinello idraulico, condotti dai fisici inglesi Willliam Thomson e Peter Tait. Costoro sostennero che l’atomo vorticoso faccia sfumare con il suo movimento la materia, rivelando come questa non sia alla fine che un intreccio di energie in movimento, «L’atomo vorticoso è semmai una materia energetica o un’energia materiale» (p. 100). Quest’atomo si esprime con il moto a spirale, presentato lungo tutto il corso del libro, dando come risultato un cono, un vortice, nel quale si incontrano le varie dimensioni spazio-temporali e gli stessi elementi si danno e si disfano nel loro relazionarsi. Così in queste pagine viene confermata la tesi iniziale: tutto è vortice e ogni entità vi è dentro.
L’ultimo aspetto trattato dal libro è quello del movimento, presentato nel sesto capitolo del testo: Kìnêma. Il titolo del capitolo è una ripresa del termine greco kinesi, movimento, dal quale deriva la nostra parola cinema, essendo il cinema un fenomeno che è al contempo statico e in movimento, e che in greco si esprime appunto con la parola kìnêma, mosso. La particolarità di questa sezione, però, risiede nel fatto che l’autore esponga questa tematica attraverso l’analisi cinematografica del film Uncut Gems. Il parallelismo condotto durante tutto il capitolo è quello tra le tesi di Zenone di Elea sul movimento e le vicissitudini del protagonista di Uncut Gems, un gioielliere ebreo di New York che vive immerso nei debiti di gioco e che ha l’opportunità di vendere un prezioso opale per fare la “vincita della sua vita”. Tuppini, riprendendo l’insegnamento zenoniano per cui, «ciò che si muove non si muove né nel luogo in cui è, né nel luogo in cui non è» (p. 115) mostra come il movimento verso un luogo, da A a B, sia illusorio poiché composto e mediato da infinite tappe intermedie; così come il protagonista del film che non esce mai dal circolo delle scommesse e dei debiti, la sua corsa verso la vincita è sempre spezzata da molteplici insuccessi. Il risultato ultimo è quello di mostrare come sia impossibile assegnare al movimento un valore assoluto, essendo questo fisico e mentale, lento e veloce, regressivo e progressivo, ossia imprevedibile. Oltre all’analisi di Uncut Gems, Tuppini mostra come il genere cinematografico sia immerso nella questione filosofica del movimento, essendo il film, nella sua composizione, un susseguirsi di fotogrammi, mentre il risultato finale è un unico flusso continuo di immagini. Il primo punto di vista è quello dello sceneggiatore, il quale deve comporre l’azione del film, mentre il secondo caso è relativo allo spettatore, che nel film deve trovare quella coerenza che si aspetta dalla trama. Eppure, anche nel movimento vorticoso del cinema, che sia in fotogrammi o in un flusso, è presente un momento in cui il moto e l’immobilismo della scena si incontrano: l’attimo del primo piano, poiché «Il primo piano scioglie e riannoda il tessuto del racconto» (p.135). Questa tecnica registica conferisce o toglie il senso alla trama, è un coinvolgimento, anche emotivo, con il personaggio, un face to face tra lo spettatore e l’attore. Questo è l’attimo in cui movimento e paralisi, corpo mosso e corpo fermo si danno, cioè il kìnêma.
In conclusione, il vortice studiato e presentato da Tuppini nel corso del libro non è altro che il movimento, la sensazione e la turbolenza che incontriamo negli eventi con cui ci relazioniamo e con il quale dobbiamo intessere una rete composta da nodi esperienziali, i quali compongono i caratteri più profondi di questo sistema e, dunque, della nostra esistenza.
di Alessandro Balbo
-
Il libro di Manlio Iofrida, Per un paradigma del corpo: una rifondazione filosofica dell’ecologia, uscito per Quodlibet alla fine del 2019, si presenta come uno snodo ricco e importante per un approccio teoretico, etico e critico all’attuale questione ecologica. In questo senso, il libro s’inserisce nel cuore stesso del dibattito – non solo italiano – incrociando tematiche come il corpo, il concetto di Natura, lo statuto filosofico del vivente e della sua relazione con la tecnica (a questi temi si aggiungano la critica della cultura, la storia dell’arte, il dialogo tra filosofia e altri campi del sapere, i rapporti tra la cultura Europea e i suoi grandi altri ecc.).
Il libro assume quella che potremmo definire un’ottica cosmopolitica e si presenta come il crocevia d’intuizioni, idee e riflessioni che animano il gruppo di ricerca Officine Filosofiche (il gruppo gestisce anche un’omonima collana editoriale), fondato e diretto dallo stesso Iofrida assieme a Ubaldo Fadini. Molti argomenti sviluppati nel libro intrecciano le principali linee di lavoro del gruppo, contribuendo così a fare dell’ecologia filosofica uno dei campi di ricerca più innovativi e stimolanti dell’attuale panorama filosofico italiano.
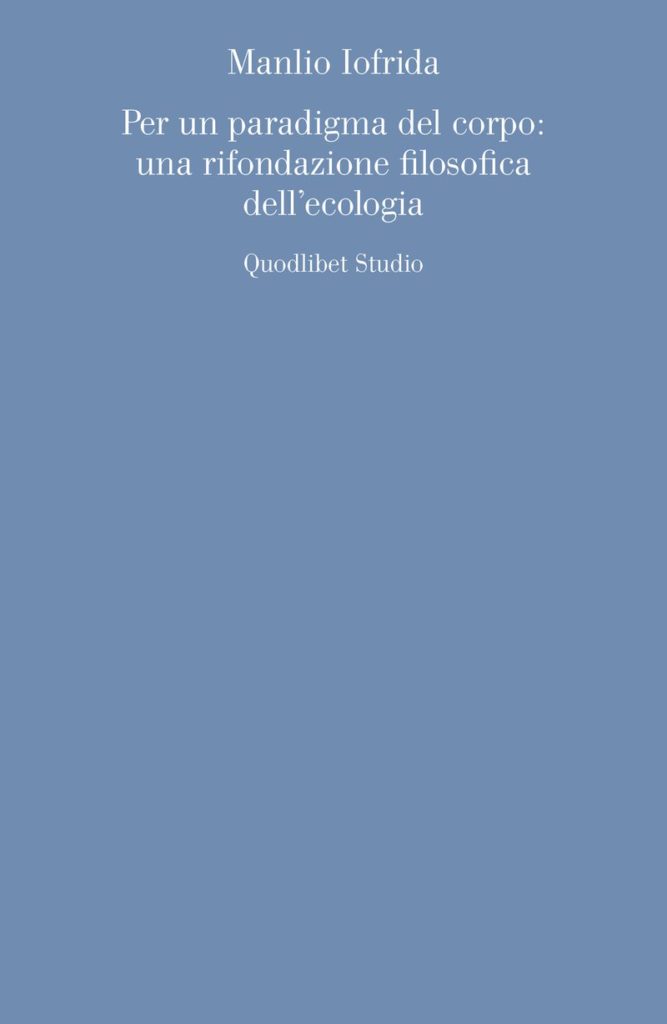
Si può dunque comprendere, sin da queste prime considerazioni, che riportare in maniera analitica o anche solo accidentale tutti gli impliciti teorici – nonché la profonda erudizione dell’autore che conferisce all’ecologia un ampio spessore culturale – è compito improbo per una recensione e, probabilmente, anche inutile. Quel che ci proponiamo di fare in questa sede è di attraversare il testo in maniera “libera” tentando di esplicitare alcuni aspetti che sembrano restituire, nella parzialità della nostra lettura, alcune delle intenzioni di base dell’autore.
Non si può non partire dalla centralità teorica del tema del corpo che, non nuova nel lavoro di Iofrida, si richiama esplicitamente all’opera complessiva di Merleau-Ponty e all’attualità del suo concetto di Natura (pp. 19-31) «come limite che la cultura non può sorpassare» (p. 30). Sotto tale aspetto, questo studio si riallaccia (pp. 9-16), pur con oltre dieci anni di distanza, al precedente lavoro dell’autore Per una storia della filosofia francese contemporanea: da Jacques Derrida a Maurice Merleau-Ponty. Dire che questo sia un libro “merleau-pontyano” è senza dubbio corretto e tuttavia rischierebbe di schiacciarne la profondità su un “arroccamento” teorico, una semplice riproposizione ermeneutica. Devono essere menzionati, infatti, almeno altri due autori classici presenti come linee di basso nell’architettura del testo: Schelling ritorna diffusamente nel testo, utilizzato in chiave anti fichtiana-attualista (pp. 38, 141) o hegeliano-sintetico (anche se Hegel resta comunque un autore importante nell’impostazione ecologica iofridiana, pp. 138-140); ma è soprattutto il Kant della Critica della facoltà di giudizio a fornire un’impalcatura teorica di primo piano (vanno, poi, almeno ricordati i nomi di Goethe, Schiller e Adorno, per completare la batteria tedesca di riferimento, cfr. pp. 47-52). Ci sia concesso dunque di entrare nel vivo del libro approcciandolo alla lontana, così da poter restituire, se non altro, il profumo della complessa architettonica di Iofrida.
In siffatta architettonica, l’ecologia non si presenta tanto, né solo, come una disciplina scientifica (pp. 45-47) ma, potremmo dire, si tratta di una questione di gusto, di istituire un paradigma del gusto ecologico. Come si può intuire, molto lessico di Iofrida è intriso di una semantica post-kantiana. Il gusto, permettendoci l’ardire di parafrasare Kant, è quella strana facoltà di giudicare secondo sentimento (leggendo in questa chiave il giudizio riflettente).
Sappiamo anche che il sentimento è un vero e proprio mondo intermedio che si situa tra la facoltà di conoscere e quella di desiderare, ossia tra l’intelletto e la ragione, tra la “necessità naturale” e la “libertà umana” (che Iofrida definisce prometeica, cfr. pp. 59-61). Dire, dunque, che l’ecologia è questione di gusto significa affermare che essa si situa nel mezzo di un’ardita relazione tra la Natura e la Cultura – dualismo principale di molte riflessioni ecologiche. Ma, altresì, ci dà delle informazioni sugli aspetti “filosofici” dell’ecologia: il gusto, sappiamo dal §40 sul senso comune della Terza Critica, va educato. L’ecologia, secondo Iofrida, non consiste né nella descrizione di uno stato di cose oggettive (ci sia concessa la banalizzazione: filosoficamente, l’ecologia non può essere ridotta a una disciplina naturalistica) né, occorre fare attenzione, nella prescrizione di massime della ragione (che si limiterebbe a un greenwashing della Ragion Pura Pratica): l’ecologia è filosoficamente fondata nella misura in cui è capace di una vera e propria educazione sentimentale. Così, l’ecologia filosofica non è né scientifica (occorre «declinare l’ecologia come critica anti-intellettualista», p. 54) né morale («non si pone come sussunzione dominante», p. 119), ma è intimamente etica (l’ecologia, ci ricorda l’autore, è un pensiero della finitezza, pp. 52-56). È a partire da una esigenza etica (e, con Merleau-Ponty, connesso a un certo spinozismo schellinghiano, da un’esigenza anche ontologica) che va letta la proposta di un paradigma del corpo. Non si tratta, così, di fondare un principio di rappresentazione, o massime pratiche, ma di sviluppare delle ipotesi etiche, per dir così, da un punto di vista pragmatico.

Maurice Merleau-Ponty Fatta questa premessa, possiamo addentrarci in alcuni aspetti concettuali. Uno dei concetti chiave per leggere la proposta iofridiana è quello di inerenza (pp. 29-31). Di matrice fenomenologica, l’inerenza è un fenomeno corporeo e rimanda a una «ontologia relazionale» (p. 41) che si pone in antitesi tanto con le ontologie costruttiviste del pensiero debole (p. 43) quanto con le ontologie realiste di certi modi di intendere il materialismo (pp. 60-61). L’inerenza è il concetto cardine di un’ecologia che si propone di lavorare in chiave ontologica sulla «nostra relazione coi milieux» (p. 41) – i riferimenti sono alla «geografia […] fenomenologica» (p. 39) di A. Berque: la relazione degli “individui” con gli ambienti (o paesaggi) «non è quella della sostanza pensante con la sostanza estesa; […] piuttosto c’è uno sconfinamento, un’interpenetrazione» (p. 41). L’inerenza ci offre una cifra filosofica importante: essa è la relazione chiasmatica – è evidente nel lessico iofridiano l’influenza di Merleau-Ponty – del vivente con i suoi dintorni, le sue Umwelten, il co-appartenersi di individuo e ambiente. Intreccio, potremmo dire, della parte con il tutto.
In quanto etica ontologicamente orientata, l’ecologia si interessa non alle partizioni sostanziali – che comportano, sul piano etico, la costruzione di un’impalcatura morale – bensì agli assunti relazionali (ci sia concessa un’assonanza col lavoro di Giuseppe Semerari 2009) che solo centrando l’analisi filosofica sulle potenze corporee possono essere messi in risalto. Questa inerenza, che è una mediazione senza soggetto – e che anzi produce soggettività – non è pensabile come Aufhebung, bensì come un’unità senza concetto (p. 115) attuata per il tramite del corpo «e la sua apprensione orizzontale del mondo» (p. 25). L’esigenza di un paradigma del corpo è dunque insito nella tematica stessa della relazione ecologica, così che, per Iofrida, ogni ecologia, sul piano etico, non può non passare – anche implicitamente, come traspare mediante la critica alla smaterializzazione postmoderna (pp. 67-68) – per il tramite di un paradigma del corpo.
Il problema del corpo è però l’altra faccia di un ulteriore assunto di Iofrida, ovvero l’idea complementare che la Natura non sia un oggetto (p. 45) e che il vivente non sia meccanizzabile (p. 30). Il rischio di interpretare in chiave puramente valoriale, facendo di tali assunti delle massime della Ragione, è grosso. Occorre dunque tentare di essere chiari, ancora una volta, sul lessico dell’autore. Siamo pur sempre, lo si è detto, sul piano del giudizio riflettente. I riferimenti sono ancora all’opera di Merleau-Ponty e, tramite lui, Schelling e Kant. In ultima istanza, l’orizzonte concettuale ci appare ancora di matrice kantiana. L’idea che il vivente non sia meccanizzabile vuol dire che lo specifico fenomeno di inerenza dell’umano agli altri viventi (che compongono i suoi dintorni) non è un rapporto conoscitivo, o intellettuale, né tuttavia un rapporto pratico. Non è conoscitivo perché, in quanto soggetti empirici, non tutti gli umani sono “scienziati”, e questo non pone particolari problemi. Ma non è neppure un rapporto pratico, perché non è possibile estrapolare una massima categorica da questa idea: non tutti i viventi possono agire conformemente a scopi (tralasciamo i motivi di tale impossibilità). L’idea che il vivente non sia meccanizzabile non è un enunciato che riguardi il regno della libertà. Concessa la formula, quella tra viventi non è una relazione tra esseri (radicalmente) liberi, situandosi, invece, nel regno intermedio tra la necessità dell’oggetto naturale e la libertà radicale del soggetto trascendentale (Merleau-Ponty 1996, 312-313).
Il problema del vivente – che possiamo anche chiamare, se ci è concesso, il problema della finalità senza scopo – è un problema sentimentale e affettivo. È ancora un paradigma del corpo che permette di comprenderlo: un corpo è il medium non solo, e non tanto, della natura e della libertà, bensì della inerenza al mondo e agli altri viventi. È mediante il corpo – un’utilità non strumentale – che si è costitutivamente aperti ad altre modalità dell’esistere e del vivere. Una mediazione senza soggetto che si fa nel mezzo delle relazioni inter-individuali: l’inerenza come vero e proprio fenomeno trans-individuale, contatti molteplici e variegati tra corporeità (cfr. Merleau-Ponty 1996, 254-261). Appare, in queste considerazioni, un altro dei concetti cardine della proposta di Iofrida, concetto che crea un ponte col suo lavoro precedente: si tratta della nozione di libertà strutturale. Una concezione strutturale – o ecologica – della libertà comporta che essa non sia la radicale assenza di limiti, bensì che trovi la propria potenza esistenziale ed espressiva nella composizione delle relazioni, nella ricchezza e varietà degli affetti e degli incontri corporei.
È una libertà che non è competenza di una filosofia della prassi, ma di un’etica, come accennato, dal punto di vista pragmatico. Un’ecologia della libertà richiede pratica e attenzione [Aufmerksamkeit] (p. 146), un’educazione sentimentale finalizzata a un uso ragionevole degli affetti. Insomma, la libertà, in una prospettiva ecologicamente orientata, presuppone una capacità tecnica. È in quest’ottica che leggiamo, infatti, la proposta di Iofrida di una tecnica ecologica (pp. 84-90). Si tratta di una formula ambigua, ma le ambiguità spariscono se non usciamo dalla semantica nella quale ci stiamo muovendo. Un tale epiteto, infatti, è lontano da un greenwashing delle attuali configurazioni tecnico-tecnologiche del tardo capitalismo: insomma, non si prospetta la necessità di una Green Economy. Si tratta, invece, di una concezione ecologica della tecnica che tenga conto del portato affettivo – cioè esistenziale e vitale – della tecnica.
In questo senso, una tecnica ecologica è di segno contrario rispetto alle attuali configurazioni produttive (si tratta di uscire dal dualismo manicheo «produzione o libertà», p. 60; andare al di là dell’alleanza demoniaca di capitalismo e schizofrenia, cfr. Pignarre & Stengers 2016) configurandosi invece come rivolta alla convivialità – tra umani e tra umani e non umani – incastonata nella complessità variegata degli ambienti di vita (fondamentale in quest’ottica il capitolo dedicato alla teoria dei sistemi, pp. 121-140). È ancora una semantica del giudizio: la tecnica rimanda all’arte, cioè una tecnica ecologica diventa una vera e propria arte dello stare in vita da parte dei viventi – ecologicamente, vi è tecnica ovunque vi sia fragilità e ostinazione della vita: occorre «concepire l’arte come un nuovo modo di rapportarsi al mondo […] poiché, già in se stessa, tale prassi priva di finalità è un’altra e superiore modalità di azione del nostro corpo vivente rispetto a quella meramente utilitaria, essa può essere punto di partenza di una prassi concreta […] e punto di arrivo di una costruzione dal basso, partecipata, intersoggettiva» (p. 152).
Senza dubbio si tratta di una concezione ottimistica della tecnica: nessuna caduta da un eden ormai perduto, né solo nichilistica distruzione della vita da accettare passivamente come un destino. Si tratta, invece, di un’arte pericolosa, quella dello stare in vita, proprio perché la vita – un vivente – è insieme ostinazione e fragilità: l’educazione sentimentale serve a saper «reggere delle crisi, saper gestire il rischio […], anche se rischio significa appunto che la crisi non è mai del tutto esclusa e che il disordine può avere sempre il sopravvento» (p. 123). È una concezione ecologica e ottimistica della tecnica, sì, ma non è il frutto di una anima bella (ecco comparire una certa ispirazione hegeliana). Rifacendosi al lavoro di Kurt Goldstein (2016), neurologo tedesco del secolo scorso, tra le fonti di Merleau-Ponty, Iofrida ci ricorda che «un organismo vivente, e l’uomo in particolare, è teso ad accrescere continuamente la propria complessità […]; esso cerca dunque la relazione e anche il conflitto, in un mondo in cui l’ordine è sempre un momento precario all’interno di una lotta di forze eterogenee che genera un perenne dinamismo» (p. 127).
Educazione sentimentale, teoria degli affetti e concezione tecnica del vivente: i tre capisaldi che istituiscono la fondazione filosofica dell’ecologia proposta attraverso un paradigma del corpo. Tale paradigma fa sì che un’ecologia filosofica si trovi a proprio agio non nel contemplare un’astratta e fondativa Natura Naturante, un’origine ormai perduta o distrutta dalla cattiveria dell’Uomo, bensì nel concepire modi possibili del vivere in comune, forme collettive di esistenza con i più ampi margini di gioco transindividuali, vincoli che non obbligano capaci di aumentare le potenze esistenziali e le capacità creative dei viventi umani e non (è questo il principale rimando al concetto di natura di Merleau-Ponty). Si tratta di una concezione minoritaria della storia, del divenire minoritario dell’umano, dei suoi affetti, delle sue ibridazioni, delle sue contaminazioni (cfr. Deleuze & Guattari 2015, 349-357). Una storia minore che non ha la Natura come Grande Altro, bensì che è caratterizzata dalla sua inerenza all’elemento naturale, alla sua imprevedibilità, alle sue complessità ontologiche (ma anche epistemologiche, dato che, ecologicamente, l’ontologia è inscindibile da un’epistemologia): si tratta di una storia universale della contingenza (Deleuze & Guattari 2002, 86).
L’ecologia filosofica proposta da un paradigma del corpo è così una filosofia artistica, un’arte, pericolosa e sublime a un tempo, del vivere insieme, del condividere la Terra con altri viventi (l’Autore parla di «un materialismo della Terra», p. 44). Un’arte, per chiudere restituendo il ruolo di Michel Foucault nel nuovo paradigma ecologico (pp. 205-211), che sia una «estetizzazione della vita come progetto condiviso di una comunità di eguali che dialogano e, esercitando la socievolezza, istituiscono con il mondo e gli altri una relazione che non è quella della ragione strumentale, brutalmente utilitaria, ma che può a tutti gli effetti definirsi ecologica: non è il bello quella dimensione sempre mobile di limite in cui ci apriamo al mondo e agli altri non in funzione di un dominio, ma per essere passivi quanto attivi, copresenti in una relazione con l’alterità che può definirsi col termine, anch’esso fenomenologico, di attenzione?» (p. 211).
Bibliografia minima
Deleuze, G. & Guattari, F. (2002; ed or. 1991). Che cos’è la filosofia?. Torino: Einaudi.
Deleuze, G. & Guattari, F. (2015; ed. or. 1980). Mille piani. Capitalismo e schizofrenia 2. Tr. it. G. Passerone. Roma: Castelvecchi.
Goldstein, K. (2016; ed. or. 1934). L’organismo. Un approccio olistico alla biologia derivato dai dati patologici nell’uomo. Tr. it. L. Corsi. Roma: Fioriti.
Merleau-Ponty, M. (1996; ed. or. 1995). La natura. A cura di M. Carbone. Milano: Cortina.
Pignarre, P. & Stengers, I. (2016; ed. or. 2005). Stregoneria capitalista. Pratiche di uscita dal sortilegio. Tr. it. di S. Consigliere e A. Solerio. Milano: IPOC.
Semerari, G. (2009; ed. or. 1961). La filosofia come relazione. Milano: Guerini.
di Gianluca De Fazio
-
Andrea Cavalletti – Vertigine. La tentazione dell’identità
Recensioni / Settembre 2019 In quel distanziamento della prospettiva che si fa disorientante si coglie la vertigine, lo sguardo scavalca lo spazio reale ed effettivo per assurgere a vette basse, collocate in una profondità che si potrà toccare soltanto dopo lo schianto. Vicinanza e lontananza si deformano, creando un doppio sguardo che nella sua dualità bipolare alterna rischio, tentazione, paura e slancio; sintomi di un capogiro che vorticando su se stesso si autoalimenta senza arrestarsi mai. La vertigine, però, non è soltanto l’effetto di una distorsione visuale provocata dal timore dell’altezza, non va quindi ristretta al solo campo ottico, essa incarna anche la tendenza dell’essere a superarsi e a ritrovarsi - o a smarrirsi - in quello sguardo duplicato che, per forza di cose, interroga l’altro, e nella presenza dell’alterità si risolve. Vertigine è dunque quello stato che permette all’identità di rappresentarsi in una forma che richiede incertezza e la continua messa in discussione. Tale concezione della vertigine che si manifesta sia come sintomo psico-fisico che psicologico/ filosofico è ben rappresentata nel film del 1958 di Alfred Hitchcock, Vertigo (o La Donna che visse due volte) e che Andrea Cavalletti ha preso come punto di riferimento per sviluppare le proprie riflessioni inerenti la vertigine e raccolte nel suo ultimissimo libro edito da Bollati Boringhieri: Vertigine. La tentazione dell’identità. Questo libro difatti tratta il fenomeno della vertigine rendendolo strumento necessario per realizzare una vera e propria lettura dell’identità, in cui la perdita e il ritrovo di se stessi giocano ruoli fondamentali. È tale vertigine, dunque, il fulcro essenziale del testo che per l’autore, proprio per la sua natura malferma, incerta e cinetica, serve come supporto per intercettare e spiegare i nodi di un’identità che non trova (e non troverà) mai compimento in una forma definitiva. Tale “tentazione e ricerca” dell’identità è affrontato nel testo da punti di vista che fino ad ora erano stati esplorati in maniera separata e parziale e mai interconnessi tra di loro, cosa che Cavalletti fa, attuando un vero e proprio dialogo tra teorie scientifiche, psicologiche, filosofiche e artistiche; realizzando una mappatura intertestuale in cui il tema della vertigine resuscita in una nuova luce.
In quel distanziamento della prospettiva che si fa disorientante si coglie la vertigine, lo sguardo scavalca lo spazio reale ed effettivo per assurgere a vette basse, collocate in una profondità che si potrà toccare soltanto dopo lo schianto. Vicinanza e lontananza si deformano, creando un doppio sguardo che nella sua dualità bipolare alterna rischio, tentazione, paura e slancio; sintomi di un capogiro che vorticando su se stesso si autoalimenta senza arrestarsi mai. La vertigine, però, non è soltanto l’effetto di una distorsione visuale provocata dal timore dell’altezza, non va quindi ristretta al solo campo ottico, essa incarna anche la tendenza dell’essere a superarsi e a ritrovarsi - o a smarrirsi - in quello sguardo duplicato che, per forza di cose, interroga l’altro, e nella presenza dell’alterità si risolve. Vertigine è dunque quello stato che permette all’identità di rappresentarsi in una forma che richiede incertezza e la continua messa in discussione. Tale concezione della vertigine che si manifesta sia come sintomo psico-fisico che psicologico/ filosofico è ben rappresentata nel film del 1958 di Alfred Hitchcock, Vertigo (o La Donna che visse due volte) e che Andrea Cavalletti ha preso come punto di riferimento per sviluppare le proprie riflessioni inerenti la vertigine e raccolte nel suo ultimissimo libro edito da Bollati Boringhieri: Vertigine. La tentazione dell’identità. Questo libro difatti tratta il fenomeno della vertigine rendendolo strumento necessario per realizzare una vera e propria lettura dell’identità, in cui la perdita e il ritrovo di se stessi giocano ruoli fondamentali. È tale vertigine, dunque, il fulcro essenziale del testo che per l’autore, proprio per la sua natura malferma, incerta e cinetica, serve come supporto per intercettare e spiegare i nodi di un’identità che non trova (e non troverà) mai compimento in una forma definitiva. Tale “tentazione e ricerca” dell’identità è affrontato nel testo da punti di vista che fino ad ora erano stati esplorati in maniera separata e parziale e mai interconnessi tra di loro, cosa che Cavalletti fa, attuando un vero e proprio dialogo tra teorie scientifiche, psicologiche, filosofiche e artistiche; realizzando una mappatura intertestuale in cui il tema della vertigine resuscita in una nuova luce.Il volume è diviso rispettivamente in sei capitoli, ognuno dei quali affronta l’argomento sotto profili tematici diversi, ma tenuti assieme da un fil rouge che permette una lettura unitaria e quantomai interessante e innovativa. Nel primo capitolo intitolato effetto–vertigo, come già anticipato, Cavalletti per introdurre il fenomeno della vertigine si rifà al film, mettendolo a confronto con i due libri a cui esso è ispirato: ossia D’entre les morts di Boileau e Narcejac del 1954 e Bruges la morte del 1892 a firma di Georges Rodenbach. L’autore non si limita a una semplice comparazione delle opere, ma radica la propria riflessione rintracciando nelle trame intime della storia elementi che superano il piano narrativo, per approdare a campi concettuali di natura prevalentemente filosofica, essenziali per iniziare un’analisi sull’identità e le sue strutture. Vertigo è per eccellenza il racconto in cui l’inganno è espresso da ogni angolatura, e non è un caso, dunque, se nel primo capitolo Cavalletti rimanda al termine Schwindel a cui si associano contemporaneamente sia i significati di inganno e tentazione, sia di malattia e trucco, o di raggiro stando al saggio del 1948 Das Manifest der Kommunistischen partei di Marx ed Engels. Vocaboli che, specialmente nel film, si manifestano sia sotto forma registica attraverso espedienti tecnici, che in forma contenutistica ad esempio tramite l’impersonificazione della defunta Madeleine da parte di Judy.

A proposito Cavalletti ricorda come il famoso effetto vertigo (dolly zoom) sia stato risolto da Hitchcock grazie alla combinazione di uno zoom in avanti e di una carrellata indietro, o di uno zoom all’indietro e una carrellata in avanti, mantenendo invariata la dimensione del soggetto, permettendo così al pubblico di assumere la prospettiva di Scottie, interpretato da James Stewart, e immedesimandosi in lui. Tale meccanismo cinematografico è un trucco inteso per svelare un altro trucco sostanziale: ossia smascherare Judy attraverso un atto di dis-velamento che fa letteralmente “morire” Madeleine. L’artificio insito nella settima arte, sottolinea Cavalletti citando Walter Benjamin, di conseguenza si sporge aldilà dei propri espedienti artigianali per raggiungere il senso intrinseco della storia e la sua trama controversa.
Sempre in questo capitolo, riprendendo gli studi psichiatrici, ad esempio di Max Simon e del neurologo Charcot, Cavalletti descrive come la vertigine, specie nel’800, sia stata vista come una nevrosi, un’anomalia del sistema nervoso o un sintomo di isteria. Un’isteria che secondo La Mettrie, Esquirol e Simone Weil (tutti autori presenti nel testo) è destinata a diventare collettiva, in quanto l’intera società è affetta da un senso di vertigine stimolata da un sentimento di paura e sopraffazione psicologica e, proprio come asseriva la Weil in Réflexions sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale: l’avvento della “macchina” cinema servirà alla macchina sociale come strumento di massa per divulgare ideologie politiche propagandistiche e aizzare le folle. Il panico/vertigine di Scottie, dunque, può anche essere letto come la paura, ma al contempo necessaria volontà, di ribellarsi dei popoli soggiogati contro gli inganni dei loro governanti che in questo caso hanno il volto di Judy. Tale rapporto intersoggettivo rimanda al secondo e terzo capitolo del libro, intitolati Non siamo qui e Abito, maschera.
In questi capitoli entra in scena un concetto filosofico fondamentale per la disquisizione di Cavalletti: l’idea di habitus. Chiamando in causa i contributi, in particolar modo, di Husserl e del teorico dell’arte Robert Klein, all’interno del libro l’autore tessa un’indagine sulla vertigine che si posiziona ad un livello intersoggettivo. Se secondo Husserl l’habitus è ciò che è proprio del soggetto, ossia ciò che si possiede in quanto entità pensante e individuale. È interessante notare come Klein colga nella vertigine la possibilità di riscattare “l’abitudine” attraverso l’instaurazione di una relazione con un’entità esterna che si frappone, facendogli così raggiungere la dimensione dell’inappropriabile. La vertigine, perciò, secondo Klein provoca una dislocazione dell’io, in quanto lo sguardo altrui ci conquista, sottraendoci alla nostra coscienza riflessiva.
Cavalletti molto intuitivamente e sempre in riferimento a ciò, cita anche il carattere di reversibilità di Merleau-Ponty. Egli ricorda infatti come il filosofo francese in Phénoménologie de la perception e in Le visible et l’invisible precisa come le azioni dell’altro si riflettano in noi, in quanto quando l’essere si manifesta, esso esprime la presenza dell’altro - o dell’altro in me, urtando così la componente soggettiva. E la prospettiva del mondo, intrecciandosi inesorabilmente con quella dell’altro, viene attirata in un vortice in cui il mondo non è più pensato come proprio, perché appunto si viene influenzati da ciò che si verifica esternamente. E tale concezione, volendo, richiama anche alle recenti teorie sui neuroni specchio, in cui il gioco della reversibilità si attua ad un livello neurale. Cavalletti tramite un’analisi che coinvolge i maggiori pensatori della filosofia moderna, pone la vertigine come strumento intersoggettivo, ribadendo come la spinta tentatrice a gettarsi nel vuoto consista in realtà in una doppia percezione che ci fa sentire contemporaneamente qui e là. Facendo intervenire ancora Klein, l’autore nomina l’Eigenheit, ossia il rimbalzo tra rimorso e ricordo che stimola il soggetto a concepire il laggiù come un qui, e il qui come un là. Ricordandoci come sul precipizio si diviene un altro, evocando, così, l’ambivalenza data della presenza di Judy e Madeline che nel momento prima della caduta dalla torre coesistono entrambe.
Sempre attenendosi al contributo dei pensatori moderni, Cavalletti negli ultimi tre capitoli (Un singolare trasporto, Baratro, e Superficie) fa emergere questioni che, come in precedenza, amalgamano l’ambito cinematografico con quello filosofico. Compaiono quindi i concetti di: análogon, lapsus e Sterben (il morire). Seguendo le orme tracciate da Aristotele e successivamente da Hobbes, il lapsus non viene definito come un inganno dell’inconscio – lapsus che in questo particolare caso si esprime nell’atto volontario di Judy di indossare il collier appartenuto alla defunta Madeline – ma come un’azione compiuta in stato di veglia. Una volontà, potremmo dire sintetizzando, che permette alla maschera di cadere, richiamando ancora in causa il fenomeno della vertigine, quale esperienza stessa della messa in causa dell’identità. “L’ego è essenzialmente afflitto dalla vertigine, se questa consiste – nel compiere il passo che non si vorrebbe compiere, in un solecismo, in una contraddizione o in un lapsus dell’intentio (se potessimo non presupporre con questa parola il centro i l’identità che è forse la vertigine stessa a produrre)” (p. 97). Cavalletti in merito fa un ulteriore passo in avanti, portando come esempio l’esperienza attoriale di travestimento e smascheramento citando il famoso caso di Mary Pickford e il suo disorientamento vertiginoso nel guardarsi con gli occhi di un’altra senza essere la stessa, e riconoscendo nell’altro un análogon senza vita.
“Nella vertigine cinematografica la vertigine dell’identità viene annullata, e l’attrice potrebbe finalmente guardarsi con gli occhi di un’altra senza dover essere la stessa, senza dover aderire alla propria maschera colmandola di vita”(p. 148). Un senza vita che ci rimanda inesorabilmente al tema della morte (Sterben) e del baratro che, stando alla filosofia di Heidegger (autore che domina il capitolo quinto), è inclusa nella questione dell’Essere; in quanto l’essere esiste proprio a partire dalla sua possibilità di morte che non può per nessuna ragione venir rimandata. L’essere, di conseguenza, si determina anche grazie ad un’anticipazione di un non esserci più, perché in tale potenzialità l'esserci sovrasta se stesso, rimandando così al proprio poter-essere più proprio. E proprio in questo anticipo di poter essere che l’esserci, sempre secondo Heidegger, si apre alla sua condizione più estrema: la morte.
Ed è in base ai principi fino ad ora esposti, che Cavalletti ribadisce più spesso, anche durante il suo intervento del 22 Maggio presso la libreria Libre di Verona, quanto sia fondamentale il concetto di fissare la vertigine; fissarla appunto in quanto essa permetterebbe all’essere di rivelarsi nelle sue espressioni più autentiche, concedendo all’identità di formarsi e definirsi proprio in base a tale sbilanciamento vertiginoso. Da questo excursus si intuisce come Vertigine sia un’opera che apra un dialogo in cui le tematiche filosofiche e cinematografiche, congiungendosi tra loro, formano idee e principi che inquadrano il fenomeno della vertigine all’interno di una prospettiva nuova, in cui la spinta alla discussione e all’interrogazione dei vari quesiti non è mai data per scontata, ma sempre stimolata a superarsi e a oltrepassare i propri limiti; esattamente come l’uomo che dall’alto rivolgendo in basso il proprio sguardo si reincontra e si perde nel medesimo istante.
Silvia Cegalin
-
Nota di lettura di P. Amoroso, Pensiero terrestre e spazio di gioco, Mimesis, 2019.
 Il libro di Prisca Amoroso, Pensiero terrestre e spazio di gioco. L’orizzonte ecologico dell’esperienza a partire da Merleau-Ponty, edito per Mimesis, è un testo che si presta ad almeno due piani di lettura possibili. Per un lato, si tratta di una monografia attenta ad alcuni sviluppi del pensiero di M. Merleau-Ponty che, ad oggi, restano per lo più ai margini dalla critica esegetica (sia detto a titolo indicativo: la centralità dei corsi dedicati all’apprendimento nel bambino, gli influssi di alcuni inediti husserliani, i rapporti laterali con la psicoanalisi di Winnicott, etc.). D’altro lato, ci troviamo di fronte al tentativo di dare consistenza ad un percorso di pensiero originale. Si tratta quindi, tanto di un libro su, quanto di un cammino con Merleau-Ponty. Vorremmo partire da questo particolare intreccio di esegesi critica e costruzione concettuale per restituire alcuni aspetti che ci sembrano maggiormente rilevanti nel tentativo di inserire questo lavoro in contatto con alcuni dibattiti attuali, come quelli dell’ecologia filosofica e del problema della vita (Cfr. Iofrida 2012; Barbaras 2008). A tal fine, vorremmo prendere l’avvio dal capitolo intitolato Vincoli e improvvisazione (pp. 131 - 135), che si situa nel cuore dell’argomentazione dell’autrice. Questi concetti ci offrono uno spaccato interessante del lavoro svolto nel libro e restituiscono alcune cifre della posta in gioco del tentativo di Amoroso. Il particolare interesse di questo capitolo è dato da una sorta di case study, se è lecito esprimersi in questi termini, riportato dall’autrice e citato dal Merleau-Ponty (2010: 46) de La struttura del comportamento: si tratta degli studi del neurologo tedesco Kurt Goldstein (2010, 198 - 199) sullo scarabeo stercoraro. L’interesse per questo case study deriva dal fatto che tanto Goldstein, quanto Merleau-Ponty - e, con loro, Amoroso - considerano questo animaletto come un esempio di adattamento che potremmo definire contingente. Andiamo con ordine.
Il libro di Prisca Amoroso, Pensiero terrestre e spazio di gioco. L’orizzonte ecologico dell’esperienza a partire da Merleau-Ponty, edito per Mimesis, è un testo che si presta ad almeno due piani di lettura possibili. Per un lato, si tratta di una monografia attenta ad alcuni sviluppi del pensiero di M. Merleau-Ponty che, ad oggi, restano per lo più ai margini dalla critica esegetica (sia detto a titolo indicativo: la centralità dei corsi dedicati all’apprendimento nel bambino, gli influssi di alcuni inediti husserliani, i rapporti laterali con la psicoanalisi di Winnicott, etc.). D’altro lato, ci troviamo di fronte al tentativo di dare consistenza ad un percorso di pensiero originale. Si tratta quindi, tanto di un libro su, quanto di un cammino con Merleau-Ponty. Vorremmo partire da questo particolare intreccio di esegesi critica e costruzione concettuale per restituire alcuni aspetti che ci sembrano maggiormente rilevanti nel tentativo di inserire questo lavoro in contatto con alcuni dibattiti attuali, come quelli dell’ecologia filosofica e del problema della vita (Cfr. Iofrida 2012; Barbaras 2008). A tal fine, vorremmo prendere l’avvio dal capitolo intitolato Vincoli e improvvisazione (pp. 131 - 135), che si situa nel cuore dell’argomentazione dell’autrice. Questi concetti ci offrono uno spaccato interessante del lavoro svolto nel libro e restituiscono alcune cifre della posta in gioco del tentativo di Amoroso. Il particolare interesse di questo capitolo è dato da una sorta di case study, se è lecito esprimersi in questi termini, riportato dall’autrice e citato dal Merleau-Ponty (2010: 46) de La struttura del comportamento: si tratta degli studi del neurologo tedesco Kurt Goldstein (2010, 198 - 199) sullo scarabeo stercoraro. L’interesse per questo case study deriva dal fatto che tanto Goldstein, quanto Merleau-Ponty - e, con loro, Amoroso - considerano questo animaletto come un esempio di adattamento che potremmo definire contingente. Andiamo con ordine.L’obiettivo - del capitolo come delle sue fonti - è quello di criticare le concezioni meccanicistiche del vivente, dell’animale e del corpo. Secondo Amoroso, in linea con lo spirito merleau-pontyano, in tali modi di pensare al vivente «non c’è spazio per l’improvvisazione» (p. 131). A partire da questa constatazione, Amoroso sottolinea che l’animale non è assimilabile ad una macchina meccanica in quanto, a differenza di quest’ultima, «non possiede un dispositivo prestabilito» (p. 131) di gestualità e azioni, cioè di forme a priori di comportamento. L’animale non è un oggetto (ma potremmo dire, altresì, che non è un noema), piuttosto è espressione di una variegata capacità d’azione in riferimento ad una serie di contesti. «In altri termini, la vita è caratterizzata da una certa forma di ambiguità, di apertura di fronte allo stimolo, dunque di capacità di improvvisare di fronte al domandare, continuamente rinnovato, del reale» (p. 131).
Vediamo emergere, in questi passaggi, una relazione ambientale che restituisce, almeno in parte, la cifra ecologica di queste analisi. Ma emerge altresì una presa di posizione specifica in merito alla questione del vivente. La vita, ma come vedremo è più consono dire l’atto del vivere, è qualcosa che si situa nell’intermondo (cfr. Merleau-Ponty 2008, 147-148) tra le istanze problematiche sollevate dall’ambiente e le capacità di risposta del vivente, capacità che sono sempre aperte e allo stesso tempo vincolate da una specifica topologia, ad una situazione. Vivere consiste nell’essere situati in questo spazio di gioco, mondo intermedio (Iacono 2010, 67-87) tra le urgenze dell’ambiente e le capacità (o plasticità) del vivente.
Ora, è in questa doppia cattura, in questo chiasma per riprendere la concettualità di Merleau-Ponty, che si pone la questione della vita, ed è qui che diviene centrale il lavoro di Goldstein. Amoroso mutua dal neurologo tedesco una peculiare nozione di adattamento: «[q]uesta idea è tematizzata da Goldstein come venire a patti (coming to terms) del soggetto con la situazione: l’organismo riorganizza continuamente se stesso e il proprio mondo in funzione delle proprie possibilità e necessità» (p. 133). Questo modo di concepire l’adattamento esprime l’idea che tra l’ambiente (il quale, in riferimento a von Uexküll, viene declinato dall’autrice nei termini di Umwelt) e l’individuo non si diano mai relazioni univoche e che nessuno dei due termini possa avere un privilegio ontologico sull’altro. In quest’ottica, l’idea di adattamento è interpretata in chiave non riduzionistica. Riprendendo alcuni aspetti del pensiero francese novecentesco (ma non solo: molti i richiami nel libro a Huizinga, Winnicott, etc.), Amoroso vuol evidenziare che l’adattamento e il chiasma tra individuo e ambiente mette in risalto che è la relazione ad aver valore d’essere, la quale è irriducibile ad uno solo dei due poli: nessuna priorità ontologica dell’ambiente sull’individuo, né dell’individuo sull’ambiente.
Per un verso, infatti, «l’organismo contrae il mondo per adattarlo alla propria condizione» - nel duplice senso del termine contrarre: ridurlo ai dintorni, ma anche assumerlo come abitudine -, mentre per un altro, «il vivente si adatta esso stesso al proprio ambiente, si riorganizza nel proprio rapporto con esso» (p. 134). Per evidenziare questo chiasma tra attività e passività (dell’organismo come dell’ambiente), Amoroso si richiama allo scarabeo analizzato da Goldstein, il quale «deambula, quando è sano, sempre con un’andatura ambiale, e, nel caso di amputazione di una o più falangi, usa alternativamente l’ambio e il trotto, a seconda dell’ambiente in cui si trova» (p. 135). L’esempio è utilizzato, come detto, anche da Merleau-Ponty (2010, p. 46) il quale sottolinea che tale capacità «non si verifica che sotto la pressione delle condizioni esteriori».
Questo doppio vincolo, questa relazione di continui feedback tra individuo e ambiente, è espressione della capacità dell’organismo «di far valere la propria libertà rispetto ad un limite […]. Rispetto ad un problema cui non era destinato dalla propria natura, l’animale dimostra una capacità quasi inventiva, di riassestarsi. Un vivente così pensato non è macchina almeno quanto esso non si costituisce come libertà assoluta» (p. 135).
Torneremo a breve su quest’ultimo passaggio. Per il momento è opportuno sottolineare che la capacità inventiva del vivente è espressione di un processo di adattamento basato su una negoziazione continua tra il dentro e il fuori, tra l’individuo e l’ambiente. Insomma, in primissima istanza vivere è una relazione che si basa sul venire a patti con l’ambiente, con un continuo risolvere problemi o, per dirla con Merleau-Ponty (2003, 293-318), rispondere alle avversità dell’esistenza.
In un’ottica di tal fatta viene a cadere l’idea di un ambiente come Natura Originaria, ovvero come principio Naturante (si tratta dunque di una posizione ecologica e non naturalistica, in quanto predilige le relazioni alle cose [Sachen]). Ma viene meno anche l’idea di un individuo isolato, dato che esso è sempre determinato dai processi di individuazione. Quella tra individuo e ambiente, così, è una relazione ambigua e avversativa che mette in atto processi di individuazione vivente.
Trattandosi di una posizione non naturalistica, la relazione vitale non è qualcosa di naturale, ma va sempre giocata e istituita: essa non è data ma è sempre da farsi. Vivere si presenta così come una prassi e non come l’oggetto di un sapere particolare o un noema: più che al Bìos, vivere rimanda ad un piano agonale, a qualcosa da fare piuttosto che a una mera cosa [Blosse Sache]. La vita, insomma, va praticata.
Con quest’ultima considerazione ci spostiamo su un altro riferimento centrale del libro di Amoroso: il biologo olandese Frederik J. Buytendijk, anch’egli tra le fonti di Merleau-Ponty. L’autrice mutua dallo scienziato l’espressione scandalo biologico dell’allegrezza, che dà il titolo ad un capitolo di poco successivo al primo commentato (pp. 151 - 155). Questa formula esprime l’idea che se il vivere è una prassi - attiva quanto passiva - e non un dispositivo prestabilito comportamentale, allora l’atto del vivere si presenta come una molteplice e variegata ricchezza di espressioni vitali, spesso anche del tutto inattese (mostruose, fuori natura e finanche pericolose per il vivente stesso). Proprio in questa multiforme varietà inattesa consiste lo scandalo della vita: essa non è riducibile ad un meccanismo, ma, mediante la doppia cattura, non è neppure uno slancio vitale, pura libertà assoluta, come abbiamo avuto modo di accennare.

Nell’ottica di uno slancio vitale, infatti, la vita non avrebbe altro senso se non se stessa, riproponendo nuovamente un dualismo tra qualcosa che ha un fine in sé e qualcosa che ha un fine fuori di sé. Si tratta di una prospettiva nella quale la vita ha un valore in sé, come un nuovo imperativo categorico e non ci sarebbe spazio per i singoli viventi poiché avrebbero il fine fuori di sé e dunque sarebbero solo mezzi attraverso i quali la vita esprimerebbe se stessa.
Lo scandalo del vivere, al contrario, è che vi sia la possibilità, nonostante tutto, di una vita. Lo scandalo consiste nel fatto che vivere non è che un continuo processo di indeterminazione e individuazione e che non ci si possa rapportare a questo vivere se non, per riprendere il lessico di Mille piani di Deleuze e Guattari (2015, 51), nella modalità della sottrazione, dell’ N-1. Ecco lo scandalo del vivere: si deve sempre strappare una vita dalle avversità, dalle contingenze, dalle istanze problematiche, perché vivere non è qualcosa che è esente dal fare dei singoli viventi. Vi sono infinite vite possibili e non una Vita Infinita: molteplici viventi infinitamente variegati, affetti in infiniti modi.
Un vivente, una vita è situata sempre nel mezzo dell’attivo e del passivo, dell’azione e della passione, è sempre aperta ai rischi e a forme di resistenza che ne ostacolano lo sviluppo: una vita, un vivente è sempre un paradosso esistenziale. Contro l’imperativo categorico della Vita Infinita, Amoroso tenta di giocare la carta della finalità senza scopo del vivente (pp. 195 ss), un finalismo che determina la dimensione contingente e paradossale di una vita. Vivere non è mai dunque un sostantivo, ma, di nuovo, un verbo, un agire, una pragmatica. Una vita non è che un continuo venire a patti con ciò che c’è, con e dentro l’esistente: un continuo attuare equilibri metastabili. Vivere, quindi, non è che creare delle resistenze nell’esistente.
Radicalizziamo ancora la tesi: vivere significa costringere l’esistenza a trasformarsi. Ciò fa sì che non si vive mai semplicemente contro la morte, vivere non è questione di mera sopravvivenza. Se vivere è un processo di adattamento continuo, questo adattamento non sarà, quanto meno in prima istanza, una lotta per la sopravvivenza (la quale presuppone, come argutamente sottolinea Amoroso, un ultimatum dell’ambiente all’organismo, p. 153), ma una lotta per trasformare l’esistente. Dal venire a patti allo scandalo dell’allegrezza, quindi: riecheggia, nel libro di Amoroso, l’idea che è solo attraverso l’allegrezza che si può vivere, ovvero trasformare l’esistenza. Sono le spinoziane passioni gioiose che aumentano lo spazio di gioco nelle avversità di una vita. Spinoziane, certamente. Ma anche profondamente merleau-pontyane (cfr. Merleau-Ponty 2008, 148 ss; 2003, 277-293): vivere non è la lotta a morte tra rivali, che condurrebbe ad una concezione competitiva della vita, ma la cooperazione tra viventi per trasformare lo stato di cose.
Ecco quindi tre concetti chiave del lavoro di Amoroso: vita, esistenza e trasformazione. Tutti e tre questi concetti necessitano di uno spazio di gioco (Amoroso mutua il termine husserliano Spielraum, pp. 127-130) ove far crescere le relazioni, unico oggetto possibile dell’ontologia (la domanda ontologica, merleau-pontyanamente, non riguarda l’Essere, ma l’atto di creazione delle relazioni). Inevitabile, così, che tali riflessioni approdino al problema della soggettività e, con essa, alla critica di alcuni sviluppi della filosofia cartesiana. Con Merleau-Ponty, Amoroso tenta di delineare un’etica della contingenza (pp. 211 - 215), ovvero concepire la soggettività come potenza d’agire e non come interiorità cosciente e pensante: tentare di sostituire all’Ego Cogito, un Ich Kann, un Io posso. Un soggetto non è altro così da una vita che si pratica nei meandri delle avversità dell’esistenza.
Queste ultime considerazioni ci riportano al capitolo del libro di Amoroso dal quale siamo partiti, Vincoli e improvvisazione. Qui l’autrice connette la già commentata idea di Goldstein al lavoro del poeta Paul Valèry. Strana unione tra Scienza e Poesia, tra Ragione e Sentimento che ci limitiamo a segnalare e che nei lettori più avveduti non può che risuonare con il lavoro di Merleau-Ponty. In particolare, però, Amoroso rilancia l’importanza della nozione di Implexe «che esprime [la] fondamentale eventualità della vita» (p. 132). L’Implexe, infatti, è per il poeta francese «ciò per cui io sono eventuale» (p. 133). Amoroso fa giocare questa nozione contro l’idea di soggetto come cosa pensante, o, per essere più precisi, contro una concezione sostanzialistica della soggettività. L’autrice rilancia l’idea che una soggettività, in quanto qualcosa che può, non è identificabile col pensiero - non nei termini del Cogito, quanto meno - ma con l’eventualità.
Essere viventi, essere al mondo, divenire una vita significa essere sempre in relazione con qualcos’altro che c’è già, un qualcosa che ci precede e che ci supera. Essere una vita, inoltre, non è mai una condizione solipsistica: si vive sempre in una molteplicità, mai per sé. Una vita è pur sempre un’esistenza collettiva e intersoggettiva, mai meramente individuale. Ma ciò implica anche che, mentre la soggettività non è un per sé, il qualcosa non è neppure un in sé: non è un quid meramente indeterminato, ma un piano di esistenza avversativo che richiede la nostra vita, la nostra opera, la nostra incompiutezza. Essere viventi significa essere eventuali. Ma quest’ultima determinazione ci dice anche che vivere non è un pratica tra le altre. Vivere è una vera e propria ars inveniendi. In questa prospettiva si apre uno spiraglio, un cammino possibile verso una noologia di ispirazione merleau-pontyana, con cui vogliamo concludere.
Il pensiero (un pensiero terrestre, nietzscheanamente fatto di carne e nervi), svincolato dalla forma soggettiva, diviene una specie di virtù e in quanto tale occorre imparare a praticarla. Pensare, nella prospettiva di Amoroso, vuol dire apprendere e imparare a costruire insieme agli altri (umani e non) degli spazi di gioco nei quali poter sperimentare l’eventualità di una vita. Ma pensare vuol dire altresì costringere l’esistente a venire a patti con quella scandalosa allegrezza di una vita collettiva, l’unica soggettività capace di resistere alle avversità di ciò che c’è.
di Gianluca De Fazio
Bibliografia
Barbaras, R. (2008). Introduction à une phénoménologie de la vie. Paris: Vrin.
Deleuze, G. & Guttari, F. (2015). Mille piani. Roma: Castelvecchi.
Goldstein, K. (2010). L’organismo. Trad. it. Di L. Corsi. Roma: Fioriti.
Iacono, A.M. (2010). L’illusione e il sostituto, Milano: Mondadori.
Iofrida, M. (2012). Vita natura soggetto, in M. Iofrida (a cura di), Crisi. Condizione e progetto. Modena: Mucchi.
Merleau-Ponty, M. (2003). Segni. Trad. it. di G. Alfieri. Milano: Net.
Merleau-Ponty, M. (2008). Le avventure della dialettica. Trad. it. di D. Scarso. Milano-Udine: Mimesis.
Merleau-Ponty, M. (2010). La struttura del comportamento. Trad. it. di M. Ghilardi e L. Taddio. Milano-Udine: Mimesis.
-
 La constatazione della pervasività degli automatismi che intessono la nostra esistenza individuale e collettiva porta Pelgreffi a sviluppare un’interrogazione radicale intorno all’essenza di tale fenomeno. L’automatismo viene considerato a partire dall’ampiezza del suo senso, che trova applicazione in ambiti apparentemente eterogenei, come il biologico e il sociale, rivelando, fin dall’inizio, la sua costitutiva ambiguità, che porta, tra l’altro, a un’essenziale riconfigurazione della tradizionale opposizione tra naturale e culturale. Il comportamento automatico si rivela essere, da una parte, il modo di manifestarsi di ciò che è spontaneo, non programmato, emergente. In quest’ottica, afferisce all’ambito del biologico, delle procedure innate radicate nel profondo del bios, dell’inconscio corporeo e psichico. Dall’altra, richiama ciò che è stato appreso ed è diventato abitudine, nel senso di ciò che si impone come prassi automatica a seguito di ripetizioni esercitanti. Si tratta, in questo caso, dello spettro di significati che rimandano al contesto della “seconda natura”, ossia delle abitudini acquisite nel corso della vita, le quali si installano sugli automatismi innati, rimpiazzandoli e riconfigurandoli.
La constatazione della pervasività degli automatismi che intessono la nostra esistenza individuale e collettiva porta Pelgreffi a sviluppare un’interrogazione radicale intorno all’essenza di tale fenomeno. L’automatismo viene considerato a partire dall’ampiezza del suo senso, che trova applicazione in ambiti apparentemente eterogenei, come il biologico e il sociale, rivelando, fin dall’inizio, la sua costitutiva ambiguità, che porta, tra l’altro, a un’essenziale riconfigurazione della tradizionale opposizione tra naturale e culturale. Il comportamento automatico si rivela essere, da una parte, il modo di manifestarsi di ciò che è spontaneo, non programmato, emergente. In quest’ottica, afferisce all’ambito del biologico, delle procedure innate radicate nel profondo del bios, dell’inconscio corporeo e psichico. Dall’altra, richiama ciò che è stato appreso ed è diventato abitudine, nel senso di ciò che si impone come prassi automatica a seguito di ripetizioni esercitanti. Si tratta, in questo caso, dello spettro di significati che rimandano al contesto della “seconda natura”, ossia delle abitudini acquisite nel corso della vita, le quali si installano sugli automatismi innati, rimpiazzandoli e riconfigurandoli.L’intento di Pelgreffi è rendere tale ambiguità, consustanziale al concetto di automatismo, non già paradosso paralizzante, ma apertura di senso produttiva e meritevole di essere indagata nella sua doppiezza. Tale approccio permette di chiamare in causa un’altra ambiguità del concetto di automatismo, che concerne il suo riferirsi, al tempo stesso, alla vita individuale e collettiva. Gli automatismi sviluppati dai singoli individui si riflettono e dialogano costantemente con le dinamiche che regolano la convivenza, culturalmente codificata, all’interno di un collettivo. Tale prisma semantico viene messo in luce tramite un’attenta e avveduta rassegna delle teorie di coloro che si sono occupati, ciascuno a modo proprio ma anche in dialogo reciproco, del concetto di automatismo. Dalle analisi classiche intorno al concetto aristotelico di hexis si giunge alla filosofia francese novecentesca, passando per Hume, Nietzsche e Butler. Non viene tralasciato il dialogo, da una parte, con le scienze psicologiche (in particolare Pavlov e Janet) e, dall’altra, con la pratica artistica dell’attore, compresa attraverso le riflessioni di Diderot e di Stanislavskij. Tali incursioni ermeneutiche permettono a Pelgreffi di approdare a un dialogo serrato con i risultati teorici ottenuti da Merleau-Ponty, in particolare nella sua Fenomenologia della percezione, e mettere in evidenza il ruolo cruciale che la corporeità svolge all’interno di una teoria generale degli automatismi.

Il corpo, compreso come limite e soglia, si configura come il punto fondamentale di incrocio e trasformazione tra le diverse forme di automatismo evidenziate in precedenza. Tale approccio permette di delineare la funzione formante degli automatismi, ossia la circostanza, secondo la quale l’acquisizione di abitudini ripetute ha valore soggettivante, nella misura in cui plasma la modalità di esistenza di chi incarna tali abitudini. È una simile prospettiva che permette a Pelgreffi di introdurre la dinamica eminentemente etica aperta da una filosofia dell’automatismo, nella misura in cui la funzione formante di quest’ultimo rivela, come suo doppio costitutivo, la presenza di una resistenza basale, della possibilità di uno stacco produttore di divergenza, nel processo di acquisizione degli automatismi e nella loro riconfigurazione. In tale potenzialità trasformante si cela la possibilità etica e il focus gnoseologico che permettono di comprendere come si possa produrre differenza attraverso la ripetizione, ossia come sia possibile la de-automatizzazione dei propri automatismi, pur dimorando all’interno dell’orizzonte ampiamente automatizzato in cui la vita si esplica in quanto tale.
La peculiarità dell’approccio adottato da Pelgreffi consiste nel situare nel corpo e, pertanto, nell’insieme di pratiche che possono proporsi di istituire i criteri di un’etica della corporeità, la soglia di tale possibilità di de-automatizzazione, ossia di riconfigurazione critica dei propri automatismi attraverso gli automatismi stessi: «la corporeità è la zona intermediale in cui l’automatismo come senza precedenti e l’automatismo come risultato della ripetizione trovano una sintesi non neutralizzante, aperta anche alla diversione dalla forma sintetica operante» (p. 88). Una tale prospettiva viene conquistata considerando gli automatismi nella loro dimensione genetica e processuale, al fine di comprendere l’acquisizione di un’abitudine nel suo svolgersi e affermarsi e metterne in luce la struttura composta da esercizi ripetuti con effetti di ritorno plastici e in continuo dialogo con una resistenza produttiva installata nella corporeità. Particolare rilievo assume, in una tale ottica, l’attenzione al processo di apprendimento delle abitudini, nel quale si celano le codificazioni sociali (Bourdieu) e i presupposti manuali della tecnica (Sennett). L’intento è quello di ricondurre criticamente il potere della ripetizione automatizzantesi contro la ripetizione stessa, in quanto «all’interno dell’automatismo, esistono contro-movimenti di de-automatizzazione che si tratta di veicolare, di guidare e gestire dall’interno» (p. 220). A partire da questa prospettiva, è importante rilevare come un tale approccio permetta di aprire la strada a una radicale riconfigurazione del ruolo della soggettività, la quale non viene abbandonata, ma ridimensionata e ricondotta alle pratiche di vita, innervate nella corporeità e nel suo fondo inconscio, solo a partire dalle quali la figura del soggetto si può manifestare, dato che «non c’è soggetto senza automatismo, senza estroflessione originaria al dispositivo» (p. 179). È al livello di tali pratiche, delle quali il soggetto rappresenta il risultato epifenomenico parziale e posteriore, che un’etica della resistenza produttiva e della ripetizione differenziante può essere codificata.
di Marco Pavanini
-
 Un libro monumentale. Da avere in tutte le biblioteche, non solo di chi si interessa di filosofia e ha amato gli esistenzialisti, ma di tutti coloro che vogliono capire il XX secolo, e quindi il mondo in cui viviamo ora (ma, azzardo, anche di chi vuole solo leggere una bella storia, come fosse un romanzo). Sarah Bakewell ripercorre infatti, alternando gravità e leggerezza, tutta la storia del Novecento attraverso la vita e il pensiero di alcuni dei suoi attori più significativi, nella fattispecie gli intellettuali francesi e tedeschi, cosiddetti fenomenologi e esistenzialisti (ma non solo). Alla base di quest’opera di raffinata divulgazione c’è l’assunto, caro agli esistenzialisti – a prescindere dal fatto che non tutti coloro che sono stati definiti tali abbiano accettato questa etichetta – che non si può capire una filosofia senza l’uomo che la pensa, o meglio, che vita e pensiero sono inscindibili. L’una influenza l’altra e viceversa. E poi la filosofia deve avere un senso per le nostre vite, deve essere applicabile alla vita quotidiana, altrimenti diventa un mucchio di parole difficili che ci si sputa addosso credendosi intelligenti.
Un libro monumentale. Da avere in tutte le biblioteche, non solo di chi si interessa di filosofia e ha amato gli esistenzialisti, ma di tutti coloro che vogliono capire il XX secolo, e quindi il mondo in cui viviamo ora (ma, azzardo, anche di chi vuole solo leggere una bella storia, come fosse un romanzo). Sarah Bakewell ripercorre infatti, alternando gravità e leggerezza, tutta la storia del Novecento attraverso la vita e il pensiero di alcuni dei suoi attori più significativi, nella fattispecie gli intellettuali francesi e tedeschi, cosiddetti fenomenologi e esistenzialisti (ma non solo). Alla base di quest’opera di raffinata divulgazione c’è l’assunto, caro agli esistenzialisti – a prescindere dal fatto che non tutti coloro che sono stati definiti tali abbiano accettato questa etichetta – che non si può capire una filosofia senza l’uomo che la pensa, o meglio, che vita e pensiero sono inscindibili. L’una influenza l’altra e viceversa. E poi la filosofia deve avere un senso per le nostre vite, deve essere applicabile alla vita quotidiana, altrimenti diventa un mucchio di parole difficili che ci si sputa addosso credendosi intelligenti.Questa avventura ha inizio tra il 1932 e il 1933 in un caffè di Parigi, il Bec-de-Graz, in cui ritroviamo tre amici seduti a un tavolino a bere cocktail all’albicocca: Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir e Raymond Aron. Quest’ultimo studiava a Berlino ed era intento a raccontare agli altri due una nuova affascinante filosofia che si stava affermando in Germania: la fenomenologia. I fenomenologi non partivano da teorie o idee astratte, non gli interessava sapere se le cose fossero reali o certe, ma analizzarle in quanto fenomeni, prendendole come tali, immergendosi nella propria esperienza, nella vita così come la vivevano. Uno dei padri della fenomenologia, Edmund Husserl, diceva che bisognava andare “alle cose stesse!” e lo stesso Aron, rivolgendosi a Sartre, disse: “se sei un fenomenologo, puoi parlare di questo cocktail ed è filosofia!”. Questa svolta filosofica non lasciò indifferenti Sartre e la de Beauvoir i quali negli anni successivi forgiarono la loro personale filosofia: l’esistenzialismo (francese). Esso, come la fenomenologia, ma più a fondo, permetteva di occuparsi della vita vera, dell’esistenza, appunto, quella concreta, quella che ha a che fare con la scelta, la libertà, la responsabilità, l’autenticità.

Seguono il viaggio di Sartre in Germania, la fucina fenomenologica di Husserl e le mirabolanti avventure dei suoi manoscritti, lo stupore di Heidegger di fronte all’Essere, l’incanto delle sue lezioni e la sua ambigua vicenda umana e filosofica (elementi inscindibili), la Seconda Guerra Mondiale, i filosofi al fronte, l’Occupazione di Parigi dei nazisti, la Resistenza – in cui Sartre e compagnia impegnarono tutte le loro forze e l’esistenzialismo si rivelò un’arma fondamentale –, i romanzi, le rappresentazioni teatrali, la musica e la nuova moda parigina, Boris Vian e la sua tromba, Merleau-Ponty e i suoi passi di danza, Albert Camus e la sua sensibilità, Sartre e la de Beauvoir chiusi nei caffè a scrivere e fumare, la Liberazione, i lusinghieri inviti negli Stati Uniti, i litigi, le rotture di amicizie per differenze di opinioni politiche (tra Sartre e Aron, Sartre e Camus, Sartre e Merleau-Ponty, Merleau-Ponty e Camus…), il grande impegno politico portato avanti con la letteratura, la Guerra Fredda, il comunismo, la guerra per l’indipendenza dell’Algeria, la rivolte in Ungheria e in Cecoslovacchia, le rivolte studentesche, per i diritti civili, il femminismo, i premi Nobel rifiutati (Sartre) per mantenere l’indipendenza di pensiero. Un viaggio appassionante fra le trame di una fetta di secolo densissima che ha delineato il mondo in cui oggi viviamo.
Al caffè degli esistenzialisti (Fazi Editore 2016), oltre alla sua capacità di spiegare con semplicità, trasporto e precisione l’esistenzialismo e le vicende umane che hanno gravitato intorno a esso, ha il grande merito di ri-conferire a questa filosofia (una filosofia nata per essere applicata nella vita concreta), a questo modo di essere e guardare le cose, il ruolo che merita, un ruolo fondamentale per la storia del pensiero e la storia tout court. Al di là delle mode di Saint-Germain-des-Prés, l’esistenzialismo è stato il monito di uomini e donne che dedicarono la propria vita alla nostra libertà, per un mondo libero e responsabile. Ha cambiato la vita delle persone che prima di leggere le sue opere pensava che il mondo andasse avanti così perché era giusto, ha avuto un impatto concreto incredibile. Negli anni Cinquanta e Sessanta ha sostenuto il femminismo, i diritti degli omosessuali, l’abbattimento delle divisioni sociali, le lotte contro il razzismo e il colonialismo, ispirando sempre nuove forme di liberà. Ha messo al centro dell’attenzione la nostra concreta esistenza, chi siamo e come dovremmo vivere, lasciando però a noi la scelta. Anche senza saperlo, oggi siamo tutti un po’ esistenzialisti.
di Stefano Scrima
-
Estesie #3 – Sul binario della deformazione
Estesie, Serial / Maggio 2016Nel senso più generico del termine, la deformazione consiste nell’alterazione, temporanea o definitiva, della configurazione originaria di un oggetto, e in pittura indica quel processo di alterazione delle forme naturali che porta a risultati spesso considerati mostruosi o aberranti. Attraverso le diverse riflessioni di artisti e filosofi, nel corso del Novecento la deformazione ha però subito una notevole evoluzione concettuale, passando dall’essere concepita come specifico fattore stilistico a processo genetico dello stile in quanto tale, fino a darsi addirittura come mediazione di più larghe operazioni estetiche o extra-pittoriche.

Untitled, Jannis Kounellis (1968)
A inizio Novecento, il simbolista francese Maurice Denis proponeva un’acuta distinzione tra deformazione “oggettiva” e deformazione “soggettiva”: la prima, accostabile alla coeva nozione worringeriana di abstraktion, si costituiva come principio regolatore delle tensioni formali interne all’immagine secondo quelle che Denis definisce le “leggi eterne della decorazione”; la seconda scaturiva dalla necessità di mediare la natura attraverso il proprio “temperamento” psichico. La nuova teoria della pittura di Denis si basa sull’espressione per “equivalenze” e non più per “mimesi”, individuando così le basi di quella che sarà la più valida e genuina pittura contemporanea. Alla luce di quanto si è visto nei decenni a venire, potremmo infatti intravedere in questa coppia polare il seme di due linee stilistiche dominanti nella cultura novecentesca: dalla prima la dipartenza dello sviluppo di tutti i decorativismi geometrici e delle ricerche di arte concreta, mentre dall’altra le contratture segniche e materiche degli espressionismi, manifestatisi nel corso del secolo a più riprese, fino agli esiti figurativi dell’Informale.
Il futurista Carlo Carrà, in un breve e puntuale scritto intitolato proprio La deformazione in pittura e pubblicato sulla rivista «Lacerba» del 15 marzo 1914, afferma che ormai non possa più sussistere opera senza l’intervento della deformazione, considerando questa soluzione non solo come “fattore predominante” nella costruzione del quadro, ma addirittura come un “altimetro” per misurare i vari gradi di espressione plastica di un’opera. Naturalmente, in piena fede futurista, Carrà vede la deformazione come conseguenza del movimento, della necessità di resa dinamistica della realtà e rivanga quel concetto riportato nel Manifesto tecnico della pittura futurista del 1910 secondo cui “per la persistenza dell’immagine nella retina, le cose si moltiplicano”, ma soprattutto “si deformano, susseguendosi, come vibrazioni, nello spazio che percorrono”. Le affermazioni di Carrà riguardano problematiche stilistiche ben precise e circoscritte al loro tempo, ma l’intuizione per cui la deformazione sia alla base di qualunque opera d’arte contemporanea è di una lungimiranza che solo anni dopo e in sede di riflessione estetica avrebbe trovato un più ampio sviluppo. Dovremo perciò aspettare la soglia degli anni Cinquanta perché il concetto di deformazione venga esteso da Maurice Merleau-Ponty fino ad assurgere a sinonimo di stile. Per il fenomenologo francese lo stile è un modo di ricreare i fenomeni e trovare per essi nuove modalità di essere nel mondo, perché solo il pittore riesce a percepire “le norme e le deviazioni dell’inaccessibile pienezza delle cose”. La sua dissertazione sullo stile muove dall’assorbimento sul piano fenomenologico del concetto di “deformazione coerente” formulato da André Malraux (autore esplicitamente richiamato nel titolo con le voci del silenzio), secondo il quale ogni pittore ha un proprio modo consapevole di deformare i dati visibili per risemantizzarli, investirli di nuovi significati. Quasi come in un lontano dialogo con Maurice Denis, anche Merleau-Ponty concepisce lo stile-deformazione come “sistema di equivalenze”, ma aggiunge che solo attraverso “l’indice universale della deformazione coerente” un artista “concentra il senso ancora sparso nella sua percezione e lo fa esistere espressamente”. Qui l’oggettivo e il soggettivo teorizzati da Denis sono come stati fusi in un unico canale di accesso alla realtà attraverso cui il pittore rielabora le qualità dei dati visivi nella più generale prospettiva di una propria definizione stilistica. A proposito di questa assimilazione del concetto di deformazione a quello di stile, andrebbe forse considerato il fatto che gli anni in cui scrive Merleau-Ponty sono anche i graffianti anni dell’Informale, rappresentato in Francia da maestri quali Jean Dubuffet e Jean Fautrier. Corrente pittorica di larga e capillare diffusione, incentrata su problematiche esistenziali affatto estranee al pensiero fenomenologico, essa ha, com’è noto, fervidamente applicato indici di deformazione estrema alle proprie figure, aspetto che può avere giocato un qualche ruolo nelle riflessioni del nostro filosofo.

Jean Dubuffet, Affluence (1961)
Il contributo più articolato sul concetto di deformazione arriva però da un filosofo italiano, sempre di scuola fenomenologica, Miro Martini, allievo di Antonio Banfi e autore di un ampio e complesso saggio intitolato La deformazione estetica, frutto di profonde riflessioni sull’atto estetico come atto deformante. Si tratta di un sistema che ingloba e sostiene la corrispondenza cara a Merleau-Ponty tra deformazione e stile, ma che va ben oltre i comuni processi di formalizzazione artistica per aprirsi al più generale piano dell’estetica. Martini estende tale concetto “all’intero mondo estetico nella varietà dei suoi piani fondamentali”, quasi intuendo che l’orizzonte mediale dell’arte si sarebbe a breve espanso enormemente fino a coincidere con quello della quotidianità; secondo Dino Formaggio, con questa “legge dell’esistere artistico in concreta esperienza” Martini intendeva sostenere che “l’arte compie un’opera di trans-valutazione dei momenti della vita, del vivere di ogni giorno”, una traslazione del mondano nell’artistico attraverso quella che oggi con Arthur Danto diremmo una trasfigurazione del banale. Si tratta di sottrarre quindi elementi concreti e dinamiche del quotidiano alla loro comune funzione pratico-utilitaristica per riscattarli esteticamente o, come rimarca Formaggio, “a dar forma compiuta e nobiltà di stile ad ogni esperienza del vivere”. Conferme pratiche alle idee di Martini sarebbero arrivate solo anni e anni dopo la sua scomparsa con fenomeni quali lo happening, la performance, l’Antiform o le poetiche del Concettuale; ma mi pare piuttosto significativo che nella Milano di metà anni Cinquanta, e poco dopo l’uscita (purtroppo postuma) del testo di Miro Martini, artisti spazialisti come Agostino Bonalumi o Enrico Castellani cominciassero a intervenire su delle tele monocrome per dilatarle, estrofletterle, alterandone la configurazione di base e sperimentando così la deformazione non più sul piano virtuale della figurazione, bensì su quello della piena materialità (pur rimanendo ancora legati a un supporto artistico tradizionale), producendo in definitiva una sorta di sinergia tra teorie e poetiche contemporanee, e riuscendo anzi a dare alle idee martiniane un’indiretta e probabilmente inconsapevole convalida.
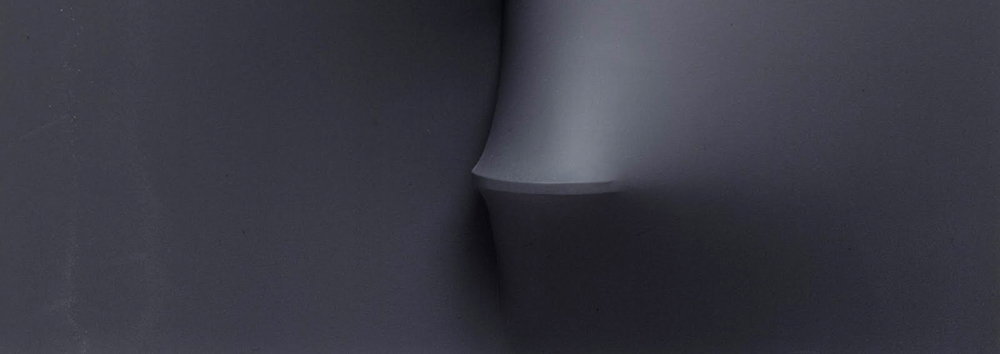
Agostino Bonalumi, Senza titolo - nero (1968)
Ecco dunque emerso lo status “bipolare” del concetto di deformazione nella cultura del Novecento, dove al primo polo, quello originario o dell’uso comune del termine e relativo a questioni plastico-formali (deformazione come alterazione di configurazione), se ne affianca un altro relativo a ridefinizioni artistiche dell’esperienza tramite mezzi, elementi e modalità dell’esperienza stessa (deformazione come stile e, solo dopo, come riformulazione estetica del quotidiano), ampliando così ad libitum le possibilità pratiche di stilizzazione. Quello tra deformazione plastica e deformazione estetica non è tuttavia un conflitto insolubile o un eterno scontro tra nemici giurati, ma al contrario una quieta e fruttuosa convivenza, spesso di reciproco supporto: le due istanze si incrociano e dialogano sempre più di frequente, e soprattutto oggi, nell’uso di mezzi come la fotografia o il video ormai divenuti imprescindibili per la ricerca contemporanea. La deformazione plastica, infatti, ha trovato in questi strumenti vie di aggiornamento oggi battutissime come l’uso delle distorsioni, delle alterazioni di segnale, e manipolazioni di ogni sorta, per le quali è proprio la deformazione estetica, lanciata nella prospettiva di una potenziale pan-artisticità dell’esperienza, a garantirne il valore espressivo. Da qui in poi, il concetto di deformazione in ambito artistico non potrà che vivere dunque di alternanze e distinzioni, ma questo suo bipolarismo lo manterrà, senza dubbio, fiamma di ogni dibattito sullo stile, sulle poetiche, sull’esistenza dell’arte. Attuale per sempre.
di Pasquale Fameli
Bibliografia
Carrà, C. (1978). La deformazione in pittura (1914). In M. Carrà (a cura di), Carlo Carrà. Tutti gli scritti (pp. 30-33). Milano: Feltrinelli.
Danto, A. (2008). La trasfigurazione del banale. Una filosofia dell’arte (1981). Bari: Laterza.
Denis, M. (1920). Théories 1890-1910. Du symbolisme et de Gauguin vers un nouvel ordre classique (1913). Paris: L. Rouart et J. Watelin Éditeurs; in particolare pp. 23, 268.
Martini, M. (2002). La deformazione estetica (1955). Milano: Unicopli; in particolare: pp. 55-57. Si veda inoltre la prefazione alla seconda edizione di Dino Formaggio, in particolare pp. 2-3.
Merleau-Ponty, M. (1967). “Il linguaggio indiretto e le voci del silenzio” (1952). In Id., Segni. Milano: Saggiatore; in particolare p. 81.
Worringer, W. (1976). Astrazione e empatia (1907). Torino: Einaudi.
-

Eliseo Mattiacci, Rifarsi (1973)
Ogni indagine che ponga il corpo al proprio centro implica spesso, quasi inevitabilmente, un’indagine sull’identità, e la performance italiana dei primi anni Settanta lo ha dimostrato in modo encomiabile. Le pratiche della modificazione somatica e della trasformazione facciale sono state infatti al centro di una stagione culturale che ha visto nella liberazione del corpo la possibilità di un superamento della società dei consumi attraverso una radicale ridefinizione estetica del comune comportamento. Il famoso verso «Je est un autre» di Arthur Rimbaud può essere perciò preso a vessillo di quella che, più che una stagione all’inferno, può essere intesa come una stagione all’interno della questione identitaria.
Quando si parla di mutazione e di modificazione del volto e del corpo in ambito artistico si pensa subito alle performance chirurgiche di Orlan: il suo è senza dubbio uno dei casi più emblematici, ma anche dei più estremi, di una ricerca genuinamente body che ha tuttavia i suoi inizi negli anni Settanta, con modi certamente meno invasivi ma non per questo meno rilevanti. Simili pratiche performative vanno senza dubbio ricondotte all’articolata vicenda di annichilimento dell’io in epoca postmoderna. Già a metà del Novecento, Ronald Laing aveva stabilito che la schizofrenia non fosse un semplice disturbo psichico, ma addirittura la malattia del nostro tempo: secondo lo psichiatra scozzese, infatti, gli uomini costruiscono tanti io falsi per corazzarsi e per difendersi dall’aggressione della realtà. È in questo modo che si giungerà alla minimizzazione dell’io, brillantemente analizzata da Christopher Lasch nei primi anni Ottanta, il quale insisterà proprio come Laing sull’idea che questa riduzione serva da corazza, sia cioè una protezione dai turbamenti del proprio tempo. Tra questi due poli sono molte le tappe che hanno segnato tale percorso, e un ruolo di prim’ordine va riconosciuto agli studi microsociologici di Erving Goffman il quale, considerando il self come maschera, ovvero come costruzione o simulazione di un’identità, ha contribuito in larga parte a mostrarne la fragilità e la precarietà, nonché l’ineludibile dipendenza dalla rete sociale e relazionale.È alle teorie di Goffman che Vito Acconci si è ispirato per le sue prime performance legate proprio alla questione identitaria ed è in questo stesso snodo che si possono collocare certe performance di alcuni artisti italiani dei primi anni Settanta quali Eliseo Mattiacci, Giorgio Ciam, Fernando De Filippi o Lamberto Calzolari, impegnatisi nel tentativo di riconfigurare o espellere il proprio io in sede performativa. Certe teorie e certe riflessioni internazionali su simili problematiche passavano già in Italia, e quindi era facile che questi artisti, come altri, ne fossero a conoscenza; nel Bel Paese tuttavia, la necessità di una riduzione dell’io aveva già trovato luogo nella poesia dei Novissimi, come acutamente rilevato da Alfredo Giuliani già sulla soglia degli anni Sessanta, ed era immaginabile che di lì a breve avrebbe trovato esiti anche con altre forme espressive. La fragilità dell’identità postmoderna, inoltre, ha in Italia una prima formulazione di tutto rispetto nella letteratura di Luigi Pirandello, teorico della nota dicotomia volto-maschera. Quello dei performer italiani è infatti il tentativo di essere uno, nessuno e centomila, e proprio come l’antieroe pirandelliano, ragionano sui difetti e sulle difformità che lo specchio restituisce loro, non certo per vuota vanità, ma per maturare una certa consapevolezza egoico-esistenziale.

Fernando De Filippi, Sostituzione (1974)
La più emblematica di queste azioni è Rifarsi di Eliseo Mattiacci, tenutasi presso la galleria Alexander Jolas di Milano nel 1973: qui l’artista marchigiano si ricopre il viso di argilla, manipolandola e plasmandola nel tentativo di rimodellare i propri tratti somatici. Il concetto del “rifarsi”, oggi molto in voga e legato solitamente alla volontà di migliorare il proprio aspetto oppure di adattarlo ai più correnti canoni estetici, viene posto al centro di un’operazione che va per il verso opposto, con effetto imbruttente. Già in Art Make-Up (1967) Bruce Nauman aveva proposto un ipotetico tentativo di abbellimento in virtù di una certa indagine sul corpo, un’indagine fenomenologica, ma nell’azione di Mattiacci l’esito è nettamente spinto sul versante peggiorativo, quasi a redarguire ogni tentativo di intervento plastico. Del resto, il corpo degli anni Settanta è un corpo da riscoprire in quanto carne dell’essere – chair avrebbe detto Maurice Merleau-Ponty – e non dell’apparire; ed è un corpo amoroso, come quello di Norman O. Brown, oppure un catalizzatore bioenergetico, secondo gli studi condotti da Alexander Lowen sulla scorta delle teorie di Wilhelm Reich, e quindi fremente di liberare senza più limiti le proprie pulsioni.
Sulla pratica del make-up è incentrata anche una performance del bolognese Lamberto Calzolari (fratello del più noto Pier Paolo, esponente di spicco dell’Arte Povera) tenutasi presso la Galleria 2000 di Bologna nel marzo 1974. Nel corso della sua azione Calzolari si sottopone a un lungo maquillage condotto dalla cognata Ginestra (figlia del pittore Vasco Bendini) che lo trucca come una donna, con tanto di cerone e rossetto. Viene infranto il tabù della separazione dei sessi e la liberazione pulsionale si fa esplicita: l’identità appare qui come un concetto da superare in virtù di una più onesta affermazione del corpo, ente detentore, secondo Freud, di componenti maschili e femminili che sono all’origine del processo di identificazione sessuale di ogni individuo. Al di là della problematica sessuale, il ricorso al make-up e il tentativo di “essere un altro” possono tuttavia assumere anche una connotazione politica: è il caso della Sostituzione compiuta dal leccese Fernando De Filippi il 14 marzo 1974 in cui l’artista si trucca per assomigliare a Lenin, già soggetto di molti suoi acrilici iperrealisti del 1971-72. Il lungo e lento processo di trasformazione è stato documentato fotograficamente nelle sue varie fasi, così da potersene mostrare i vari stadi secondo una progressione graduale.
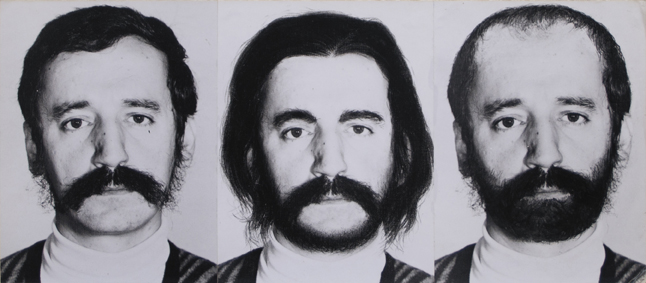
Giorgio Ciam, Sui peli (1972)
Simili operazioni di trasformismo, però lontane da problematiche politiche, sono state compiute in modo più sistematico dall’aostano Giorgio Ciam, attivo a Torino già dalla fine degli anni Sessanta; a differenza di De Filippi, però, l’aostano non interviene direttamente sul proprio volto, affidando piuttosto le sue mutazioni alla manipolazione fotografica. Qui l’identità è presa di mira in maniera diretta e sottoposta a una sorta di “verifica incerta”: sul volto di Ciam vengono di volta in volta applicati barba, baffi, capelli o frammenti di altri volti fino a renderlo completamente irriconoscibile. Mediante queste continue sostituzioni somatiche, Ciam riconfigura il sistema dell’identikit (inventato solo vent’anni prima e subito perfezionato dalla Smith & Wesson) come strumento estetico: negandone la comune funzione, l’aostano ne rovescia completamente il senso, trovando in esso non un mezzo di costruzione facciale ma, al contrario, una metafora della disgregazione identitaria. Le molte combinazioni testate da Ciam sulla propria immagine ripropongono e ribadiscono la volontà tutta novecentesca di “essere un altro” e, insieme alle azioni di Mattiacci, Calzolari e De Filippi, attestano indirettamente come la condizione dell’io in epoca postmoderna sia di continua negazione o di riformulazione, per un’identità dai mille volti.
di Pasquale Fameli
Bibliografia
Barilli, R. (1974). Cronache del comportamento: Lamberto Calzolari, in «NAC», 4, pp. 11-12.
De Filippi, F. (1974). Sostituzione. Milano: Edizioni Arte Borgogna.
Fameli, P. (2015). Vito Acconci e la sparizione dell’io, in «Figure», 2, pp. 71-78.
Giuliani, A. (a cura di) (1965). I Novissimi. Poesie per gli anni ’60 (1961). Milano: Rusconi e Paolazzi.
Goffman, E. (2002). La vita quotidiana come rappresentazione (1959). Bologna: il Mulino.
Laing, R.D. (1969). L’io diviso. Studio di psichiatria esistenziale (1955). Torino: Einaudi.
Lasch, C. (1985). L’io minimo. La mentalità della sopravvivenza in un’epoca di turbamenti (1984). Milano: Feltrinelli.
Pirandello, L. (1992). Uno, nessuno e centomila (1926). Milano: Mondadori.
Re, E. (a cura di) (2007). Giorgio Ciam. Dentro il sogno 1969-1995. Prato: Gli Ori.
Trini, T. (1973). Mattiacci. Milano: Galleria Alexander Iolas.
-
La realtà è dura, si dice. Non è una questione di “visione pessimistica del mondo”, come si potrebbe pensare di primo acchito. Piuttosto, è la semplice ‒ quasi ovvia ‒ constatazione che il nostro incontro con la realtà è sempre anche uno “scontro”, un impatto con qualcosa che ci precede e ci resiste. Metaforicamente, uno scontro con qualcosa a cui non importa nulla della nostra esistenza. Può essere un impatto traumatico o gioioso, ma si tratta pur sempre di un impatto. Ora, l'ontologia ha precisamente il compito di descrivere il reale, ciò che c'è, senza ri(con)durre la durezza del reale a elementi a esso estranei.
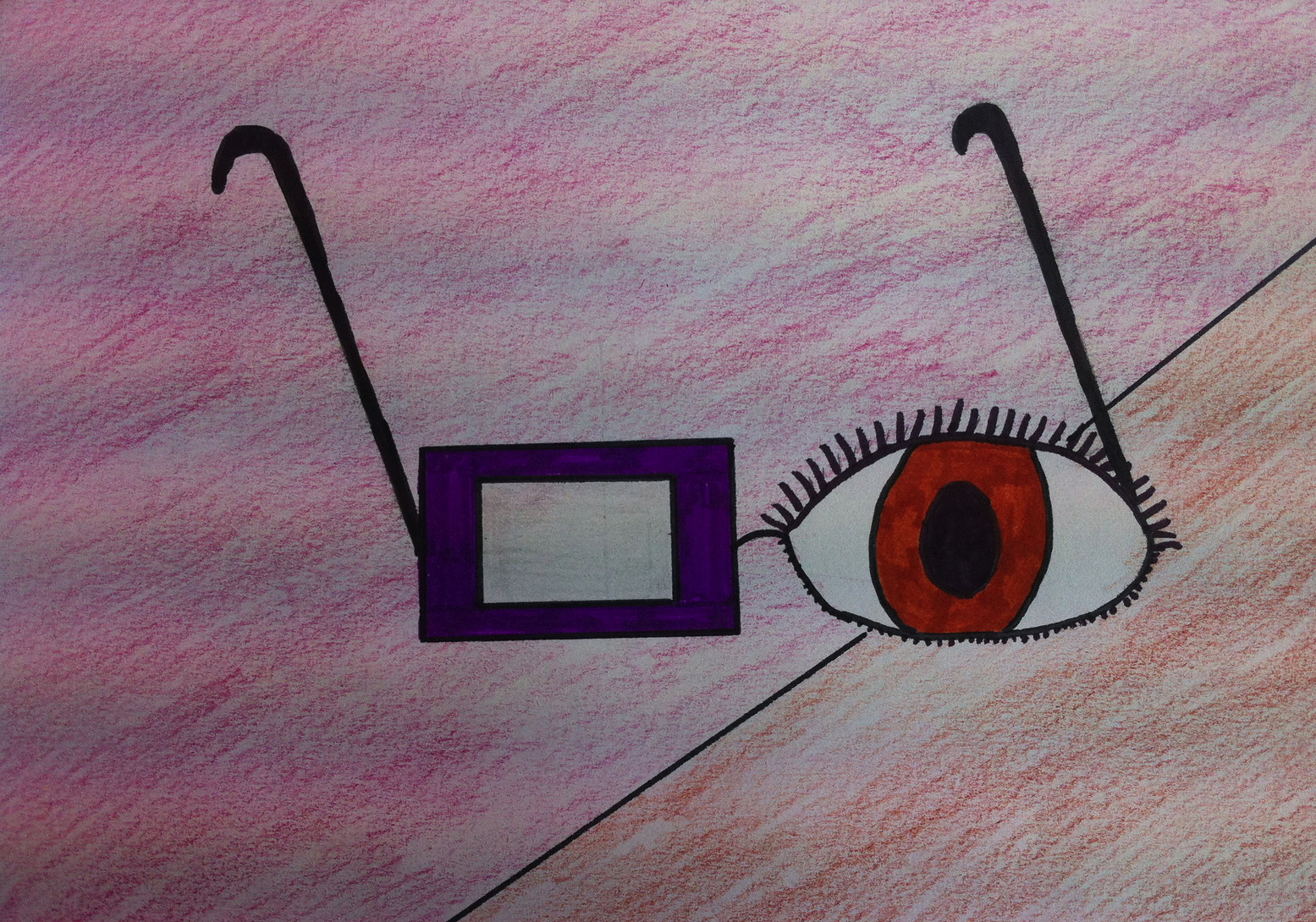
Bisogna ammetterlo: purtroppo non abbiamo alcuna priorità ontologica sugli altri enti che popolano il mondo. Il fatto che possiamo parlarne ‒ cosa che non può fare, per esempio, una sedia ‒ non significa che l'esistenza degli oggetti dipenda dal nostro pensiero. Tuttavia, il pensiero occidentale nel corso della propria storia ha messo a punto una grande varietà di strategie per attenuare, se non addirittura negare, tale impatto con la durezza del reale, con risultati non sempre felici. Tant'è che, come quasi universalmente riconosciuto, il Novecento ‒ anche sotto la spinta delle immani tragedie di cui è stato al tempo stesso protagonista e spettatore ‒ si è trovato come costretto a rimettere in questione i pilastri dell'ontologia classica e moderna. Ciononostante, tale crisi ha dato avvio, per così dire, a una grande “rinascita” dell'ontologia, tanto in ambito continentale quanto analitico. In altri termini, il dibattito contemporaneo ha visto, e vede tuttora, fiorire una pluralità di prospettive incentrate sull'ontologia e sulla sua rilevanza essenziale per una descrizione della realtà che non persegua più l'obiettivo di ridurne la durezza. Così, alle ben note critiche dell'ontologia proposte ‒ solo per citare alcuni tra gli autori più noti in Europa e oltreoceano ‒ da Nietzsche, Husserl, Heidegger, Derrida, Whitehead, Russell, Carnap e Wittgenstein, è seguito un profondo ripensamento dello statuto dell'ontologia e della sua funzione all'interno del discorso filosofico contemporaneo e ‒ si spera ‒ futuro. È dunque un fatto storico che i vari approcci critici contemporanei all'ontologia abbiano, per così dire, liberato nuovi modelli teorici in grado di fornire una molteplicità di risposte alla questione fondamentale cos'è la realtà? O, più precisamente, cosa significa affermare che qualcosa esiste o può essere detto reale?
Questo numero di Philosophy Kitchen si propone di attraversare alcuni dei maggiori indirizzi del pensiero contemporaneo ‒ tanto di ispirazione analitica quanto continentale ‒ che hanno segnato in modo indelebile la riflessione occidentale attorno alla questione dello statuto dell'ontologia. Non è un caso che il numero si apra con un incisivo contributo di Maurizio Ferraris, che sintetizza qui le ragioni essenziali del Nuovo Realismo, ormai oggetto di dibattito a livello internazionale, e della propria concezione della verità come «emergenza». Pur nella molteplicità degli approcci qui presentati, il motivo conduttore che s'impone chiaramente può essere individuato nella necessità per la filosofia ‒ di oggi ma soprattutto di domani ‒ di farsi carico seriamente della realtà e della sua infinita capacità di modellare la soggettività umana attraverso la storia. Definitivamente tramontato il mito moderno del soggetto copula mundi, si apre così lo spazio per una riconsiderazione più disincantata, ma non per questo meno impegnata, del reale in tutte le sue molteplici sfaccettature.
A cura di Claudio Tarditi
Scarica PDF
English version
DOI: https://doi.org/10.13135/2385-1945/4.2016
Pubblicato: marzo 2016
Indice
Editoriale
Claudio Tarditi - Durezza della realtà, durata dell'ontologia [PDF It]
Maurizio Ferraris - Realtà come emergenza [PDF It]
Francesca Dell'Orto - Fenomenologia trascendentale e ontologia universale [PDF It]
Mario Autieri - Husserl: per una definizione del trascendentale e delle sue implicazioni ontologiche [PDF It]
Luca Vanzago - La negatività naturale. Riflessioni sull'ontologia della carne nella filosofia di Merleau-Ponty [PDF It]
Diego D'Angelo - La carne e il tatto nel De Anima di Aristotele.Un'interpretazione fenomenologica [PDF It]
Filippo Domenicali - Il pluralismo esistenziale di Étienne Souriau. Breve introduzione alla filosofia dei modi di esistenza [PDF It]
Giacomo Foglietta - Un mondo di esperienza neutra [PDF It]
Gert-Jan van der Heiden - Hermeneutics or Mathematics. Two ways of Thinking Plurality Today [PDF En]
Michele Lubrano - Ontologie neofreghiane: le origini e gli sviluppi più recenti [PDF It]
Lorenzo Paudice - Pseudo-designazioni ed entità immaginarie in G. Ryle [PDF It]
Alfonso Di Prospero - Idealismo e realismo secondo l'ontologia del Tractatus logico-philosophicus [PDF It]