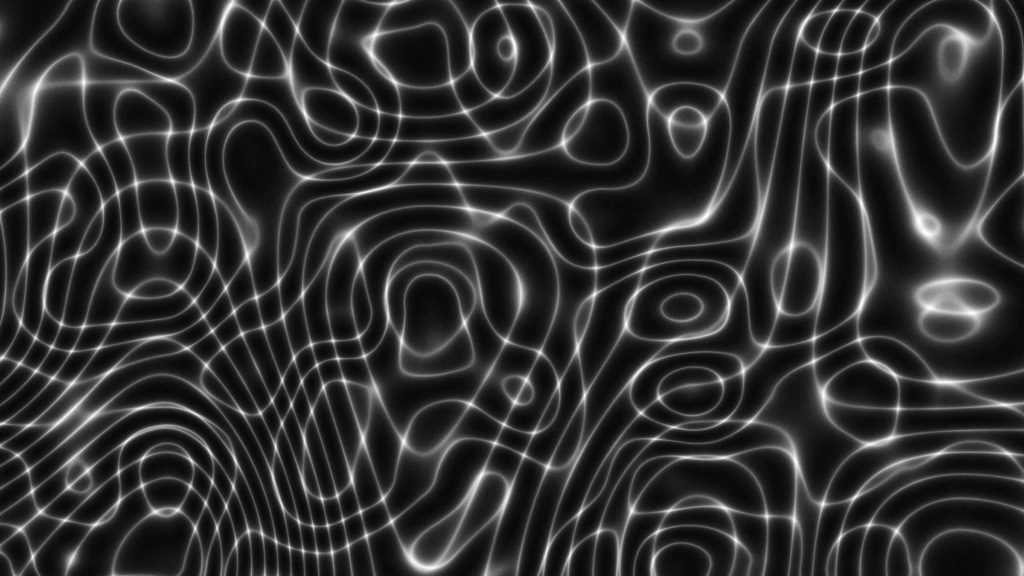Nell’estate del 1956, in quel di Hanover, in un workshop organizzato presso il Darmouth College, una gang di ricercatori, distaccandosi dalla koinè cibernetica da cui proveniva, diede vita a quel programma di ricerca ai più noto come “Intelligenza Artificiale”. Gli stessi padri fondatori non furono placidamente concordi nell’adottare la suddetta espressione. Ci furono delle resistenze e vennero avanzate delle proposte alternative (come quella di Herbert Simon: “Complex Information Processing”), ma la spuntò John McCarthy: la neonata impresa fu battezzata “Artificial Intelligence”. Visto il successo che il brand non smette di riscuotere, l’ostinazione di McCarthy ha ripagato. Se l’avesse avuta vinta Simon, probabilmente il nostro presente sarebbe un tantino diverso. Forse ci staremmo chiedendo per quale stramba ragione Spielberg ha intitolato un suo film, che vede come protagonista un bambino androide, Complex Information Processing.
Da un punto di vista di marketing, la scelta di McCarthy fu azzeccatissima. Purtroppo, a distanza di quasi settant’anni dalla nascita dell’espressione, “Intelligenza Artificiale” continua a sollevare giusto un paio di problemi, relativi (1) all’assenza di una definizione univoca e operativa di intelligenza e (2) all’assenza di una definizione univoca e operativa di artificiale. Gli ascoltatori di un podcast di successo come quello di Lex Fridman ne avranno fatto esperienza: quanti sono i ricercatori nell’ambito dell’AI, tante sembrano essere le definizioni e di intelligenza e di artificiale.
Questo lungo preambolo mi pare doveroso, dal momento che, se fossi un libraio avvezzo a catalogare la mia offerta per generi, il libro Menti Parallele. Scoprire l’intelligenza dei materiali di Laura Tripaldi, uscito sul finire del 2020 per effequ nella collana Saggi Pop, lo piazzerei, a mo’ di provocazione, nello scaffale “Intelligenza Artificiale”. La ragione è semplice: si tratta di un libro che, tra le altre cose, ci costringe a riflettere criticamente sul modo in cui comunemente vengono usati gli attributi “intelligente” e “artificiale”.

Nell’impossibilità di partire da definizioni univoche e dirimenti, Tripaldi ci invita ad andare alle cose stesse per interfacciarci con quei materiali che contribuiscono a costruire la nostra (ma è tanto nostra quanto loro) cultura materiale. Gli smart materials di cui Tripaldi parla sono tutti ascrivibili alla “galassia auto-”: auto-regolazione, auto-replicazione, auto-organizzazione, auto-assemblaggio, ecc., sono le loro principali caratteristiche. In quanto sistemi auto-, operano in maniera non eterodiretta, costituendosi tramite processi decentralizzati, diffusi, bottom-up, e dischiudendo, così facendo, particolari domini cognitivi, dunque generando le proprie forme di intelligenza. Questi materiali sono menti parallele, dove «la parola parallelo, in questo contesto, serve a sottolineare che, all’interno di queste strutture, non esiste un’organizzazione gerarchica precostituita: non c’è nessuna “cabina di comando” che dirige il comportamento delle parti e non esiste un manuale di istruzioni che indica alle singole parti componenti come organizzarsi le une rispetto alle altre» (p. 190).
Le menti parallele che abitano il libro di Tripaldi lo rendono un regno vasto, popoloso. A muoversi tra le sue pagine ci sono sete ampollose, muffe mucillaginose, e-skins, soft-robots, nanocompositi, leghe a memoria di forma, cellule artificiali, nanobots e molte altre “forme di vyta”. Tripaldi mobilita creature mitologiche e letterarie alla stregua di animali totemici per simbolizzare le proprietà delle tanti menti parallele: Aracne, Idra, Golem, Frankenstein. Sono questi gli anfitrioni che ci introducono, rispettivamente, ai primi quattro capitoli: il primo, La tela di Aracne, ha come protagoniste l’operazione di tessitura e le proprietà di rete; il secondo, Molte Teste, si concentra sui processi cognitivi in parallelo e acentrici; nel terzo, La struttura che connette, le scienze dei materiali sono inquadrate alla luce della teoria dei sistemi complessi; il quarto, Mostri viventi, tratta in maniera affatto originale diverse questioni legate all’artificial life. Il quinto e ultimo capitolo, La materia del futuro, sviluppa invece alcune conseguenze etiche, politiche ed ecologiche a partire dalla “nuova alleanza” che nei capitoli precedenti Tripaldi ci invita a stringere con il popolo dei materiali.
È giusto lasciare ai lettori il piacere di scoprire passo dopo passo le proprietà di queste menti singolari, che Tripaldi ci restituisce in maniera vivida e appassionata con una prosa cristallina, leggera, propria di chi ha affinato l’arte (difficilissima) della divulgazione. Mi preme invece porre l’attenzione su alcuni aspetti generali.
Tripaldi ha scritto un libro politico dalla prima all’ultima pagina. La posta in gioco è una ridefinizione dei collettivi i cui attori sono tanto gli umani quanto i non-umani. L’interfaccia di cui ci parla Tripaldi, il luogo materiale dell’incontro che connette (e nel farlo, trasforma) due strutture, è sempre uno spazio diplomatico. Lo stesso laboratorio assume i contorni dell’agorà, luogo di incontro e di negoziazione, zona di intra-azione (per usare il termine che Tripaldi riprende da Karen Barad) in cui le scienziate e gli scienziati operano e sono operati, stipulano contratti con attori non-umani e costruiscono mediazioni. Sebbene Tripaldi non si richiami apertamente al Bruno Latour di Non siamo mai stati moderni o all’Isabelle Stengers di Le politiche della ragione, la sua proposta mi sembra ascrivibile al solco tracciato da queste opere.
Nel suo libro Tripaldi schiera un temibilissimo tridente offensivo, che comprende la scienza dei materiali, la teoria della complessità e il post-umanesimo di matrice femminista: le scienze dei materiali ci introducono a tecnologie soft, flessibili e sensibili, reticolari e adattabili; la teoria della complessità è il vettore che ci instrada nella “galassia auto-”; il post-umanesimo femminista dischiude nuovi modi di relazione con la materialità e la tecnologia, ispirati alla sottile arte della tessitura, di contro all’immagine virile dei duri corpi che si scontrano e di una materia da piegare con la forza. L’arte della tessitura, d’altronde, potrebbe avere 90mila anni. Se questa ipotesi, che Tripaldi riprende dal lavoro dell’archeologa Elizabeth Wayland Barber, dovesse essere vera, allora l’età della pietra sarebbe già una age of network.
Il pericolo cui l’operazione di Tripaldi si espone è certamente quello di una feticizzazione della rete e della relazione. Rete diventerebbe un culto, relazione la parola magica con cui scardinare ogni “-centrismo”. La retiologia, per usare un’espressione di Pierre Musso, è in agguato dietro ogni pagina di Menti Parallele. Tripaldi disinnesca questo rischio proprio a partire dal corpo a corpo che intrattiene con i materiali, i quali presentano proprietà di cui, senza la mobilitazione del dispositivo rete, non si potrebbe rendere conto. L’insistenza sull’arte della tessitura, sull’importanza delle relazioni e del dialogo lungo le interfacce, scaturisce dalla ricerca di Tripaldi in quello spazio politico che è il laboratorio. Le filosofie cui ricorre (il summenzionato post-umanesimo di matrice femminista), i frames teorici cui si richiama (la teoria dei sistemi complessi) e le figure mitologiche e fantastiche che mobilita, diventano gli alleati con i quali l’autrice narrativizza la sua esperienza di chimica e scienziata dei materiali. La narrazione così dispiegata produce esiti interessanti: i riverberi animisti e panpsichisti sono i cascami di un neo-materialismo per il quale le differenze tra i materiali non dipendono dal carattere sostanziale dei componenti di cui sono fatti, ma dal loro tessuto relazionale. Sono i modi di relazione a generare differenti strutture e a determinare particolari funzioni. Il progettista di nuovi materiali o il novello chimico-alchimista che concretizza creature sintetiche non operano dando forma a una materia amorfa, non ricalcano uno schema ilemorfico, ma interpretano e dialogano con processi auto-organizzativi. I materiali prendono forma tramite processi bottom-up che implicano complesse reti di produzione dei componenti che li compongono. Il progettista, in questa rete, è un nodo tra i tanti e la sua azione consiste nel tradurre, mediare e dirigere (come un direttore d’orchestra) dinamiche auto-organizzative. Si dilegua l’immagine del progettista artefice che impone una forma a una materia amorfa, che dà voce a materiali muti. Che ne è dell’artificio nel dileguarsi dell’artefice? In altre parole, di cosa parliamo quando parliamo di artificiale? Ogni smart material è sicuramente il risultato di una poiesis, della quale però il principale artefice è il materiale stesso (un modo assai lasco di dire autopoiesi). Nulla si crea, tutto si trasforma: il progettista è tutt’al più l’hub di una rete che apre (o chiude) spazi di possibilità per nuove trasformazioni.
Inoltre, come abitanti della “galassia auto-”, ognuno dei materiali di cui Tripaldi ci parla produce, nella sua dinamicità, le proprie forme di intelligenza. Non si tratta di estendere la nozione comune di intelligenza (umana troppo umana, vaga troppo vaga) ai materiali, ma di trovare la radice comune di tutte le differenti menti materiali e i modi in cui questa radice si declina generando una pluralità di intelligenze (differenti modi di apprendere, adattarsi, interagire con l’ambiente, ecc.).
Quasi in conclusione al libro Tripaldi si rivolge alle tessitrici del futuro. Gli scenari propizi o nefasti dati dalla proliferazione di agenti nanotecnologici, il modo in cui verrà declinata la natura farmacologica delle nuove tecnologie (cure o veleni) dipenderanno dalle reti che saremo in grado di tessere, dai modi in cui verranno negoziati gli spazi di trasformazione e di intra-azione.
Non esistono soluzioni a buon mercato per scongiurare fin da subito i problemi che potrebbero sorgere con l’entrata in scena di nuove tecnologie. Nella penultima pagina di Menti Parallele si trova scritto: «l’unica via d’uscita dal problema della nostra relazione con la tecnologia è la via che ci passa attraverso» (p. 218). Là dove c’è il pericolo, cresce anche ciò che salva.
Se l’errore imperdonabile del dottor Frankenstein non è riconducibile alla hybris che lo porta a concretizzare una vita sintetica, ma al fatto di non averle dato l’amore di cui aveva bisogno, allora l’insegnamento principale che è possibile ricavare da Menti Parallele risiede nell’attenzione amorevole e appassionata che Tripaldi dedica ai suoi “mostri”. «L’intelligenza emerge dalle relazioni» (p. 190): tutto dipenderà dalla qualità dei fili con cui si imbastiranno i futuri orditi.
di Luca Fabbris