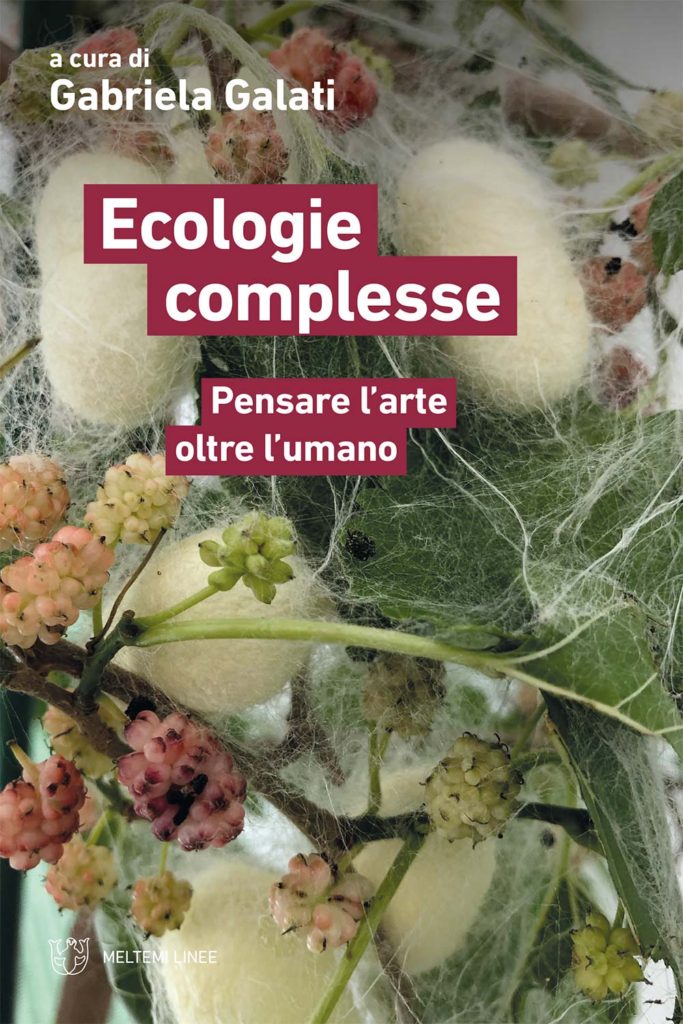-
-
Sloterdijk Suite: gestire la riduzione
Recensioni / Luglio 2023È esperienza comune tra i lettori di Sloterdijk rimanere perplessi davanti alla decina di pagine che conclude il suo capolavoro del 2009, Devi cambiare la tua vita. Dopo un lungo percorso, in pieno stile sloterdijkiano, tra i meandri della vita incentrata sull’esercizio, e dopo aver gettato uno sguardo – attraverso le lenti dell’antropotecnologia generale – sul paesaggio incredibilmente vasto delle discipline, nonché dopo aver seguito le sue linee di sviluppo interne, nell’arco che connette storicamente gli esercizi degli antichi a quelli dei moderni e al loro fallimento, ci si trova, come si suol dire, «con un pugno di mosche in mano». Tutto ciò che Sloterdijk offre, nella parte che si vorrebbe più propositiva del suo lavoro, è l’abbozzo di un’etica della co-immunità, mediante la quale soltanto l’umanità potrebbe finalmente diventare – da mero flatus vocis – un concetto politico, all’ombra inquietante della Grande Catastrofe ambientale e globale, nuovo attrattore di energie antropotecniche in grado di far risuonare ancora una volta la voce dell’imperativo metanoico assoluto e indicare così una rinnovata direzione alle tensioni verticali. Ma delle «regole monastiche» di questa macrostruttura immunitaria globale, le quali dovranno indurre a nuove secessioni e al costituirsi di una nuova civiltà antropotecnica, nulla ci viene detto se non che «vanno redatte ora o mai più» (Sloterdijk 2010, 556). Qual è dunque, viene spontaneo chiedersi, il valore pratico, concretamente applicabile – e perciò possibilmente politico – del pensiero antropotecnico sloterdijkiano?
È a questa stessa perplessità che sembra rispondere il saggio di Eleonora de Conciliis, Sloterdijk Suite. Espansione e riduzione dell’umano (Meltemi, 2023). La sua pubblicazione arricchisce il panorama della – crescente – ricezione italiana della filosofia di Sloterdijk, e lo fa con un intento teoretico ben preciso. L’obiettivo dichiarato dell’autrice, infatti, è quello di «sprofondare» dentro l’opera del filosofo di Karlsruhe, paragonata a un enorme dispositivo narrativo immersivo o anche a un’installazione di arte contemporanea à la Eliasson, piuttosto che tentare vanamente di «rincorrerlo» nel suo forsennato gettito di pubblicazioni, per adottare quello che è forse l’approccio più produttivo all’opera di un autore ancora vivente e così instancabilmente fecondo. Se Sloterdijk stesso è un raffinato parassita della tradizione filosofica – senza alcuna accezione spregiativa del termine: un parassita metodico nel senso indicato da Bonaiuti (2019) –, la cui opera è la smisurata espansione rizomatica, in ponderosi volumi qualificabili essi stessi come ospiti di questo magmatico germinare, di alcune fondamentali intuizioni poste sul finire degli anni ’90, è opportuno allora, ritiene de Conciliis, impegnarci a nostra volta a parassitarlo (2023, 22-24). Un simile gesto, quantomai lontano dal tradursi in un saggio monografico o in un’impossibile ricostruzione esaustiva delle fonti che la informano, è affine allo spirito antiaccademico e irriverente, nonché ironico – di quella quarta ironia a cui de Conciliis dedica il primo capitolo del saggio –, che anima l’opera di Sloterdijk e può tradursi nella libertà teoretica di lavorare a partire da Sloterdijk, con Sloterdijk ma anche oltre e contro Sloterdijk, mimando la postura che egli stesso ha adottato nei confronti di Heidegger (Sloterdijk 2004). Vale a dire: soffermarsi su alcuni aspetti particolari della sua riflessione, approfondirli ed espanderli, al prezzo di tralasciarne e ridurne degli altri.
Ed è proprio a partire dal nesso inscindibile tra espansione e riduzione che si muove il saggio di de Conciliis – sia a livello metodologico, per il quale ridurre Sloterdijk equivale a «disincantarsi, o meglio […] disintossicarsi dalla sua melodia» (de Conciliis 2023, 29), sia a livello teorico, ravvisando nel legame tra espansione e riduzione dell’umano una chiave fondamentale per leggere l’opera del filosofo di Karlsruhe in modo proficuo. Detto altrimenti, per allucinare mediante i potenti mezzi di quell’esercizio di riduzione espansiva che è la filosofia una strada concreta che conduca agli esercizi per il futuro, nella quale oltre a una necessaria riduzione antropotecnica di homo sapiens, si giunga anche a una riduzione autoironica del filosofo e del suo esercizio di morte apparente nel pensiero «a format di istruzioni tecniche miranti a una concreta, pragmatica rarefazione dell’umano» (2023, 46).
Come in una suite barocca, dove a un’allemanda segue un corrente e a una sarabanda una giga, de Conciliis ci conduce in un viaggio nell’alternanza tra queste «due facce di un unico movimento spazio-temporale» (2023, 51), nel quale la riduzione può essere intesa come un’inevitabile conseguenza della precedente espansione.
La ricerca si concentra infatti attorno a due assi tematici, che costituiscono poi l’ossatura del libro. Da un lato, a partire dalla sintesi di prospettiva sferologica e riflessioni sul nesso antropogenesi-antropotecnica, de Conciliis ricostruisce un affresco della mostruosa e affascinante epopea dell’espansione psico-spaziale dell’umano, permessa dall’iniziale auto-domesticazione antropotecnica. Essa dà luogo a una vera e propria pulsazione storica dal carattere immunitario: se l’uomo è tale, dentro e fuori l’utero, quale abitatore di spazi interni nei quali soltanto può prosperare, il movimento dell’antropogenesi sferica coincide con un ridursi a un «dentro» in cui ci si espande (materialmente e psichicamente) per imparare così ad avventurarsi nel «fuori». Movimento che si regge in gran parte sul quarto dei meccanismi antropogenici individuati da Sloterdijk: quello della trasposizione (Übertragung), concepibile tanto, come sottolinea de Conciliis, nei termini di un tentativo di ridurre simbolicamente il fuori al dentro, avvicinando così l’estraneo, quanto assimilabile a uno sforzo di trasferire il dentro nel fuori reale, in un gesto a tutti gli effetti ek-statico. Si tratta quindi del percorso che dall’insulazione nelle sfere animate dei gruppi umani originari – le orde – conduce all’attuale saturazione del mondo, risultato della terza globalizzazione che ha condotto la Terra a essere risucchiata in uno spazio interno del capitale (im Weltinnenraum des Kapitals), nel quale è palese «sia l’assenza di un “fuori”, che l’infestazione del “dentro”» (de Conciliis 2023, 192).
È a questa vertiginosa e ormai insostenibile espansione che consegue, sempre meno remota, la possibilità di una battuta d’arresto, di un contraccolpo violento che si darebbe nella forma di una riduzione catastrofica e incontrollata – lo spettro angosciante dell’estinzione della specie. A questo stesso fantasma si contrappone, d’altra parte, la seconda linea tematica del saggio di de Conciliis, ossia il dichiarato tentativo, a partire da Sloterdijk, di individuare un’altra forma di riduzione dell’umano che sia in grado di disinnescare le conseguenze della catastrofe ecosistemica, operando, mediante nuove e più opportune antropotecniche «una radicale riformattazione del sistema umano» (2023, 74).
Il libro di de Conciliis mostra qui quelli che sono forse, riassumendo al massimo una trattazione così ricca e concentrata, i suoi due più grandi meriti. Sfuggire, da un lato, alla retorica della catastrofe propria di un certo milieu «onto-ecologista», che vedrebbe nella riduzione violenta dell’umano l’unica via per chiudere i conti con l’Antropocene; proporre, dall’altro, a partire da Sloterdijk, una posizione politico-pedagogica radicale, che sappia condurre a una nuova antropogenesi in formato ridotto, a contrarre l’umano «in modo storicamente avvertito» (2023, 26).
Che una nuova ominazione sia possibile non è un’idea così inusitata, ma deriva da ciò che de Conciliis sottolinea magistralmente come «storicità dell’antropogenesi» (2023, 75-105), vale a dire la radicale contingenza dell’antropogenesi stessa, legata a quella forma di conservazione e superamento delle sue condizioni di possibilità (i quattro meccanismi antropogenici individuati da Sloterdijk e i loro complementi sferologici) che sono le antropotecniche. Esse, in quanto modalità psicofisiche di trasmissione intersoggettiva di pratiche «con cui i gruppi umani hanno preso “in mano” da soli la propria formazione simbolica e disciplinare» (Sloterdijk 2004, 159), possono retroagire sull’antropogenesi, espandendo o riducendo, aumentando o contraendo l’umano, nonché lo spazio e il peso eco-sistemico dello stesso. Aver posto così chiaramente l’accento sul carattere estremamente fluido e sulla delimitazione quantomai labile – contingente – del confine tra antropogenesi e antropotecniche è del resto il terzo indiscutibile merito del saggio di de Conciliis.
Tuttavia, se questa ne è la premessa teorica, come pensare in pratica, tale riduzione? Dichiarare l’equivalenza di umano e non-umano non è sufficiente, come non basta tentare di uscire dall’ontologia classica mediante una Object Oriented Ontology. Bisogna abbandonare – ridurre –, suggerisce de Conciliis, la tensione timotica e acrobatica condensata da Sloterdijk nelle «antropotecniche terziarie» (Lucci 2014), risultato della svolta antropotecnica racchiusa in Devi cambiare la tua vita, per tornare invece alle antropotecniche secondarie e al loro sviluppo omeotecnico, già circoscritte dal filosofo di Karlsruhe nei discussi interventi sul finire degli anni ’90, «come culmine storico dell’auto-domesticazione dei sapiens e passaggio a una nuova fase dell’antropogenesi» (de Conciliis 2023, 220-21). Abbandono la cui esigenza era già stata prospettata da de Conciliis (2020) in un precedente contributo.
La posta in gioco è quella di generare una nuova micro-umanità, a tal punto ridotta e resiliente da poter abitare nelle inedite condizioni dell’età neo-paleolitica prossima ventura, previa una riflessione sulla decrescita «in chiave problematicamente psicotecnica» per interrogarsi «sul modo in cui andrebbe inculcato nelle menti dei sapiens il “cambio di paradigma” auspicato dai teorici della decrescita» (2023, 74).
Si rintraccia qui il contributo più audace del saggio, che potrebbe anche essere definito un lungo commento all’esortazione sloterdijkiana a inaugurare un nuovo ciclo di secessioni «per far uscire nuovamente gli uomini, non più dal mondo, bensì dall’ottusità» (Sloterdijk 2010, 543). Se è vero infatti che la forma di civiltà scaturita dalla rivoluzione neolitica, con le sue antropotecniche inibenti, è ormai da tempo in crisi, espansa fino a scoppiare in una miriade schiumosa e instabile di bolle e di users al contempo frenetici e apatici, nonché sempre più infantili e incapaci di esplicitazione – e di critica –, la cui condizione esageratamente neotenica è esacerbata dalla digitalizzazione, intesa da de Conciliis come quinto nuovo meccanismo antropogenico, immaginare «esercizi per il futuro (per renderlo possibile, oltre che immaginabile)» (2023, 229) significa al contempo contrastare l’indebolimento psico-cognitivo della specie – correlato riduttivo dell’espansione – e ridurre le sue catastrofiche potenzialità espansive. Immaginare una riduzione, insomma, che consenta di perpetuare, attenuandone l’impronta ecologica, la fioritura psichica e tecnologica – introtopica – dell’umano, senza cadere in un «primitivismo naïf».
Ecco allora la ricetta di quella che de Conciliis definisce curiosamente – ma non troppo, se si considera il fondamentale capitolo Lusso neotenico e allomaternità, con la sua riflessione sul materno e sulle sue protesi nel contesto di una metamorfosi (post-)umana – «modifica ginotecnica dell’antropogenesi» (229): una graduale decrescita biologica che si esplichi mediante un pianificato e tutt’altro che distopico decremento demografico, unito a un incremento della resistenza psicofisica a situazioni di stress, nonché un rimpicciolimento, passante per vie pedagogiche, del verticalismo esasperato di homo sapiens. Ancora: una sdivinizzazione del web come premessa del suo uso intelligente, come nuova rete connettiva e «chiave mediale» dell’allenamento della comunità idioritmica – il richiamo è a Barthes – dei «ridotti»…l’elenco potrebbe anche continuare, e si potrebbe discutere sull’opportunità o meno dei singoli provvedimenti da adottare. Soffermandosi, per esempio, sulla domanda inaggirabile: come pensare l’esercizio – se è davvero possibile – rinunciando alla dimensione acrobatico-differenziale? Una cosa, tuttavia, è certa. Come afferma de Conciliis, se una riduzione è necessaria, essa non andrebbe certo subita, ma, al contrario, antropotecnicamente gestita.
Luca Valsecchi
Bibliografia
Bonaiuti, G. (2019). Lo spettro sfinito. Note sul parassitismo metodico di Peter Sloterdijk. Milano: Mimesis.
de Conciliis, E. (2020). Miglioramento umano? Sloterdijk e il problema della differenza. In M. Pavanini (a cura di), Lo spazio dell’umano. Saggi dopo Sloterdijk (127-152). Pompei: Kaiak.
de Conciliis, E. (2023). Sloterdijk Suite. Espansione e riduzione dell’umano. Milano: Meltemi.
Lucci, A. (2014). Un’acrobatica del pensiero. La filosofia dell’esercizio di Peter Sloterdijk. Roma: Aracne.
Sloterdijk, P. (2004). Non siamo ancora stati salvati. Saggi dopo Heidegger. Milano: Bompiani.
Sloterdijk, P. (2010). Devi cambiare la tua vita. Sull’antropotecnica. Milano: Raffaello Cortina.
-
Bernard Stiegler e la miseria simbolica
Recensioni / Aprile 2022Non c’è evoluzione tecnologica senza che, nel più profondo, avvenga una mutazione del capitalismo
G. Deleuze, Proscritto alle società di controlloPer cogliere il senso complessivo del denso lavoro di Bernard Stiegler, La miseria simbolica. L’epoca iperindustriale 1 (Meltemi, 2021) iniziamo con l’interrogare i termini che compongono il titolo dell’opera. In cosa consiste per l’autore “la miseria simbolica” che caratterizza le nostre società in quella che egli definisce l’“epoca iperindustriale?”
«La nostra epoca – scrive Stiegler – si caratterizza come presa di controllo del simbolico da parte della tecnologia industriale, laddove l’estetica è diventata al contempo l’arma e il teatro della guerra economica» (p. 25). L’effetto di un tale conflitto sugli individui è la miseria simbolica, vale a dire «la perdita di individuazione derivante a sua volta dalla perdita di partecipazione alla produzione di simboli, designanti, questi, tanto i frutti della vita intellettiva (concetti, idee, teoremi, saperi) che quelli della vita sensibile (arti, saper-fare, costumi)» (p. 38).
Come l’autore annuncia nella Prefazione, il testo va considerato come un commento al Proscritto sulle società di controllo (in Pourparler, Quodlibet, 2019) di Gilles Deleuze. In quelle poche pagine, com’è ben noto, Deleuze sostiene che le “società disciplinari” analizzate da Michel Foucault, con l’organizzazione dei grandi ambienti di internamento (famiglia, scuola, fabbrica, ospedale, carcere) che caratterizza la loro logica, e storicamente collocabili tra il XVIII e l’inizio del XX sec., siano ormai state sostituite dalle società di controllo, la cui peculiarità consiste nell’estensione, nell’intensificazione e nella complessificazione della logica dei processi distintivi della rivoluzione industriale applicati anche alla sfera simbolica del desiderio. Nell’attuale forma di capitalismo, che Stiegler definisce con Jeremy Rifkin «culturale» (p. 83), la dimensione estetica – qui intesa in senso ampio come dimensione del sentire in generale, e nella quale soltanto è possibile costituire un “io” e un “noi” a partire da un pathos comune – viene sistematicamente presa nelle maglie del calcolo, il cui dominio, anche grazie al recente processo di digitalizzazione, si è esteso ormai ben al di là della sfera della produzione, «nella integralità dei dispositivi caratteristici di ciò che Simondon chiama l’individuazione psichica e collettiva» (p. 82).
Nell’epoca iperindustriale la legge del capitale non è più la produzione, ma «il marketing in quanto controllo dei tempi di coscienza e dei corpi attraverso la macchinazione della vita quotidiana» (p. 83), così come il luogo paradigmatico non è più la fabbrica, ma l’impresa. L’iperindustrializzazione – è questa la tesi di Stiegler – ha dunque un riscontro paradossale: da un lato fa apparire una nuova immagine dell’individuo, il consumatore, dall’altro la generalizzazione del calcolo impedisce, o quantomeno ostacola fortemente, il processo di individuazione stesso che, solo, rende l’individuo possibile.
Del saggio deleuziano, Stiegler non condivide soltanto l’analisi insieme storica e logica relativa all’insediamento progressivo di un nuovo regime di dominazione, quello, cioè, caratteristico delle società di controllo, e che comporta una notevole perdita di individuazione, vale a dire la miseria simbolica, ma fa pienamente suo, se così possiamo esprimerci, anche lo spirito politico battagliero, che anima quelle pagine e che ben si esprime in queste parole, che lo stesso Stiegler cita: «Non è il caso né di avere paura né di sperare, bisogna cercare nuove armi» (Deleuze, 2019, p. 235). Come ben specifica Rosella Corda nell’Introduzione, il lavoro di Stiegler non si limita infatti «alla costatazione sterile o alla rassegnazione diagnostica», ma si pone l’obiettivo di trovare, «proprio in questo disperare, mancare di speranza, un po’ di possibile» (Stiegler, 2021, p. 9)
La questione delle armi, come esplicitamente afferma l’autore, è la «questione della tecnica in generale» – ovvero la questione cardine su cui ruota tutta l’opera di Stiegler fin dal suo primo lavoro La technique et le temps 1. La faute d’Épimethée, –, la quale è anche questione del politico, questione, cioè, «del destino di un noi» (Stiegler 2021, p. 38). La questione della tèchne, che, ricordiamolo, per Stiegler è un pharmakon, vale a dire insieme veleno e antidoto, si articola qui nell’ipotesi di un’organologia generale, la quale si pone l’obiettivo di indagare, dal punto di vista di una prospettiva antropologico-filosofica, la genesi del processo di ominazione. La domanda a cui l’organologia risponde è dunque una domanda sulla seconda natura dell’uomo, vale a dire sulla natura “originariamente” protesica, e cioè tecnica, dell’uomo. Un’adeguata interrogazione della secondarietà che contraddistingue l’umano rappresenta una condizione senza la quale non è possibile comprendere l’epoca attuale e la sua miseria simbolica, né risulta possibile – ed è questo ciò che più conta per Stiegler – indicare delle vie alternative a tale stato di miseria.
Il progetto di un’organologia generale prevede lo studio congiunto di quelle che Stiegler considera le «tre grandi organizzazioni che formano la potenza estetica dell’uomo: il suo corpo con la sua organizzazione fisiologica, i suoi organi artificiali (tecniche, oggetti, utensili, strumenti, opere d’arte) e le sue organizzazioni sociali che risultano dalla articolazione degli artefatti e dei corpi (pp. 31-32)». Il concetto chiave su cui l’autore costruisce tale progetto è il concetto di ritenzione terziaria, il quale, a differenza dei concetti di ritenzione primaria e di ritenzione secondaria con i quali Husserl indicava rispettivamente la dimensione della percezione e la dimensione dell’immaginazione, indica la dimensione artificiale della produzione da parte dell’uomo di oggetti di memoria esteriorizzata, come ad es. lo smartphone, i libri, gli edifici, le targhe commemorative, i film.
Nel terzo capitolo del libro “Allegoria del formicaio. La perdita di individuazione nell’epoca iperindustriale”, Stiegler ricostruisce per tappe storiche il processo di produzione delle ritenzioni terziarie, che egli chiama epifilogenesi. «L’ambiente epifilogenetico – scrive l’autore – come insieme delle ritenzioni terziarie costituisce il supporto dell’ambiente preindividuale permettendo l’individuazione del genere» (p. 89). Essendo l’epifilogensi il «deposito di memoria che è specifico di una forma di vita unica, quella del genere umano» (p. 66), ed essendo la natura dell’uomo già da sempre tecnica, la storia dell’epifilogenesi segna le tappe dell’individuazione dell’uomo, in particolare dell’uomo occidentale. Senza poter approfondire i vari passaggi che caratterizzano questa storia, che è anche la storia di una lotta per la definizione delle criteriologie dei dispositivi ritenzionali («processo di grammatizzazione», p. 90), ci preme mettere in luce il fatto che secondo Stiegler questo processo ha raggiunto un punto limite nell’epoca iperindustriale. Il processo di individuazione rischia cioè di annullarsi in favore di una «ipersincronizzazione» (p. 96) – ben resa dall’allegoria del formicaio – in cui la differenza tra “io” e “noi” collassa nel “si”, ovvero in quella condizione che Stiegler chiama anche di «mal-essere» (p. 98), tale per cui gli individui, non avendo più accesso alla produzione di simboli, perdono la loro singolarità e la correlata possibilità di proiettarsi in un “noi” e, dunque, in una dimensione politica. Privati di singolarità, gli individui cercano di singolarizzarsi mediante gli artefatti che il mercato mette loro a disposizione, il quale sfrutta la miseria propria del consumo stesso, e così facendo fanno esperienza del loro fallimento: «non si amano più e si rivelano sempre meno capaci di amare» (p. 99).
Concediamoci ora una considerazione generale sul senso dell’opera di un autore come Stiegler. Se ci soffermassimo soltanto sul lato diagnostico, sulla pars destruens del suo discorso correremmo il rischio di eludere l’aspetto più rilevante dello sforzo intellettuale – e non solo – dell’opera e della vita di Stiegler, il quale riguarda l’impegno con cui l’autore ha da sempre tentato di rispondere alla domanda: “che fare?”. Se infatti considerassimo solo l’aspetto analitico della sua opera, finiremmo per giudicare Stiegler, come pure è stato fatto soprattutto dopo la pubblicazione de La società automatica. 1. L’avvenire del lavoro (Meltemi, 2019), un autore catastrofista. Per quanto la situazione diagnosticata dall’autore sia effettivamente catastrofica, Stiegler, come si è detto, non cede nemmeno per un attimo al catastrofismo. È questo un punto battuto da tutti i curatori delle edizioni italiane recenti delle opere di Stiegler, sulla cui insistenza, potremmo dire, Meltemi ha costruito la cifra peculiare della sua operazione editoriale, che ha portato alla pubblicazione dei due volumi sulla miseria simbolica (Stiegler, 2021; La miseria simbolica. 2. La catastrofe del sentire) e a quello sulla società automatica (Stiegler, 2019) nella serie “Culture radicali” diretta da Gruppo Ippolita.
Come scrive Giuseppe Allegri in un articolo online su OPERAVIVA dal titolo Dentro, oltre e contro la società automatica, «il ricercare e l’agire di Stiegler si oppone radicalmente a qualsiasi visione apocalittica che altri rintracciano nel suo pensiero, del tutto inspiegabilmente e proprio leggendo il volume sulla Società automatica, mentre la postura del Nostro è anche e soprattutto quella progettuale e sperimentale, per la promozione e il sostegno di collettivi di ricerca che coinvolgano e che già coinvolgono ampi spezzoni di società, associazionismo di base e frammenti di classe dirigente, disposti ad accettare e orientare la trasformazione tecno-digitale e socio-economica nel senso di un ripensamento radicale delle categorie e delle pratiche sociali per maggiore autodeterminazione, dignità, felicità in favore dei molti» (https://operavivamagazine.org/dentro-oltre-e-contro-la-societa-automatica/). Lo stesso Allegri, autore della postfazione al testo qui recensito, e significativamente titolata Ricchezza delle pratiche inventive, fa un lungo elenco delle attività che hanno impegnato Stiegler dalla fine degli anni Novanta fino alla sua scomparsa nell’agosto del 2020, e che lo hanno coinvolto nella fondazione di «nuove istituzioni», quali, tra le molte altre, citiamo Ars Industrialis, «la cui “ragione sociale” è quella di un’associazione europea per una politica industriale delle tecnologie dello spirito», o «IRI – Institute pour la Recherche et l’Innovation presso il Centre Pompidou, all’interno del quale è riuscito a promuovere una rete di Digital Studies inaugurata nel 2012»,o che lo hanno visto collaborare al «progetto avviato nel maggio 2016 di Territoire Apprenant Contributif, che coinvolge i 9 comuni di Paris Nord/Seine-Saint-Denis» (pp. 160-161).
Specificamente per quel che riguarda La miseria simbolica 1. L’epoca iperindustriale, in tutte le pagine che compongono i quattro capitoli del libro, finanche nei punti in cui la disperazione emerge in maniera più forte, e, anzi, soprattutto lì, la domanda sul “che fare?” e la ricerca continua di quella che con una bella espressione Stiegler definisce l’«energia zoppicante della chance» (p. 124) non scompaiono mai dall’orizzonte. In particolare, si ha un riscontro evidente dell’insistenza con cui Stiegler si spende per “cercare nuove armi” nell’analisi dei due film On connaît la chanson di Alain Resnais e Tiresia di Bertrand Bonello, che egli conduce rispettivamente nel secondo (Come se ci mancassimo o di come trovare delle armi a partire da Parole parole parole… (On connaît la chanson) di Alain Resnais”) e nel quarto capitolo (“Tiresia e la guerra del tempo. A proposito di un film di Bertrand Bonello”) del testo.
Nel film di Resnais il nostro autore trova esemplarmente tracciata, nel modo in cui il regista compone e scompone cliché attraverso l’utilizzo della tecnica del sampling e più specificamente attraverso la ripetizione ventriloqua che i personaggi si trovano a fare dei ritornelli di alcune famosissime canzoni francesi, la via «per una nuova capacità di immaginare/sentire» (p. 15), che prenda le mosse proprio da quel processo che fa scomparire la differenza tra “io” e “noi” nel “si”, ma tentando di invertirne la direzione.
di Gian Marco Galasso
-
Che la teoria sia sede di conflitti, anche aspri, esiziali e ultimativi, tanto da trascinare con sé e pregiudicare in profondità l’obiettività (presunta) dei contendenti, è cosa nota da almeno duecento anni a questa parte (da Hegel in poi). Che il sapere, allo stesso modo, configuri un’occasione per la riproduzione di sistemi di dominio di varia natura, facendosi spesso occasione di esclusione, marginalizzazione e oppressione, anche questo è diventato ormai un truismo della teoria critica contemporanea, informata come è, persino quando non lo dichiara apertamente, da marxismo, freudismo e nietzschianesimo (i quali hanno fatto nello scorso secolo il loro lavoro di decisiva persuasione). Che questa consapevolezza diffusa e diversamente articolata vada poi trasformata in una pratica pedagogica alternativa, incentrata sulla funzione guaritrice della teoria, è invece cosa ben meno scontata e largamente disattesa, nei fatti, da coloro che coltivano e insegnano discipline teoriche in ambito umanistico. Ora, è di questa esigenza, elevata a principio euristico cardinale, che si fa portatore Insegnare a trasgredire. L’educazione come pratica della libertà di bell hooks, recentemente pubblicato in italiano da Meltemi (2020, 18 euro). Il volume, tradotto da feminoska, nota attivista transfemminista nostrana, prefato da Rahel Sereke e Mackda Ghebremariam Tesfaù, anche loro attiviste della blackness italiana, e seguito da un breve intervento del Gruppo Ippolita, che dirige la collana di Culture radicali in cui è apparso, si segnala innanzitutto per il tono, caratteristico della scrittura saggistica dell’autrice, lontano anni luce dagli stilemi e dai tic della ricerca accademica standard. Al secolo Gloria Jean Watkins, l’autrice, femminista africano-americana, è infatti la rappresentante forse più esemplare di un orientamento della ricerca contemporanea che incentra la propria operatività sull’«enfasi sulla voce» (p. 183) personale e che concepisce, di conseguenza, la «teoria come pratica sociale dal valore libertario» (p. 99). Partendo dalla constatazione di una discrasia fondamentale tra pratica e teoria che affligge il pensiero occidentale, riflessa oggigiorno nell’introduzione nei programmi educativi di argomenti progressisti a cui non fa seguito tuttavia un adeguato mutamento del processo pedagogico, bell hooks discute infatti in maniera dettagliata il modo in cui ogni soggetto, e anzi, meglio: ogni corpo, è sempre implicato in un vissuto che lo colloca necessariamente da una certa parte della barricata, con buona pace di quell’universalità del sapere che è spesso null’altro che il nome attribuito al posizionamento dell’uomo bianco occidentale eterosessuale.
Il libro è articolato in saggi, i quali procedono in maniera concentrica intorno a uno stesso perno: dare spazio, letteralmente e metaforicamente, a coloro che un certo regime di verità – quello, appunto, dei saperi accademici – ha espulso con certosina meticolosità dal novero dei soggetti autorizzati a far risuonare la propria esperienza, i soggetti supposti non sapere. Il piano autobiografico diventa così terreno di verifica sperimentale della proposta di bell hooks, fondata come è sulla rivendicazione di un «accesso significativo alla verità» (p. 61) per tutti/e coloro ai quali e alle quali esso è stato in qualche modo negato. Il racconto della propria formazione prima nelle scuole nere degli anni Sessanta, dove «l’apprendimento e la vita della mente» erano «un atto contro-egemonico, un gesto fondamentale di resistenza alle strategie di colonizzazione razzista bianca» (p. 32), poi nelle scuole desegregate, dove al contrario «improvvisamente, la conoscenza riguardava solo l’informazione» (p. 33), così come la sua esperienza diretta di insegnante, dapprima nelle università private e poi in quelle statali, diventa perciò il filo conduttore di un’inchiesta sulla necessità di abbandonare la concezione «depositaria dell’educazione» in favore di una pratica dell’istruzione in cui «la volontà di sapere» va sempre a braccetto con «la volontà di diventare» (p. 51). Di diventare che cosa? La risposta è netta: capaci di vivere più intensamente la propria esistenza perché, infine, più liberi/e. Il nome di questa pratica, «pedagogia impegnata», va allora inteso nel suo duplice senso: impegnata nei temi e nelle forme, sul piano dell’enunciato ma anche, ancora più significativamente, sul piano dell’enunciazione, dell’insieme dei presupposti pragmatici grazie ai quali parlare non è mai un atto neutro, un semplice comunicare contenuti cognitivi resecati dal resto della vita delle persone, ma sempre anche un atteggiarsi concretamente rispetto alle costellazioni di poteri che informano ogni società. La «narrativa confessionale» e la «discussione digressiva» diventano allora, nel concreto della scrittura come dell’insegnamento, lo strumento principale di tematizzazione della propria condizione, ciò mediante cui «rivendicare una forma di conoscenza» (p. 183) di cui tutti e tutte, studenti e studentesse compresi, possono parlare, sentendosi autorizzati a farlo. D’altronde, ne va di una messa in mora della stessa logica dicotomica che organizza le nostre società, in cui sembra si debba sempre sacrificare qualcosa per accedere al potere che le diverse istituzioni (educative, economiche, politiche ecc.) consentono di beneficiare a chi ne fa parte: «questo processo [l’essere partecipanti attivi nel percorso pedagogico] non è semplice: ci vuole coraggio per abbracciare una visione di completezza dell’essere che non rafforza la narrazione capitalista che suggerisce, invece, che sia sempre necessario rinunciare a qualcosa per ottenerne un’altra» (p. 217).

bell hooks Ecco allora che uno dei meriti di bell hooks consiste nella capacità di mettere sistematicamente in tensione due aspetti, la razza e il genere, i quali si intersecano spesso, anche all’interno degli ambienti femministi, secondo geometrie tutt’altro che invariabili. Come racconta ampiamente la studiosa, questa linea di frattura interna al campo femminista ha determinato in passato una esclusione programmatica dell’esperienza femminile nera, che, con le sue peculiarità, di razza e di classe, non risponde al tipo della femminista bianca, spesso proveniente da contesti economici e culturali privilegiati. «Eravamo prima donne o nere?» (p. 158), si chiede allora sintomaticamente bell hooks, dando un contributo imprescindibile anche alla «decostruzione della donna come categoria analitica», alla critica dell’«esperienza della donna universalizzata» (p. 124). Il suo invito è dunque a parlare di genere in modo più complesso, tenendo conto della doppia emarginazione, da parte delle femministe bianche e del patriarcato nero, di cui sono state vittime le donne nere (e di colore in generale) nel momento in cui hanno, anche a livello accademico, rivendicato il proprio punto di vista. Scritto in una forma quasi diaristica, Insegnare a trasgredire conduce perciò il lettore in una sorta di progressiva coscientizzazione – termine che la scrittrice riprende dalla pedagogia libertaria di Paulo Freire, vero e proprio punto di riferimento della sua riflessione – concernente il proprio posizionamento nei riguardi del sapere, costringendo chi scrive a chiedersi in che misura possa essere titolato a esprimersi su un libro simile, senza arrogarsi al contempo un diritto di parola che non muove, almeno di primo acchito, da un’esperienza in prima persona analoga a quella evocata dall’Autrice.
Il percorso, pacato e graduale, verso l’acquisizione di un’evidenza che, nel suo carattere meta-teorico, sembra sospendere la vigenza delle prerogative e dei privilegi del discorso universitario, richiede dunque di essere attentamente valutato e meditato, a scanso degli equivoci che potrebbe in prima istanza ingenerare. Nella misura in cui enuncia che ogni teoria risponde sempre anche a un’esigenza singolare, calata nel vivo di un’esistenza materiata, e che non c’è punto di vista universale che non sia comunque anche particolare – che il soggetto del sapere, in altre parole, è sempre un soggetto orientato, incapace di ergersi una volta per tutte al di là di se stesso, per valutare in modo neutrale il punto di vista dell’altro – sembrerebbe, banalmente, autorizzare una forma di relativismo generale sub specie subalternitatis. Al rischio di auto-confutazione che una simile enunciazione comporta, in quanto essa stessa teorica, l’Autrice oppone però un punto fermo invalicabile, che sembra riecheggiare, senza citarlo (almeno in queste pagine), il celebre motto foucaltiano sul sapere – il quale non sarebbe fatto per comprendere, ma per prendere posizione. Con un fondamentale distinguo, però, che anche il “comprendere” – pratica pedagogica se mai ce n’è stata una – è una delle forme del prendere posizione e, per certi versi, la forma per eccellenza con cui ci si atteggia praticamente nel reale, per modificarlo, modificando la propria stessa esistenza (aspetto sul quale, ipotizziamo, il Foucault più tardo, quello dell’estetica dell’esistenza, avrebbe convenuto). Contro quindi chi ritiene che l’alternativa tra pratica e teoria sia inaggirabile, come quella tra verità ed esperienza, e che si tratti, riprendendo la tesi marxiana, di interpretare o di trasformare il mondo, disgiuntivamente, la teoria è presentata da bell hooks come un «luogo di guarigione» (p. 95) a tutti gli effetti: come, in breve, «forma di azione» (p. 99), innanzitutto su se stessi e poi, inevitabilmente, anche sul circostante. Solo un teorico privilegiato, rappresentante del patriarcato capitalista e colonialista bianco, può credere infatti che la teoria sia senza effetti immediati e che vada dunque coltivata a riparo da perturbazioni pragmatiche ed esperienziali d’ogni sorta, con l’esclusione, naturalmente, di quelle che contribuiscono inavvertite alla riproduzione del sistema di dominio vigente. «Penso che uno dei disagi inespressi relativi al modo in cui il discorso su razza e genere, classe e pratica sessuale ha portato scompiglio nell’accademia è proprio la sfida a quella divisione tra mente e corpo. Chi è potente ha il privilegio di negare il proprio corpo» (p. 172). Senza nulla togliere, perciò, al valore più-che-personale del sapere (al suo portato, appunto, in senso proprio scientifico: vale a dire, intersoggettivo e transculturale), dato anzi esattamente dal suo sprofondare nelle proprie condizioni ‘carnali’ di possibilità, bell hooks ci invita a tenere sempre conto della situazionalità in cui ogni atto teorico è fattivamente inserito, senza far finta che se ne possa fare tranquillamente a meno, come si trattasse di scorie da eliminare il prima possibile, perché per il resto non fanno che inquinare (inquietare) la trasparenza cristallina della ragione. La ragione militante – e ogni ragione in un certo senso lo è, anche senza saperlo – è tanto più lucida quanto più si fonda consapevolmente sulle proprie radici auto-biografiche, quanto più espone, nel corpo della sua articolazione logico-concettuale, i segni dell’oppressione che tenta proprio per ciò di scardinare, facendoli diventare il punto di partenza di una vera e propria «comunità di apprendimento». È qui che, credo, anche l’esperienza di un o una non marginalizzato/a, almeno a prima vista, può trovare non solo di che imparare, il che è ovvio e auspicabile, ma anche di che entrare in risonanza, per reperirsi sul limite della propria esperienza di soggetto di sapere che è spesso, nondimeno, soggetto alsapere altrui. Se ci si incunea negli interstizi della propria esistenza in cui si è sperimentato (e chi, in qualche modo, non l’ha fatto?) una qualche forma di esclusione dettata dalla propria appartenenza, anche temporanea, a una categoria non egemonica, la necessità di partire dal sé, per raggiungere il prossimo, diventa inaggirabile. Come discenti, d’altro canto, abbiamo tutti attraversato quella situazione specifica in cui il sapere sembra provenire immancabilmente dall’Alt(r)o, da una fonte esterna sulla quale non si ha il minimo controllo e dalla quale, in ultima istanza, ci si sente sempre giudicati/e. È come operatori di conoscenza che, in primis, si è costretti a riconoscere che il sapere non è un’operazione priva di attriti concreti, a cui ciascuno/a accede sempre da una posizione di relativa marginalizzazione e la cui costruzione avviene però davvero soltanto nello spazio tra le persone, tra i corpi, tra le esperienze, anche le più negative.

Kara Walker L’evidenza al cospetto della quale ci conduce hooks è dunque la seguente: non c’è teoria in ambito umanistico che non si radichi in un vissuto singolare, senza con ciò erodere tutta la sua eventuale portata veritativa; non c’è concetto che non abbia la sua scaturigine in un affetto situato, che non sia enunciato dalla bocca o esca dalla penna di una persona in carne e ossa, promanando così da un io concreto, incistandosi sempre in una materia viva, senziente, desiderante e, quando è il caso, persino dolente, senza per questo diventare l’incarnazione di una prospettiva solamente idiosincratica, privata, collettivamente inaccessibile. Anzi, è il dolore – quel dolore che un ‘malato’ come Ottiero Ottieri definiva «il problema filosofico più serio» – a essere l’elemento che articola il pensiero all’esistenza, che congiunge il logos al pathos e viceversa: che lega insomma la Ragione, con la maiuscola a capolettera, al corpo (alle ragioni, al plurale, dei corpi), rendendola appunto frequentabile anche dal prossimo e al suo bagaglio di esperienze singolarizzate. Rendendola vera, in un senso al contempo epistemico ed etico. Ecco la consapevolezza di cui una pratica del sapere informata a criteri di unilaterale ‘scientificità’ vorrebbe fare piazza pulita, in quanto ritenuta incompatibile con il ‘rigore’ altrimenti esigito dalla teoria, e della quale sono innanzitutto i cosiddetti “subalterni” a essere i depositari. È nei comportamenti degli ‘anormali’, per usare una categoria di vaga eco foucaultiana, che fa capolino, in modo senz’altro urticante ma indiscutibile, l’implicatura necessaria che ogni atteggiamento epistemico intrattiene con quanto, faute de mieux, si può chiamare la prospettiva in prima persona. Sono loro i tenutari del sapere di secondo livello, e invero di ultimo livello, concernente il radicamento storico e carnale del sapere, l’unico in grado di estrapolarsi dalle proprie condizioni di emersione e di additare se stesso, restando vero. Come scrive bell hooks: «Sono giunta alla teoria attraverso la sofferenza: il dolore dentro di me era così intenso che non potevo più sopportarlo. Sono arrivata alla teoria disperata, bisognosa di comprendere – comprendere cosa stesse accadendo intorno a me e nel mio intimo. Più di ogni altra cosa, desideravo che il dolore sparisse. La teoria ha rappresentato per me un luogo di guarigione» (p. 93). Esiste insomma un sapere, minoritario per definizione, che concerne la centralità inaggirabile del dolore, un sapere che riguarda la necessaria implicatura (uso un termine della pragmatica non a caso) soggettiva della conoscenza, quale che sia la sua forma, per quanto possa essa presentarsi in una veste intenzionalmente avalutativa, neutrale: in una parola, “scientifica”. E questo per un motivo molto semplice: donne, soggetti razzializzati, persone neuro-atipiche, trasgressori della norma eterosessuale, sfruttati d’ogni tipo, malati in generale, coloro che, in un modo o nell’altro, sono considerati innanzitutto come oggetti, prima ancora che come soggetti, e il cui corpo o comportamento non sono mai del tutto invisibili, non possono mai, in forza di quello che subiscono, prescindere dalla loro situazione concreta, segnata invariabilmente da un certo coefficiente di sofferenza. L’invisibilità – come il silenzio degli organi per la salute – è infatti un privilegio dei ‘normali’: l’incorporeo è il prodotto di un modo di esistenza che non conosce (troppi) limiti. «La cancellazione del corpo incoraggia a pensare che stiamo ascoltando fatti neutrali e oggettivi, fatti che non sono legati a chi condivide le informazioni. Siamo invitati a insegnare come se le nozioni non emergessero dai nostri corpi. È significativo che quelli di noi che cercano di criticare i pregiudizi in classe sono stati costretti a tornare al corpo per parlare di noi stessi come soggetti nella storia. Siamo tutti soggetti nella storia. Dobbiamo tornare allo stato di esseri incarnati per decostruire il modo in cui il potere viene tradizionalmente utilizzato in classe, negando la soggettività ad alcuni gruppi ed accordandola ad altri. Riconoscendo la soggettività e i limiti dell’identità, interrompiamo quell’oggettivazione che è così necessaria in una cultura del dominio» (p. 174).
All’alternativa secca di verità ed esperienza, e alla «svalutazione paternalistica» (p. 122) della seconda, bisogna opporre dunque, seguendo bell hooks, la consapevolezza che la verità ultima dell’esperienza (personale) consiste in un'esperienza (interminata e collettiva) di verità: in un apprendimento «senza limiti» (p. 235) in cui pratica e teoria convergono senza mai arrivare a suturarsi definitivamente l’una all’altra, restando aperte a nuovi contributi, sempre. In cui il limite – incontrato ed esperito proprio malgrado – gioca insomma la funzione di ostacolo e di rilancio, al contempo: «anche desiderare è un modo di conoscere» (p. 126). Non si tratta quindi di cedere a forme autoconsolatorie di whisful thinking, ma, si potrebbe dire, di rintracciare nel desiderio stesso una forma di sapere imperniata sulla sua capacità di eccedersi di continuo, nel confronto con la diversità e la difficoltà. Di superare insomma ogni status quo, anche epistemologico, in vista della sua riformulazione condivisa, grazie al pungolo del dolore, di cui una teoria estranea alla vita vorrebbe rimuovere toto cælo la presenza, rinchiudendo ciascuno e ciascuna in se stesso/a, e del quale invece una pratica libertaria dell’educazione non può non tenere conto, per farne il proprio atout fondamentale, risolvendolo nell’esperienza comune dell’imparare. Qui habet aures audiendi, audiat…
di Daniele Poccia