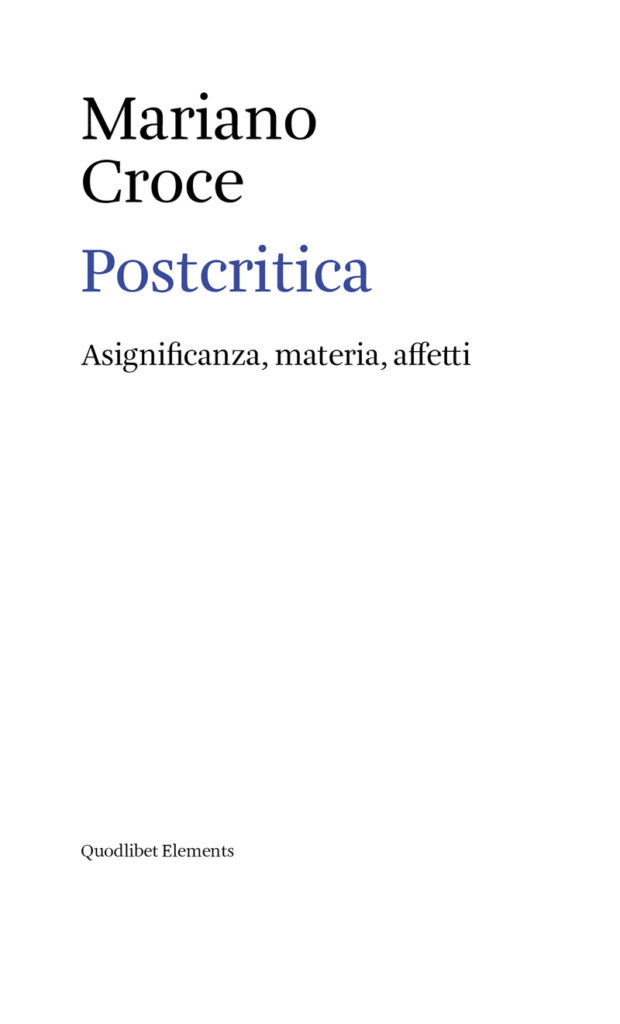Nel testo di recente pubblicazione per Quodlibet, Postcritica. Asignificanza, materia e affetti, Mariano Croce si inserisce nel dibattito contemporaneo sul tema della postcritica, ambito trandisciplinare degli studi umanistici, che coinvolge non solo la riflessione filosofica, ma anche l’antropologia, la sociologia, la critica letteraria, la linguistica e i cultural studies. Il termine postcritica fu coniato negli anni Cinquanta da Michael Polanyi, scienziato e filosofo; esso designa una posizione teorica che si propone di andare oltre l’orientamento della filosofia critica, il cui paradigma epistemico coincide con la ricerca di un rapporto obiettivo con la realtà e più nello specifico con la lettura, possibile solo nella misura in cui si utilizzano le lenti del dubbio e dell’epoché, scavando nelle profondità occulte e nascoste del reale e dei testi. La postcritica supera quest’esigenza “paranoide” che culmina nella cosiddetta “ermeneutica del sospetto”, presentandosi piuttosto come un’attitudine di incontro con il mondo e la lettura, che ne metta in luce gli aspetti fenomenologici, estetici ed affettivi. Come nota Eve Kosofsky Sedgwick in Paranoid Reading and Reparative Reading, uno dei testi fondativi della postcritica: «il sospetto guarda solo al generale, ai grandi apparati nascosti e affoga il singolare, le relazioni locali, contingenti in un episteme che ritiene onnicomprensiva» Sedgwick, 2003, pp. 123-151). Allo stesso modo per Rita Felksi, Elizabeth S. Anker, Bruno Latour o Laurent de Sutter, esponenti di spicco del movimento postcritico, gli strumenti critici “hanno esaurito il loro vapore”, secondo un’incisiva espressione di Latour (Latour, 2004, p. 225), lasciando il posto ad una diversa immagine della lettura e della nostra interazione con la realtà. Per gli autori sopracitati in quest’ottica non c’è nulla da indagare oltre e al di sotto degli a/effetti che il mondo e l’esperienza dell’incontro con i testi producono.
ll libro di Croce si presenta come un contributo originale rispetto alla letteratura del campo nella misura in cui offre al lettore tre nuovi strumenti concettuali per fare postcritica. Attraverso le nozioni di asignificanza e materia, nonché tramite una specificazione del concetto di affetto, l’autore segue infatti un percorso logico-argomentativo che porta a definire lo spazio pratico, poietico e vitale della postcritica. Essa si mostra come un esercizio, un movimento o un’attitudine. Scrive Croce: «vorrei poter dare un senso di ciò che la postcritica fa anziché ciò che dice. Il mio dire sarà quindi un mezzo per fare postcritica» (p. 7).
Il primo capitolo del testo si apre tramite una riflessione da parte dell’autore sul concetto di asignificanza, tesa a dimostrare l’importanza di un ripensamento dell’idea di matrice logocentrica in base alla quale la realtà risulta accessibile solo nei suoi effetti epifenomenici linguistici e nelle sue trame segniche. Croce sostituisce a questa visione l’ipotesi di una fuoriuscita dal regime della significazione, per approdare ad «un linguaggio asignificatorio che tracci connessioni e crei legami tra le cose, anziché imporre loro un significato» (p. 20). Per l’autore la fascinazione profondamente antropocentrica per il significante si correla all’esigenza di un apparato critico, dal portato normativo. Criticare, seguendo l’etimo greco di krino, è infatti sempre sinonimo di creare confini rigidi, stabilendo crinali non oltrepassabili e giudizi che sanciscono limiti monolitici. Se tutto è significazione, parola, linguaggio e non si dà nulla oltre un fitto reticolo segnico, resta tuttavia un’esigenza quasi paradossale ed ossessiva (e ad avviso dell’autore nociva), di scavare al di sotto del logos per scorgere «una realtà più profonda, tacita, opaca, sede di meccanismi più pervasivi» (p. 14). Così l’ostinazione per il segno, (che si configura come una necessità imprescindibile di denominare e circoscrivere tramite la parola oggetti, vissuti ecc.), si coniuga ad un’attitudine critica, tesa a decrittare le verità che la significanza di fatto occulta e rende opache. Viene dunque esplorata l’ipotesi di un contatto con gli “effetti di superficie” che l’asignificanza produce, in contrapposizione all’inabissamento nelle profondità che avviene ad opera della critica. Croce, sulla scia di Deleuze, Latour e De Landa, definisce i presupposti teorici di un’“ontologia piatta” e immanente, un piano di consistenza orizzontale dove la vera profondità coincide con la superficie e gli oggetti non sono nient’altro che gli a/effetti che essi producono. Il processo di significazione perde quindi la primazia di unica condizione dell’esperienza, dando spazio alla realtà minuta degli interstizi topografici del non-linguistico. Ad avviso dell’autore tra lingua e topografia intercorre una distanza radicale: fuori dal linguaggio ci sono luoghi, tragitti e relazioni da mappare. La topografia del non-linguistico è letteralmente nella sua radice etimologica (“topos”, luogo e “graphein”, scrivere), una “scrittura di luoghi”, una cartografia delle relazioni e delle connessioni che gli enti intrattengono, al di là dei confini della parola. Da questo punto di vista, se il logos de-limita una zona sostanziale propriamente umana, l’affetto invece, presentandosi come un possesso non eminentemente antropocentrico e personalistico, attraversa gli enti secondo una direttrice transpecifica e transfrontaliera, eccedendoli e precedendoli in un senso non trascendente, ma topologico e trans-individuale. L’affetto intrattiene un rapporto stretto con l’impersonale e l’anonimo, è un tramite, un vettore di scambio che intesse mediazioni connettive e disgiuntive. L’affettività è quindi un costrutto topografico, che elude il perimetro del linguaggio, nella misura in cui veicola relazioni e congiunzioni. Per sfuggire alla trappola del segno occorre in definitiva collocarsi in un regime affettivo ed asignificante, non negando in toto la funzione del linguaggio, ma facendo breccia fra i suoi intervalli, fendendolo, balbettandolo e «piegandolo ad usi non significativi» (p. 21).
Il secondo capitolo del libro è dedicato ad un itinerario attraverso varie figure letterarie che “scrivono il movimento puro” (p.49): dai romanzi di Alain Robbe-Grillet, basati su un passaggio da un uso denotativo del linguaggio al linguaggio delle cose stesse, passando per le significazioni “tentacolari” di Giorgio Manganelli, per arrivare agli esercizi di stile di Raymond Quenau, Croce traccia una cartografia di una letteratura minore, dall’eco deleuziana. Il riferimento più affascinante contenuto nel testo tuttavia è forse quello dei romanzi di Clarice Lispector, che mettono in scena, in alleanza con Spinoza, una vera e propria poetica degli affetti e del movimento. È la stessa scrittura a divenire, a prendere forma in segni che più che di voci hanno i caratteri di gesti e vibrazioni: dire significa tracciare linee, unendo enti, situazioni e cose. Per Lispector usare la parola non comporta nessuna rinuncia alla componente materica del reale nella misura in cui attraverso di essa non si dice ciò che accade, ma si producono eventi. Gli autori citati rappresentano per Croce esempi di scrittura postcritica poiché “dissodano il linguaggio” (p. 38), scoprendo nuove alleanze tra le parole e l’esperienza, dando voce alle cose stesse, nella loro relazionalità. Ciò ad avviso dell’autore è possibile grazie all’utilizzo di procedure poetiche e narrative, quali figure retoriche come omoteleuti, onomatopee, lipogrammi etc. (nella fattispecie in Quenau) che disarticolano il linguaggio, frammentandolo e moltiplicandolo, orientandolo verso l’asignificanza, tramite enunciati che implicano l’evocazione di realtà materiche (aptiche, visive, gustative, nel caso di Lispector) o ancora, ad esempio, attraverso le “inerzie iperdescrittive” (p. 38) di Robbe-Grillet. Lo spazio che l’autore ritaglia alla letteratura è di ausilio nel definire una filosofia composta da relazioni, movimenti e flussi. Come nota Deleuze: «scrivere è una questione di divenire, sempre incompiuto, sempre in fieri» (Deleuze, 1993, p. 13). La letteratura permette inoltre di soffermarsi ulteriormente sul tema dell’asignificanza, sondandone i meccanismi e gli effetti.

Nel terzo capitolo, dedicato alle operazioni della materia, l’autore mette a tema, sulla falsariga di Karen Barad, (una delle più rilevanti teoriche femministe dei “nuovi materialismi”), la nozione di intra-azione e di agentività, ampliando il suo intento di definire nuovi strumenti concettuali per esercitare la postcritica. Per Croce, lettore di Barad, l’intra-azione si presenta come l’assenza di una preesistenza dei termini sulle relazioni. Barad sostituisce al concetto di inter-azione, da intendersi come l’entrare in rapporto di termini (di individuazione, nella fattispecie) già stabiliti, la nozione di intra-azione, che implica il costituirsi dei termini in seno a dei rapporti e non al di fuori di essi. La materia si presenta cioè come uno snodo reticolare, come un dinamismo processuale e genetico; essa ospita relazioni che producono intra-attivamente termini (Barad 2017). Nell’universo della materialità-flusso, simultaneamente psichica e somatica, i termini non vengono prima delle relazioni, ma ne sono gli “effetti di superficie” (p. 9) e le increspature: essi si presentano come delle agglutinazioni sempre revocabili e in divenire. L’individuazione è in questo senso una composizione, una sezione intra-attiva della materia che la delimita in maniera aperta senza mai circoscriverla definitivamente. Per Croce: «l’individuazione prende corpo sul piano o superficie in cui le cose si compongono, scompongono e ricompongono» (p. 66). Il ricco vocabolario di Croce, intessuto di suggestioni icastiche e immagini evocative, ci dice sicuramente qualcosa del tentativo filosofico e argomentativo dell’autore: la parola si piega al non-linguistico, facendosi strada attraverso l’asignificanza, cercando di restituire “blocchi di sensazioni ed affetti”, per usare dei termini deleuziani. Dopo aver definito il concetto di intra-azione, Croce riflette sulla nozione di agentività, offrendo un percorso logico teso a mostrare come le due nozioni contribuiscono a ridefinire lo spazio di un “nuovo materialismo”. L’agentività, in questo senso non va intesa (nel senso classico socio-cognitivo) come la capacità di agire attivamente e trasformativamente di un singolo soggetto né tanto meno come un attributo che si predica di un individuo isolato, quanto piuttosto come l’energia emergente di un campo di forze metastabile e materiale, che esorbita i confini dell’Io. Croce prende a prestito dal pensiero di Gilbert Simondon il concetto di metastabilità. Per sistema metastabile quest’ultimo intende un campo di forze né stabile né instabile, sospeso in uno stato di equilibrio ricco di potenziali, che si conserva fintantoché non viene fornito allo stesso un quantitativo di energia che ne perturbi l’omeostasi. Punto d’arrivo della riflessione di Croce in questo capitolo è l’idea che l’attività agentiva ed intra-attiva della materia si presenti come un dinamismo di forze pre-personale, pre-individuale e metastabile in continua riconfigurazione, trasformativa ed affettiva.
Nell’ultimo capitolo del testo Croce mostra come gli incontri fra gli enti rispondano a dinamiche energetiche di “chemiotassi affettive”. L’autore mutua il concetto di chemiotassi dalla biologia, dove per il termine si intendono i fenomeni con cui organismi multicellulari o unicellulari direzionano i loro movimenti, a seconda della presenza di alcune sostanze chimiche. L’intento di Croce è quello di delineare (seguendo contemporaneamente la riflessione di Spinoza sulle affezioni e gli affetti) una mappatura degli incontri, nocivi o vantaggiosi, che compiamo giornalmente. “Taxis”, dal greco, è disposizione, relazionalità, ma anche allo stesso tempo, schieramento o contrappunto. L’Etica di Spinoza, nella fattispecie nella lettura che ne offre Deleuze, per Mariano Croce, si riferisce in fondo a situazioni minute e circostanziate, a grattacapi, malesseri o incontri favorevoli che accrescono la nostra potenza di agire: «un buon caffè come un amore, determinano un passaggio dello stato di potenza» (p. 79), così come, al contrario, se «ho preso un caffè in un brutto posto con una persona triste» (p. 66) non posso che intristirmi, facendomi attraversare da forze che agiscono a detrimento della mia potenza. Affettare ed essere affetti è dunque una scienza delle composizioni, “un’alchimia” delle connessioni, non antropocentrica, ma orizzontale: «che si tratti di un libro, di una pianta, di un minerale, di un individuo, di un gruppo di individui, di una comunità - si forma un’alchimia affettiva che elimina qualsiasi pretesa di distanza e neutralità» (p. 24). La dimensione affettiva della realtà materica implica dunque un concetto di ontologia che ospiti fra le sue pieghe un nuovo lessico, composto da termini aperti e smarginati, che rispecchino l’operatività energetica e sempre diveniente dell’essere metastabile. Per Croce connettori, reagenti, tensori, torsori, vettori (e,e,e…) abitano il piano di immanenza, popolandolo di molteplicità, intensità e variazioni.
In definitiva l’autore presenta la necessità di risemantizzare i termini tradizionali dell’ermeneutica, ridisegnandone i confini: al segno corrisponde il dominio dell’asignificante, all’atteggiamento interpretativo una collocazione affettiva, mentre la materialità orizzontale sostituisce le profondità di un atteggiamento critico. È in quest’ottica e da questo vertice osservativo che occorre attraversare il testo di Croce, misurandosi con una lettura che sia anch’essa affettiva, seguendo in ciò Deleuze, per il quale è necessario restituire «un’immagine pratico-affettiva della lettura, trasversale e non intellettualistica» (Deleuze e Guattari, 1972, p. 156). L’auspicio è dunque che l’impatto con il testo si configuri esso stesso come un’ermeneutica dell’incontro.
di Silvia Zanelli