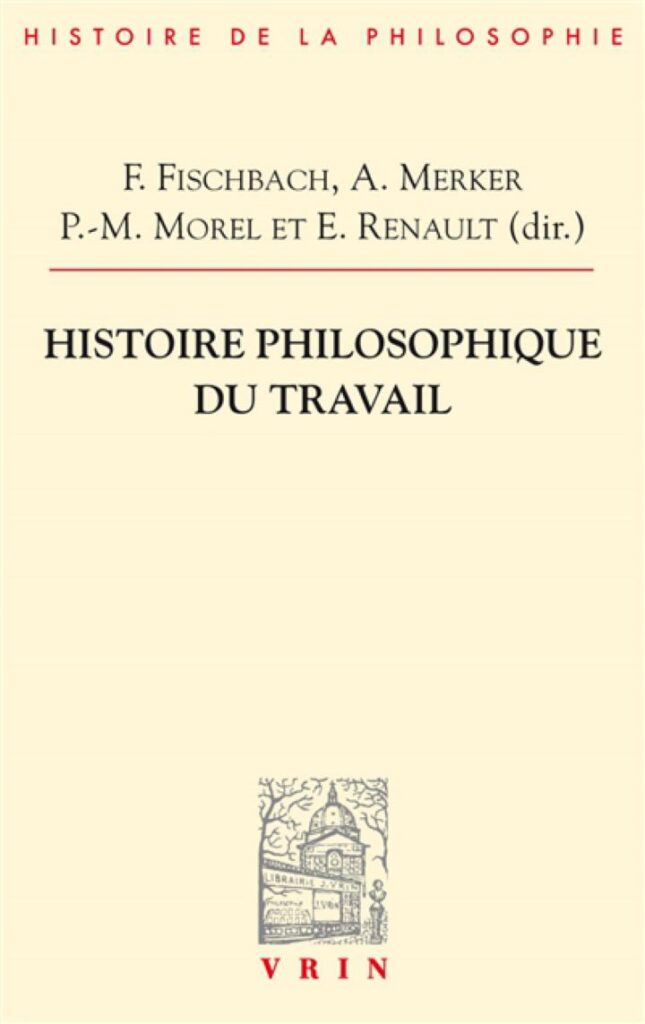1. marxismo
Molti intellettuali non solo italiani – in particolare i filosofi - anche quando hanno preso direzioni di pensiero distanti dal marxismo, poi, quando devono valutare il mondo politico, sociale, economico… di oggi, spesso guardano a tutto ciò sempre con occhiali marxisti. Parlo di persone insospettabili - fenomenologi, storici dell’arte, filosofi della scienza, teologi. Costoro di solito guardano e giudicano le cose dell’oggi secondo categorie marxiste. In particolare, per l’intellettuale non-economista, soprattutto se lavora in campo umanistico, leggere il mondo economico in chiave marxista è parte della propria fisionomia di uomo o donna colta. E siccome da tempo non leggo la vita storica ed economica secondo griglie marxiste, mi chiedo spesso se io sia ancora un intellectuel. Userò il termine francese. Il marxismo è economia per umanisti non per economisti, e c’è da chiedersi perché.
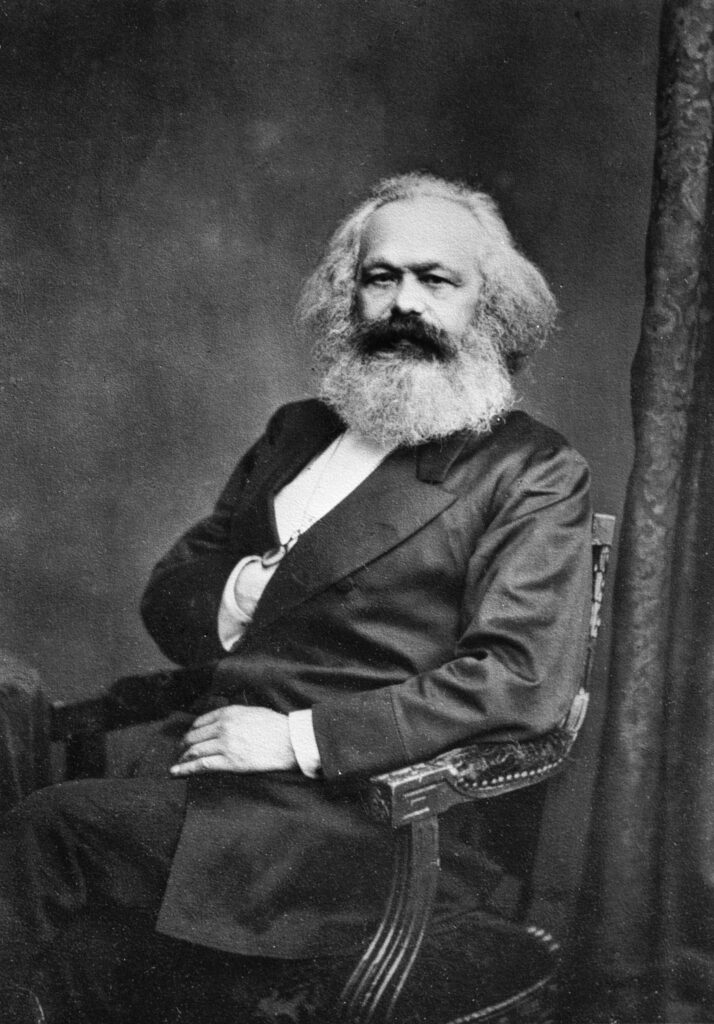
Con “chiave marxista” mi riferisco a una certa reattività alle cose della società che riassumerei così:
In politica conta la lotta di emancipazione di tutti coloro che sono in una posizione subalterna o assoggettata ad altri.
Quasi tutti i mali sociali vengono oggi dall’assetto capitalistico delle nostre società.
L’intellettuale si batte al fianco di tutti i diseredati e il suo spirito è essenzialmente anarchico. La società del futuro dovrà essere una società anti-gerarchica, libertaria.
Questo è il sostanziale atto di fede dell’intellectuel di oggi.
Tutto ciò implica l’assunto che il marxismo, in particolare Il Capitale di Marx, sia la descrizione in sostanza definitiva della società moderna, anche odierna. I grandi problemi economici e geo-politici di oggi vengono interpretati sulla falsariga marxista del funzionamento del capitalismo. Talvolta, si ammette l’aggiunta rinfrescante del “borghese” Keynes, nella misura in cui preconizzava l’intervento dello stato nell’economia. Da un secolo e mezzo a questa parte, Marx sta a questi intellectuels così come la Bibbia sta agli Ebrei. Le idee di Marx non vengono mai messe in questione. Per esempio, la tesi secondo cui il lavoro è ad un tempo una merce e ciò che dà valore alle merci è stato ripreso tante e tante volte, anche in sistemi di pensiero che si rifanno a paradigmi diversi. Ma penso che il Grund marxista sia piuttosto una sabbia mobile.
Eppure oggi nemmeno gli economisti considerati più a sinistra – come A. Sen, J. Stiglitz, P. Krugman – applicano criteri marxisti alle loro analisi, ma si rifanno all’economia successiva a quella “classica”. Marx appartiene, con Smith Malthus e Ricardo, all’economia detta classica[1].
2.
Un filosofo teoretico molto prestigioso tiene una lezione sul terzo libro del Capitale di Marx. La svolge in chiave filosofica. E si sofferma sui punti in cui Marx afferma che la ricchezza finanziaria funziona secondo una logica interna (che diremmo speculativa) del tutto sciolta dal valore economico, il quale valore – disse Marx – è dato dal lavoro vivo. La prima alienazione capitalista - ce ne sono altre - è quella per cui il danaro produce danaro e perde quindi contatto con ciò che dà senso e valore al danaro, il lavoro.
Il filosofo teoretico dice di aver investito una somma in banca: ha versato 100 e dopo un anno se ne ritrova 120. “Come è possibile che i soldi siano aumentati? Hanno fatto all’amore?” I soldi producono soldi perché la rappresentazione si aliena da ciò che rappresenta e si riproduce da sé. E cosa avrebbe pensato se invece, dopo una stagione di orso azionario, si fosse ritrovato con soli 80 euro? Avrebbe pensato che la banca lo ha derubato?
Eppure ogni economista sa che la banca non ha operato alcuna magia, semplicemente ha investito in modo avveduto i 100 iniziali. Cerca di investire su attività che, sui tempi lunghi, si riveleranno produttive, ovvero, che producano ricchezza. Attraverso la banca, il professore ha finanziato attività fruttuose, anche se, ovviamente, tra l’investimento iniziale e il guadagno finale c’è tempo per attività speculative, ovvero per la possibilità di fare denaro a partire dal danaro. Ma le speculazioni prima o poi mostrano la corda, portano a crolli in borsa, fallimenti di banche… Le grandi crisi – come quelle del 1929 e del 2008 – nascono come crisi finanziarie (e non, come credono tanti, per sovrapproduzione industriale) quando cioè il mercato finanziario si scolla troppo dalle basi produttive.
In genere gli intellectuels detestano i commercianti. Costoro risultano più odiosi degli industriali. Il fatto che il panettiere si prenda 20 in più rispetto ai 100 da lui spesi per comprare il pane fresco dal forno viene visto come l’imposizione di una gabella, dato che il filone di pane è rimasto nel frattempo identico. Questo è effetto del pregiudizio che chiamerei produttivista: che il vero valore di una merce è quello del prodotto così come esce dalle mani del suo produttore diretto. Il resto sarebbe parassitismo. Eppure il panettiere all’angolo di strada svolge una funzione distributiva molto utile. Se ogni giorno io dovessi andare alle 6 di mattina dal fornaio per comprare il mio pezzo di pane, questo risulterebbe molto più costoso per me in termini di tempo e di soldi. Il panettiere non è un grassatore, svolge un servizio. Questo servizio va remunerato.
Ma la questione di fondo è: che cosa fa sì che qualcosa valga 100? Quel che conta nel valore matematizzato non è la cifra assoluta, ma la differenza numerica rispetto a tutti gli altri valori. In effetti, il problema di Marx e degli economisti che lo avevano preceduto era questo: che cosa determina il valore economico di una qualsiasi merce? La risposta di Marx fu la teoria del valore-lavoro. Ovvero, il vero valore di una merce è dato dal lavoro vivo in esso contenuto. Ma allora, se quel che dà valore è il lavoro, che cosa remunera l’imprenditore, il datore di lavoro? Risponde Marx: il plusvalore, ovvero la parte non pagata all’operaio. Per Marx non la proprietà, ma il profitto imprenditoriale, è un furto.
Cosa lo aveva portato a questa conclusione?
3.
La teoria del valore-lavoro era già stata formulata da David Ricardo. Era un ebreo arricchitosi come agente di cambio e che poi aveva vissuto da gentiluomo di campagna. Vide chiaramente che il valore economico è dato dallo scambio e non dall’uso, eppure avanzò la teoria secondo cui il valore di scambio dei beni è regolato dal lavoro in esso incorporato. Ricardo cita Adam Smith: “È naturale che ciò che è normalmente il prodotto di due giorni o di due ore di lavoro debba valere il doppio di ciò che è normalmente il prodotto del lavoro di un giorno o di un’ora”[2]. Questa idea oggi ci appare bizzarra. Se i lavoratori di una fabbrica ci mettono un giorno solo per produrre mille pantaloni alla moda mentre quelli di un’altra fabbrica mettono due giorni per produrre mille pantaloni ma non più alla moda – ammettendo identica la loro produttività - vedremo che i mille della prima fabbrica saranno molto più costosi di quelli della seconda. Evidentemente Ricardo non teneva conto di un fattore che per noi oggi è fondamentale: la variabilità della domanda, ovvero, in parole povere, delle mode.
Ricardo è l’inventore della terribile legge bronzea dei salari. Secondo lui il salario aveva la funzione di assicurare la sussistenza fisica del lavoratore e la sua riproduzione, senza aumenti né diminuzioni. Insomma, chi viveva del proprio lavoro sarebbe rimasto sempre povero e nulla, né uno stato compassionevole né un forte sindacato, avrebbe potuto modificare quel destino. Va detto che per “povertà” Ricardo intendeva non la semplice sussistenza biologica ma anche “le comodità divenute essenziali per abitudine” (un Ricardo di oggi vi inserirebbe anche il possesso di un computer, di un frigorifero, di una utilitaria…). Inoltre lo sviluppo dell’economia avrebbe potuto spingere verso l’alto il “prezzo naturale del lavoro” anche per periodi prolungati. Comunque, la conclusione più immediata era l’ineluttabilità della miseria di chi lavora in una società capitalista: la legge economica che ne è alla base non può essere cambiata. Miele per le orecchie di Herr Marx.
Quel che restava comunque inspiegato nel sistema ricardiano era il profitto industriale. Se il valore di un prodotto è dato dal costo del lavoro richiesto per produrlo nella condizione marginale (ovvero al minor costo possibile), allora da dove vien fuori la remunerazione del capitale, il profitto di chi ha investito? Ricardo risponde: viene sempre dal lavoro. Viene dal lavoro passato necessario per costruire gli stabilimenti e il macchinario (captale fisso) e per acquistare beni capitali (capitale circolante o d’esercizio). Il profitto sarebbe allora il pagamento posticipato di questo lavoro passato.
Se i profitti corrispondono alla remunerazione del lavoro impiegato in passato nella formazione del capitale, allora la conclusione ad alcuni apparve ovvia: l’investitore si appropria di una ricchezza che a rigore appartiene all’operaio. Il guadagno dell’imprenditore è del tutto ingiusto. Una conclusione del genere poteva essere evitata rigettando la teoria del valore-lavoro e la legge bronzea dei salari di Ricardo come inadeguata. Marx non la rigettò, la prese alla lettera: il profitto, che chiamò plusvalore, era la parte non pagata all’operaio.
Certamente Marx non divenne comunista leggendo Ricardo, piuttosto usò le teorie economiche di punta del proprio tempo per dare un fondamento “di testa” al proprio comunismo “di cuore”. Come per i teologi: prima viene la fede, poi viene la ragione che la giustifica. Chi è mai divenuto un credente a seguito di una impeccabile dimostrazione dell’esistenza di dio? Secondo me nessuno. La teoria – in questo caso economica – è una pezza d’appoggio intellettuale alla propria passione religiosa o politica. Marx ebbe il genio di stabilire un ponte tra fede comunista e la scienza economica dell’epoca sfruttando certe carenze interne al sistema esplicativo di Ricardo. marxismo
Joseph Schumpeter[3] sosterrà poi che la linea Ricardo-Marx nel pensiero economico è rimasta sempre, in fondo, un ramo secondario. La teoria del lavoro-valore e l’ingiustificabilità del profitto non è mai stata veramente presa sul serio dagli economisti successivi. Il valore è stato sempre visto come dipendente dal gioco della domanda e dell’offerta, non come espressione di un lavoro “trascendente”. Ma la teoria del lavoro-valore è stata sempre presa molto sul serio, per circa due secoli, dagli intellectuels.
4.
Allora, perché qualcuno come Marx ha creduto nella teoria del lavoro-valore a cui di fatto non ha mai creduto nessuno? Perché quella teoria gli faceva troppo comodo. Innanzitutto questa teoria permette di quantificare, e quindi di obiettivare, la denuncia di sfruttamento. In effetti, riconoscersi come sfruttato è atto più che mai soggettivo. A che punto comincia lo sfruttamento? Quando per un lavoro ricevo 200, o 150, o 100…? Anche se sono una star strapagata posso dire che sono sfruttato perché pagano troppo poco le mie esibizioni rispetto a qualche altra star. Grazie all’escamotage del plusvalore, credo allora di misurare lo sfruttamento con precisione: è il profitto dell’imprenditore. Punto. La lotta per avere salari più alti e condizioni di lavoro migliori diviene allora “scientifica”. Dalla mera compassione per l’operaio si passa a chiedere giustizia per lui su una base obiettiva.
Soprattutto, la teoria del valore-lavoro ci fa credere che quello che dovrebbe essere – che più lavori, più ha valore quello che produci – è nel fondo ciò che è. In effetti, tendiamo a trovare ingiusto che chi lavori tanto guadagni meno di chi lavora poco. Il fatto che per un’ora di lavoro una domestica prenda 12 euro mentre un luminare della medicina in un’ora ne guadagni 500 ci dà un senso d’ingiustizia. L’ingiustizia risulta da un nostro presupposto, che tutti siamo eguali, come afferma l’etica cristiana. Ma è fattualmente vero che siamo eguali?
Conoscevo un artista che non ebbe mai molto successo. Una volta mi indicò la sua ultima creazione, una scultura, dicendo “Ci ho lavorato per otto mesi giorno e notte… e poi nessuno la vuole comprare!” Lo diceva col tono di chi subiva un sopruso. Ma l’ingiustizia è inscritta nella vita stessa. Così ci suona terribilmente ingiusto che un bambino nasca deforme o malato, e che resti così per tutta la vita. Non l’ha meritato. In questo caso però non ce la possiamo prendere con l’assetto perverso dell’ordine sociale, ma piuttosto con la malvagità di dio o della natura.
La strategia tacita di Marx consiste nel dire che in fondo la realtà (l’essere) è giusta, che davvero il lavoro dà valore alle cose prodotte, ma è la società a distorcere la realtà. La società falsifica la natura. Il dover-essere (Sollen) viene celebrato come verità dell’essere (Sein). Sarebbe la società umana a introdurre un’ingiustizia che nella realtà non si dà. Discende dall’argomentazione di Rousseau, quando, per esempio, sosteneva contro Voltaire che il terremoto di Lisbona, in quanto naturale, non poteva essere “cattivo”. Erano le case costruite a Lisbona quelle cattive[4].
Ora, la teoria secondo la quale il Sein e il Sollen nel fondo coincidono - ciò che è vero è anche giusto, e l’ingiusto è sempre falso, un abuso - è profondamente consolatoria. È una forma di teologia laicizzata. Per il pensiero cristiano dio è sempre buono e giusto, anche se viviamo in un mondo strapieno di malvagità e di ingiustizia. Secoli di talento teologico sono stati spesi per dimostrare che il mondo creato da dio è pur sempre il migliore dei mondi possibili, ed è l’essere umano a introdurre il male nel mondo. Nel XIX° secolo al posto di dio si è messa natura (Natura sive Deus), per cui l’antropologia marxista ha voluto dimostrare che la realtà è buona e giusta, e che il male e l’ingiustizia sono prodotti della perversità umana.
Abbiamo visto questa visione emergere in occasione della recente pandemia di Coronavirus. Tanti filosofi hanno dato per certo che questa epidemia fosse del tutto diversa dalle altre del passato, perché era una epidemia scatenata dall’uomo. Ciò fa parte di un riflesso ereditato dal rousseauismo-marxismo: anche la mutazione di un virus, cosa vecchia come il mondo, deve essere messa sul conto della perversità della società industriale. Non si accetta la monotonia di natura, che se la ride della potenza umana e produce nuovi virus nocivi come faceva millenni fa. Anche se certo la grande mobilità umana ha accelerato e ampliato la circolazione dei virus. I virus circolano molto più velocemente in popolazioni di animali numerose e molto mobili. Il marxismo, per il quale il vero essere è sempre giusto e buono, si è insomma sostituito al cristianesimo nel dire che l’ingiustizia cosmica non esiste, e che noi umani, con un po’ di buona volontà, restituiremo alla realtà il suo onore. Come nella concezione cattolica, sono gli umani, col libero arbitrio, a introdurre il male nel mondo.
Eppure questa promozione immensa della volontà umana – l’essere umano può ripristinare la giustizia nel mondo – ha come condizione la denuncia dell’umanità come causa prima artefice del male. Da Rousseau fino a Žižek, questa è la storia del mondo post-cristiano. Che solo gli umani possono restituire al mondo quella giustizia che essi stessi gli hanno tolto. L’umanità sarà la salvatrice del mondo (anche naturale) proprio perché è stato lei a introdurre il Male nel mondo.

5.
In che modo invece gli economisti, liberisti e anti-liberisti, vedono oggi il valore economico? Secondo me, già Aristotele aveva detto l’essenziale sullo scambio economico: in realtà di tutto si può fare scambio: esso trae la prima origine da un fatto naturale, che cioè gli uomini hanno di alcune cose più del necessario, di altre meno[5]. Si scambia sempre un eccedente con qualcosa che si desidera. Non importa perché si desideri questa o quell’altra cosa, l’importante è che si desideri qualcosa. Alla fonte dello scambio economico non c’è il lavoro, c’è il desiderio. In particolare, il desiderio di qualcosa che ci manca. È quel che genera la demand, domanda. (Questo non toglie che l’offerta, supply, possa creare nuove domande. Se invento il viagra, mettiamo, e lo offro sul mercato, il desiderio di erezione creerà un demand di viagra.)
Ovviamente, se voglio scambiare devo produrre questo eccedente – a meno che io non lo possieda già come patrimonio acquisito. La produzione di questo eccedente ha un costo per me, e quindi il prezzo finale del mio prodotto dovrà includere i costi di produzione, tra cui il costo del lavoro mio o di altri. Se sono io il lavoratore, il costo sarà il tempo e l’energia da me spesi per produrre quel prodotto. Ma molte cose hanno un valore economico che non dipende affatto dal lavoro impiegato per produrle.
Mettiamo il caso che io abbia ereditato un casale contadino costruito nel XV° secolo. Mi rendo conto oggi che quel casale si trova in un contesto che consideriamo “incantevole”, e quella regione è divenuta alla moda. Potrò affittare a prezzi altissimi quel casale a chi voglia fare turismo, e così diverrò benestante. Sfrutto il lavoro di coloro che costruirono quel casale sei secoli fa? Non ha senso. Rendo redditizio quel casale perché è molto desiderato oggi. Approfitto dell’altrui desiderio.
Avere danaro è avere quindi sempre un eccedente. Anche un poveraccio che possegga solo dieci euro, ha un eccedente di dieci euro. Per una ragione semplice: che quei dieci euro non può usarli direttamente come oggetto per soddisfarsi, gli servono solo per lo scambio. Certo, potrebbe sempre usare quella banconota come fazzoletto di carta, mettiamo. Ma negli ultimi tempi il danaro si è del tutto smaterializzato, e un numerino sul computer non posso usarlo affatto, nemmeno soffiarmici il naso.
È stupefacente: solo oggi, grazie alla completa smaterializzazione del danaro, abbiamo finalmente compreso – anche intellettualmente e non solo praticamente – che il danaro sin dai primordi è stato sempre e solo questo: numeri. Eppure l’invenzione di una moneta di scambio è precocissima, si è passati ben presto dal baratto all’uso di monete, fossero queste conchiglie, penne, ecc. La moneta è sempre la rappresentazione di una ragione di scambio[6].
Immaginiamo un mercato primitivo in cui due patate si scambiano con quattro mele o con dieci pesche. Abbiamo già una precisa ragione di scambio. Ovvero, se diamo a una patata il valore arbitrario di 10 - mettiamo: conchiglie - possiamo dire che in questo mercato:
1 patata = 10 conchiglie; 1 mela = 5 conchiglie; 1 pesca = 2 conchiglie
Possiamo materializzare questi numeri anche con banconote, ma il loro senso resta sempre lo stesso: sono equazioni. Per cui, se metto a, b e c al posto rispettivo di patate, mele e pesche, avremo:
a = 2 b = 5 c oppure c = b / 2 = a / 5
Banali equazioni.
Alla base dello scambio c’è il desiderio per ciò di cui manco. Se ho due patate in più che non mangerò mai e sono privo di pesche che invece desidero gustare, so che devo dar via una mia patata eccedente per avere cinque pesche. Tutte le complessità dei mercati internazionali di oggi sono una enorme complicazione di questa logica semplicissima che è alla base di ogni economia.
Marx considerava il danaro una merce imperitura perché credeva nell’essenza religiosa dell’economia. Il danaro, come la divinità, è imperitura. E come ogni divinità va denunciata come alienazione (Feuerbach), così il danaro va denunciato come astrazione sempre incompiuta. Per Marx il concreto è vero, l’astratto è falso. Ma questo carattere imperituro del danaro non viene da un assunto quasi-religioso nel suo uso, viene dal fatto che il danaro è sempre stato, sin dagli albori, matematica. E i numeri, pur senza essere divini, sono imperituri. Scambiando, gli esseri umani matematizzano i loro rapporti senza volerlo. Insomma, credere che la realtà sia concretezza e l’astrazione, i numeri, siano fede è una fede sbagliata. La matematizzazione crescente della natura a opera della scienza mostra che ciò che c’è di più concreto, la natura, è sempre matematizzabile – perché la scienza nella natura cerca sempre relazioni. Le equazioni sono la verità profonda delle cose. E i prezzi delle merci non sono altro che equazioni.
6.
L’umanità ci ha messo millenni per capire questa cosa così semplice, che la moneta rappresenta delle ragioni di scambio. L’essere umano sa tante cose inconsciamente, ma ci mette secoli per pensarle. Così, per secoli, si tendevano a usare buone monete, ovvero oggetti che avessero di per sé un valore d’uso. La logica del baratto si è prolungata nella ricerca della buona moneta. Da qui il mito dell’oro, pregiudizio giunto grazie a Keynes fino al 1971, anno del crollo del sistema di Bretton Woods, che si basava ancora sull’oro. Ma perché l’oro è visto come prezioso? Perché l’oro era molto desiderato, quindi appariva prezioso di per sé. Era usato come moneta anche perché agevole, non si degrada facilmente - ma oggi ci rendiamo conto che delle cifre in un programma di computer sono meno degradabili dell’oro. Da qui l’illusione del Gold Rush, che ci si arricchisse ammassando oro. Il fatto che gli esseri umani abbiano fatto ben presto abile uso di monete, non implica affatto che le abbiano intellettualmente capite. Dopo tutto, funzione della filosofia è capire finalmente ciò che già sappiamo.
Sulle banconote della lira era scritto “Pagabili a vista al portatore”. Il pagante era la Banca d’Italia. Ma pagabile con che? All’epoca erano considerate vere monete l’oro e il dollaro. Ma non esiste vera moneta materiale. Abbiamo visto che per Marx il valore è il lavoro accumulato, invece il vero valore è lo scambio stesso. Un paese ricco è un paese che scambia molto, un paese povero è un paese che scambia poco. E lo scambio a sua volta trae il suo valore dal desiderio d’altro. Si scambia con l’altro per desiderio d’altro.
Sappiamo che da un paio di secoli l’economia mondiale si espande, in quasi tutto il mondo. Prima non era così. L’espansione economica si basa sul modo espansivo del desiderio, ovvero, si è sempre insoddisfatti, vogliamo sempre di più, more… Il capitalismo è il blob del desiderio. Certo pensiero post-moderno ama pensare che alla base della moneta come oggetto di scambio non ci sia nulla, che il danaro sia copie senza alcun originale, sembiante di sembiante. Non ci sarebbe nulla alla base del danaro. Ma non è vero: alla base c’è lo scambio. Certo lo scambio non è una cosa ma un processo. Questo processo, visto da lontano, sembra una cosa. In un certo senso, lo scambio si vede, si illustra nella ricchezza appariscente di un paese, grattacieli, autostrade trafficate, ristoranti pieni…
Dunque il danaro, qualcosa di connesso all’intera economia di un paese, rappresenta, dettaglia, la potenza di scambio di questo paese. Dico bene la potenza di scambio, non la ricchezza. Se c’è un clan che vive in perfetta autarchia, produce tutto quello di cui i suoi membri hanno bisogno o desiderano senza dover scambiare nulla con l’esterno, potrà essere un clan felice ma economicamente irrilevante: nella misura in cui non scambia, non è un’entità economica[7].
In fondo, il socialismo è il sogno di essere questo clan: chiudere la società in modo che essa produca solo oggetti d’uso, mai nessun eccedente da scambiare. Ma non appena qualcuno nel clan socialista desidera qualcosa che nel clan non c’è… cominciano i guai. In particolare, il mercato nero. Il socialismo vorrebbe sopprimere quel desiderio d’altro che per alcuni (basti pensare a Lacan) è essenziale all’essere umano. Il comunismo crollò in URSS proprio per questo: i sovietici cominciarono a desiderare ardentemente qualcosa che si trovava solo in Occidente. Ma l’URSS non aveva granché da scambiare con l’Occidente. Anche oggi, del resto, la Russia non ha molto di più da scambiare del suo petrolio.
Se ho in tasca 100 euro, questa banconota rappresenta – nel senso che sta al posto di – una certa frazione dei beni di scambio, non di consumo, prodotti all’interno dei paesi dell’eurozona. È ingenuo pensare che il danaro sia qualcosa di puramente simbolico, un’astrazione: come tutti sappiamo, è qualcosa di ben reale. Atrocemente reale per chi non ce l’ha! Andate a dire a un poveraccio che il danaro si basa su una fede religiosa, come pensava Walter Benjamin! Preferirà derubarvi del portafoglio.
Insomma, il capitalismo non ha nulla della fede religiosa[8]. La ferrea realtà del danaro è dovuta al fatto che è il corrispettivo di una potenza, quella di poter scambiare. Certo questa corrispondenza è incerta, varia giorno per giorno, nessuno sa precisamente quanta parte della potenza di scambio dell’eurozona rappresenta quella banconota euro che ho in tasca… da qui le continue fluttuazioni del cambio, i giochi speculativi. Posso aver rubato quella banconota, eppure sappiamo che è ben reale perché tutti desiderano quei 100 euro. Il danaro è l’unico bene che tutti desiderano in quanto è il bene che tutti devono usare per soddisfare le loro domande, e si domanda qualcosa perché la si desidera. Che c’è di più concreto di questo?
Quindi, quando dico che il danaro rappresenta, intendo qualcosa che è al posto di, ma che proprio per questo ha il potere di ciò che rappresenta. È come quando un re inviava un suo rappresentante a un negoziato: quel che decideva il plenipotenziario del re era come se fosse deciso dal re stesso. Il danaro non è un sembiante della potenza di scambio, è un rappresentante della potenza che ha esso stesso potere di scambio.
Potremmo andare oltre, e dire che ogni società è una rete di scambi. Per Claude Lévi-Strauss, ogni società è scambio di parole, di doni e di donne. E possiamo inserirvi anche lo scambio economico di beni. La società non è un “qualcosa” ma un insieme di processi, tra cui ci sono i processi economici, ovvero produrre per scambiare. Marx lamentava il fatto che nel capitalismo tutto diventi scambio, anche la vita coniugale. Ma è sempre stato così. Per lo più i marxisti quando parlano di “società capitalista” in realtà stanno parlando della società tout court, di tratti che il capitalismo non ha fatto che rendere evidenti ed esaltare. Una famiglia può essere basata sull’amore, ma essa implica sempre delle regole implicite di scambio. Nella famiglia tradizionale lo scambio era: “io uomo porto i mezzi per vivere, e tu donna ti occupi della casa e dei marmocchi”. Nella famiglia moderna, basata sull’eguaglianza dei sessi, il patto di scambio non è più così preciso e chiaro, ragion per cui essa è tanto fragile.