-
-
 L’accattivante titolo Re Mida a Wall Street. Debito desiderio e distruzione tra psicoanalisi, economia, filosofia (Mimesis, 2015) costituisce una sorta di compendio lacaniano al tema del debito. Tenendo conto dell’enorme offerta di studi critici in circolazione, il tentativo del numero 5 di LETTERa, curato da Federico Leoni, è decisamente apprezzabile perché propone un’angolatura differente rispetto a quella dominante, prettamente economico-matematica. In che modo tratta il debito un analista? Come il Maestro? Élisabeth Roudinesco (1997, pp. 389, 397-398) racconta che Lacan aveva un debole per i soldi: gli analizzanti insolventi venivano inseguiti da una voce mielosa per ottenere il compenso pattuito. Il costo delle sedute era d’altronde carissimo: da ottimo freudiano sapeva che guarigione e prezzo sono direttamente proporzionali. I contributi raccolti, tra cui si elencano quelli di Jean-Luca Nancy e Elvio Fachinelli, aiutano a capire la complessa osmosi tra il discorso analitico e quello economico disponendo il dibattito attorno a due assi, l’uno simbolico e l’altro reale. Per la psicoanalisi – come Giancarlo Ricci giustamente sottolinea – il debito è simbolico. L’essere umano riceve dall’Altro una sorta di investimento iniziale di natura linguistica – un po’ come le imprese che ottengono un prestito per prendere avvio. Diversamente dalle aziende, per il soggetto sarà però impossibile sottrarsi: dal momento in cui entra nel linguaggio, dovrà fare i conti con qualcosa che gli è stato donato senza averlo richiesto. Anche disfarsene pare difficile. La catena di significanti in cui siamo catturati, se da un lato permette a ognuno di inserirsi nell’ordine dello scambio simbolico, cioè parlare, dall’altro può risultare un intralcio faticoso quando diventa una ripetizione arida, un equivalente dell’istinto senza essere animali. Come i giocatori d’azzardo patologici trattati da Nicolò Terminio, obbligati a scommettere aspettando che i soldi finiscano e venga così arginato il loro automatismo. Ci chiediamo: chi alza il braccio per muovere la leva della slot machine? È abbastanza chiaro quanto sia difficile essere liberi? Sebbene suoni sufficientemente reazionaria da non essere presa in considerazione, Goethe aveva suggerito una strategia per emanciparsi: riconquistare ciò che è stato ereditato. In tal modo si spera di possedere davvero il lascito senza esserne posseduti.
L’accattivante titolo Re Mida a Wall Street. Debito desiderio e distruzione tra psicoanalisi, economia, filosofia (Mimesis, 2015) costituisce una sorta di compendio lacaniano al tema del debito. Tenendo conto dell’enorme offerta di studi critici in circolazione, il tentativo del numero 5 di LETTERa, curato da Federico Leoni, è decisamente apprezzabile perché propone un’angolatura differente rispetto a quella dominante, prettamente economico-matematica. In che modo tratta il debito un analista? Come il Maestro? Élisabeth Roudinesco (1997, pp. 389, 397-398) racconta che Lacan aveva un debole per i soldi: gli analizzanti insolventi venivano inseguiti da una voce mielosa per ottenere il compenso pattuito. Il costo delle sedute era d’altronde carissimo: da ottimo freudiano sapeva che guarigione e prezzo sono direttamente proporzionali. I contributi raccolti, tra cui si elencano quelli di Jean-Luca Nancy e Elvio Fachinelli, aiutano a capire la complessa osmosi tra il discorso analitico e quello economico disponendo il dibattito attorno a due assi, l’uno simbolico e l’altro reale. Per la psicoanalisi – come Giancarlo Ricci giustamente sottolinea – il debito è simbolico. L’essere umano riceve dall’Altro una sorta di investimento iniziale di natura linguistica – un po’ come le imprese che ottengono un prestito per prendere avvio. Diversamente dalle aziende, per il soggetto sarà però impossibile sottrarsi: dal momento in cui entra nel linguaggio, dovrà fare i conti con qualcosa che gli è stato donato senza averlo richiesto. Anche disfarsene pare difficile. La catena di significanti in cui siamo catturati, se da un lato permette a ognuno di inserirsi nell’ordine dello scambio simbolico, cioè parlare, dall’altro può risultare un intralcio faticoso quando diventa una ripetizione arida, un equivalente dell’istinto senza essere animali. Come i giocatori d’azzardo patologici trattati da Nicolò Terminio, obbligati a scommettere aspettando che i soldi finiscano e venga così arginato il loro automatismo. Ci chiediamo: chi alza il braccio per muovere la leva della slot machine? È abbastanza chiaro quanto sia difficile essere liberi? Sebbene suoni sufficientemente reazionaria da non essere presa in considerazione, Goethe aveva suggerito una strategia per emanciparsi: riconquistare ciò che è stato ereditato. In tal modo si spera di possedere davvero il lascito senza esserne posseduti.A ciò si deve aggiungere il lato reale della pulsione – la dimensione decisiva dell’analisi su cui si valuta la riuscita di una cura. Freud aveva intuito che l’uomo è refrattario alla salvezza, non vuole saperne di guarire, perché comporta l’abbandono del proprio godimento.
 L’aspetto assurdo è che l’uomo gode di oggetti ritenuti totalmente inutili, inessenziali, dal senso comune. È noto il parallelismo tra feci e denaro, lo è meno che l’escremento sia un oggetto causa del desiderio, un “plusgodere”. Elvio Fachinelli parla dell’oro come del «primo cocente amore del giovane capitalismo» (p. 16), e siamo dunque stupiti nel pensare che qualche banchiere sperduto a Wall Street strabuzzi gli occhi nel vedere una “montagna di merda”. La materia a cui si dà meno importanza risulta invece determinante. C’è una cosa curiosa, se si legge il contributo di Massimo Amato. Questi spiega che i soldi non valgono nulla, la moneta è fatta solo per sparire nella circolazione – allo stesso modo delle feci. Eppure, perché mai tanta gente si ostina ad accumulare il nulla? Come l’avaro di Molière che stipava tutto nel giardino e sovente andava ad assicurarsi che non mancasse niente, così molte persone controllano più volte al giorno con lo stesso tic osceno, per esempio, che il fondo obbligazione continui a rendere. Keynes aveva azzeccato la questione: occorre creare una moneta che in sé non si trattenga, perché se si lasciano le cose al loro corso, l’uomo si mostrerà stitico.
L’aspetto assurdo è che l’uomo gode di oggetti ritenuti totalmente inutili, inessenziali, dal senso comune. È noto il parallelismo tra feci e denaro, lo è meno che l’escremento sia un oggetto causa del desiderio, un “plusgodere”. Elvio Fachinelli parla dell’oro come del «primo cocente amore del giovane capitalismo» (p. 16), e siamo dunque stupiti nel pensare che qualche banchiere sperduto a Wall Street strabuzzi gli occhi nel vedere una “montagna di merda”. La materia a cui si dà meno importanza risulta invece determinante. C’è una cosa curiosa, se si legge il contributo di Massimo Amato. Questi spiega che i soldi non valgono nulla, la moneta è fatta solo per sparire nella circolazione – allo stesso modo delle feci. Eppure, perché mai tanta gente si ostina ad accumulare il nulla? Come l’avaro di Molière che stipava tutto nel giardino e sovente andava ad assicurarsi che non mancasse niente, così molte persone controllano più volte al giorno con lo stesso tic osceno, per esempio, che il fondo obbligazione continui a rendere. Keynes aveva azzeccato la questione: occorre creare una moneta che in sé non si trattenga, perché se si lasciano le cose al loro corso, l’uomo si mostrerà stitico.Un punto di sintesi teorica, tra quello che abbiamo chiamato il lato simbolico e quello reale, è il “discorso del capitalista”, proposto da Lacan nel 1972. Introdotti qualche anno prima, i “quattro discorsi” sono infatti dei dispositivi concettuali in grado di connettere sociale e individuale, linguaggio e godimento. Utili agli analisti per inquadrare la struttura dell’analizzante, a noi interessano per un diverso motivo. Nel suo intervento, Federico Chicchi nota come la soggettività più diffusa non si senta in colpa perché in debito, ma nel caso sia incapace ad accedere a nuovo credito. Insomma, una volta ci sanzionavamo perché ogni volta il godimento era troppo, ora ci accusiamo di non godere mai abbastanza. Tale ribaltamento è dovuto al fatto che nel discorso del capitalista si instaura un rapporto privilegiato con l’oggetto del godimento; si assiste quindi all’“industrializzazione del desiderio” (Lacan, 1978, p. 229). Visto che è nella natura degli oggetti essere sostituibili (dato il carattere metonimico del desiderio), comprendiamo anche perché l’individuo capitalistico non si accontenti mai e percepisca ogni limite come un’insopportabile privazione.

Andrea Mura si sofferma diffusamente su questi e altri aspetti, ma non accenna alla centralità della stupidità come fattore centrale dell’uscita dal discorso del capitalista. La coppia furbizia/stupidità ricorre spesso negli scritti degli anni ’70 di Lacan. Per esempio, nel testo del 1973 Excursus afferma: «per rendere veramente bene come analisti, si dovrebbe, al limite, riuscire a ridurre se stessi più stupidi che di natura» (ibidem). Nel seminario Les non-dupes errent, dell’anno seguente, si sosterrà che convenga essere il più allocchi possibile per non errare: se il capitalismo è astuto, ha successo e funziona, chissà cosa accadrà a contatto con la stupidità.
di Filippo Aguzzi
Bibliografia
Lacan J. (1978). Excursus, in Id. Lacan in Italia (1953-1978), trad. it. di L. Boni. Milano: La Salamandra.
Roudinesco É. (1997). Jacques Lacan. Outline of a life, history of a system of thought. New York: Columbia University Press.
-
Mariana Mazzucato – Lo stato innovatore
Recensioni / Aprile 2016 Con il libro Lo Stato Innovatore (Laterza, 2014) Mariana Mazzucato ha rotto il silenzio che pervadeva nell’accademia e tra l’opinione pubblica europea circa il ruolo dello Stato in una moderna economia di libero mercato. Il libro ha avuto un’ampia diffusione, soprattutto in Italia e nel Regno Unito, dove Mazzucato insegna Economia dell’innovazione. Se ne è molto dibattuto, perché la tesi centrale dell’autrice è in radicale opposizione sia con le teorie economiche correnti sia con l’atteggiamento della politica europea degli ultimi trent’anni: secondo l’autrice lo Stato dovrebbe intervenire di più e meglio nel sistema economico. Esperta di innovazione tecnologica e del rapporto di quest’ultima con la crescita economica e il tessuto produttivo, Mazzucato sostiene due posizioni fondamentali: la prima è che il contributo attivo dello Stato nel creare innovazione tecnologica è largamente sottostimato e taciuto; la seconda è che il settore privato non è in grado di produrre da solo l’innovazione necessaria per garantire crescita economica e risposte ai più urgenti problemi globali (in primis la crisi ambientale).
Con il libro Lo Stato Innovatore (Laterza, 2014) Mariana Mazzucato ha rotto il silenzio che pervadeva nell’accademia e tra l’opinione pubblica europea circa il ruolo dello Stato in una moderna economia di libero mercato. Il libro ha avuto un’ampia diffusione, soprattutto in Italia e nel Regno Unito, dove Mazzucato insegna Economia dell’innovazione. Se ne è molto dibattuto, perché la tesi centrale dell’autrice è in radicale opposizione sia con le teorie economiche correnti sia con l’atteggiamento della politica europea degli ultimi trent’anni: secondo l’autrice lo Stato dovrebbe intervenire di più e meglio nel sistema economico. Esperta di innovazione tecnologica e del rapporto di quest’ultima con la crescita economica e il tessuto produttivo, Mazzucato sostiene due posizioni fondamentali: la prima è che il contributo attivo dello Stato nel creare innovazione tecnologica è largamente sottostimato e taciuto; la seconda è che il settore privato non è in grado di produrre da solo l’innovazione necessaria per garantire crescita economica e risposte ai più urgenti problemi globali (in primis la crisi ambientale).Mazzucato ha un curriculum di eccezione da economista eterodossa. Ha ottenuto il dottorato alla New School for Social Research, prestigiosa università americana considerata fra le più progressiste d’oltreoceano. Effettivamente i riferimenti teorici del libro sono esplicitamente eterodossi: John Maynard Keynes, Joseph Schumpeter, Karl Paul Polanyi e Hyman Minsky sono tra i nomi che l’autrice evoca per fondare le argomentazioni di policy del libro su solide basi teoriche. L’argomento più convincente in favore del necessario intervento statale per promuovere e realizzare l’innovazione scientifica e tecnologica sarebbe la differenza tra i concetti di rischio e di incertezza, sottolineata dall’economista americano Frank Hyneman Knight negli anni Venti del secolo scorso. Il primo caratterizza la condizione di indeterminatezza rispetto a una serie di eventi che potrebbero verificarsi. Prendiamo per esempio il classico lancio della monetina. Non si può sapere prima del lancio quale sarà il risultato, ma si può calcolare con precisione la distribuzione probabilistica dei due eventi possibili. Da ciò risulta che il rischio è quantificabile e in effetti i moderni mercati finanziari si basano sostanzialmente sulla misurazione del rischio e della sua “commodificazione” sotto forma di assicurazioni, contratti derivati e altri tipi di strumenti economici. L’incertezza invece è la completa incapacità di prevedere un evento futuro, proprio come nel caso di uno scienziato che conduce un esperimento per scoprire una nuova tecnologia. Secondo Mazzucato l’innovazione si basa sul concetto di incertezza ed è per questo che il settore privato – aziende e venture capitalist, cioè quegli investitori specializzati nel finanziare progetti innovativi e altamente rischiosi – dimostra di non avere gli incentivi giusti e quel “capitale paziente” che permetterebbe all’innovazione di fiorire.
Secondo l’autrice le più grandi multinazionali rispondono alla deregolamentazione dei mercati finanziari reinvestendo i loro profitti nel riacquisto delle proprie azioni anziché promuovere il comparto di ricerca e sviluppo (R&S) o proporre progetti innovativi. I fondi di venture capital invece guadagnano dalla
 vendita di quote di società altamente innovative sui mercati azionari, il loro scopo non è certamente attendere di rientrare dell’investimento attraverso il normale flusso di ricavi che il nuovo prodotto garantirebbe. L’orizzonte temporale dei fondi di venture capital non supera i cinque anni, un problema fondamentale se si considera che possono essere necessari anche diversi decenni per commercializzare i risultati di ricerche scientifiche innovative. Per far entrare lo Stato sulla scena, Mazzucato sfata un mito resistente nella teoria economica: il concetto di fallimento del mercato. Questo non rappresenta né l’unica né la più importante ragione del perché lo Stato debba farsi protagonista attivo dei complessi processi dell’innovazione. La teoria sostiene che il mercato dovrebbe essere lasciato libero di autoregolarsi tranne in casi eccezionali, nei quali l’ammontare del bene fornito dal mercato è inferiore all’ammontare ottimale (da qui il fallimento). Per quanto riguarda l’innovazione, però, lo Stato è l’unica istituzione in grado di assumere l’incertezza e di guidare i processi innovativi con un mix di politiche e investimenti mirati. Quel che è chiaro è che lo Stato non dovrebbe semplicemente limitarsi a creare le condizioni migliori affinché siano i privati a condurre i processi di innovazione tecnologica e industriale, ma dovrebbe invece svolgere un attivo ruolo di coordinamento, di finanziamento e di promozione attraverso agenzie pubbliche, centri di ricerca e partnership con il settore privato.
vendita di quote di società altamente innovative sui mercati azionari, il loro scopo non è certamente attendere di rientrare dell’investimento attraverso il normale flusso di ricavi che il nuovo prodotto garantirebbe. L’orizzonte temporale dei fondi di venture capital non supera i cinque anni, un problema fondamentale se si considera che possono essere necessari anche diversi decenni per commercializzare i risultati di ricerche scientifiche innovative. Per far entrare lo Stato sulla scena, Mazzucato sfata un mito resistente nella teoria economica: il concetto di fallimento del mercato. Questo non rappresenta né l’unica né la più importante ragione del perché lo Stato debba farsi protagonista attivo dei complessi processi dell’innovazione. La teoria sostiene che il mercato dovrebbe essere lasciato libero di autoregolarsi tranne in casi eccezionali, nei quali l’ammontare del bene fornito dal mercato è inferiore all’ammontare ottimale (da qui il fallimento). Per quanto riguarda l’innovazione, però, lo Stato è l’unica istituzione in grado di assumere l’incertezza e di guidare i processi innovativi con un mix di politiche e investimenti mirati. Quel che è chiaro è che lo Stato non dovrebbe semplicemente limitarsi a creare le condizioni migliori affinché siano i privati a condurre i processi di innovazione tecnologica e industriale, ma dovrebbe invece svolgere un attivo ruolo di coordinamento, di finanziamento e di promozione attraverso agenzie pubbliche, centri di ricerca e partnership con il settore privato. Nei capitoli centrali del libro, Mazzucato passa in rassegna numerosi esempi storici che dimostrano il ruolo attivo dello Stato nei processi di innovazione. Il suo caso studio più eclatante sono gli Stati Uniti. Qui, molti dei programmi pubblici che finanziarono ricerca di base e applicata nei settori delle biotecnologie e dei farmaci furono approvati dall’amministrazione conservatrice di Ronald Reagan negli anni Ottanta. A tal proposito l’autrice ricorda l’apparente conflitto tra i sostenitori delle politiche interventiste di Alexander Hamilton (1755-1804) e quelli delle politiche del laissez-faire di Thomas Jefferson (1743-1826). Negli Stati Uniti, la posizione ufficiale è sempre stata jeffersoniana mentre la politica economica – adottata silenziosamente – decisamente hamiltoniana. Già nel 1958 il governo creò un ufficio governativo all’avanguardia nella promozione dello sviluppo tecnologico per la difesa nazionale (Darpa). Le caratteristiche del Darpa erano: autonomia dal governo, ingenti finanziamenti e capacità di attrarre le menti più brillanti del paese. Senza il Darpa alcune tra le più importanti innovazioni in campo informatico (per esempio internet) non sarebbero state possibili.
Per spiegare il ruolo decisivo avuto dallo Stato nel potenziare innovazione tecnologica e permettere lo sviluppo di nuovi prodotti, Mazzucato dedica un intero capitolo ad Apple, l’azienda del popolarissimo Steve Jobs. Creata in un garage con pochissimi mezzi e tanto spirito imprenditoriale, Apple rappresenta nell’immaginario comune l’impresa di successo che ha rivoluzionato i mercati con prodotti tecnologicamente all’avanguardia. Peccato che, secondo Mazzucato, Jobs e compagni non sarebbero andati da nessuna parte senza le invenzioni finanziate dal governo americano. Internet, GPS, schermi tattili e le più moderne tecnologie di comunicazione sono state tutte inventate grazie allo Stato e poi utilizzate da Apple. Il segreto del successo dell’azienda di Cupertino starebbe nella capacità di integrare innovazione preesistenti e nella cura del rapporto utente-supporto informatico.

In sostanza la tesi di Mazzucato è che lo Stato debba essere considerato un partner del settore privato nei processi di innovazione tecnologica e non un semplice facilitatore. Al contrario del privato, lo Stato può assumere l’incertezza e coordinare i processi virtuosi che portano le economie capitaliste a crescere. L’autrice condanna le recenti tendenze delle grandi imprese farmaceutiche e high-tech alla socializzazione del rischio – cioè lo sfruttamento della ricerca finanziata dallo Stato – per poi privatizzare i profitti, non remunerando adeguatamente i lavoratori o cercando di eludere il fisco. La ricetta di Mazzucato è riassumibile in un concetto espresso nella parte finale del libro: «quando la distribuzione dei proventi finanziari del processo di innovazione riflette la distribuzione dei contributi al processo stesso, allora l’innovazione tende a ridurre la diseguaglianza». Questa è però anche la debolezza della tesi esposta nel libro: manca un’analisi approfondita delle complesse dinamiche economiche che caratterizzano le moderne economie globali. Un ruolo diverso dello Stato nei processi di innovazione sarebbe il grimaldello per invertire la tendenziale stagnazione delle economie occidentali e per risolvere il problema della riconversione industriale. Troppi elementi vengono ricondotti all’interno del discorso dell’economia dell’innovazione; per esempio il problema delle diseguaglianze crescenti difficilmente può essere affrontato entro tale cornice teorica.
Infine sembra mancare un’indagine dei processi politici che guidano lo Stato. Chi è lo Stato innovatore e come si forma? Quali sono gli incentivi necessari per mettere in moto i virtuosi meccanismi dell’innovazione coordinati dallo Stato? Su questo punto il testo di Mazzucato è deficitario, cosa che, tra l’altro, rende il suo punto di vista facilmente attaccabile: chiedere più Stato affidandosi vagamente a una leadership più forte o a una capacità di visione maggiore rischia di produrre solamente corruzione e sprechi.
di Alberto Fierro
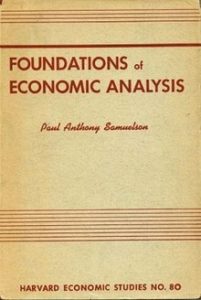 Secondo la ben nota, non solo tra i filosofi, “fallacia naturalistica” di Hume, è illecito dedurre dall’essere il dover essere, dai fatti i valori, dalle spiegazioni i desideri, dal vero il bene. Allo studio dell’essere, dei fatti, delle spiegazioni e della verità si sono da sempre dedicate le scienze “dure”, cioè le scienze naturali, che hanno carattere descrittivo, e mai normativo. L’economia, almeno nella sua accezione mainstream, è la scienza sociale generalmente ritenuta più vicina, nei suoi metodi, alle scienze naturali: a tale indirizzo “scientista” ha dato lustro l’opera di Paul Samuelson. Nel 1947 egli diede alle stampe un’opera fondamentale, dal titolo Foundations of Economic Analysis, in cui, tramite l’applicazione dei principi dell’equilibrio termodinamico alla teoria neoclassica dell’equilibrio, delineava un modello elegante ed efficace per una teoria generale dell’equilibrio economico: secondo Samuelson, così come fanno i sistemi fisici, anche i sistemi economici reagiscono alle modifiche esterne, minimizzandone l’impatto e preservando il loro stato di equilibrio. L’opera di Samuelson è rilevante anche per gli scopi teorici che si prefigge dal punto di vista metodologico: l’autore si propone infatti di procedere ad un lavoro di unificazione, attraverso il linguaggio della matematica, dei fondamenti della teoria neoclassica micro e macroeconomica. Nel 1970, egli fu il primo economista americano ed essere insignito del premio Nobel: i suoi meriti scientifici consistono nel progetto di formalizzazione matematica delle tesi elaborate dagli economisti neoclassici, operazione che permise di elevare il livello di analisi della scienza economica.
Secondo la ben nota, non solo tra i filosofi, “fallacia naturalistica” di Hume, è illecito dedurre dall’essere il dover essere, dai fatti i valori, dalle spiegazioni i desideri, dal vero il bene. Allo studio dell’essere, dei fatti, delle spiegazioni e della verità si sono da sempre dedicate le scienze “dure”, cioè le scienze naturali, che hanno carattere descrittivo, e mai normativo. L’economia, almeno nella sua accezione mainstream, è la scienza sociale generalmente ritenuta più vicina, nei suoi metodi, alle scienze naturali: a tale indirizzo “scientista” ha dato lustro l’opera di Paul Samuelson. Nel 1947 egli diede alle stampe un’opera fondamentale, dal titolo Foundations of Economic Analysis, in cui, tramite l’applicazione dei principi dell’equilibrio termodinamico alla teoria neoclassica dell’equilibrio, delineava un modello elegante ed efficace per una teoria generale dell’equilibrio economico: secondo Samuelson, così come fanno i sistemi fisici, anche i sistemi economici reagiscono alle modifiche esterne, minimizzandone l’impatto e preservando il loro stato di equilibrio. L’opera di Samuelson è rilevante anche per gli scopi teorici che si prefigge dal punto di vista metodologico: l’autore si propone infatti di procedere ad un lavoro di unificazione, attraverso il linguaggio della matematica, dei fondamenti della teoria neoclassica micro e macroeconomica. Nel 1970, egli fu il primo economista americano ed essere insignito del premio Nobel: i suoi meriti scientifici consistono nel progetto di formalizzazione matematica delle tesi elaborate dagli economisti neoclassici, operazione che permise di elevare il livello di analisi della scienza economica.