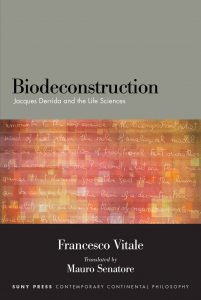«Non sono giochi di parole. I giochi di parole non mi hanno mai interessato.
Piuttosto, sono dei fuochi di parole: consumare i segni fino alla cenere»
J. Derrida, Posizioni
 È un atto di audacia leggere oggi Derrida. Oggi, in un momento storico in cui, sul piano filosofico, tutto sembra portarci lontano da Derrida e giocare contro di lui. Nel tempo della filosofia come conceptual engineering e iper-specializzazione logico-linguistico-matematica1, del dominio dell’argomentazione come unico viatico di rigore e chiarezza, e della stessa chiarezza-esattezza come assoluto contrassegno di razionalità, non può più esserci posto per un filosofo come Derrida. E così gli atteggiamenti più diffusi nei confronti dell’autore della Grammatologie sono due, esattamente inversi: la diffidenza e l’esclusione dal campo filosofico – con l’inclusione in quello letterario e retorico – o la caricatura, la ripetizione, il banale scimmiottamento di uno stile. Ma rifiutare o adorare Derrida, in realtà, sono solo le due facce del medesimo malessere che vive la filosofia oggi. Derrida è il pensatore dell’effrazione, del rinvio, dell’altrove. Altrove, rispetto a ogni classificazione professionale e istituzionale: ermeneutica, filosofia del linguaggio, filosofia della mente, comunicazione, linguistica, logica, psicologia, ecc. Altrove, rispetto alla scrittura stessa. Leggere testi inaccessibili come Glas, Tympan, La carte postale o La vérité en peinture, distillandone il contenuto propriamente filosofico, è un’operazione molto complessa, una sfida alla filosofia e alla nostra stessa capacità di scrivere e di leggere, che non può essere formalizzata nello spazio di un sillogismo, di una solida connessione di premesse e conclusione. Perché richiede qualcosa di più, l’audacia di abbandonare ogni tutore, ogni appoggio concettuale e la violenza, appunto, di «consumare i segni fino alla cenere».
È un atto di audacia leggere oggi Derrida. Oggi, in un momento storico in cui, sul piano filosofico, tutto sembra portarci lontano da Derrida e giocare contro di lui. Nel tempo della filosofia come conceptual engineering e iper-specializzazione logico-linguistico-matematica1, del dominio dell’argomentazione come unico viatico di rigore e chiarezza, e della stessa chiarezza-esattezza come assoluto contrassegno di razionalità, non può più esserci posto per un filosofo come Derrida. E così gli atteggiamenti più diffusi nei confronti dell’autore della Grammatologie sono due, esattamente inversi: la diffidenza e l’esclusione dal campo filosofico – con l’inclusione in quello letterario e retorico – o la caricatura, la ripetizione, il banale scimmiottamento di uno stile. Ma rifiutare o adorare Derrida, in realtà, sono solo le due facce del medesimo malessere che vive la filosofia oggi. Derrida è il pensatore dell’effrazione, del rinvio, dell’altrove. Altrove, rispetto a ogni classificazione professionale e istituzionale: ermeneutica, filosofia del linguaggio, filosofia della mente, comunicazione, linguistica, logica, psicologia, ecc. Altrove, rispetto alla scrittura stessa. Leggere testi inaccessibili come Glas, Tympan, La carte postale o La vérité en peinture, distillandone il contenuto propriamente filosofico, è un’operazione molto complessa, una sfida alla filosofia e alla nostra stessa capacità di scrivere e di leggere, che non può essere formalizzata nello spazio di un sillogismo, di una solida connessione di premesse e conclusione. Perché richiede qualcosa di più, l’audacia di abbandonare ogni tutore, ogni appoggio concettuale e la violenza, appunto, di «consumare i segni fino alla cenere».
Per questo motivo, la recente ripubblicazione della traduzione italiana di La disseminazione (a cura di Silvano Petrosino, Milano, Jaca Book) è un evento degno di nota. Rileggere testi come “La farmacia di Platone”, “La doppia seduta” e “La disseminazione” – scritti tra il 1968 e 1970 – significa non soltanto chiedersi che cosa ne è oggi della “decostruzione”, precisamente nel senso che Derrida attribuiva a questa espressione, ma anche cercare di collocare storicamente questa domanda. Collocarla storicamente, non soltanto nel quadro della filosofia francese contemporanea – ammesso che tale espressione indichi una reale continuità di pensiero e non un semplicemente un gruppo di autori o un “clima”, ma questo è un altro problema –, bensì rispetto alla profonda trasformazione che la società occidentale ha subito negli ultimi quarant’anni con lo sviluppo della tecnologia digitale, quella che è stata definita la softwarizzazione della società. Evento, questo, connesso alla scrittura nel suo senso più proprio, cioè la trace, la messa in questione della linearità della scrittura alfabetica e quindi della metafisica della presenza, del logocentrismo e del fallo-logocentrismo.
Ma guardiamo al libro, anzitutto. Leggere La disseminazione è un’operazione complessa, che richiede tempo e fatica, nonché il coraggio di fare i conti con un pensiero molteplice, in cui sfugge il punto di inizio. «Nessun inizio offre le garanzie necessarie di neutralità» scrive Sollers in Dramma, frase collocata da Derrida nel cuore del saggio “La disseminazione”, tessuto di citazioni a metà strada tra il commento e il testo originale, autentico “avvenire” della decostruzione che si riflette in uno stile preciso. La decostruzione si presenta come lavoro sul testo che viene dal testo, che “avviene” nel testo, «una fase indispensabile di capovolgimento» (p. 50). Non è concettualizzazione selvaggia, insensata, fantasiosa. È un paziente scavo nel testo scritto, a contatto con la scrittura come esperienza del linguaggio che mette in questione il linguaggio stesso. Attraverso tale scavo ogni elemento del testo è animato da «una rotazione velata» (p. 353) che ne sprigiona l’energia nascosta, cioè il mitogramma, citando l'antropologo Leroi-Gourhan, autore molto importante per Derrida. Questo significa risalire, nel testo, dalla scrittura alfabetica al mitogramma come scrittura non-lineare ma radiale, polinodale, visiva, spaziatura, «una grafica che agisce nella stessa sequenza detta fonetica, elaborandola, traducendosi in essa ancor prima di comparire, di lasciarsi infine riconoscere, nel momento in cui cade in coda al testo, come un resto e come una sentenza» (p. 362). L’operazione derridiana assomiglia così a quelle «radiografie che scoprono, sotto l’epidermide dell’ultima pittura, un altro quadro nascosto: dello stesso pittore o di uno diverso, poco importa, che avrebbe, non disponendo di altre tele o ricercando un nuovo effetto, utilizzato la base di un vecchio dipinto o conservato il frammento di un primo schizzo. […] un’altra geometria futura» (p. 363-370).
La scrittura come «altra geometria futura» sfugge alla rappresentazione e si afferma quale condizione di ogni verità e di ogni pensiero. È questo il filo conduttore di “La farmacia di Platone”, così come di un altro testo, ormai anch’esso un classico, “La doppia seduta”, lungo “braccio di ferro” con Platone, e dietro di lui Hegel, e con il concetto di mimesis a partire da Mallarmé, dove l’obiettivo della lettura non è più “una semplice rilevazione di concetti o di parole», bensì «ricostruire una catena in movimento, gli effetti di una rete e il gioco di una sintassi» (p. 218). Anche qui Derrida guarda verso un'altra scrittura, non lineare, ovvero la mimique del Pierrot di Mallarmé, «un intaglio che apre ancora su un altro testo e pratica un’altra lettura» (p. 227) poiché «il Mimo […] non rappresenta niente, non imita niente, non deve conformarsi a un referente anteriore in un disegno di adeguazione o verosimiglianza. […] [Il Mimo è] un doppio che non raddoppia alcun semplice, che non è prevenuto da nulla, nulla che non sia già in ogni caso doppio» (p. 228).

Mi fermo a queste poche citazioni. Di che cosa ci sta parlando Derrida? Del movimento della significazione, la semiosi essenziale all'essere umano, quella necessità di dare un significato che rende possibile il linguaggio, il pensiero, la coscienza e infine la presenza stessa. Questo movimento è la materialità e l'iterabilità della traccia: il “fuori” è nel “dentro”. Il che non significa affatto affermare il primato della retorica sulla logica, come sosteneva Habermas in un celebre saggio. Derrida ci spinge invece a guardare oltre la logica e la retorica, oltre il “fuori” e il “dentro”, interrogandosi sulla contaminazione essenziale e originaria tra i due poli, «la complicità essenziale dell'empirismo e del formalismo» (p. 55). Questa è precisamente l’operazione trascendentale che la decostruzione ci insegna: mostrare la complementarietà dinamica degli opposti. Non c’è presenza piena o essere pieno o coscienza piena: la différance, nella sua mancanza di sonorità, è questo perenne movimento di superamento, questa oscillazione tra presenza e assenza, identità e differenza, rinvio infinito, ammissione dell’impossibilità della genesi, dell’origine assoluta. Su questa tesi Derrida costruisce il nodo teorico essenziale del suo pensiero, destinato a ripetersi secondo modalità sempre diverse, fino agli scritti più recenti sul dono, sull’ospitalità, sull’universalità, sulla pena di morte o sulle «politiche dell’amicizia».
Se questo è il punto nodale di La disseminazione, tracciarne un bilancio critico è cosa molto più difficile e certamente non può essere fatto in poche pagine. È una banalità dirlo, ma in questo caso è vero: siamo ancora troppo storicamente vicini all’opera del filosofo algerino per poterne avere una visione completa, apprezzandone la complessità in modo positivo – e anche in modo diverso da come Derrida stesso ha l'ha pensata. Dobbiamo procedere per tentativi. Uno di questi – a mio avviso – può essere quello di cercare di far fruttare la creatività del pensiero di Derrida mettendola a contatto con la filosofia analitica, con l'informatica e con le scienze cognitive. Può essere una strada utile non solo per rinnovare le chiavi interpretative che applichiamo a Derrida, ma anche per “disarmare” questi due ambiti, in un senso propriamente filosofico, cioè abituandoli alla torsione concettuale e linguistica della decostruzione che è «l’esporsi – come ha detto Derrida in un'intervista alla fine della sua vita – a ciò di cui non ci si può appropriare: a quel che c’è, prima di noi, senza di noi; c’è qualcuno, qualcosa che (ci) avviene, e che non ha bisogno di noi per avvenire». Compiere un'operazione di questo tipo significherebbe rispettare anche un'altra dimensione cruciale per Derrida: la destinazione, l'invio, la tensione, l'apertura del segno verso il futuro. Leggere Derrida come una lettera inviata alla filosofia futura.
Luca M. Possati