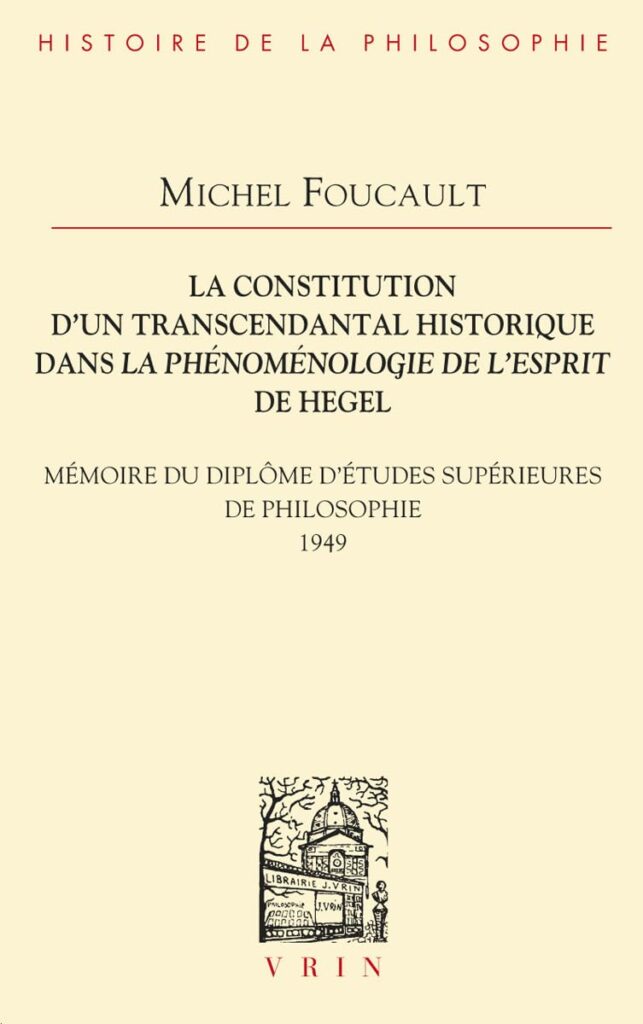-
-
L’inconscio e il trascendentale. Saggi tra filosofia e psicoanalisi di Giovanni Leghissa (Orthotes, 2023) è a suo modo e a dispetto delle apparenze un libro di metafisica: a percorrere e collegare i cinque testi che lo compongono è infatti il tema filosofico per eccellenza, quello della fondazione. Che ne è, oggi, del gesto della fondazione? È ancora possibile effettuarlo, ossia – nei termini dell’autore – dominare, con sguardo “totale”, l’enciclopedia dei saperi? La risposta di Leghissa, che si muove nel solco della fenomenologia husserliana (seppur riveduta e corretta), è naturalmente negativa: le risorse che il sapere filosofico ha da sempre dispiegato per dare un fondamento in senso logico, ontologico e percettologico (p. 109) alla realtà non possono se non essere interne al sistema indagato. Con buona pace delle pretese – in fondo teologiche – che ancora animavano i pensatori sistematici del XIX secolo, Leghissa sostiene come sia costitutivamente impossibile reclamare uno sguardo “da fuori”, fondando dall’esterno ciò nella cui costruzione siamo inevitabilmente coinvolti (p. 20). Si tratta di un definitivo congedo dalla filosofia (p. 22), in favore di saperi scientifici e umanistici più attrezzati in quanto circoscritti e controllabili? Al contrario: se la filosofia, pur accogliendo in sé l’impossibilità della fondazione, intende riguadagnare la pretesa di porsi quale sapere critico universale, in grado di mettere in questione ciò che non si indaga poiché ritenuto ovvio tanto nei suoi stessi confronti quanto rispetto a ciò che le è esterno, bisognerà procedere a una sua riforma, che investa nel profondo i suoi principali operatori.
È innanzitutto l’ormai classica distinzione tra empirico e trascendentale a dover essere rimodulata (p. 113). Mantenere una netta separazione tra questi due ambiti, quasi che spontaneamente ciò che percepiamo con i sensi possa riapparire intatto nelle più alte sfere della concettualità – o che, all’inverso, le forme ideali separate riescano ad aderire perfettamente all’esperienza sensibile – significa condannare il pensiero al vicolo cieco di un dualismo che non riuscirà mai a riunire adeguatamente ciò che ha separato. Seguendo la lezione dello schematismo kantiano e la sua successiva penetrazione all’interno del pensiero di Husserl (p. 113), Leghissa mostra come operazioni sintetiche capaci di prefigurare la costruzione dell’idealità siano già attive all’interno della sensibilità e come, di conseguenza, la stessa concettualità non sussista mai in piena purezza, ma risulti sempre coalescente con una componente di natura empirica (p. 116). Nozioni husserliane quali quelle di sintesi passiva (p. 113), di ritenzione (p. 114) e di mondo della vita (p. 136) vanno così intese secondo Leghissa in un senso non duale, molto vicino – si potrebbe aggiungere – alle riflessioni di Gilles Deleuze sulla natura filosofica dell’immanenza, tale per cui ciò che costituisce la condizione trascendentale (ad esempio la nozione di triangolo) risulta effettivamente esistente soltanto nella sua concreta apparizione empirica (ossia il triangolo disegnato).
Allo stesso tempo – e conseguentemente – sarà l’altrettanto originaria distinzione tra mythos e logos a dover essere rimessa in questione: il gesto inaugurale – di nuovo: fondativo – con cui la filosofia ha preteso onorare la propria vocazione razionale, prendendo al contempo le distanze dalle narrazioni proprie dell’orizzonte mitico è infatti, ancora una volta, un’operazione inservibile (p. 118). Come ha sapientemente mostrato Jacques Derrida, è a rigore impossibile istituire una distinzione definitiva tra concetto e metafora, proprio perché questa stessa distinzione non sembra prestarsi a un’analisi di tipo concettuale: a mancare è il concetto filosofico della metafora, la “metafora della metafora” (p. 123). A una più accurata ricognizione risulta dunque chiaro non solo come – idea già maturata per esempio nel pensiero di Bergson – le metafore possano fornire un concreto ausilio allo sviluppo del pensiero filosofico, ma anche come i principali operatori filosofici risultino indecidibili (p. 128), ossia non posizionabili completamente né da parte metaforica né da parte concettuale (com’è significativamente il caso della Lebenswelt husserliana).
L’embricazione costitutiva tra empirico e trascendentale quanto quella tra concetto e metafora conduce così Leghissa a riflettere sul significato e il portato del gesto filosofico. In primo luogo esso dovrà da un lato porsi sotto il segno della decostruzione (p. 128): la filosofia dovrà muoversi in quel groviglio di concetti e metafore che caratterizza l’insieme dei saperi, con l’obiettivo critico di chiarire e mostrare gli aspetti mitici all’opera nella razionalità e quelli razionali agenti all’interno dei mitologemi. In secondo luogo, essa, nel riconoscere i propri costitutivi limiti, dovrà allearsi con un altro sapere ibrido per eccellenza, ossia la psicoanalisi che, sull’asse Freud-Lacan, ha per sua propria natura fatto i conti con l’impossibilità di una fondazione ultima. Secondo Leghissa la psicoanalisi freudiana – soprattutto nella sua versione lacaniana, “linguistica” e strutturale – nell’interrogare da vicino la nozione di inconscio, può istituirsi quale “macchia cieca” della filosofia, ossia riuscire da un lato nell’intento di rendere visibili quelle sue operazioni interne (p. 11) che le restano per sua natura precluse e, dall’altro, di attutire la sua ineludibile volontà – di natura in fondo mitica – di “fare uno”, ossia di ridurre l’intero campo del reale a puro concetto (p. 144).
Sono però forse le incursioni nell’antropologia filosofica, condotte a partire dal pensiero di Hans Blumenberg, a dare alla prospettiva di Leghissa particolare originalità, schivando gli esiti spesso sterili che incontrano oggi gli epigoni di Husserl e Derrida. Le rimodulazioni del rapporto tra empirico e trascendentale, così come la pratica filosofica della decostruzione e la possibile alleanza con la psicoanalisi trovano quale presupposto una precisa ipotesi antropologica – in fondo già nietzscheana – che vede nell’essere umano “un animale che, per superare oggettive deficienze adattive […] si concede il lusso di creare artefatti anche piuttosto elaborati” (p. 134). L’esigenza umana di costruire un linguaggio attraverso cui raccontar storie per “dominare” il reale costituisce lo sfondo – una sorta di mondo della vita riletto però in chiave antropologica – a partire dal quale l’avventura anche “teoretica” di Homo sapiens può essere posta. Si comprende allora in maniera più chiara il ripetuto appello a combattere quella purezza che il filosofico ha da sempre riservato per sé: si veda, a titolo di esempio, l’analisi storico-teologica che Leghissa consacra alla nozione plotiniana di Uno, svelandone implicazioni ed esigenze, e capace di mostrare come tale concetto/metafora non emerga alla stregua di un prestito calato dall’empireo, ma si realizzi e diventi concretamente operativo attraverso la compresenza e l’evoluzione di differenti “figure” (pp. 128-133).
È proprio a partire da qui, ossia dalla capacità di mostrare la natura impura del concetto e la conseguente presenza di ampi tassi di mythos nel cuore stesso della razionalità filosofica che si situa la proposta “politica” che emerge dal testo: l’attività di critica filosofica, in pieno accordo con l’esplicita rivendicazione di un’eredità illuminista, deve essere al tempo stesso produttrice di emancipazione. Leghissa riflette lungamente – attraverso le intuizioni di Freud sul rapporto tra io e massa e quelle di Lacan intorno al nome del padre – sulla natura “fantasmatica” della relazione che l’uomo instaura costantemente con la realtà: tanto nell’esperienza dell’innamoramento (p. 82), quanto nel rapporto con la legge e con gli altri (p. 88) è ogni volta in atto un meccanismo emotivo di identificazione che conduce l’individuo a una rinuncia all’attività individuale in favore di un comportamento stereotipato (pp. 28-50; pp. 62-63; pp. 88-98). Se è vero che tale meccanismo di identificazione è imprescindibile per la crescita dell’essere umano e di esso è dunque impossibile liberarsi completamente, la presa di consapevolezza conseguente alle attività di una filosofia psicoanalitica (o di una psicoanalisi filosofica) potrà quantomeno indurre il soggetto a un rapporto più sorvegliato nei confronti del reale.
A partire da queste considerazioni, si sarebbe tentati di assegnare alla psicoanalisi una funzione politica emancipatrice, ma è l’autore stesso a metterci in guardia: proporre un freudismo o un lacanismo massimalista e rivoluzionario (nei tanto esempi in cui oggi si declina) significa misconoscere il pessimismo antropologico che da sempre ha animato il discorso psicoanalitico, per il quale “le pulsioni aggressive degli uomini non sono in alcun modo eliminabili” (p. 77). Al di là dei confini di questo pessimismo, ossia al di là del nesso tra desiderio e fantasma, e in ottica esplicitamente utopistica, è forse meglio guardare – sembra confessarci Leghissa – alle preziosissime indicazioni fornite dal Marchese de Sade nella sua opera (pp. 99-108). Sganciando la pulsione sessuale dal desiderio – quale autore in fondo meno erotico? – Sade sembra immaginare una società senza fantasmi, ossia pienamente egualitaria, la quale da un lato è in grado di mostrare la completa arbitrarietà delle norme sociali in quanto tali (p. 107) e dall’altro scommette su cosa può significare una libertà “assoluta” incarnata da soggetti completamente sovrani (p. 108).
Di fronte alla proposta teorico-politica proposta da Leghissa si potrebbero tuttavia avanzare alcune obiezioni relative al ruolo che in essa viene ad assumere la filosofia. Seguendo alcuni nuclei argomentativi pare che questa ne esca notevolmente ridimensionata: all’interno del progetto enciclopedico – cui essa non prende di fatto parte – le resterebbe in eredità soltanto un compito di natura fenomenologico-descrittiva (p. 22), peraltro in un contesto in cui i saperi sono oggi perfettamente in grado di autolegittimarsi (certo, con una dose più o meno massiccia di artifici retorici), respingendo con successo ogni intrusione nel proprio ambito di indagine. Se si seguono altri passaggi emerge invece la posizione opposta, per cui sull’impresa filosofica pare gravare un carico che è forse al di là delle sue reali capacità e competenze: da un lato questa dovrebbe sapersi riparametrare a puntello critico capace di sondare i presupposti inindagati dell’intero campo dei saperi (p. 139) e, dall’altro, una volta posta la sua alleanza con la psicanalisi, parrebbe vocata allo sforzo quasi ossimorico di tenere insieme il riconoscimento del bisogno umano di rassicurazioni identificative al valore emancipativo che una “mitologia della ragione” potrà indurre (p. 145). Insomma, la filosofia sembra alternativamente destinata o al congedo dall’enciclopedia dei saperi o a un potenziamento ipertrofico della sua stessa presenza.
Al netto di queste considerazioni, L’inconscio e il trascendentale si presenta come una raccolta di saggi ricca di stimoli non soltanto teorici, nella quale si tenta un decisivo collegamento tra la riflessione metafisica sulla natura del gesto filosofico e l’indagine delle caratteristiche proprie dell’essere umano e del suo modo di abitare la realtà, la storia e le istituzioni. Leghissa si dimostra così in grado di maneggiare, accompagnandola con rigore argomentativo, quell’arte della “distanza” – quel voler afferrare la natura intima del reale senza voler coincidere completamente con esso – che è in fondo il senso stesso dell’impresa filosofica.
Giulio Piatti