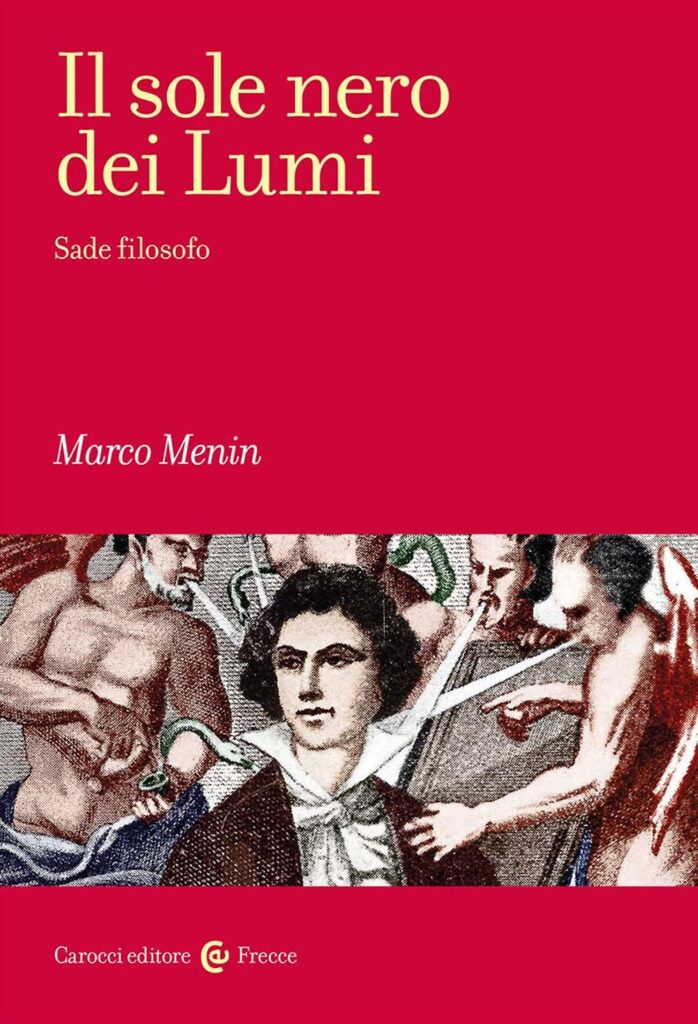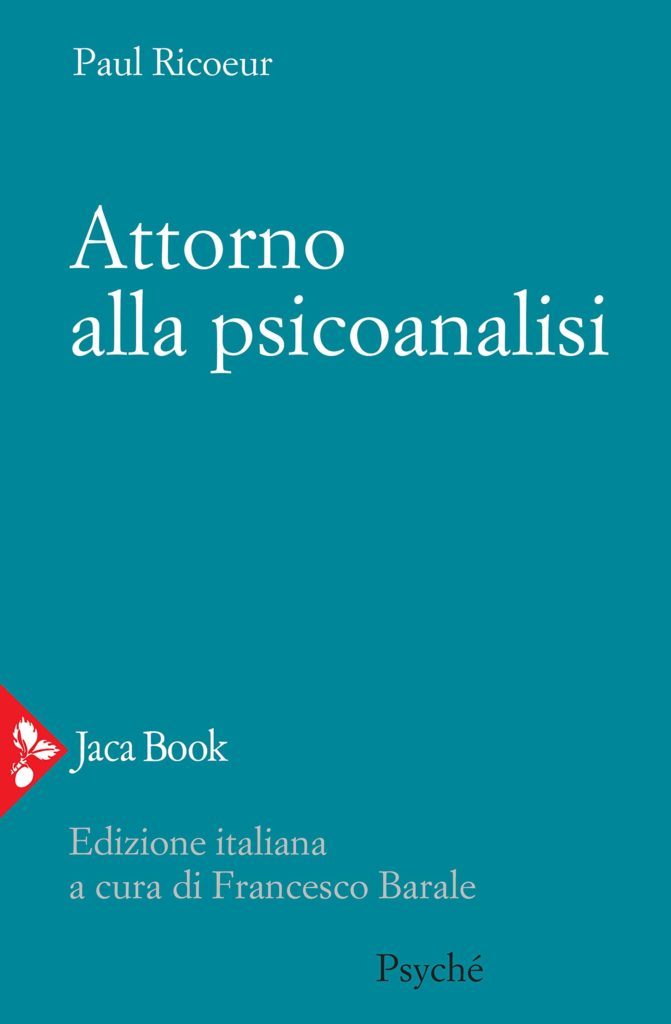-
-
Paul Ricoeur. Attingere dall’intraducibile
Recensioni / Settembre 2020La pubblicazione degli scritti psicoanalitici di Paul Ricoeur sotto il nome Attorno alla psicoanalisi avviene come una delle tappe di un processo che la casa editrice Jaca Book intende riprendere e portare avanti, alla luce di un ideale antico, circa la trattazione dell’Altro, che la collana Psyché riprende da un suo progetto editoriale risalente agli anni ’60, e tuttavia nuovamente al centro dell’esigenza culturale contemporanea. Non è un caso, nel considerare l’opera complessiva, che il titolo della collana sia lo stesso che Derrida diede a due sue raccolte di scritti incentrati sul tema dell’«invenzione dell’altro». Che si raccolgano molti dei testi psicoanalitici di Ricoeur (attinti dall’omonimo fondo francese) non deve sorprendere in tal senso, poiché proprio la questione dell’emergenza dell’Altro si snoda attraverso essi, divenendo sempre più cruciale.
Tale domanda si pone nel momento in cui Ricoeur s’interroga su cosa sia l’uomo. Domanda centrale e tipica della maturità del pensiero di Ricoeur, dalla cui posizione liquiderà rispettosamente come «fabulatoria» (p. 375) la pretesa foucaultiana della sua morte. L’uomo è sì un sistema metaforico, ma mantiene al tempo stesso una sua dimensione che non viene costruita o decostruita. L’uomo continua a porre e a costituire un problema in quanto tale, che non si può ridurre a un prodotto culturale ottenuto da un certo modo di praticare le forme del sapere. È un problema ancora presente e lo sarà anche in futuro, ancora sempre da analizzare, e che non si trova confinato all’interno di una specifica episteme. Non si riduce solo a un’invenzione enunciativa, ma a un modo di stare al mondo che non può essere decostruito, sebbene, attraverso le sue auto-narrazioni e razionalizzazioni, continui a porre l’esigenza di darsi un senso, agendo sulla causa non propriamente razionale che le motiva.
La raccolta di testi segue un ordine cronologico che risulta efficace per poter seguire il percorso lungo cui si snodano le tematiche e gli interessi di Ricoeur. Ampio e variegato è il lavoro svolto per rendere agibile la fruizione dei testi. Dalla presentazione di Francesco Barale alla postfazione di Giuseppe Martini, nel mezzo di trovano sia scritti della sola penna di Ricoeur, sia discussioni con personalità eminenti, come Enrico Castelli e Jacques Lacan.
La domanda circa l’essenza dell’uomo si trova inizialmente declinata secondo l’ordine di grandezza posto dal fenomeno originario della cultura. La cultura come momento fondativo dell’essere umano. Lo è sia in quanto strumento di difesa contro la natura, sia come particolare e delicato modo di dar forma all’altro, nel momento in cui creazione e rielaborazione di senso tendono a coincidere. Cultura è ciò che risponde, inevitabilmente attraverso la repressione degli istinti, alla gestione simbolica, da parte del soggetto cosciente, delle dinamiche fisico-biologiche che agiscono nell’uomo. Questa trova il suo strumento nel linguaggio (mentre con gli sviluppi successivi alla parola succederà la mera rappresentazione). È l’influenza dello strutturalismo linguistico che gioca la sua presa su Ricoeur, e lo conduce a considerare la questione con il filtro del testo e della parola come elementi primi e irriducibili del senso cosciente di tali forze fisiche. Per come queste si concentrano nell’uomo, configurando desideri e aspettative, azioni e repressioni, ognuna di esse ha in sé il richiamo, rivolto a qualcuno al di fuori da sé, di venir presa in carico, curata e gestita. A tale appello risponde il sistema centrale dato dal Sé, la coscienza.
L’unico espediente che in una prima fase della sua carriera Ricoeur trova adeguato, si è detto essere appunto il linguaggio, il quale si inscrive nelle dinamiche neurologiche, appellandole, e asseconda un dialogo formalizzato e meccanizzato tra i desideri reconditi e il loro centro di gestione cosciente. Il linguaggio è incaricato di dare senso a quanto non ha senso alcuno. Non si tratta di un’imposizione forzata, ma del soccorso dato a una richiesta di senso, di interpretazione. La forza desiderante invoca un riconoscimento dal sistema psichico centrale. Il desiderio è una forza che chiede, invoca di essere presa in carico, ascoltata, «proprio per il suo carattere di indirizzo all’altro» (p. 384). Verso cosa? Verso altro da se stessa. È dunque portatrice di una mancanza costitutiva, e come tale caratterizza il dolore, o quanto meno la condizione bisognosa dell’essere umano.

In tal quadro, l’intero sistema psichico, conscio e inconscio, inizia a funzionare grazie alla moneta corrente costituita dalla parola, e attraverso essa può verificarsi, nei limiti concessi dalle strutture e dalle leggi topiche, una sorta di gestione dell’energia pulsionale da parte dello psichico. In questo assunto trova la sua ragion d’essere la psicoanalisi, che viene intesa, in maniera coerente per tutta la vita dell’autore, come il lavoro tra la forza delle resistenze messe in atto dallo psichico da un lato, e il senso che il soggetto cosciente riesce a dare di se stesso dall’altro, alla luce delle poche conoscenze di sé che può ottenere direttamente. L’altro è sia ciò che va creato sia ciò con cui occorre fare i conti. Non vi è mai univocità nella relazione tra la parola posta e la forza rilevata che domanda ascolto.
Si intuisce dunque come Ricoeur tenti in più modi di attuare una riabilitazione di quel paradigma energetico che tanto ha fatto discutere tra i post-freudiani. L’idea fondamentale è tratta dall’opera freudiana, e occorre rielaborarla. In tal senso vanno le interviste multiple, incluse nell’opera, tra addetti ai lavori di più campi, dalla psichiatria psico-patologica alle neuroscienze, per tentare di ridare spolvero a un paradigma interpretativo che è fruttuoso per certi versi, e pone alcuni problemi ermeneutici per altri. Esso, infatti, non viene ripreso all’interno dello schema più semplice della duplice iscrizione del fenomeno psichico (sia nella mente sia nel corpo), ma come parte integrante e complementare rispetto a quella psichica nello stesso sistema. Si accetta anche la possibilità che si tratti di una metafora, che tuttavia contribuisce a smarcare l’intuizione della nostra archeologia da ogni possibile «idealizzazione» (p. 315 - Questa è l’interpretazione minima che Ricoeur prende in considerazione per concepire l’energetica pulsionale freudiana, che si trova trattata in questa accezione nel testo sulla Tecnica e non-tecnica nell’interpretazione, incluso nella raccolta). La cultura non è dunque un prodotto puro, perché si scopre già da sempre calato nella dinamica reale tra forza e senso. La cultura diviene così la risposta propriamente tecnologica e continua, calata nella carne della neurologia ma declinata diversamente, con cui l’uomo risponde ai bisogni dell’economia energetica. Si tratta di collegare questa ad un sistema simbolico, quanto avviene prima con il linguaggio e in seguito con la rappresentazione.
Non si prenda la presente esposizione come la fotografia teorica di quanto Ricoeur affermi in qualche suo testo. Le questioni si intrecciano e si sciolgono, vengono continuamente riproposte se riconosciute come insoddisfacenti, e approfondite se avvertite come potenzialmente fruttuose. È come se Ricoeur procedesse lungo un sentiero, e si dedicasse ad uno solo dei temi che incontra fino a ritenerlo esausto. Solo a tal punto declina la sua attenzione verso altri sforzi, che approfondiscono e allargano il quadro teorico a cui è pervenuto.
Per quanto concerne lo iato tra «forza e senso», Ricoeur lo disegna e lo pone come punto di opacità del soggetto a se stesso, che viene trattato in diversi saggi. Ne consegue una prese di distanze dall’approccio fenomenologico, da cui pure era partita la sua avventura filosofica, in relazione ai temi della colpa e del perdono. Resosi presto conto dell’insufficienza di una teoria pura della coscienza, Ricoeur non esclude la possibilità di erigere ponti tra fenomenologia e psicoanalisi, mentre viene esclusa in quanto non plausibile ogni teoria idealistica, alla quale tendono ad esempio le Meditazioni Cartesiane di Husserl, colpevoli di non considerare il ruolo specifico dato dall’opacità della coscienza e di non spiegare quindi l’insorgere dell’Altro (p. 368). Ciò nonostante, la fenomenologia rimane sempre un punto di riferimento critico, tendenzialmente oppositivo, con cui confrontarsi per prendere le misure del proprio lavoro (Ciò avviene a partire dal primo dei saggi, su La questione della prova in psicoanalisi, sino al testo dedicato a Kohut). A riprova di ciò, per chi legge il testo di Ricoeur, può risultare affine la critica all’intellettualismo che Merleau-Ponty mosse ai tentativi «intellettualistici» di ridurre la portata ontologica del reale, esterno alla coscienza, a un fattore interno alla coscienza, alla sua relazione con essa. Non è un caso allora che Ricoeur mantenga aperta la finestra del confronto con la tradizione fenomenologica, perché appare evidente una certa somiglianza strutturale nei modi in cui viene trattato il Sé nel rapporto con la forza corporea, che non si riduce a un’emanazione della coscienza.
È così che si trova la possibilità di comunicazione tra i due agenti apparentemente incommensurabili costituiti da «forza e senso», i due veri attori che si trovano in scena nel concerto umano, che si tratti dei sogni, della vita quotidiana o della seduta analitica. Le forze vanno trattate, in sede terapeutica, attraverso il senso che si può loro dare, quindi in forma narrativa. Tale forma non può scindersi dalla caratura emotiva ed empirica che anima le stesse forze, individualizzandole in un contesto storico e concreto. La specificità del tipo di approccio deve allora considerare entrambi i lati della faccenda umana. La forma narrativa, che tende a plasmare le forze che la invocano, si trova al tempo stesso a doversi adattare alla realtà pulsionale, la quale si mostra sempre e soltanto nella sua enigmaticità. Questo senso non si riduce perciò al «segmento intellettuale» costituito dall’analisi razionale del disturbo o della nevrosi, ma indica il punto su cui occorre fare il grosso del lavoro. Un lavoro pratico, fondato su un’intelligenza narrativa che si richiama alla phronesis aristotelica. L’invito è allora indirizzato a un lavoro sporco del soggetto sulle proprie emozioni, a lasciarsi andare all’ermeneutica di sé, per mettere in atto una autentica conversione. Questa è la posta in gioco più alta e decisiva, poiché in questa scommessa, che può essere attuata solo attraverso il dialogo con se stessi e con l’altro da sé, ne va di tutta l’impresa etica, oltre che di quella terapeutica.
Ciò è quanto si trova emblematicamente espresso dal problema della sublimazione, altro grosso tema tipicamente psicoanalitico, e legato al percorso che muove dalla cultura e perviene all’esigenza d ripensare il rapporto tra la gestione delle regole e l’insorgenza del nuovo. La questione si allarga così ad ogni atto umano migliorabile, e quindi si lega direttamente all’antropologia filosofica e al miglioramento di sé. Un esempio è la magistrale trattazione della Monalisa leonardesca, nel saggio luminoso sull’apporto della psicoanalisi all’analisi artistica. In Psicoanalisi e arte, Ricoeur spiega come si tratti di attingere il Nuovo dallo Stesso, attraverso un’ispirazione che al lettore può facilmente richiamare Derrida: nuove forme, un nuovo senso di quanto si crea, senza cadere nel rischio di optare per una genealogia della vita emotiva dell’autore. L’arte non si riduce al percorso analitico che porta alla sublimazione: l’arte è il prodotto libero, in quanto creato, della sublimazione. Ricoeur lo ripete più volte: è l’Altro, inteso come bacino interno di forza e infiniti possibili nuovi sensi da dare al passato in vista del futuro, ciò da cui tenta di attingere l’artista, e ciò a cui è chiamato a rispondere ogni essere umano per tentare di raccontarsi (da leggersi: vivere) sempre meglio. Ciò che viene così prodotto dall’analisi, diventa propriamente la creazione dell’oggetto del desiderio, che si sarebbe voluto trovare tra i propri ricordi, e a cui tende il lavoro dell’immaginazione.

Salvador Dalì - Sogno causato dal volo di un'ape intorno a una melagrana un attimo prima del risveglio (1944) Innumerevoli sono poi gli spunti che vengono approfonditi di conseguenza. Dalla teoria della civilizzazione freudiana, al nuovo ruolo universalizzabile della psicoanalisi: sia la cultura sia la psicoanalisi agiscono sulla passione dell’uomo, attraverso la gestione «del transfert dai conflitti di forza ai conflitti di senso» (p. 383). Si tratta inoltre dell’autonomia riservata al discorso teologico, proprio grazie ad una presa critica di distanza dall’ateismo di Freud, distinguendo le genesi del fenomeno dal suo fondamento: è il caso del testo L’ateismo della psicoanalisi freudiana. Vi si trova pure un saggio, Il sé secondo la psicoanalisi e secondo la filosofia fenomenologica, che costituisce un unicum, in quanto non ispirato principalmente da Freud, ma dalla Psicologia del Sé di H. Kohut, che viene relazionato a Hegel e a Lévinas nel tentativo di disegnare un discorso sulla dialettica circa la natura della negazione nella dialettica intercalata nell’analisi.
Trattandosi di tutto ciò, il metodo è sempre teso a percorrere a ritroso il cammino fatto dalla lingua e dalla parola per risalire indietro lungo il sentiero costellato su diversi piani di tutti i meccanismi psicologici, fino al gesto creativo. Il non-luogo ove il linguaggio trova il suo insediamento nel desiderio, per nominarlo e per definirlo.
Il percorso ermeneutico conduce da quanto è già psicologico e che ha già un senso, sebbene provvisorio, a ciò che ancora è celato al di sotto del livello della coscienza. Queste due dimensioni rispondono a due sfere dell’umano e del percorso di riconoscimento di se stessi, la prima volta all’esegesi e all’archeologia, la seconda alla teleologia e al suo divenire. Non si possono scindere questi due aspetti, come peraltro Ricoeur stesso aveva fatto nel suo Dell’interpretazione, innalzando il secondo al puro lavoro filosofico. Egli spiega infatti che, come testimonia la terapia analitica, il banco di prova dell’elaborazione meditata del proprio futuro non è esclusiva della filosofia; questa demarche richiede una dinamica spirituale più ampia, che invoca tutto il supporto della psicoanalisi. Sembra in certi punti sentir risuonare il tema del discorso su di sé tipico degli ultimi corsi di Foucault, ma è Ricoeur stesso che si smarca dall’accostamento proposto da Giuseppe Martini nell’ultima intervista presente nel volume, risalente al 2003. Il problema della terapia non può ridursi a una dimensione puramente intellettuale, poiché occorre far sì che il senso del discorso riesca a muovere le montagne poste a protezione dei contenuti e delle dinamiche inconsce. Occorre un paziente e levigato lavoro che consenta all’analizzato, che diventa analizzante in quanto attore, di metter in atto la sua trasformazione di sé, per affrontare le proprie nevrosi o psicosi. Non è una epoché intellettuale, ma un’immersione totale nel vissuto per cercare di raccontarsi altrimenti quanto si riteneva di aver già compreso definitivamente riguardo la storia passata della propria vita. A tal fine, Ricoeur prende prende spesso spunto dalla rilettura di testi più o meno canonici del corpus freudiano, come Analisi terminabile e interminabile, nonché Ripetere, ricordare, rielaborare. Riprendendo la posizione ortodossa freudiana, concorda sul fatto che non vi sia infatti termine possibile all’interpretazione sempre nuova di quanto già si è vissuto, essendo questo costitutivamente aperto alla lettura sotto diverse angolature, e secondo nuovi ritmi o andamenti. Ciò non smetterà mai di fare problema, e Ricoeur continuerà a ripensare i termini di questo problema. Il tema della fine della cura è legato ai motivi presenti nella rielaborazione del vissuto personale, la quale non si definisce mai una volta per tutte.
Ciò ha ampie conseguenze, soprattutto per le conseguenze al di fuori dello stretto campo analitico. L’etica ne viene investita pienamente, e Ricoeur affronta il tema dell’etica e della morale alla luce della psicoanalisi in più saggi.
Il pensiero di Ricoeur muove per decenni alla ricerca di nuove formulazioni di tale operazione ermeneutica. Lungo tutto il percorso di Ricoeur, sono principalmente i tre paradigmi del simbolo, del testo e della traduzione che modificano l’assetto e i metodi di questa sua indagine (Sono ancora la prefezione e la postafazione di Barale e di Martini a riannodare le fila di questi paradigmi). Il fine rimane lo stesso: si richiede che avvenga una sorta di illuminazione retroattiva delle zone non pensate, per riportarle alla luce, intessendole in nuove forme narrative date alla propria persona e al proprio vissuto. Ma il triangolo teorico tra ermeneutica come auto-narrazione, veridicità come chiave dell’accesso al profondo e cambiamento pratico di sé si rielabora ed evolve.
L’accenno alla narrazione e al ruolo costituito dalla traccia non è certo un tema esclusivo degli scritti sulla psicoanalisi, ma si lega con essi inscindibilmente per quella pretesa interminabile del lavoro di rielaborazione del senso e delle dinamiche cui ci si sottopone quasi automaticamente. Si tratta dunque di una lotta contro questi automatismi, e l’unica fonte di innovazione va cercata al di là di essi e delle loro rappresentazioni fantastiche o linguistiche, mirando a ciò che ancora non ha potuto, o non può più venir rappresentato chiaramente alla coscienza. Si tratta di attingere all’intraducibile, che si assume legato alla sorgente del dir il vero su se stessi, per trarre prospettive ed energie nuove per raccontare e vivere altrimenti ciò che rimane chiuso nel segreto della psiche, che è al tempo stesso passato e rivolto al futuro. La veridicità è allora la chiave di tutta la possibilità di mutare forma e abitudini, poiché essa è la capacità che si scopre sempre più in fondo, oltre le barriere, le quali invece tendono a mascherare il vero. E sebbene non si possa pretendere dalla psicoanalisi una morale positiva densa, si può rinvenire in essa, comunque qualcosa di importante. Con le parole di Ricoeur: «un’etica ridotta alla veridicità non è poca cosa: ha in germe nuovi atteggiamenti, frutto della fine della dissimulazione» (p. 190). La veridicità è dunque ciò che apre le porte al cammino etico, ma anche alla conoscenza di sé. Due direzioni che procedono parallele, condizioni l’una dell’altra.
Un mutamento significativo, che può leggersi nel suo graduale verificarsi, è dato dal ruolo dell’immagine, che va acquisendo una centralità sempre maggiore attraverso i vari testi della raccolta, a discapito della mera parola. Ciò implica, per Ricoeur, un ruolo più originario della Vorstellung, della rappresentazione, rispetto alla sua formulazione linguistica. Il senso può trovare un appiglio prima ancora della sua verbalizzazione, e ciò può avvenire attraverso le immagini. Ricoeur, spiegando in vari passaggi i motivi di questo sorpasso della rappresentazione sulla locuzione verbale, sembra prevedere in qualche modo l’immensa fortuna dell’immagine nella società contemporanea. Questo mutamento di registro è indicativo, inoltre, anche perché segna il distacco definitivo dal lacanismo, già iniziato a prodursi dopo la sua partecipazione ad un seminario di Lacan (Distacco motivato nel testo nella Discussione su Du Trieb de Freud et du Désir du psychanalyste). È così che l’immagine si configura come vettore potenziale di senso grazie al quale il soggetto risponde all’appello rivoltogli dalle passioni. Questo è un fattore forse decisivo anche a livello antropologico, oltre che in chiave teoretica e in quella pratica dell’analisi. Infatti, ciò che non è mai possibile fare è allungare, metaforicamente, la mano in direzione delle proprie pulsioni, per catturarle e decidere liberamente cosa farne. Soprattutto, non è possibile farlo solo attraverso il linguaggio. La rappresentazione grafica si scopre più originaria rispetto al segno linguistico, ed è a partire da quella che questo si instaura. In relazione alle pulsioni – che rimangono comunque inevitabilmente inaccessibili in loro stesse, oltre ogni possibilità della traduzione stessa – si tratta comunque sempre o di nominarle o di immaginarle, per scoprire su quali altre metafore si basano, e la scommessa è che sia proprio questa concezione del desiderio corporeo come una chiamata al senso a rendere possibile una sua gestione da parte del sistema centrale costituito dalla coscienza. una gestione di qualcosa che è bisognoso e carente. Molte possibili letture si possono dare di questa gestione della forza, di un non-rapporto, che nel venir preso in carico dal soggetto, assume la caratura di «un processo ontologico fondamentale» (p. 413. È il commento di Giuseppe Martini nella sua chiara Postfazione su la voie longue intrapresa da Ricoeur). Una concezione molto simile è ripresa nella attuale scena psicoanalitica, anche da alcuni lacaniani, come Alenka Zupančič.
Per finire, è proprio questo invito della forza a venir dotata di senso, a cercare un Altro da sé con cui venir relazionata, a porre le basi per la formazione della Psiche, e di conseguenza a consentire di formulare e immaginare una concezione globale dell’uomo. Ricoeur disegna quindi una genealogia di quest’ultima, la quale è al tempo stesso una teleologia della natura, da modificare verso la creazione in forme nuove. Ciò può avere innumerevoli percorsi di sviluppo, poiché innesta tra il linguaggio e le immagini, che costituiscono la base della cultura, e la forza viva e bruta, la possibilità di uno scambio che si mantenga libero e creativo, tale da dover puntare sempre oltre, verso quel dominio né culturale né naturale costituito dal pre-rappresentazionale, dall’illocutorio, da cui trae origine la vita.
di Carlo Treves
-
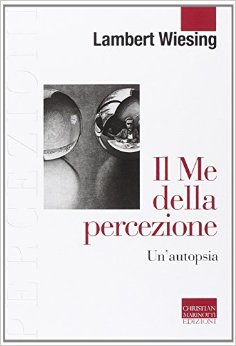 La fenomenologia, secondo Lambert Wiesing (Il me della percezione. Un’autopsia, a cura di Tonino Griffero, Christian Marinotti edizioni, 2014), deve diventare – ritornare? - greca, in almeno quattro sensi differenti. Innanzitutto facendo proprio un adagio scettico: la natura delle cose è inesplicabile. Più che lanciarsi in ipotesi metafisiche – poco importa di quale natura – bisogna ritornare, con Husserl, a un più modesto ma efficace approccio descrittivo: “quale sia stata la sua genesi, è una cosa che non ci riguarda”. In secondo luogo, liberandosi da utopie di stampo scientista, la fenomenologia dovrebbe porsi alla stregua di un testo protrettico (p. 78). Descrivere fenomenologicamente una percezione non significa trasporre una serie di proposizioni analitiche dal carattere strettamente logico-scientifico, ma invitare e convincere il lettore a praticare quelle stesse esperienze trascritte dal fenomenologo. La fenomenologia si nutre - come già notava in senso critico Derrida - di un’intuizione, una presenza originaria, impossibile da comunicare per iscritto, ma, nonostante ciò, compiutamente universale in quanto esperibile. In terzo luogo il pensiero fenomenologico dovrebbe dirigersi senza indugi verso la percezione, evento umano primario e inestirpabile. Come già sosteneva Epicuro – e prima di lui i sofisti - le percezioni sono sempre vere. E questo – aggiunge Wiesing – perché non possono mai essere concepite in altro modo, non essendo passibili di alcuna falsificazione
La fenomenologia, secondo Lambert Wiesing (Il me della percezione. Un’autopsia, a cura di Tonino Griffero, Christian Marinotti edizioni, 2014), deve diventare – ritornare? - greca, in almeno quattro sensi differenti. Innanzitutto facendo proprio un adagio scettico: la natura delle cose è inesplicabile. Più che lanciarsi in ipotesi metafisiche – poco importa di quale natura – bisogna ritornare, con Husserl, a un più modesto ma efficace approccio descrittivo: “quale sia stata la sua genesi, è una cosa che non ci riguarda”. In secondo luogo, liberandosi da utopie di stampo scientista, la fenomenologia dovrebbe porsi alla stregua di un testo protrettico (p. 78). Descrivere fenomenologicamente una percezione non significa trasporre una serie di proposizioni analitiche dal carattere strettamente logico-scientifico, ma invitare e convincere il lettore a praticare quelle stesse esperienze trascritte dal fenomenologo. La fenomenologia si nutre - come già notava in senso critico Derrida - di un’intuizione, una presenza originaria, impossibile da comunicare per iscritto, ma, nonostante ciò, compiutamente universale in quanto esperibile. In terzo luogo il pensiero fenomenologico dovrebbe dirigersi senza indugi verso la percezione, evento umano primario e inestirpabile. Come già sosteneva Epicuro – e prima di lui i sofisti - le percezioni sono sempre vere. E questo – aggiunge Wiesing – perché non possono mai essere concepite in altro modo, non essendo passibili di alcuna falsificazioneInfine – e questo ci introduce al nodo centrale del libro - una sana fenomenologia deve seguire l’Aristotele della Politica: “il tutto viene prima delle parti”. Nel caso della percezione, a cui Wiesing dedica l’intero libro, si tratta allora di superare la parti – percipiente e percepito – per indirizzarsi primariamente al Tutto – la percezione, intesa come situazione che tiene assieme i due poli del soggetto e dell’oggetto.
E’ questo il nerbo centrale della prospettiva avanzata da Wiesing, che intende capovolgere così il criticismo kantiano: invece di individuare nel soggetto, come nell’Estetica trascendentale della Critica della ragion pura, le condizioni di possibilità della percezione, bisognerebbe piuttosto analizzarne le conseguenze della realtà.
 Se la situazione percettiva sembra una realtà a tutti gli effetti inemendabile e fenomenologicamente irriducibile, la domanda da porre deve allora essere la seguente: cosa mi accade nel momento in cui vengo a trovarmi in una situazione percettiva? Schivando così sia l’oggettivismo empiristico proprio degli approcci analitici sia il soggettivismo interpretante delle filosofie ermeneutiche, Wiesing riporta al centro un discorso squisitamente fenomenologico, volto a indagare la relazione intenzionale che inequivocabilmente la percezione pone in essere. Il soggetto, da costitutore del reale o specchio di un mondo di oggetti, diventa così a tutti gli effetti il prodotto di una situazione percettiva che gli si impone. Wiesing ripete più volte quanto la percezione sia in definitiva un’imposizione – anche tragica- per il percipiente, che non può fare a meno di prendere parte alla relazione percettiva. La percezione non produce comodi naufragi con spettatore, per dirla alla Blumenberg, quanto un’inevitabile partecipazione al mondo, nell’unica forma – intenzionale - in cui questo può darsi al soggetto.
Se la situazione percettiva sembra una realtà a tutti gli effetti inemendabile e fenomenologicamente irriducibile, la domanda da porre deve allora essere la seguente: cosa mi accade nel momento in cui vengo a trovarmi in una situazione percettiva? Schivando così sia l’oggettivismo empiristico proprio degli approcci analitici sia il soggettivismo interpretante delle filosofie ermeneutiche, Wiesing riporta al centro un discorso squisitamente fenomenologico, volto a indagare la relazione intenzionale che inequivocabilmente la percezione pone in essere. Il soggetto, da costitutore del reale o specchio di un mondo di oggetti, diventa così a tutti gli effetti il prodotto di una situazione percettiva che gli si impone. Wiesing ripete più volte quanto la percezione sia in definitiva un’imposizione – anche tragica- per il percipiente, che non può fare a meno di prendere parte alla relazione percettiva. La percezione non produce comodi naufragi con spettatore, per dirla alla Blumenberg, quanto un’inevitabile partecipazione al mondo, nell’unica forma – intenzionale - in cui questo può darsi al soggetto.Nella costella
 zione ridisegnata da Wiesing, il trittico soggetto/oggetto/percezione si riconfigura, portando in primo piano la percezione come suo centro propulsore, in maniera non dissimile da quanto portato avanti, in un altro contesto, da Gilbert Simondon prima e da Bernard Stiegler oggi: nel passaggio all’individuazione non bisogna concentrarsi né sull’origine né sul termine, ma sul processo trasduttivo e relazionale in grado di articolare i due momenti. Al di qua della sclerotizzazione tra un soggettivismo autoreferenziale e un oggettivismo semplicistico, Simondon, Stiegler e Wiesing, in modi ovviamente differenti, propongono uno sguardo “terzo”, bergsonianamente orientato sui movimenti che riconfigurano le essenze statiche in poli di un processo.
zione ridisegnata da Wiesing, il trittico soggetto/oggetto/percezione si riconfigura, portando in primo piano la percezione come suo centro propulsore, in maniera non dissimile da quanto portato avanti, in un altro contesto, da Gilbert Simondon prima e da Bernard Stiegler oggi: nel passaggio all’individuazione non bisogna concentrarsi né sull’origine né sul termine, ma sul processo trasduttivo e relazionale in grado di articolare i due momenti. Al di qua della sclerotizzazione tra un soggettivismo autoreferenziale e un oggettivismo semplicistico, Simondon, Stiegler e Wiesing, in modi ovviamente differenti, propongono uno sguardo “terzo”, bergsonianamente orientato sui movimenti che riconfigurano le essenze statiche in poli di un processo.A partire dalla questione percettiva, così reinterpretata, Wiesing deduce, in maniera cartesiana, tutte le possibili conseguenze: il soggetto diventa, come si è detto, un partecipante attivo del mondo, dotato di un corpo-proprio (Leib) a cui la percezione si impone come una causa (pp. 136-140) capace di gettarlo in una dimensione sia pubblica – da qui la possibilità dell’intersoggettività (pp. 140-144) - sia continua – da qui la conferma dell’identità personale (pp.144-150).
Non siamo però sempre e soltanto condannati a percepire: secondo Wiesing lo schema dell’imposizione lascia spazio ad alcune particolari pause dalla partecipazione al mondo. Si tratta della percezione iconica, quando ci si trova di fronte a un’immagine che, presenza “diminuita”, possiede soltanto la caratteristica della visibilità. In questo caso, sebbene si possa provare empatia nei confronti, per esempio, di un film, il percipiente non si sente tuttavia “in gioco”, preso irrevocabilmente in una situazione percettiva. Il naufragio con spettatore, metafora di un a-storico mondo premoderno “a distanza di sicurezza”, ritrova allora per Wiesing pieno senso nell’esperienza compiutamente estetica, che non si impone più al percipiente. Difficile non vedere qui, come bene mostra Tonino Griffero nell’introduzione, una critica ai più entusiastici rappresentanti del cosiddetto visual o pictorial turn, convinti del potere fin troppo immersivo delle immagini estetiche.
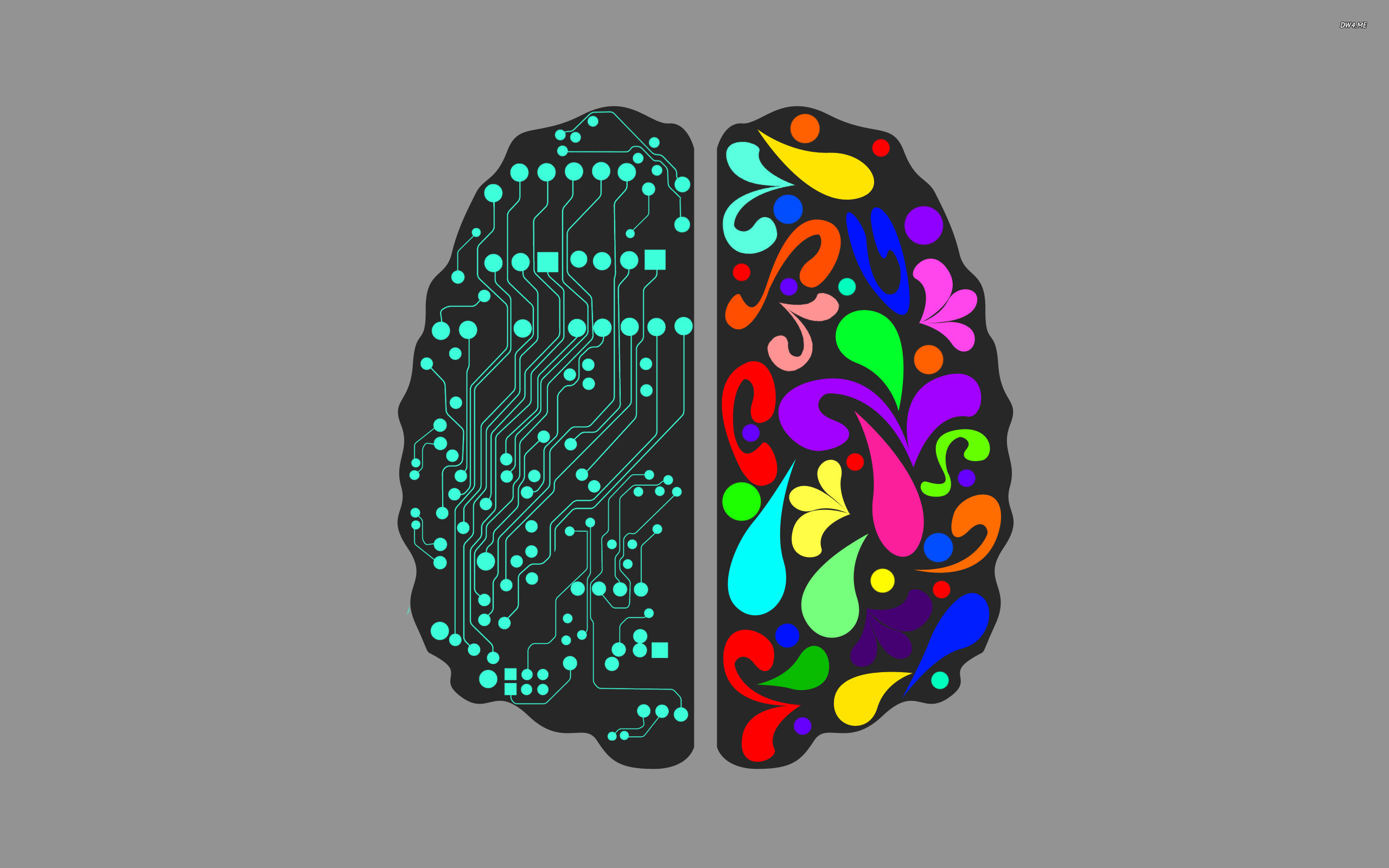
A incorniciare la prospettiva di Wiesing corre per tutto il libro una sorta di pars destruens nei confronti delle molte e differenti prospettive filosofiche che hanno affrontato il problema della percezione. Al di là dell’ovvio tributo pagato a Descartes, Husserl e Merleau-Ponty, Wiesing si impegna a decostruire due grandi rami della ricerca filosofica sull’aisthesis: da un parte i sostenitori del “mito del dato”, dall’empirismo secentesco sino alle sue più attuali recrudescenze neuro-analitiche e dall’altra i sostenitori del “mito del mediato”, da Thomas Reid a Gadamer, passando per Nietzsche e Kant. Sia che si pensi alla datità di un oggetto accessibile immediatamente da parte di un soggetto recettivo, sia che si veda nell’attività interpretante del soggetto l’unico possibile aggancio alla percezione, si ha a che fare, per Wiesing solo e soltanto con ipostasi metafisiche, racconti mitici più o meno riusciti e più o meno efficaci, ma pur sempre costruiti sulla base di modelli ipotetici. Se la scienza non può che procedere per modelli o paradigmi, la filosofia non può che farne un uso soltanto funzionale o euristico; un modello non è altro che un metodo e non può mai, per uno sguardo filosofico serio, assumere un valore di verità. Dalla confusione di verità e metodo nascono allora due prospettive che, pur combattendosi alacremente, affondano in un pregiudizio comune.
Ecco allora che Wiesing ripropone una prospettiva strettamente fenomenologica, senza modelli, capace di ritornare a una descrizione genuina della realtà. Arrivati a questo punto non si può fare a meno di chiedersi se la costellazione percettiva configurata da Wiesing – situazione percettiva antecedente a percipiente e percepito – non finisca tuttavia per essere anch’essa un modello, soprattutto quando fa derivare dalla situazione percettiva una serie di deduzioni che potremmo definire contro-trascendentali. Probabilmente è impossibile praticare un pensiero filosofico senza modelli: ciò che si può tentare di fare è allora verificare ogni volta che il modello non si sganci dal reale, ingenerando una mitologia pericolosa soprattutto in quanto inconsapevole. Quando il modello fenomenologico è ampiamento dissezionato nei suoi fondamenti, come fa Wiesing, si schivano le possibilità di una ricaduta nel mito (pseudo)filosofico. E’ questo, in particolare, il caso dell’intenzionalità, che l’autore trasla su un piano unicamente percettivo e ridefinisce nella sua consistenza relazionale. Forse la stessa fenomenologia, come sta accadendo sempre più spesso, per riproporsi oggi efficacemente, ha bisogno di ridiscutere continuamente i propri presupposti.
***
Come le recenti dichiarazioni del neuroscienziato Giacomo Rizzolatti sulla precisione del pensiero filosofico in ambito scientifico sembrano confermare, l’attenzione della scienza nei confronti della filosofia, e in particolare della fenomenologia, sembra oggi più vivo che mai. In questo contesto, la prospettiva promossa da Wiesing, umile nel richiamo alla protrettica e insieme ambiziosa nel suo universalismo fenomenologico, può allora, riportando intelligentemente al centro della riflessione filosofica l’auto-evidenza della percezione, aprire qualche nuova strada di indagine sull’uomo, vero e proprio animale percettivo.
di Giulio Piatti