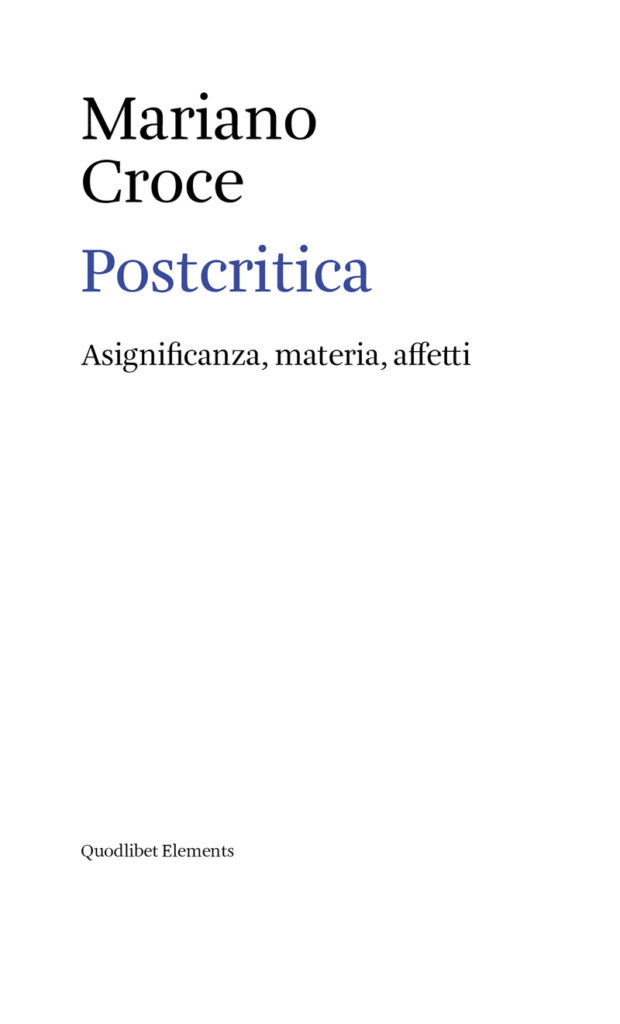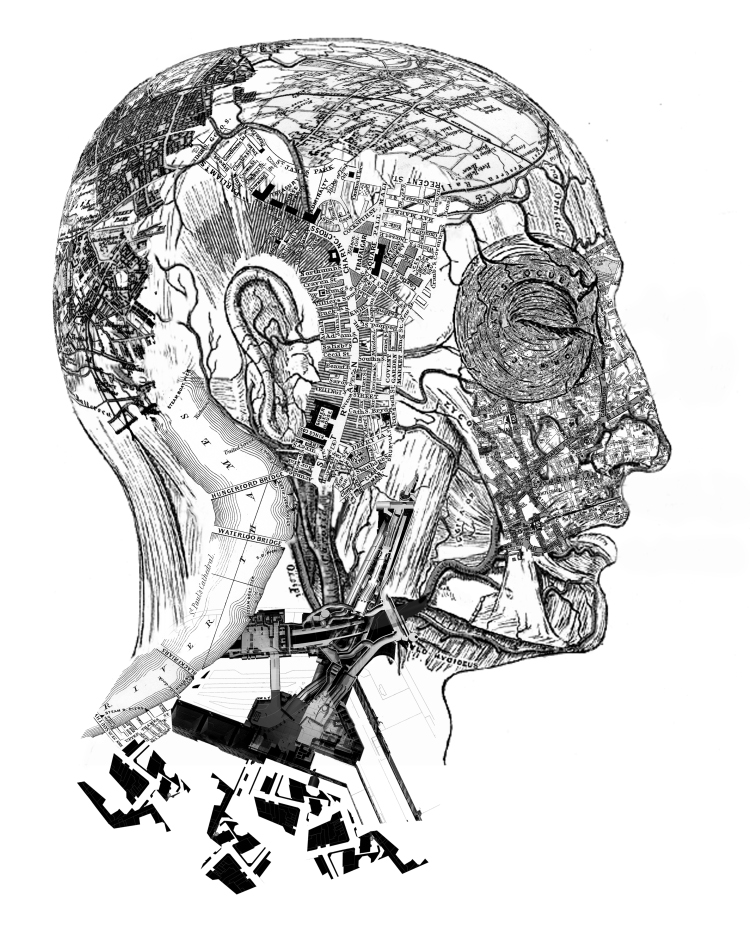«Usare un quintale di tritolo per far saltare un portaombrelli»
Quando si soffre, è difficile non lamentarsi. Di fronte al tribunale della ragione, quando finisce un amore, è arduo non compilare una confessione, facendo del proprio dolore la testimonianza del torto subito dall’altro. Ma nel fare di sé stessi un personaggio tragico, non si può sfuggire più alla propria narrazione, poiché prima di confessare, si giura sempre di dire tutta la verità. Questo libro non è una confessione e in esso non opera sotterraneamente alcuna teodicea.
A sentire Stefano Bonaga, l’amore è una virtù della forza (Sulla disperazione d’amore, Aliberti compagnia editoriale 2019, n. 28; d’ora in poi, tra parentesi, sarà indicato solo il numero dell’aforisma). Ed è proprio la forza che al disperato d’amore manca: quel che gli tocca, che è anche tutto quel che può fare, è cercare di dormire e così di dimenticare. Se la cura non funziona, almeno si otterrà una «amorevole perdita del sé» (84). Restituire la complessa sintomatologia che cataloga l’autore non pertiene a questa sede, anche perché si tratterebbe di spiegare ciò che nel testo viene raccontato, mancando a quel tono che, come si dirà più tardi, è fondamentale all’effetto del testo stesso. Per ora basterà considerare che, a parere di chi scrive, il trattato prende una posizione chiara sulla determinazione del desiderio del disperato: se è la forza che gli manca, è perché la sua disperazione è, spinozianamente, legata alla sua impotenza. La tragedia del disperato d’amore sta tutta in questo annichilimento, che è un assoggettamento dell’oggetto, ma anche e soprattutto del soggetto, in una fossa che rasenta il «nulla della potenza» (83). A esser onesti, però, il disperato può ancora agire, ma solo in maniera coatta (118), e questo fa di lui una macchina che scava nella carne, che produce concatenamenti e che funziona a un regime metaforico (21). A monte, l’autore parte da una considerazione produttiva del desiderio, piuttosto che costruire il suo ragionamento su un desiderio-assenza. La definizione della disperazione risente, di rimando, della stessa matrice filosofica, anche se, nella disperazione, l’unica concatenazione che rimane possibile è quella che opera attraverso una progressiva sottrazione del sé a sé stessi, che ha come scopo quello di lasciare indietro solo la carne, a torturarsi (14). Necessariamente, allora, la ragione si rivela più come un accidente che come una facoltà, la cui potenza è determinata dal caso (71).
La disperazione d’amore, inoltre, come omogeneo effetto di questo posizionamento, guadagna in crudeltà, poiché non si tratterà più di una sofferenza psicologizzata: l’unico suffisso di “psico-” che interessa al disperato è “-pompo” (77). Piuttosto si patisce un dolore del corpo, che impedisce qualsiasi azione, poiché a essere inibita è la potenza. Di più, la doppia articolazione che lega il disperato a chi ama, sta tutta nella costatazione che, sebbene il legame con l’amato sia reciso, non è finito l’effetto fantasmatico della sua presenza. È una legge di proporzionalità inversa quella che lega la forza dell’amato a quella del disperato (38) e più l’altro sembra felice, più il disperato perde la capacità di farci qualcosa.
Sì, però prima o poi la disperazione d’amore finisce, ed è ragionevole immaginare che così accada. Che sia la ragione a legittimare l’immaginario (35) non diminuisce però la sofferenza, poiché l’attesa è vissuta come stagnazione, nell’ordine temporale dell’aion, dell’astrazione cui non si dà rimedio se non eventuale. Di più, anche le parole del suo vocabolario stanno nello stesso tempo astratto, “nulla, essere, sempre, mai” (23). Chiaramente esse soffocano solo chi le pronuncia. Come effetto, inoltre, dell’impotenza di agire ora, il disperato si strugge nel suo desiderio declinato al «congiuntivo passato» (81). E se il tempo del disperato d’amore è astratto, il suo spazio gli è indifferente: risponde così con euforia o depressione motoria, ma in entrambi i casi la «pace logistica» (36) è negata, poiché il disperato è, in fin dei conti, «homeless» (56).
Se però è vero che si può scrivere solo di ciò che non si vuole più nel cuore (18), la scrittura è amica del disperato d’amore. Ed è lo stile particolare che utilizza l’autore che ci piacerebbe qui tematizzare, dato che è proprio questo che permette un certo effetto terapeutico sul lettore. Sebbene infatti l’autore consigli ai disperati di stare alla larga dai poeti, e anzi ci indichi di frequentare le farmacie piuttosto che le biblioteche (73), questo è un libro per i disperati d’amore, scritto da un disperato d’amore. E come si diceva, è facile scadere nel tragico. Ma il tono che regge il trattatello è piuttosto tragicomico, a ben rappresentare la situazione del disperato: paradossale figura per cui è comico considerare la sua una tragedia, rispetto a quella del mondo, ma tragico pensarla comica rispetto al suo sentire (13). La forma del trattato, poi, mimica lo stile di una scienza esatta, di una accumulazione fenomenologica dei sintomi del malato. E, avendo la presunzione di credere che l’autore abbia patito di prima mano di quel che scrive, forse proprio per quell’Alba Parietti con cui si ricorda sempre la relazione, il tono che tende all’oggettivazione prende un gusto differente. Il testo sarà così anche un po’ autoironico, e l’autore addirittura si muove per questo una accusa di mediocrità (102). Al contrario, però, il trattatello suona piuttosto come una esternalizzazione, procedimento deleuzo-guattariano che strappa i sentimenti dalle profonde interiora di un “soggetto”, proiettandoli in un campo di pura esteriorità, facendone così degli affetti (Gilles Deleuze, Félix Guattari, Mille Piani. Capitalismo e schizofrenia, Cooper&Castelvecchi, 2003, p. 500).
A ciò sembra seguire un’altra operazione essenziale perché emerga questo stile così crudelmente divertente, ovvero una oggettivazione dell’esperienza secondo una logica tutta distorta dalla materia che organizza. Come ci ricorda Enzo Melandri, ogni oggettivazione presuppone una irrazionalizzazione uguale e però contraria, cioè di segno opposto: una soggettivazione (La linea e il circolo, Il Mulino, 1968, p. 772). Si capisce perché il disperato abbia bisogno di questo procedimento per espiare il proprio dolore, cioè la propria affezione triste, che lo lascia privo di forza, ha bisogno di oggettivare la propria impossibilità di agire, in modo da permettersi una azione. Che poi le parole di un disperato vengano pubblicate sarà anche osceno, ma sta nell’ordine delle cose umane (19).
Sia chiaro, d’altro canto, che non si trova nel testo di Bonaga alcuna epistemologia “masochista”, se per quest’ultima intendiamo l’attribuzione alla disperazione di un ruolo conoscitivo o di testimonianza, in breve, di un significato. Il dolore non serve, qui come in Pavese, a niente (Il mestiere di vivere, Einaudi, 1973, p. 59). Chi non ci crede, «si merita un boia e un piccolo patibolo, senza tanto clamore, in una esecuzione minore, modesta e sottotono» (50). Nemmeno il “giusto” fa parte di questo «vocabolario della sofferenza» (27), nessuna teodicea, come si diceva, serpeggia tra le parole a far la morale al disperato. Non solo il lettore, così, non si troverà davanti ad un giudice del proprio dolore dal quale difendersi, ma si vedrà piuttosto in uno specchio distorto nel quale non può riconoscersi, seppure vi distingua le proprie forme. Si sopravvive allora, come disperati, un po’ storditi a questa lettura, poiché ridendo di sé stessi, abituati ad essere divisi da sé, ci si trova a ridere della propria disgrazia, invece che continuare a disperarsi. Spaesati dall’immagine che questo specchio ci rimanda indietro, qualcosa accade. Proprio allora si capisce perché «una risata comica seppellirà i disperati d’amore» (94).
di Irene Sottile