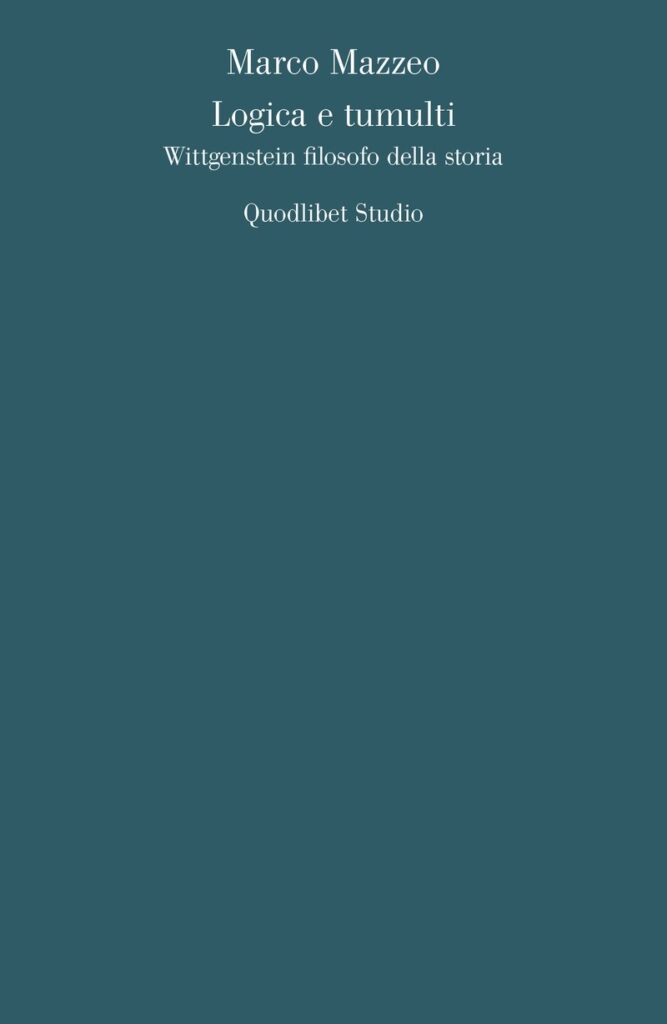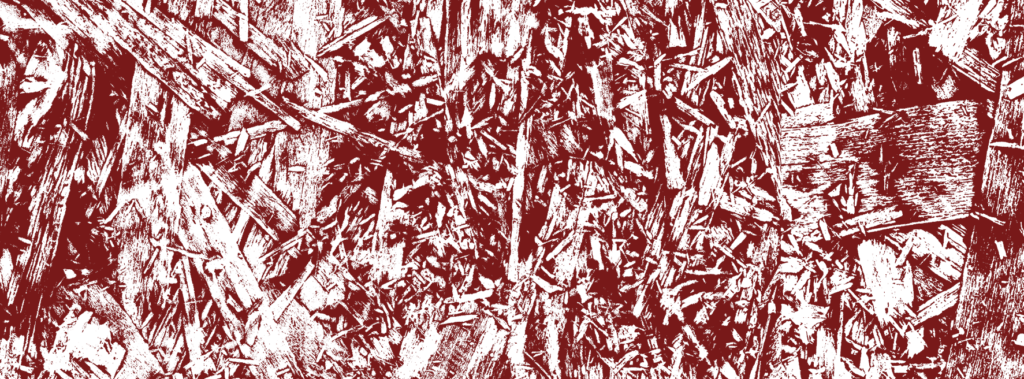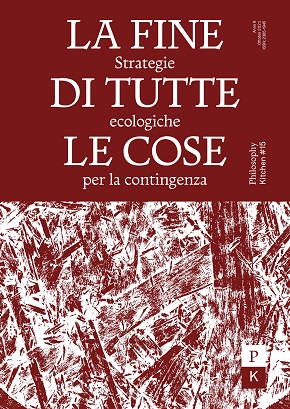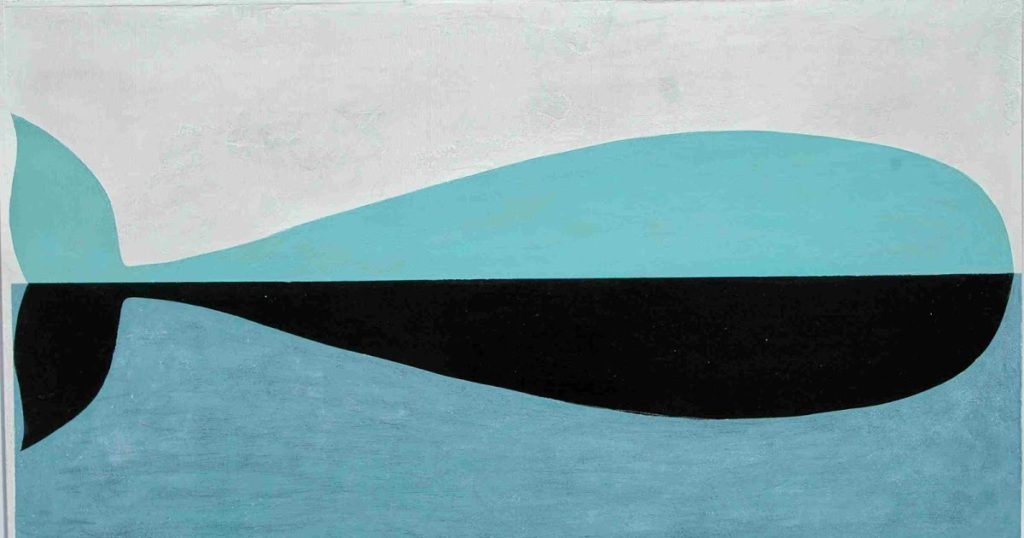-
-
L’impensato. Intervista a N. Katherine Hayles
Longform / Aprile 2022La seguente intervista a N. Katherine Hayles è stata organizzata in occasione della pubblicazione dell'edizione italiana di Unthought The Power of the Cognitive Nonconscious per l'editore Effequ. Studiosa di fama internazionale, direttrice e docente del programma di letteratura presso la Duke University ha fornito un contributo fondamentale al rapporto tra letteratura, scienza e tecnologia. Nel suo ultimo saggio l’autrice pone al centro della riflessione un ripensamento radicale della nozione di cognizione, soprattutto attraverso l’elaborazione dei concetti di cognizione non conscia e assemblaggi cognitivi. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature and Informatics, uscito nel 1999 ma ancora oggi riferimento imprescindibile per chi si occupa di postumanesimo e di posthumanities.
Intervista di Ambra Lulli
Traduzione di Alice Iacobone
Ambra Lulli: Vorrei cominciare facendo un confronto tra il tuo nuovo libro L’impensato e i tuoi lavori meno recenti. In particolare, ho notato che nel L’impensato non viene mai utilizzata la nozione di postumano. Che rapporto c’è tra la riflessione che sviluppi in questo nuovo testo sulla cognizione non conscia e sugli assemblaggi cognitivi e quella sull’interazione tra esseri umani e tecnologia che avevi portato avanti in How We Became Posthuman? Ritieni che le nozioni di postumano e postumanesimo possano essere ancora delle categorie d’analisi critica interessanti o la loro assenza nel tuo nuovo testo indica piuttosto la necessità di un loro superamento?
N. Katherine Hayles: Come sapete, i Posthuman studies sono oggi in una fase molto avanzata e contano dozzine di libri, riviste e raccolte sul tema. Insieme a molti altri autori, considero le categorie di postumanesimo e postumano come d’importanza vitale per l’analisi critica. Al centro del mio interesse per il postumano, iniziato ormai più di vent’anni fa, c’era l’idea che tecnologie computazionali come la realtà virtuale stessero decostruendo il soggetto umanista liberale. Questo processo oggi è in uno stadio ancor più avanzato. Per come lo avevo concepito allora, il postumano non implicava necessariamente un ripensamento delle forme di vita non umane. Gli importanti lavori di Donna Haraway, Cary Wolfe, Timothy Morton e altri hanno reso chiaro che il postumano, come movimento, dovrebbe incidere (e di fatto incide) anche sulle nostre relazioni con altre specie. Se ne L’impensato non menziono il postumano in maniera esplicita è perché il concetto è semplicemente assunto come precursore di nozioni centrali quali l’idea della cognizione nonconscia, dell’emergenza di media computazionali come nostri simbionti contemporanei, dell’importanza degli assemblaggi cognitivi per la vita attuale nelle società sviluppate.
AL: Partiamo dall’inizio del tuo nuovo libro. In particolare, vorrei soffermarmi sul modo in cui inviti a ripensare la cognizione, come sostanzialmente distinta dal pensiero, e in un modo che porta ad estendere questa facoltà a tutte le forme di vita biologiche e a molti sistemi tecnici. In che modo, il ripensamento da te proposto, se da un lato intende avvicinare cognizione umana e tecnica, dall’altro vuole prendere le distanze dal modello cognitivista che interpreta la cognizione come computazione? Inoltre, vorrei soffermarmi sulla nozione di informazione a cui fai riferimento quando proponi questa ridefinizione della cognizione: un “processo che interpreta l’informazione in contesti che la connettono con il significato” (p.45). Mi sembra importante notare che la nozione di informazione a cui fai riferimento si distanzia da quella puramente quantitativa e probabilistica proposta da Shannon e Weaver, per rimanere invece legata a nozioni quali quelle di significato e di interpretazione. Potresti soffermarti anche su questo punto e approfondire la nozione di informazione a cui fai riferimento? Nel testo vengono citati autori come Friedkin e Simondon.
NKH: Fondamentalmente, il paradigma cognitivista affermava che il cervello umano opera come un computer. Io penso invece che questo sia altamente improbabile, considerate le profonde differenze tra media computazionali e cervelli umani dal punto di vista dell’incarnazione [embodiment]. La mia preferenza personale va ai modelli di cognizione incarnata o incorporata, come quelli elaborati da Maturana e Varela in Autopoiesis and Cognition, da Thompson, Varela e Rosch in The Embodied Mind, da Edwin Hutchins in Cognition in the Wild, da Lawrence Barsalou nel suo lavoro sulla “grounded cognition”, per menzionarne solo alcuni. Se certamente sostengo che sia umani che computer abbiano capacità cognitive, d’altra parte però insisto anche sull’importanza della loro diversa incarnazione, che implica maniere differenti di realizzare tali funzioni cognitive. È anche per questo che ho deciso di concentrare la mia ricerca sulla cognizione invece che su, ad esempio, pensiero o intelligenza, nozioni dotate di una lunga storia che le associa esclusivamente all’essere umano. La definizione di cognizione che citate la connette a interpretazione e significato. Sono termini forti nelle discipline umanistiche, e li ho scelti in parte per questa ragione; tuttavia, li uso in una maniera che supera radicalmente le concezioni tradizionali, che storicamente hanno attribuito solo agli esseri umani il diritto di performare l’attività interpretativa e l’attività di significazione. Prendendo le mosse dalla biosemiotica, sostengo che tutti gli esseri biologici, incluse piante e organismi unicellulari, interpretano informazione dai propri ambienti in maniere che sono significative per le loro vite. Come notate, questo uso del termine “informazione” non è lo stesso di quello del concetto promosso da Shannon e Weaver; piuttosto, si avvicina alla “differenza che fa una differenza” di Gregory Bateson e alla nozione di individuazione elaborata da Simondon.
AL: I nuovi materialismi sembrano utilizzare un lessico “deleuziano” (i concetti di forze, affetti, intensità e assemblaggi contingenti) per sottolineare soprattutto il carattere dinamico e profondamente trasformativo della materialità. In questo quadro il soggetto e la cognizione, di cui queste proposte teoriche vorrebbero fare a meno, si configurano come elementi unicamente “conservativi”. Nel quadro teorico da te proposto, e attraverso l’introduzione della nozione di cognizione non-conscia, quale potenziale trasformativo viene affidato invece alla cognizione? Si può sostenere che, attraverso il ripensamento della nozione di cognizione che proponi, è possibile considerare la complessità come il prodotto di azioni/ dinamiche cognitive?
NKH: Dal mio punto di vista, il carattere trasformativo della materialità ha indubbiamente agency, basti pensare a fenomeni che vanno dalla lenta erosione delle rocce fino alle violente eruzioni dei vulcani. Per questo parlo delle forze materiali nei termini di agenti. Ciò che le forze materiali non possono fare, tuttavia, è interpretare l’informazione che viene dai loro ambienti e basare le loro azioni su tali interpretazioni. L’eruzione di un vulcano, le roboanti fratture di una valanga, la violenta formazione di un uragano si possono comprendere come la somma totale delle forze rilevanti che agiscono in quel momento. Queste forze non possono decidere di seguire un percorso differente – di aspettare che gli sciatori abbiano abbandonato le piste, ad esempio, o di investire un campo deserto invece che una città affollata. Manca loro la capacità di selezione e scelta, funzioni che tutte le forme di vita hanno, persino le più umili. In breve, le forze materiali sono agenti ma non attori, precisamente perché mancano di capacità cognitive. Gli organismi certamente hanno una propensione per l’aspetto “conservativo” nella misura in cui mirano a perpetuare la propria esistenza. Tutto lo studio dell’omeostasi è un tributo a questa idea, un’indagine dei modi in cui i corpi viventi si stabilizzano in ambienti in mutamento. Senza dubbio è per questo che Deleuze e Guattari dichiararono che i loro scritti erano contro l’organismo, il segno, il soggetto. Allo stesso tempo, però, gli organismi possono essere infinitamente creativi, come la storia dell’evoluzione ci mostra. Le rocce possono essere compresse o frantumate, traslate o fratturate, ma non possono essere altro che rocce. Gli esseri viventi, al contrario, costantemente divengono altro da ciò che sono, creando nuove cellule mentre quelle vecchie muoiono, producendo nuovi anticorpi per combattere le malattie, inventando nuovi comportamenti al mutare delle condizioni. Più un organismo è dotato di capacità cognitive, più sarà capace di invenzioni radicali. Gli esseri umani sono ovviamente il massimo emblema di questa affermazione, ma anche altre specie esibiscono notevoli capacità di trasformare sé stesse e i propri ambienti, basti pensare ai casi in cui un albero sviluppa una tossina specifica contro un parassita mai incontrato prima. Quando molteplici attori interagiscono gli uni con gli altri nel proprio ambiente, invariabilmente si ottengono delle dinamiche complesse. Questi attori non sono necessariamente dotati di coscienza, possono anche fare uso di cognizione nonconscia. Inoltre, anche per gli esseri umani, la cognizione nonconscia svolge funzioni cruciali affinché la coscienza possa operare. Dal mio punto di vista, la cognizione nonconscia rende conto della maggior parte della cognizione umana, incluse quelle funzioni spesso date per scontate come mantenere una rappresentazione corporea coerente, adattare postura e respiro alle condizioni presenti, rispondere a segni e segnali sotto la soglia della coscienza, coordinare stati emotivi e attenzione.
AL: Quali sono le implicazioni del decidere di utilizzare la nozione di “assemblaggio cognitivo” piuttosto che di rete? Mi sembra che parlare di assemblaggio ci consenta di evitare la reificazione delle interconnessioni tra agenti, considerando gli assemblaggi sempre appunto come “provvisori”, ma al tempo stesso la differenza sta nel tipo di “materialità” coinvolta. Gli assemblaggi, a differenza delle reti, sembrano fare riferimento a una materialità “carnale”, tridimensionale, che oppone resistenza e che ha a che fare con il “toccare, il respingere e il mutare” (p. 209). Potresti approfondire questo punto?
NKH: Come suggerite, un assemblaggio è più flessibile e transitorio di una rete, il che lo rende una scelta migliore dal mio punto di vista. Gli assemblaggi cognitivi sono collettività che includono umani, non umani e media computazionali, che interagiscono tutti grazie alle loro capacità cognitive. Un esempio potrebbe essere quello di quando parli al cellulare, ad esempio al tuo cane quando sei via da casa: qui si uniscono la tua cognizione, le capacità computazionali del telefono e ovviamente il tuo cane, quando inclina la testa in quel suo modo grazioso. Quando chiudi la chiamata e vai al computer, entri in un altro assemblaggio che coinvolge la macchina, le connessioni di rete, un server remoto e così via. Entrando in automobile sei in un altro assemblaggio ancora, che comprende le capacità computazionali dell’auto, i sensori della strada, i tempi dei semafori, eccetera. Come Giano, gli assemblaggi cognitivi hanno due facce. Una faccia è rivolta verso il flusso dell’informazione, l’altra verso la materialità degli enti dell’assemblaggio, ovvero le loro qualità “carnali” (per ciò che riguarda gli enti biologici) e le loro istanziazioni in metallo e silicone (nel caso dei media computazionali). L’incarnazione determina il modo in cui si dà il flusso d’informazione, per questo non possiamo comprendere l’aspetto astratto senza prendere in considerazione il lato materico.
AL: Con la nozione di assemblaggi cognitivi, sembri soprattutto voler sottolineare la situazione di densa embricazione e simbiosi, di interazione e comunicazione ormai pervasive tra cognizione umana e sistemi tecnici. La cognizione tecnica sembra avere un ruolo cruciale nelle nostre forme di vita (si pensi, ad esempio, alle cognizioni tecniche a cui è interamente affidata la gestione del traffico in una città come Los Angeles) e conseguenze enormi sulle società e le culture umane. La prospettiva sembra quindi essere quella di una coevoluzione, di una relazione simbiotica in cui per ognuno dei simbionti coinvolti risulta impossibile pensare di prosperare senza l’altro. A quali differenti visioni politiche ed etiche portano una concezione, come la tua, che sottolinea la stretta interdipendenza tra cognizioni umane e tecniche, rispetto a una concezione che considera plausibile per il soggetto umano la possibilità di “svincolarsi” dalla fitta rete di cognizioni tecniche che costituiscono la sua ecologia cognitiva? La pervasività della cognizione tecnica e la sempre maggiore autonomia dei media computazionali si associa a forme di controllo sempre più efficaci, con i problemi e i costi che queste implicano. Di fronte a questa prospettiva, non si dovrebbe forse poter pensare alla possibilità di “interrompere” o “disturbare” il flusso continuo di informazioni e di comunicazione? Non si dovrebbe, cioè, pensare il rapporto tra esseri umani e sistemi tecnici anche in termini di conflitto oltre che di simbiosi?
NKH: Tecnicamente, la definizione biologica di simbiosi comprende anche il parassitismo e altre forme di associazione distruttiva. I sistemi tecnici possono indubbiamente essere causa sia di conflitto che di simbiosi. Pensiamo all’operaio lasciato a casa perché un robot industriale ha preso il suo posto in fabbrica, o all’accusato che viene incarcerato ingiustamente invece di essere messo in libertà vigilata perché un algoritmo responsabile delle condanne reputa probabile che sarebbe un recidivo. Dal mio punto di vista, ci sono molti casi in cui dovrebbero essere gli umani, e non gli algoritmi, a prendere le decisioni. Ma dobbiamo anche tenere a mente che pure gli umani sono lungi dall’essere infallibili e sono portatori di pregiudizi espliciti ed impliciti. Per me, la maggiore differenza tra decisioni algoritmiche e giudizio umano rimane quella evidenziata da Hubert Dreyfus quasi cinquant’anni fa: gli esseri umani hanno una più ampia e comprensiva visione del mondo. In realtà, si potrebbe dire con Dreyfus che noi abbiamo un mondo, mentre gli algoritmi hanno solo dati immessi al loro interno. Nei dibattiti contemporanei c’è un gran numero di voci che esortano all’interruzione e all’alterazione, a volte mostrando una scarsa comprensione di cosa i computer realmente fanno. Sono d’accordo sul fatto che questa sia spesso una tattica necessaria, ma penso anche che sia ugualmente importante mettere in atto tattiche e strategie di decostruzione dell’antropocentrismo, compresa la convinzione che gli umani siano superiori ed abbiano il diritto di dominare su tutto il resto, anche sulle altre specie e sulle intelligenze artificiali. Data l’urgenza della crisi ambientale attuale, ci occorrono diversi modi di concepire il mondo e la nostra relazione con esso. Abbandonare l’antropocentrismo è un modo per conseguire questo obiettivo. Lo sostituirei con ciò che chiamo “reciprocità ecologica”, evidenziando le relazioni tra gli esseri umani, i viventi non umani e i media computazionali.
AL: Parlando degli algoritmi di trading automatizzato, metti in luce come l’operare della cognizione tecnica in questo caso avvenga sfruttando temporalità inaccessibili alla cognizione cosciente, e come ciò costituisca un’ “ecologia cognitiva algoritmica di sole macchine”. I modi in cui gli umani possono interagire con queste ecologie di sole macchine, in modo da correggerle secondo criteri etici (penso, ad esempio, all’andamento dei mercati finanziari) hanno più a che fare con l’intervento in quelli che definisci “punti di flesso”, piuttosto che con la regolamentazione. Si tratta di un’opzione di controllo “debole” su processi che rimangono fondamentalmente ingovernabili, contrapposta all’idea di un controllo “forte”? In che modo tutto ciò ci porta a un necessario ripensamento del paradigma cibernetico, che vedeva nei cicli di feedback la chiave per il controllo e l’autocontrollo delle tecnologie cognitive? Sembra che i cicli di feedback di cui parlava la cibernetica abbiano assunto le sembianze di cicli ricorsivi in grado di generare grande complessità e impredicibilità, trasformando gli ambienti in cui queste tecnologie cognitive operano in ambienti fortemente instabili, potenzialmente soggetti a rapide rotture e crisi improvvise.
NKH: Non sono contraria alla regolamentazione, ma tutto dipende dal tipo di regolamentazione proposta e da quali conseguenze, desiderate e indesiderate, essa potrebbe avere. Nel capitolo sugli algoritmi di trading discuto alcune proposte di riforma del processo di trading automatizzato che operano non attraverso la regolamentazione governativa, che si è dimostrata inefficace o addirittura controproducente, ma attraverso il cambiamento delle condizioni in cui si effettuano le transazioni, ad esempio rallentandole intenzionalmente. Immagino che questo si possa chiamare “controllo debole”, ma non sono sicura di come potrebbe configurarsi un “controllo forte” – forse nel modo in cui la Cina gestisce i propri mercati azionari? Come sapete, i cicli di retroazione [feedback loop] del paradigma cibernetico possono essere sia negativi, tendendo ad attenuare e bilanciare le oscillazioni nel sistema, o positivi, accentuando le fluttuazioni fino al punto di rottura. Nei sistemi biologici, si danno entrambi i tipi di feedback loop. Probabilmente un qualche tipo di equilibrio tra i due è necessario per qualsiasi sistema complesso, sia esso biologico o tecnico. La troppa stasi e creatività è repressa; un’eccessiva fluttuazione e l’intero sistema potrebbe collassare. Il trucco è trovare la giusta combinazione che possa portare a trasformazioni positive.
AL: La contingenza e l’imprevedibilità sembrano avere, nel tuo libro, anche un potenziale liberatorio: ciò emerge soprattutto nei capitoli 7 e 8, quando esplori il potenziale utopico degli assemblaggi cognitivi. Come “inconoscibile”, la contingenza al cuore degli assemblaggi cognitivi è al centro della tua interessante analisi del romanzo L’intuizionista di Colson Whitehead. Scegliendo come chiavi di lettura per interpretare il romanzo il problema dell’arresto di Turing e i problemi di incompletezza di Godel, l’ “inconoscibile” e il “non computabile” sembrano investiti della speranza in un futuro più giusto. Potresti soffermarti su questo punto e spiegarci meglio in che modo intendi questo potenziale utopico e liberatorio degli assemblaggi cognitivi?
NKH: Il mondo reale è costellato di contingenze e eventi imprevedibili, che possono essere sia liberatori che devastanti – un vento può permettere al navigante di entrare in porto o può essere così violento da strappare via le case. Nei mondi artificiali dei media computazionali la contingenza e l’imprevedibilità devono invece essere integrate, con un’importante eccezione. Come M. Beatrice Fazi evidenzia, l’impossibilità dimostrata da Turing di trovare una soluzione generale al problema dell’arresto – ovvero, il fatto che non si possa prevedere in anticipo se un determinato algoritmo si fermerà o se verrà eseguito per sempre – apre uno spazio per la contingenza persino entro le operazioni apparentemente deterministiche di un computer. Fazi mette questa contingenza computazionale in relazione con il virtuale di Deleuze e le occasioni reali di Whitehead. Persino le reti neurali non sfuggono al problema dell’arresto, perché ancora lavorano attraverso astrazioni computazionali che cercano di sistematizzare gli aspetti della realtà. È stato mostrato che il teorema di Gödel e il problema dell’arresto sono interconvertibili (cioè, partendo da uno qualunque dei due, l’altro può essere inferito da esso). Lo stesso Gödel ha sottolineato che le limitazioni articolate nei due teoremi si riferiscono solo ai sistemi formali (ad esempio, ai sistemi aritmetici) e non al pensiero umano in sé, che secondo lui potrebbe spaziare liberamente in regioni in cui la computazione non arriva (per come la mette Turing, i numeri incommensurabili). È interessante notare come nel suo articolo del 1936 sul problema dell’arresto, Turing abbia provato che l’insieme dei numeri computabili ha la stessa dimensione dell’insieme dei numeri naturali o contabili. Entrambi sono molto più piccoli dell’insieme dei numeri reali, che è più ampio di vari ordini di grandezza. Da questo punto di vista, il campo del computabile è molto più piccolo del campo del pensabile (per gli umani). Gli esseri umani possono inventare i computer, ma i computer non possono inventare gli esseri umani.
AL: Sembra che il potenziale utopico del non-conscio cognitivo abbia il significato, per te, anche di una “speranza” che riguarda il futuro degli studi umanistici. In particolare, sembri auspicare la possibilità per gli studi umanistici, grazie all’introduzione del non-conscio cognitivo, di uscire dall’isolamento che li caratterizza, e di poter invece cominciare ad apportare decisivi contributi a discipline scientifiche quali ad esempio l’informatica, l’ingegneria elettrica, l’architettura o perfino l’economia. Quali sono esattamente, secondo te, le poste in gioco etiche e politiche di questa ibridazione disciplinare e di questa riarticolazione dei rapporti tra saperi all’insegna della profonda interazione e necessaria interdipendenza? Ciò richiederebbe agli studi umanistici una conversione dei propri paradigmi talmente profonda da poter essere considerata una vera e propria “rottura epistemica”, come tu stessa sostieni. C’è anche qualcosa che potrebbe andare perso per gli studi umanistici, in termini di capacità di incidere sul nostro presente e futuro, all’interno di questa nuova ecologia disciplinare?
NKH: Le scienze si interrogano sempre sul “cosa?” e spesso sul “come?”, ma solo molto raramente si domandano “perché?” o “che cosa significa questo?”. Tradizionalmente queste domande sono appannaggio degli studi umanistici, con lunghe e ricche tradizioni in filosofia, scienze delle religioni, letteratura, etica, e altre discipline. Con l’espansione costante della tecnosfera, le domande legate al “perché?” e al “dovremmo?” (distinte da quelle come “saremmo in grado?”) stanno diventando sempre più urgenti. Gli studiosi di discipline umanistiche hanno la competenza e la conoscenza necessarie per produrre importanti contributi su questi temi. Alcune aree degli studi umanistici che sono in rapida espansione, come gli Animal studies e le Environmental Humanities, hanno già offerto contributi importanti per l’avanzamento in ambito tecnico e scientifico, spaziando dalla gestione degli animali di laboratorio a una più profonda comprensione dell’importanza delle relazioni ecologiche in generale. Tuttavia, gli umanisti devono anche comprendere che intervenire in ambito tecnico e scientifico realizzando interazioni efficaci ha il suo prezzo. Come gli attivisti contro l’AIDS hanno presto capito, interventi riusciti con protocolli tecnici e scientifici richiedono di apprendere le basi del campo d’interesse. La comunicazione richiede un lessico comune, o almeno una zona d’intersezione linguistica. Sono convinta che l’interazione coi saperi tecnici e scientifici contribuirebbe anche a creare un atteggiamento di scetticismo da parte delle discipline umanistiche nei confronti dei loro stessi eccessi, il che dal mio punto di vista avrebbe effetti benefici. In questa prospettiva ci sono dunque vantaggi per le scienze e le tecnologie nel relazionarsi con le discipline umanistiche e vantaggi per le discipline umanistiche nel confrontarsi con le scienze e le tecnologie. Perché non dovremmo volerlo?
Intervista di Ambra Lulli
Traduzione di Alice Iacobone
-
Il libro di Manlio Iofrida, Per un paradigma del corpo: una rifondazione filosofica dell’ecologia, uscito per Quodlibet alla fine del 2019, si presenta come uno snodo ricco e importante per un approccio teoretico, etico e critico all’attuale questione ecologica. In questo senso, il libro s’inserisce nel cuore stesso del dibattito – non solo italiano – incrociando tematiche come il corpo, il concetto di Natura, lo statuto filosofico del vivente e della sua relazione con la tecnica (a questi temi si aggiungano la critica della cultura, la storia dell’arte, il dialogo tra filosofia e altri campi del sapere, i rapporti tra la cultura Europea e i suoi grandi altri ecc.).
Il libro assume quella che potremmo definire un’ottica cosmopolitica e si presenta come il crocevia d’intuizioni, idee e riflessioni che animano il gruppo di ricerca Officine Filosofiche (il gruppo gestisce anche un’omonima collana editoriale), fondato e diretto dallo stesso Iofrida assieme a Ubaldo Fadini. Molti argomenti sviluppati nel libro intrecciano le principali linee di lavoro del gruppo, contribuendo così a fare dell’ecologia filosofica uno dei campi di ricerca più innovativi e stimolanti dell’attuale panorama filosofico italiano.
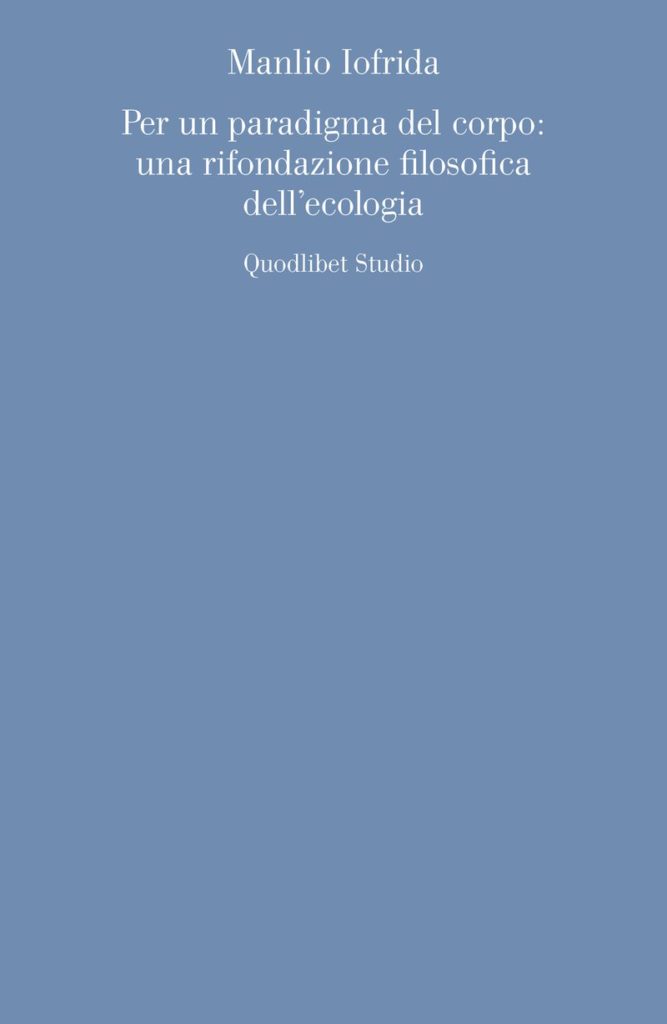
Si può dunque comprendere, sin da queste prime considerazioni, che riportare in maniera analitica o anche solo accidentale tutti gli impliciti teorici – nonché la profonda erudizione dell’autore che conferisce all’ecologia un ampio spessore culturale – è compito improbo per una recensione e, probabilmente, anche inutile. Quel che ci proponiamo di fare in questa sede è di attraversare il testo in maniera “libera” tentando di esplicitare alcuni aspetti che sembrano restituire, nella parzialità della nostra lettura, alcune delle intenzioni di base dell’autore.
Non si può non partire dalla centralità teorica del tema del corpo che, non nuova nel lavoro di Iofrida, si richiama esplicitamente all’opera complessiva di Merleau-Ponty e all’attualità del suo concetto di Natura (pp. 19-31) «come limite che la cultura non può sorpassare» (p. 30). Sotto tale aspetto, questo studio si riallaccia (pp. 9-16), pur con oltre dieci anni di distanza, al precedente lavoro dell’autore Per una storia della filosofia francese contemporanea: da Jacques Derrida a Maurice Merleau-Ponty. Dire che questo sia un libro “merleau-pontyano” è senza dubbio corretto e tuttavia rischierebbe di schiacciarne la profondità su un “arroccamento” teorico, una semplice riproposizione ermeneutica. Devono essere menzionati, infatti, almeno altri due autori classici presenti come linee di basso nell’architettura del testo: Schelling ritorna diffusamente nel testo, utilizzato in chiave anti fichtiana-attualista (pp. 38, 141) o hegeliano-sintetico (anche se Hegel resta comunque un autore importante nell’impostazione ecologica iofridiana, pp. 138-140); ma è soprattutto il Kant della Critica della facoltà di giudizio a fornire un’impalcatura teorica di primo piano (vanno, poi, almeno ricordati i nomi di Goethe, Schiller e Adorno, per completare la batteria tedesca di riferimento, cfr. pp. 47-52). Ci sia concesso dunque di entrare nel vivo del libro approcciandolo alla lontana, così da poter restituire, se non altro, il profumo della complessa architettonica di Iofrida.
In siffatta architettonica, l’ecologia non si presenta tanto, né solo, come una disciplina scientifica (pp. 45-47) ma, potremmo dire, si tratta di una questione di gusto, di istituire un paradigma del gusto ecologico. Come si può intuire, molto lessico di Iofrida è intriso di una semantica post-kantiana. Il gusto, permettendoci l’ardire di parafrasare Kant, è quella strana facoltà di giudicare secondo sentimento (leggendo in questa chiave il giudizio riflettente).
Sappiamo anche che il sentimento è un vero e proprio mondo intermedio che si situa tra la facoltà di conoscere e quella di desiderare, ossia tra l’intelletto e la ragione, tra la “necessità naturale” e la “libertà umana” (che Iofrida definisce prometeica, cfr. pp. 59-61). Dire, dunque, che l’ecologia è questione di gusto significa affermare che essa si situa nel mezzo di un’ardita relazione tra la Natura e la Cultura – dualismo principale di molte riflessioni ecologiche. Ma, altresì, ci dà delle informazioni sugli aspetti “filosofici” dell’ecologia: il gusto, sappiamo dal §40 sul senso comune della Terza Critica, va educato. L’ecologia, secondo Iofrida, non consiste né nella descrizione di uno stato di cose oggettive (ci sia concessa la banalizzazione: filosoficamente, l’ecologia non può essere ridotta a una disciplina naturalistica) né, occorre fare attenzione, nella prescrizione di massime della ragione (che si limiterebbe a un greenwashing della Ragion Pura Pratica): l’ecologia è filosoficamente fondata nella misura in cui è capace di una vera e propria educazione sentimentale. Così, l’ecologia filosofica non è né scientifica (occorre «declinare l’ecologia come critica anti-intellettualista», p. 54) né morale («non si pone come sussunzione dominante», p. 119), ma è intimamente etica (l’ecologia, ci ricorda l’autore, è un pensiero della finitezza, pp. 52-56). È a partire da una esigenza etica (e, con Merleau-Ponty, connesso a un certo spinozismo schellinghiano, da un’esigenza anche ontologica) che va letta la proposta di un paradigma del corpo. Non si tratta, così, di fondare un principio di rappresentazione, o massime pratiche, ma di sviluppare delle ipotesi etiche, per dir così, da un punto di vista pragmatico.

Maurice Merleau-Ponty Fatta questa premessa, possiamo addentrarci in alcuni aspetti concettuali. Uno dei concetti chiave per leggere la proposta iofridiana è quello di inerenza (pp. 29-31). Di matrice fenomenologica, l’inerenza è un fenomeno corporeo e rimanda a una «ontologia relazionale» (p. 41) che si pone in antitesi tanto con le ontologie costruttiviste del pensiero debole (p. 43) quanto con le ontologie realiste di certi modi di intendere il materialismo (pp. 60-61). L’inerenza è il concetto cardine di un’ecologia che si propone di lavorare in chiave ontologica sulla «nostra relazione coi milieux» (p. 41) – i riferimenti sono alla «geografia […] fenomenologica» (p. 39) di A. Berque: la relazione degli “individui” con gli ambienti (o paesaggi) «non è quella della sostanza pensante con la sostanza estesa; […] piuttosto c’è uno sconfinamento, un’interpenetrazione» (p. 41). L’inerenza ci offre una cifra filosofica importante: essa è la relazione chiasmatica – è evidente nel lessico iofridiano l’influenza di Merleau-Ponty – del vivente con i suoi dintorni, le sue Umwelten, il co-appartenersi di individuo e ambiente. Intreccio, potremmo dire, della parte con il tutto.
In quanto etica ontologicamente orientata, l’ecologia si interessa non alle partizioni sostanziali – che comportano, sul piano etico, la costruzione di un’impalcatura morale – bensì agli assunti relazionali (ci sia concessa un’assonanza col lavoro di Giuseppe Semerari 2009) che solo centrando l’analisi filosofica sulle potenze corporee possono essere messi in risalto. Questa inerenza, che è una mediazione senza soggetto – e che anzi produce soggettività – non è pensabile come Aufhebung, bensì come un’unità senza concetto (p. 115) attuata per il tramite del corpo «e la sua apprensione orizzontale del mondo» (p. 25). L’esigenza di un paradigma del corpo è dunque insito nella tematica stessa della relazione ecologica, così che, per Iofrida, ogni ecologia, sul piano etico, non può non passare – anche implicitamente, come traspare mediante la critica alla smaterializzazione postmoderna (pp. 67-68) – per il tramite di un paradigma del corpo.
Il problema del corpo è però l’altra faccia di un ulteriore assunto di Iofrida, ovvero l’idea complementare che la Natura non sia un oggetto (p. 45) e che il vivente non sia meccanizzabile (p. 30). Il rischio di interpretare in chiave puramente valoriale, facendo di tali assunti delle massime della Ragione, è grosso. Occorre dunque tentare di essere chiari, ancora una volta, sul lessico dell’autore. Siamo pur sempre, lo si è detto, sul piano del giudizio riflettente. I riferimenti sono ancora all’opera di Merleau-Ponty e, tramite lui, Schelling e Kant. In ultima istanza, l’orizzonte concettuale ci appare ancora di matrice kantiana. L’idea che il vivente non sia meccanizzabile vuol dire che lo specifico fenomeno di inerenza dell’umano agli altri viventi (che compongono i suoi dintorni) non è un rapporto conoscitivo, o intellettuale, né tuttavia un rapporto pratico. Non è conoscitivo perché, in quanto soggetti empirici, non tutti gli umani sono “scienziati”, e questo non pone particolari problemi. Ma non è neppure un rapporto pratico, perché non è possibile estrapolare una massima categorica da questa idea: non tutti i viventi possono agire conformemente a scopi (tralasciamo i motivi di tale impossibilità). L’idea che il vivente non sia meccanizzabile non è un enunciato che riguardi il regno della libertà. Concessa la formula, quella tra viventi non è una relazione tra esseri (radicalmente) liberi, situandosi, invece, nel regno intermedio tra la necessità dell’oggetto naturale e la libertà radicale del soggetto trascendentale (Merleau-Ponty 1996, 312-313).
Il problema del vivente – che possiamo anche chiamare, se ci è concesso, il problema della finalità senza scopo – è un problema sentimentale e affettivo. È ancora un paradigma del corpo che permette di comprenderlo: un corpo è il medium non solo, e non tanto, della natura e della libertà, bensì della inerenza al mondo e agli altri viventi. È mediante il corpo – un’utilità non strumentale – che si è costitutivamente aperti ad altre modalità dell’esistere e del vivere. Una mediazione senza soggetto che si fa nel mezzo delle relazioni inter-individuali: l’inerenza come vero e proprio fenomeno trans-individuale, contatti molteplici e variegati tra corporeità (cfr. Merleau-Ponty 1996, 254-261). Appare, in queste considerazioni, un altro dei concetti cardine della proposta di Iofrida, concetto che crea un ponte col suo lavoro precedente: si tratta della nozione di libertà strutturale. Una concezione strutturale – o ecologica – della libertà comporta che essa non sia la radicale assenza di limiti, bensì che trovi la propria potenza esistenziale ed espressiva nella composizione delle relazioni, nella ricchezza e varietà degli affetti e degli incontri corporei.
È una libertà che non è competenza di una filosofia della prassi, ma di un’etica, come accennato, dal punto di vista pragmatico. Un’ecologia della libertà richiede pratica e attenzione [Aufmerksamkeit] (p. 146), un’educazione sentimentale finalizzata a un uso ragionevole degli affetti. Insomma, la libertà, in una prospettiva ecologicamente orientata, presuppone una capacità tecnica. È in quest’ottica che leggiamo, infatti, la proposta di Iofrida di una tecnica ecologica (pp. 84-90). Si tratta di una formula ambigua, ma le ambiguità spariscono se non usciamo dalla semantica nella quale ci stiamo muovendo. Un tale epiteto, infatti, è lontano da un greenwashing delle attuali configurazioni tecnico-tecnologiche del tardo capitalismo: insomma, non si prospetta la necessità di una Green Economy. Si tratta, invece, di una concezione ecologica della tecnica che tenga conto del portato affettivo – cioè esistenziale e vitale – della tecnica.
In questo senso, una tecnica ecologica è di segno contrario rispetto alle attuali configurazioni produttive (si tratta di uscire dal dualismo manicheo «produzione o libertà», p. 60; andare al di là dell’alleanza demoniaca di capitalismo e schizofrenia, cfr. Pignarre & Stengers 2016) configurandosi invece come rivolta alla convivialità – tra umani e tra umani e non umani – incastonata nella complessità variegata degli ambienti di vita (fondamentale in quest’ottica il capitolo dedicato alla teoria dei sistemi, pp. 121-140). È ancora una semantica del giudizio: la tecnica rimanda all’arte, cioè una tecnica ecologica diventa una vera e propria arte dello stare in vita da parte dei viventi – ecologicamente, vi è tecnica ovunque vi sia fragilità e ostinazione della vita: occorre «concepire l’arte come un nuovo modo di rapportarsi al mondo […] poiché, già in se stessa, tale prassi priva di finalità è un’altra e superiore modalità di azione del nostro corpo vivente rispetto a quella meramente utilitaria, essa può essere punto di partenza di una prassi concreta […] e punto di arrivo di una costruzione dal basso, partecipata, intersoggettiva» (p. 152).
Senza dubbio si tratta di una concezione ottimistica della tecnica: nessuna caduta da un eden ormai perduto, né solo nichilistica distruzione della vita da accettare passivamente come un destino. Si tratta, invece, di un’arte pericolosa, quella dello stare in vita, proprio perché la vita – un vivente – è insieme ostinazione e fragilità: l’educazione sentimentale serve a saper «reggere delle crisi, saper gestire il rischio […], anche se rischio significa appunto che la crisi non è mai del tutto esclusa e che il disordine può avere sempre il sopravvento» (p. 123). È una concezione ecologica e ottimistica della tecnica, sì, ma non è il frutto di una anima bella (ecco comparire una certa ispirazione hegeliana). Rifacendosi al lavoro di Kurt Goldstein (2016), neurologo tedesco del secolo scorso, tra le fonti di Merleau-Ponty, Iofrida ci ricorda che «un organismo vivente, e l’uomo in particolare, è teso ad accrescere continuamente la propria complessità […]; esso cerca dunque la relazione e anche il conflitto, in un mondo in cui l’ordine è sempre un momento precario all’interno di una lotta di forze eterogenee che genera un perenne dinamismo» (p. 127).
Educazione sentimentale, teoria degli affetti e concezione tecnica del vivente: i tre capisaldi che istituiscono la fondazione filosofica dell’ecologia proposta attraverso un paradigma del corpo. Tale paradigma fa sì che un’ecologia filosofica si trovi a proprio agio non nel contemplare un’astratta e fondativa Natura Naturante, un’origine ormai perduta o distrutta dalla cattiveria dell’Uomo, bensì nel concepire modi possibili del vivere in comune, forme collettive di esistenza con i più ampi margini di gioco transindividuali, vincoli che non obbligano capaci di aumentare le potenze esistenziali e le capacità creative dei viventi umani e non (è questo il principale rimando al concetto di natura di Merleau-Ponty). Si tratta di una concezione minoritaria della storia, del divenire minoritario dell’umano, dei suoi affetti, delle sue ibridazioni, delle sue contaminazioni (cfr. Deleuze & Guattari 2015, 349-357). Una storia minore che non ha la Natura come Grande Altro, bensì che è caratterizzata dalla sua inerenza all’elemento naturale, alla sua imprevedibilità, alle sue complessità ontologiche (ma anche epistemologiche, dato che, ecologicamente, l’ontologia è inscindibile da un’epistemologia): si tratta di una storia universale della contingenza (Deleuze & Guattari 2002, 86).
L’ecologia filosofica proposta da un paradigma del corpo è così una filosofia artistica, un’arte, pericolosa e sublime a un tempo, del vivere insieme, del condividere la Terra con altri viventi (l’Autore parla di «un materialismo della Terra», p. 44). Un’arte, per chiudere restituendo il ruolo di Michel Foucault nel nuovo paradigma ecologico (pp. 205-211), che sia una «estetizzazione della vita come progetto condiviso di una comunità di eguali che dialogano e, esercitando la socievolezza, istituiscono con il mondo e gli altri una relazione che non è quella della ragione strumentale, brutalmente utilitaria, ma che può a tutti gli effetti definirsi ecologica: non è il bello quella dimensione sempre mobile di limite in cui ci apriamo al mondo e agli altri non in funzione di un dominio, ma per essere passivi quanto attivi, copresenti in una relazione con l’alterità che può definirsi col termine, anch’esso fenomenologico, di attenzione?» (p. 211).
Bibliografia minima
Deleuze, G. & Guattari, F. (2002; ed or. 1991). Che cos’è la filosofia?. Torino: Einaudi.
Deleuze, G. & Guattari, F. (2015; ed. or. 1980). Mille piani. Capitalismo e schizofrenia 2. Tr. it. G. Passerone. Roma: Castelvecchi.
Goldstein, K. (2016; ed. or. 1934). L’organismo. Un approccio olistico alla biologia derivato dai dati patologici nell’uomo. Tr. it. L. Corsi. Roma: Fioriti.
Merleau-Ponty, M. (1996; ed. or. 1995). La natura. A cura di M. Carbone. Milano: Cortina.
Pignarre, P. & Stengers, I. (2016; ed. or. 2005). Stregoneria capitalista. Pratiche di uscita dal sortilegio. Tr. it. di S. Consigliere e A. Solerio. Milano: IPOC.
Semerari, G. (2009; ed. or. 1961). La filosofia come relazione. Milano: Guerini.
di Gianluca De Fazio
-
 Questo lavoro di Ronchi non può essere ignorato da chi continua o comincia a considerare la filosofia uno sforzo rigoroso e sistematico. Esso, non esito a dire, risponde a una delle domande comunemente dette “da un milione di dollari”: ma la filosofia ci serve oggi? Se sì, in che modo? E risponde non dicendo che è così e perché è così, ma mostrandolo. Apocalissi valoriali, catastrofi culturali, instabilità politiche, identità frantumate, mutamenti sociali, stravolgimenti psicologici, crisi economiche, flussi perpetui, turbolenze costanti, intrecci inestricabili, dinamiche inarrestabili, movimentismi, aperture incessanti, ossessione per la novità, e così via: sembrerebbe questa la cifra della contemporaneità, di un’epoca in cui trasformazioni e processi sembrano moltiplicarsi in modo quasi asfissiante. Vediamo istituzioni nascenti o fatiscenti, crisi economico-sistemiche, esistenze in costante transizione, affermazione del lifelong learning, moltiplicazione di scoperte scientifiche e di progetti di ricerca in campi nuovi, sommovimenti sociali e politici e chi più ne ha più ne metta. Si tratta di una fase storico-culturale che comincia a essere esplicitamente connotata come «interregno» (C. Bordoni), quasi alla stregua di un limbo perpetuo, di una fase di transizione in atto ma senza un “verso dove”, di un cambiamento in corso ma senza un “verso cosa”, di un post- (modernità, verità, democrazia, guerra, comunità, Stato, …) che rigira su di sé, sospeso tra l’euforia e la fobia per ciò che sarà, come tra il disprezzo e la malinconia per ciò che è stato. Sembrerebbe di vivere in un periodo socio-politico nel quale la depressione si diffonde, intesa come affaticamento esistenziale e proprio in rapporto alla configurazione di un ambiente dove riveste un ruolo centrale la persistenza dello sforzo di configurare il proprio posizionamento, piuttosto che la permanenza di una posizione data (A. Ehrenberg). Simili fenomeni dinamico-relazionali o «d’intorno», per dirla con E. Morin, sembrano aprire almeno tre tipi di interrogativi.
Questo lavoro di Ronchi non può essere ignorato da chi continua o comincia a considerare la filosofia uno sforzo rigoroso e sistematico. Esso, non esito a dire, risponde a una delle domande comunemente dette “da un milione di dollari”: ma la filosofia ci serve oggi? Se sì, in che modo? E risponde non dicendo che è così e perché è così, ma mostrandolo. Apocalissi valoriali, catastrofi culturali, instabilità politiche, identità frantumate, mutamenti sociali, stravolgimenti psicologici, crisi economiche, flussi perpetui, turbolenze costanti, intrecci inestricabili, dinamiche inarrestabili, movimentismi, aperture incessanti, ossessione per la novità, e così via: sembrerebbe questa la cifra della contemporaneità, di un’epoca in cui trasformazioni e processi sembrano moltiplicarsi in modo quasi asfissiante. Vediamo istituzioni nascenti o fatiscenti, crisi economico-sistemiche, esistenze in costante transizione, affermazione del lifelong learning, moltiplicazione di scoperte scientifiche e di progetti di ricerca in campi nuovi, sommovimenti sociali e politici e chi più ne ha più ne metta. Si tratta di una fase storico-culturale che comincia a essere esplicitamente connotata come «interregno» (C. Bordoni), quasi alla stregua di un limbo perpetuo, di una fase di transizione in atto ma senza un “verso dove”, di un cambiamento in corso ma senza un “verso cosa”, di un post- (modernità, verità, democrazia, guerra, comunità, Stato, …) che rigira su di sé, sospeso tra l’euforia e la fobia per ciò che sarà, come tra il disprezzo e la malinconia per ciò che è stato. Sembrerebbe di vivere in un periodo socio-politico nel quale la depressione si diffonde, intesa come affaticamento esistenziale e proprio in rapporto alla configurazione di un ambiente dove riveste un ruolo centrale la persistenza dello sforzo di configurare il proprio posizionamento, piuttosto che la permanenza di una posizione data (A. Ehrenberg). Simili fenomeni dinamico-relazionali o «d’intorno», per dirla con E. Morin, sembrano aprire almeno tre tipi di interrogativi.