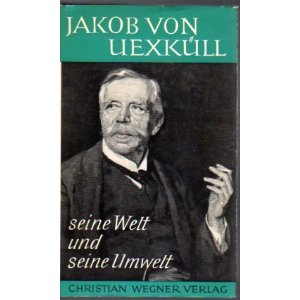Se guardiamo una delle nostre mani, siamo per lo più portati ad avere percezione netta o della totalità della mano o delle cinque dita, senza renderci conto dello spazio tra le dita, il quale – a ben pensarci – è ciò che costituisce la mano in quanto mano, le dita in quanto dita separate e mobili. Non è un caso se non abbiamo nemmeno una parola specifica per indicare tale spazio.
Se guardiamo una delle nostre mani, siamo per lo più portati ad avere percezione netta o della totalità della mano o delle cinque dita, senza renderci conto dello spazio tra le dita, il quale – a ben pensarci – è ciò che costituisce la mano in quanto mano, le dita in quanto dita separate e mobili. Non è un caso se non abbiamo nemmeno una parola specifica per indicare tale spazio.
Ebbene, la questione del transindividuale sta tutta qui: tematizzare la relazione per lasciarsi alle spalle tanto l’individualismo (la mano è la sommatoria delle singole dita) quanto l’organicismo (la mano è innanzitutto una totalità). Il voluminoso collettaneo curato da Étienne Balibar e Vittorio Morfino si occupa proprio di mettere al centro della riflessione la questione della relazione, in particolare rispetto allo statuto del soggetto. Tale problema è indubbiamente uno dei punti nevralgici della riflessione filosofica contemporanea, che dopo aver scoperto nel Novecento la questione dell’alterità, sembra ora concentrata sull’esigenza di non fare anche di questa una nuova forma di monolite, di sostanza assoluta: la relazione approfondisce e riproblematizza l’alterità, che sia nella forma della communitas (Esposito), del cum (Nancy), del rizoma (Deleuze) o appunto del transindividuale.
I termini che compongono il sottotitolo dell’opera possono essere fatti giocare per sintetizzarne il filo conduttore complessivo: i soggetti sono relazioni in mutazione. I soggetti sono significa che la questione della soggettività non è semplicemente cancellata in preda ai furori della fine di, significa cioè che ha una sua consistenza e problematicità da affrontare di petto e soprattutto a partire dal riconoscimento preliminare della pluralità; relazioni significa che non è però più possibile pensare l’essere dei soggetti senza la relazione o – meglio – che la relazione è ciò che persino precede e non segue i soggetti; in mutazione significa che tale essere è consegnato al divenire, che la stabilità della sostanza è consegnata alla dinamicità o metastabilità, ossia che i soggetti – le relazioni – sono processi aperti, non teleologicamente indirizzati.
Il transindividuale è notoriamente un concetto legato specificamente al nome di Simondon, motivo per cui i due curatori nell’introduzione si chiedono se sia possibile parlare più ampiamente di una tradizione del transindividuale, in senso storico e ancor più concettuale: sono in gioco da un lato tutti i tentativi di pensare il rapporto tra individuo e società, mettendo al centro né l’uno né l’altra ma la relazione in quanto tale, e dall’altro lato gli sforzi di desostanzializzare l’ontologia.

Alla traduzione di uno dei più significativi capitoli dell’opera di Muriel Combes su Simondon è assegnato il compito di tracciare le coordinate generali del transindividuale nelle riflessioni simondoniane: il transindividuale si qualifica come relazione di relazioni, come ciò che unifica non l’individuo e la società, bensì una relazione interna all’individuo (individuazione psichica) e una esterna (individuazione collettiva). Pre- e trans-individuale si mostrano così intimamente connessi nella misura in cui il transindividuale è quella carica relazionale che sorge nei soggetti dal di fuori per mettere in moto diverse fasi di un processo di individuazione. Inoltre, viene sottolineato che la prospettiva dinamico-relazionale simondoniana offre i presupposti per un’antropologia non antropocentrica, per la quale le specie viventi si differenziano non in base al possesso di qualità sostanziali o proprietà essenziali, bensì per via di un insieme di condotte in grado di porre differenze di soglie. Si apre cioè la possibilità di un nuovo umanesimo costruito sulle rovine dell’idea di una natura o essenza umana univocamente determinata, muovendo dalla convinzione che non è la specie umana a essere carente o incompleta, bensì sono gli individui umani a esserlo in quanto possiedono una carica di realtà non ancora realizzata e che può essere espressa soltanto passando per il transindividuale. Questo umanesimo dopo la morte dell’uomo si chiede dunque non cosa è l’uomo, ma quanto potenziale ha per andare al di là di se stesso, cosa può in quanto non solo.
Tra i contributi di taglio più prettamente storico-filosofico troviamo quello di Augusto Illuminati, che traccia il filo rosso Averroè-Spinoza-Marx, tramite i concetti di intelletto unico, moltitudine e general intellect; Mariana de Gainza offre dal canto suo una lettura di Spinoza che pur facendo leva sull’interpretazione moltitudinaria e desiderante legata a Deleuze e Negri, si sforza comunque di ridurre il coefficiente di attrito tra una simile declinazione espressivo-affermativa e quella classica di Hegel, maggiormente incentrata su negazione e determinazione; Warren Montag mostra invece il passaggio da un’ontologia e una politica di stampo individualista a quelle di taglio transindividuale attraverso il passaggio dalle aporie della simpatia smithiana alla fecondità della teoria dell’immaginazione e degli affetti spinoziana, per la quale non esiste qualcosa come un rifugio interno in cui isolarsi e fuggire con un corretto esercizio della volontà, ma solo esposizione e relazione tra corpi.
Attraverso il legame Marx-Vygotskij, Felice Cimatti approfondisce proprio le aporie dell’individualismo, mostrando come esse inficino alla radice il programma delle scienze cognitive. Lo scopo è elaborare un materialismo della relazione per il quale l’individuo è l’essere sociale e nel quale un ruolo centrale è giocato dal pensiero verbale, dove il linguaggio diventa intellettivo proprio mentre il pensiero diventa verbale. Poiché l’individuazione è un processo dinamico sempre dotato di carica inespressa, vale a dire che non è compiuta una volta per tutte, si pone il tema politico della completa e sempre rinnovata accessibilità umana di tale processo, ossia la questione di come delle istituzioni possano esprimere il transindividuale senza impoverirlo o cristallizzarlo in un’unica dimensione.
Il tema del linguaggio è ancora più nettamente al centro del testo di Guillaume Sibertin-Blanc, concentrato sul tentativo di pensarne la dimensione sociale nel senso di un insieme di rapporti transindividuali e non di uno spazio di intersoggettività contrattuale o comunicativa, con particolare riferimento alle pagine di Millepiani di Deleuze e Guattari: il perno è il superamento della concezione appropriativa del linguaggio, che appiattisce la produzione di enunciati sul proferimento di atti individuali di cui il soggetto si riconosce come causa. Il soggetto va piuttosto considerato l’effetto di concatenamenti linguistici collettivi in senso transindividuale: ogni enunciato, ben prima di ogni io, fa parlare la totalità del campo sociale.
Il problema del rapporto tra conatus e istituzioni è invece esplicitamente sviluppato dal contributo di Frédéric Lordon, che rinnova il gesto foucaultiano per cui quella del potere non è una questione di essenza (che cos’è il potere) bensì di modalità di funzionamento, arrivando a spiegare che rispetto alla forza desiderante generica e intransitiva che è il conatus, le istituzioni si caratterizzano per il loro potere di affettare, ossia di determinare i conati a prendere una direzione e non un’altra. Più precisamente, un’istituzione è ciò che affetta simultaneamente e identicamente un gran numero di individui, è quanto produce ed è al contempo prodotto da una certa maniera di sentire comune: l’istituzione cattura la potenza della moltitudine, la prende a prestito per darle forma; necessita di essere prodotta a ogni istante e può far fare un gran numero di cose agli affettati, ma non qualsiasi cosa indiscriminatamente. A dire: un potere preso a prestito dalla moltitudine è un potere che non cessa mai di appartenere alla moltitudine, che può sempre essere revocato dai conati.
Analoga sensibilità percorre le pagine di Jason Read che, connettendo il tema del transindividuale a quello del comune, pongono la domanda del soggetto politico e la declinano rispetto alla modalità della produzione di soggettività: si tratta di individuare non tanto un nuovo soggetto politico che possa guidare la rivoluzione o l’emancipazione, bensì un differente posizionamento nelle condizioni date. Si tratta cioè innanzitutto di capire che i modi di produzione sono produttori tanto di un oggetto per il soggetto quanto di un soggetto per l’oggetto, ossia di un habitus soggettivo che diventa seconda natura. Le condizioni pre- e trans-individuali di tale produzione, richiamando le riflessioni di Virno, vengono fatte coincidere con il comune, preso nella tenaglia di reificazione (espressione e messa in forma della sua carica potenziale), alienazione (inespressione di tale carica, che resta implicita e inafferrabile dunque condizionante) e feticizzazione (assegnazione alle cose di qualità e attributi umani, sociali). Se nella feticizzazione la cosa sostituisce la relazione, nella reificazione la cosa è ciò che mette in relazione, mentre l'alienazione rappresenta la perdita non di ciò che vi è di più unico e personale, bensì la scissione del legame con ciò che vi è di più generico e condiviso. La natura generico-relazionale propria degli animali umani, che proprio il capitalismo flessibile-comunicativo di stampo postfordista esporrebbe in quanto tale, pur feticizzando il mercato e alienando il comune, ossia precludendo ogni diversa possibilità individuativa.
L’attenzione a concepire le cose sociali in maniera non sostanziale e feticizzante la ritroviamo anche nelle pagine che Bruno Karsenti dedica alla questione totemica, cercando di riattivare la prospettiva di Durkheim oltre la critica troppo frettolosa di Lévi Strauss: emerge come la socialità non si genera a partire dall’interazione tra singole coscienze, ma si traspone in segni emblematici che rendono possibile l’interazione come esperienza sociale o meglio transindividuale. Lo statuto del Sacro come toccabile-intoccabile è da leggere dunque proprio alla luce del fatto che esso rappresenta quella potenza impersonale che rende possibile le relazioni e la messa in moto dei processi di individuazione.
 Il tema della natura umana e le possibilità di un nuovo umanesimo dopo la morte dell’uomo sono invece il cuore pulsante della rilettura delle Tesi su Feuerbach da parte di Étienne Balibar, che si sofferma soprattutto sul significato che l’espressione francese ensemble assume nella formulazione della sesta tesi. Cercando di rintuzzare le critiche althusseriane a ogni forma di umanesimo teorico e di antropologia filosofica essenzialista, si fa strada l’interpretazione secondo cui se da un lato Marx abbandona senza dubbio ogni prospettiva sostanzialista in favore di un concetto di essenza come processo e attività (praxis), dall’altro lato ciò non comporta affatto l’abbandono di qualsiasi concetto di natura umana. Piuttosto, questa deve essere colta a partire dall’affermazione di una relazionalità sociale dipinta in maniera generica e non già determinata: praxis e relazionalità sociale (ossia transindividualità) fanno tutt’uno nella misura in cui la seconda evita proprio di proporre un modello di completezza, per essere concepita invece come condizione di possibilità di ogni specificazione storica ossia prassica. La relazionalità sociale è dunque orizzontale e indefinita, molteplice ed eterogenea, ossia aperta tanto concettualmente quanto concretamente e, proprio per questo, consegnata al processo storico: Marx propone cioè una concezione della natura umana incentrata non su una rinnovata totalizzazione di attributi o proprietà, ma sulla necessità di una incessante metamorfosi che non può che avvenire relazionalmente. Come antropologicamente gli uomini esistono solo al plurale, così ontologicamente la sostanza esiste solo in maniera relazionale.
Il tema della natura umana e le possibilità di un nuovo umanesimo dopo la morte dell’uomo sono invece il cuore pulsante della rilettura delle Tesi su Feuerbach da parte di Étienne Balibar, che si sofferma soprattutto sul significato che l’espressione francese ensemble assume nella formulazione della sesta tesi. Cercando di rintuzzare le critiche althusseriane a ogni forma di umanesimo teorico e di antropologia filosofica essenzialista, si fa strada l’interpretazione secondo cui se da un lato Marx abbandona senza dubbio ogni prospettiva sostanzialista in favore di un concetto di essenza come processo e attività (praxis), dall’altro lato ciò non comporta affatto l’abbandono di qualsiasi concetto di natura umana. Piuttosto, questa deve essere colta a partire dall’affermazione di una relazionalità sociale dipinta in maniera generica e non già determinata: praxis e relazionalità sociale (ossia transindividualità) fanno tutt’uno nella misura in cui la seconda evita proprio di proporre un modello di completezza, per essere concepita invece come condizione di possibilità di ogni specificazione storica ossia prassica. La relazionalità sociale è dunque orizzontale e indefinita, molteplice ed eterogenea, ossia aperta tanto concettualmente quanto concretamente e, proprio per questo, consegnata al processo storico: Marx propone cioè una concezione della natura umana incentrata non su una rinnovata totalizzazione di attributi o proprietà, ma sulla necessità di una incessante metamorfosi che non può che avvenire relazionalmente. Come antropologicamente gli uomini esistono solo al plurale, così ontologicamente la sostanza esiste solo in maniera relazionale.
A un simile orizzonte, il saggio di Vittorio Morfino aggiunge un ulteriore decisivo elemento: la tematizzazione del transindividuale tra Goldmann e Althusser consente di esplicitare l’esigenza di abbandonare ogni modello teleologico, ossia di non concepire la fine del processo come realizzazione di quanto si trova già all’origine en germe. Il divieto di spiegare il presente in base al futuro e viceversa, ribadito anche dalla logica exattante gouldiana, non si traduce però nella negazione del movimento, della processualità, perché anzi comporta la radicale affermazione della sua immanenza. Insomma, la natura aperta e relazionale umana comporta un processo di espressione e configurazione che non deve essere letto facendo ricorso allo schema circolare e teleologicamente connotato Inizio (paradisiaco o infernale)-Svolgimento-Fine (recupero dalla caduta o redenzione dal male).
Ciò ha conseguenze fondamentali rispetto alla filosofia della storia, che il contributo di Francisco Naishtat sull’ontologia dell’accaduto mette bene in luce, attraverso una critica di quelle teorie dell’azione che rintracciano l’agente da un lato nell’individuo (gli eventi storici come somma di azioni individuali) e dall’altro lato in entità collettive (classi o gruppi), che di fatto sono semplici ipostatizzazioni, pur dotate di una certa utilità storiografica (gli eventi storici come frutto di azioni collettive). La storia ha dunque attori ma non autori e richiede di essere pensata elaborando un’ontologia del tutto peculiare, perché il suo incedere eventuale non può in nessun modo essere ascritto a un responsabile individuale o collettivo e ancor meno situato su un piano teleologicamente determinato (gli eventi storici come accadimento di ciò che non poteva non accadere). Occorre perciò pensare l’evento storico come sopravvenienza rispetto all’azione, emergenza non di qualunque tipo però, perché sempre rapportata in modo ermeneuticamente significativo – nonché ex post facto – al contesto in cui accadono i fatti.
Al testo di Andrea Cavazzini è affidato il fondamentale compito di illustrare il ruolo che il transindividuale gioca e può giocare nelle scienze della vita contemporanee, da un punto di vista tanto epistemologico quanto scientifico in senso stretto. La disamina del ruolo dell’individuazione nelle scienze biologiche e del protagonista del processo evolutivo di volta in volta delineato dai vari paradigmi di ricerca ha come principale portato la critica a ogni forma di neoatomismo, nella misura in cui viene messa in discussione la possibilità di pensare la vita a partire da una qualche forma di unità minima dotata di autosufficienza, autonomia o persino onnipotenza. Che si attribuisca il ruolo principale alla specie, ai singoli organismi, alle cellule, ai geni (o ai memi, ecc.), ciò che sembra restare immutata è l’incapacità di tematizzare sino in fondo il ruolo che la relazione gioca nell’evoluzione della vita. In altri termini, è come se fosse prima di tutto la relazione a evolversi e a farlo su diversi e non gerarchizzati livelli: relazione tra specie, tra organismi, tra ambienti e organismi, tra ambienti, tra cellule, tra geni, tra geni e cellule, ecc. Emerge da ultimo – con esplicito richiamo al nome fondamentale di von Uexküll – una prospettiva biosemiotica, per la quale l’evoluzione è un processo di prelevamento, selezione e costruzione di forme significanti in quanto consentono di svolgere determinate funzioni (a livello di specie, di organismo, di ambiente, di cellula, di gene, ecc.). Tale processo non rinvia in nessun modo a un qualche codice prefissato, a un programma completo che specifica la totalità delle proprie condizioni d’esecuzione, prima e indipendentemente dal contesto di tali condizioni, ma chiama in causa appunto innanzitutto una qualche forma di relazione. Ancora una volta, in questo scenario la differenza tra specie è letteralmente conseguenza del fatto che certi processi di individuazione naturali hanno come esito l’assunzione di determinati comportamenti e atteggiamenti, che – riguardo all’uomo e con particolare riferimento all’etologia di Lestel – sono contraddistinti da un costante, simbolico, mediato e attivo interfacciarsi e interagire con altri processi di individuazione naturali.
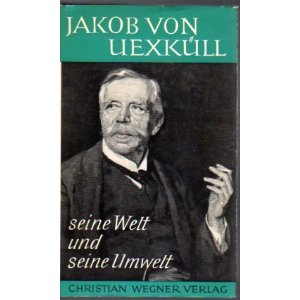
Patrice Maniglier innesta la propria originale ipotesi sulla cognizione umana e in particolare sullo statuto del linguaggio proprio su simili presupposti, richiamando a propria volta la teoria degli ambienti uexkulliana: se infatti a dover essere messa al centro è la questione della relazione tra organismo e ambiente, questo deve valere anche per l’uomo e per ciò che di più specificamente umano sembra esserci, il linguaggio. Questo – differentemente dai cognitivismi di vario stampo – deve essere visto non tanto come strumento ma come ambiente, ossia non come qualcosa di cui ci si serve ma come qualcosa in cui si vive: ciò che riguarda innanzitutto non conoscenza, calcolo o ragionamento, bensì percezione e organizzazione del flusso dell’esperienza. Fare ingresso in una lingua significa fare ingresso in una cultura, non nel senso dell’appropriazione di una serie di competenze sintattico-grammaticali o cognitivo-intellettuali, bensì dell’immersione graduale in un complesso di frequenze variabili che portano all’emersione di identità percettive globali. Parlare significa insomma percepire; parlare la stessa lingua vuol dire non intendersi su un insieme di performance vere e riconducibili a un qualche sistema formale, bensì potersi accordare – quasi nel senso musicale – su percezioni, su forme sensibili da condividere: significa tentare d’istruire o riconoscere in un dato contesto una variante costruibile, una salienza percettiva.
Quando si parla dunque si comunica e si trasmette soltanto a partire da quel movimento preliminare che configura un apparato percettivo che consente di riconoscere certe possibilità e di ignorarne altre: con ciò, il vero problema della mente è quello di individuare delle forme a partire dal brusio del mondo; il vero problema del rapporto tra culture è quello di riuscire a segmentare flussi (sonori ma non solo) di per sé ancora indifferenziati, di apprendere nuove forme di sensibilità, nuovi stili, dettagli, finezze e parametri definitori del mondo. Da ultimo, si fa strada l’idea per cui una possibilità specifica aperta dal linguaggio umano sia la capacità di istituire dei sensi di per sé non somiglianti alla dimensione strettamente fisica dei segnali eppure ugualmente condivisibili, ripetibili, trasmissibili e stabili, proprio in quanto non al di là di tale dimensione. In altre parole, la relazione tra il segnale e il senso è tale per cui quest’ultimo è esteriore rispetto al primo, è cioè una relazione di tipo simbolico; meglio ancora, sono qui in gioco diversi tipi di possibili relazioni, vale a dire la possibilità di imporre ai segnali dell’ambiente diverse metriche, differenti maniere di misurare e categorizzare, di decomporle e ricomporle – di costituire e creare mondi. Si tratta allora della possibilità di valutare, di fornire valutazioni ad altri e di essere sensibili alle valutazioni altrui: il significato della valutazione è proprio legato a questo sistema di reciproci feedback, alla dimensione transindividuale del senso. Una valutazione è in ultima istanza non ciò che è nelle teste ma nemmeno semplicemente fuori dalle teste, è tra di esse, è quel tra-di-esse che ne consente l’individuazione.
Si potrebbe in conclusione dire che lo sforzo di concepire un neoumanesimo dopo la morte dell’uomo, non antropocentrico e capace di empiricizzare il trascendentale, fa tutt’uno con il coraggio di insieme riprendere e ripensare quella che è stata forse la prima radicale affermazione umanista della storia del pensiero occidentale, ancora soffocata da una lettura troppo superficialmente relativista: l’uomo come misura di ogni chrematon. Il presente volume ci offre così in ultima battuta alcuni tra i primi e decisivi passi da compiere, consentendo di riformulare l’animale umano come misura relazionale di ogni chrematon.
di Giacomo Pezzano
 Con La comunità sconfessata (ed. orig. La communauté désavouée, Galilée, Paris 2014) Jean-Luc Nancy compie un passo avanti nel tentativo di dipanare e allargare le maglie di un gioco di rimandi reciproci che lo connette a Maurice Blanchot a partire da L’absolu littéraire, apparso nel 1978: un rapporto di prossimità che lega Nancy a Blanchot nonostante i differenti percorsi teorici. La risposta di Nancy a La communauté inavouable di Blanchot, uscito nel 1983, si fa attendere trent’anni, anni che sono stati non solo testimoni della morte dello stesso Blanchot, ma anche della reale difficoltà di comprensione del suo testo e, in particolare, di quel segreto inconfessabile che, secondo l’autore, caratterizza propriamente la comunità. Nancy ammette di essere rimasto inizialmente paralizzato nel constatare che un autore del calibro di Blanchot decidesse di rispondere a un “giovane filosofo senza autorità” (p. 32) e con una tale sollecitudine (La communauté inavouable esce infatti lo stesso anno dell’articolo di Nancy intitolato La communauté désoeuvrée, “Aléa”, n. 4/1983). Solo recentemente l’imbarazzo e lo stupore, oltre che una certa prudenza teorica, hanno ceduto il passo all’urgenza etica che il tema della comunità prospetta e all’importanza di un’interrogazione su quel carattere comune delle nostre esistenze che ci consente di essere in rapporto, nell’insieme e nella condivisione (partage) ancora prima che individui o entità discrete.
Con La comunità sconfessata (ed. orig. La communauté désavouée, Galilée, Paris 2014) Jean-Luc Nancy compie un passo avanti nel tentativo di dipanare e allargare le maglie di un gioco di rimandi reciproci che lo connette a Maurice Blanchot a partire da L’absolu littéraire, apparso nel 1978: un rapporto di prossimità che lega Nancy a Blanchot nonostante i differenti percorsi teorici. La risposta di Nancy a La communauté inavouable di Blanchot, uscito nel 1983, si fa attendere trent’anni, anni che sono stati non solo testimoni della morte dello stesso Blanchot, ma anche della reale difficoltà di comprensione del suo testo e, in particolare, di quel segreto inconfessabile che, secondo l’autore, caratterizza propriamente la comunità. Nancy ammette di essere rimasto inizialmente paralizzato nel constatare che un autore del calibro di Blanchot decidesse di rispondere a un “giovane filosofo senza autorità” (p. 32) e con una tale sollecitudine (La communauté inavouable esce infatti lo stesso anno dell’articolo di Nancy intitolato La communauté désoeuvrée, “Aléa”, n. 4/1983). Solo recentemente l’imbarazzo e lo stupore, oltre che una certa prudenza teorica, hanno ceduto il passo all’urgenza etica che il tema della comunità prospetta e all’importanza di un’interrogazione su quel carattere comune delle nostre esistenze che ci consente di essere in rapporto, nell’insieme e nella condivisione (partage) ancora prima che individui o entità discrete.