L'obiettivo principale di questa rubrica, in quanto rubrica, è quello di compiacere e sollazzare il lettore, conducendolo astutamente e subdolamente all'assuefazione.
A parte questo tratto che essa condivide con la grandissima parte della scrittura su internet, tuttavia, bisogna avvertire che questa subdola rubrica ha anche un altro obiettivo che (vedi sopra) verrà enunciato alla fine di questo primo articolo.
Quanto al tema della rubrica, anche se è legittimo aspettarsi una certa varietà, essa tratterà di filosofia e di altre cose, e specificatamente della relazione fra la filosofia e le altre cose. Benché questo punto di partenza possa sembrare non solo banale, ma tale da ridefinire il concetto di banalità, a guardarlo più da vicino esso è spaventosamente ambizioso. Come articolare la relazione fra la filosofia e il suo altro senza disporre di una preliminare definizione di filosofia, e in particolare una capace di distinguere la filosofia dal suo “altro”? Osserviamo che ciò che dovremmo risolvere “in via preliminare” è nientedimeno che la questione del “che cos'è la filosofia”, questione quantomai aperta, e che nessun filosofo serio si azzarderebbe a chiudere, non senza consapevolezza di scommettere su una tale mossa il destino del proprio pensiero e della propria carriera.
Non c'è in questo nulla di male: il gesto con il quale le scienze si separano dalla filosofia, d'altra parte, è in genere anche il medesimo gesto con il quale esse si danno un metodo, una serie di procedure, un oggetto, un obiettivo condiviso. La filosofia, in quanto “resto”, resta polisemica, polimorfa e polemica. Tanto più difficile resta il lavoro di stabilire il suo “altro”. Non semplifica le cose il fatto che, molto probabilmente, a guardarlo abbastanza da vicino questo altro diverrà a sua volta l'occasione per fare della filosofia.
In questo spazio collaterale, abbastanza vicini al corpo della rivista Philosophy Kitchen da assorbirne in parte l'originalità e il percorso teoretico, abbastanza lontano da schivarne l'inevitabile serietà e i problemi metodologici connessi, vorremmo contribuire allo sforzo di esplorazione dello spazio tormentato della filosofia contemporanea a partire da due assunti:
-
La filosofia non può rendersi autonoma (da nulla)
Questa prima interdizione torna a esprimere una verità banale, che proprio per la sua banalità risulta raramente tematizzata dalla riflessione filosofica. L'unico modo di farla valere infatti, è rifiutarsi di rispondere alla domanda: “a cosa serve la filosofia? Qual è il suo compito specifico?” A tali domande non si può che rispondere evasivamente (i migliori esempi di letteratura filosofica che si incaricano di rispondere a tali domande sono infatti esempi altissimi di letteratura “d'evasione”). 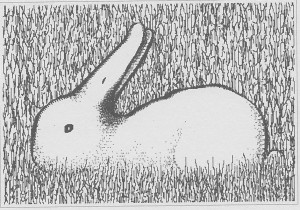 Bisogna tuttavia motivare tale rifiuto, che pare a tutta prima molto poco filosofico, e specificatamente in contrasto con la necessità filosofica di rendere conto dello scopo e della significatività del proprio pensiero. Proponiamo in questa sede due spunti per la futura elaborazione di una tale mossa. In primo luogo il fatto che la filosofia si costituisce come residuo di una serie di “separazioni” o “scissioni” che fondano le scienze particolari, scissioni effettuate proprio a partire da una specificazione preliminare di un campo oggettuale, un metodo, una serie di procedure e assunti teorici (la cui modificabilità e discutibilità nulla toglie alla necessità che essi esistano in forma esplicita perché una scienza possa dirsi tale). In secondo luogo, e forse più importante, il fatto che la filosofia non può che esercitarsi a partire da particolari fratture epistemiche. Adattando il vecchio adagio aristotelico secondo il quale si comincia a filosofare dalla meraviglia, occorre dire che si comincia a filosofare intorno a quelle aporie capaci di mobilitare il pensiero altrimenti fermo. Né è in alcun modo prevedibile da che lato lo stupore ci costringerà a uscire dalla stupidità. Il filosofo non può – in buona fede – figurarsi di avere un “campo” o un “ambito” specifico, proprio perché a lui spetta (e nel corso delle varie scissioni tale onere non è ancora stato reclamato da nessuno, restando perciò squisitamente filosofico) intervenire laddove la definizione degli ambiti si rende imprecisa, laddove esiste un problema in forma di enigma, che non si lascia esaurire all'interno di un singolo campo e quindi ci obbliga a rimettere in discussione – una discussione razionale – l'articolazione e il diritto di ciascuna delle razionalità specifiche che il nostro problema travaglia e destabilizza.
Bisogna tuttavia motivare tale rifiuto, che pare a tutta prima molto poco filosofico, e specificatamente in contrasto con la necessità filosofica di rendere conto dello scopo e della significatività del proprio pensiero. Proponiamo in questa sede due spunti per la futura elaborazione di una tale mossa. In primo luogo il fatto che la filosofia si costituisce come residuo di una serie di “separazioni” o “scissioni” che fondano le scienze particolari, scissioni effettuate proprio a partire da una specificazione preliminare di un campo oggettuale, un metodo, una serie di procedure e assunti teorici (la cui modificabilità e discutibilità nulla toglie alla necessità che essi esistano in forma esplicita perché una scienza possa dirsi tale). In secondo luogo, e forse più importante, il fatto che la filosofia non può che esercitarsi a partire da particolari fratture epistemiche. Adattando il vecchio adagio aristotelico secondo il quale si comincia a filosofare dalla meraviglia, occorre dire che si comincia a filosofare intorno a quelle aporie capaci di mobilitare il pensiero altrimenti fermo. Né è in alcun modo prevedibile da che lato lo stupore ci costringerà a uscire dalla stupidità. Il filosofo non può – in buona fede – figurarsi di avere un “campo” o un “ambito” specifico, proprio perché a lui spetta (e nel corso delle varie scissioni tale onere non è ancora stato reclamato da nessuno, restando perciò squisitamente filosofico) intervenire laddove la definizione degli ambiti si rende imprecisa, laddove esiste un problema in forma di enigma, che non si lascia esaurire all'interno di un singolo campo e quindi ci obbliga a rimettere in discussione – una discussione razionale – l'articolazione e il diritto di ciascuna delle razionalità specifiche che il nostro problema travaglia e destabilizza.
-
La filosofia non può bastare a se stessa
 La seconda interdizione deve valere, più che da condizione fondamentale relativa alla possibilità della filosofia in generale, allo spirito con il quale affrontare lo sforzo filosofico. Non sarebbe scorretto dire che non c'è nulla nella filosofia che le imponga di assumere come compito la trasformazione del reale, e sarebbe invece piuttosto corretto affermare che resta a tutt'oggi un’illusione mitica, anche piuttosto datata, l'idea che la razionalità agisca direttamente come forza trasformativa delle nostre forme di vita concrete. I problemi di cui la filosofia si occupa non hanno la forma dell'errore, ma quello dell'aporia, e proprio per questo non si è affatto sicuri di ricavare dall'analisi un qualche strumento che consenta di trasformare la realtà problematica, né tanto meno di “risolvere” con mezzi esclusivamente teorici il problema. Un po' per la frustrazione che questo stato di cose induce nei filosofi, un po' per la nostra giovanile esuberanza, tuttavia, ci sentiamo di sfidare questo stato di cose, e precisamente a partire dalla continuità che abbiamo già rimarcato, la caratteristica di quella superficie membranosa che oppone e mette in contatto il pensiero filosofico e il suo oggetto – che forse sarebbe meglio chiamare tema, per non riproporre una vecchia dicotomia che ci resta, almeno nelle fasi preliminari, d'intralcio. Il modo di questa operazione non può che riportarci al concetto di “teoria”.
La seconda interdizione deve valere, più che da condizione fondamentale relativa alla possibilità della filosofia in generale, allo spirito con il quale affrontare lo sforzo filosofico. Non sarebbe scorretto dire che non c'è nulla nella filosofia che le imponga di assumere come compito la trasformazione del reale, e sarebbe invece piuttosto corretto affermare che resta a tutt'oggi un’illusione mitica, anche piuttosto datata, l'idea che la razionalità agisca direttamente come forza trasformativa delle nostre forme di vita concrete. I problemi di cui la filosofia si occupa non hanno la forma dell'errore, ma quello dell'aporia, e proprio per questo non si è affatto sicuri di ricavare dall'analisi un qualche strumento che consenta di trasformare la realtà problematica, né tanto meno di “risolvere” con mezzi esclusivamente teorici il problema. Un po' per la frustrazione che questo stato di cose induce nei filosofi, un po' per la nostra giovanile esuberanza, tuttavia, ci sentiamo di sfidare questo stato di cose, e precisamente a partire dalla continuità che abbiamo già rimarcato, la caratteristica di quella superficie membranosa che oppone e mette in contatto il pensiero filosofico e il suo oggetto – che forse sarebbe meglio chiamare tema, per non riproporre una vecchia dicotomia che ci resta, almeno nelle fasi preliminari, d'intralcio. Il modo di questa operazione non può che riportarci al concetto di “teoria”.
La teoria, secondo uno dei suoi utilizzi più antichi e universalmente riconosciuti, raddoppia la prassi, vale a dire opera razionalizzando ciò che la precede – ciò che ci porta a dire che essa è sempre “in ritardo” sulla realtà, occupata a spiegare come e perché facciamo cose (parlare, pensare, vedere, amare, vivere) che in realtà facevamo anche prima che la filosofia cominciasse a spiegarcele. Che ce ne facciamo, dunque, delle spiegazioni della filosofia? Esse sono necessarie? Utili? La risposta è duplice: da un lato come abbiamo detto, la filosofia inizia proprio laddove si possa ritrovare, profondamente imbricata nelle forme dell'attività umana, una struttura aporetica. Il fatto che si parla, si muore, si pensa e si conosce da migliaia di anni non può metterci al sicuro dal fatto che una o più di queste attività potrebbero divenire problematiche da un momento all'altro, ed anzi nel momento in cui se ne fa filosofia – o almeno, se ne fa significativamente filosofia – esse sono già divenute problematiche (e quindi si trasformeranno, filosofia o no). Dall'altro lato, nella reduplicazione teorica della prassi, ciò che era dato “per scontato” e non si manifestava che nell'uniformità di un comportamento appreso e successivamente riprodotto (secondo lo schema dell'habitus) entra in una struttura differenziale, in un calcolo razionale destinato ad enunciarne il senso. La comprensione si determina dunque come opposizione, confronto, correlazione capace di rendere conto del reale a partire dal trascendentale, con l'effetto secondario tutt'altro che trascurabile dell'aprire, attraverso la discussione filosofica del reale, la possibilità di una seconda “messa in discussione”, appartenente a linguaggi diversi da quello filosofico, che si specifica nell'assunzione di responsabilità nei confronti del reale, che dovrà ormai fare i conti con la virtualità dei “possibili” che gli si oppongono.
A partire da queste interdizioni, alle quali affidiamo il compito di delimitare lo spettro delle nostre possibilità filosofiche e la portata dell'intenzione che ci muove, possiamo infine dichiarare l'argomento di Take Away, vale a dire la messe di realtà contraddittorie ed irriflesse che si muovono al di fuori della corrente pratica filosofica, fuori dalle aule universitarie e altre sedi istituzionali, e per i più svariati motivi risultano invisibili o insignificanti a chi si interessa perlopiù di forme già raffinate di teoria. Intendiamo andare di volta in volta a caccia di realtà concrete o virtuali, di particolari trascurabili o di assi portanti, praticando una forma nobile di bracconaggio che conduca, nella migliore delle ipotesi, a un arricchimento dello strumentario filosofico e a una ulteriore dimostrazione dell'irrinunciabile ruolo della riflessione, anche in una società segmentata e postindustriale, convinta come quella che ci circonda di poter fare a meno della consapevolezza dei suoi meccanismi fondamentali. Nella peggiore delle ipotesi, come spesso accade, arriveremo in ritardo, consegnando tuttavia alla memoria la traccia irrisolta delle nostre migliori aspirazioni.
Nota di stile: operazioni del genere possono valersi profittevolmente della forma del “metalogo” batesoniano, che è di per sé una forma di dialogo filosofico, oltre che di quella del micro-saggio. Non essendo propriamente materiale di “alta cucina” filosofica, quanto trattazione e ricerca di filosofemi impliciti (secondo la lezione gramsciana), take away si presenta come rubrica parafilosofica, con la speranza di essere stimolo, contorno e contrappunto della più seria attività teoretica della rivista.
di Lorenzo Palombini

