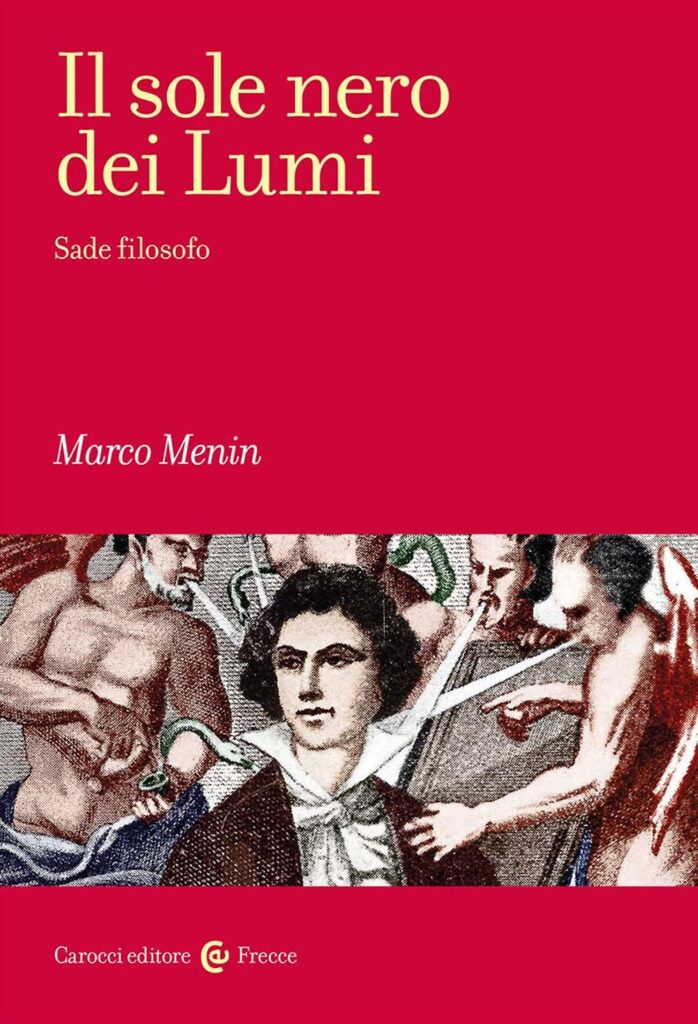-
-
 Nella prefazione a La filosofia dell’Illuminismo (1932) Ernst Cassirer scriveva che per comprendere la filosofia del XVIII secolo non si dovesse tanto far riferimento all’ampiezza della produzione scientifica che aveva caratterizzato il secolo dei Lumi, bensì chiariva quanto fosse più proficuo focalizzare l’attenzione sulla profondità che caratterizzò i sistemi filosofici dell’epoca, nelle diverse sfumature e nella vasta pluralità. Illuminismo. Storia di un’idea al plurale a cura di Massimo Mori e Salvatore Veca, pubblicato quest’anno da Carocci concretizza la possibilità di confrontarsi con uno studio stimolante e approfondito sull’Illuminismo. Questa possibilità è garantita dall’intento dei curatori che anima la realizzazione dell’opera: leggere e interpretare il Secolo dei Lumi, non secondo una visione monolitica, ma, come si evince dal sottotitolo, trattarlo come la storia di una pluralità di idee, ben ancorate alle vicende storiche e culturali del tempo, ma in grado di offrire appigli teorici di grande originalità rispetto alla tradizione.
Nella prefazione a La filosofia dell’Illuminismo (1932) Ernst Cassirer scriveva che per comprendere la filosofia del XVIII secolo non si dovesse tanto far riferimento all’ampiezza della produzione scientifica che aveva caratterizzato il secolo dei Lumi, bensì chiariva quanto fosse più proficuo focalizzare l’attenzione sulla profondità che caratterizzò i sistemi filosofici dell’epoca, nelle diverse sfumature e nella vasta pluralità. Illuminismo. Storia di un’idea al plurale a cura di Massimo Mori e Salvatore Veca, pubblicato quest’anno da Carocci concretizza la possibilità di confrontarsi con uno studio stimolante e approfondito sull’Illuminismo. Questa possibilità è garantita dall’intento dei curatori che anima la realizzazione dell’opera: leggere e interpretare il Secolo dei Lumi, non secondo una visione monolitica, ma, come si evince dal sottotitolo, trattarlo come la storia di una pluralità di idee, ben ancorate alle vicende storiche e culturali del tempo, ma in grado di offrire appigli teorici di grande originalità rispetto alla tradizione.Il testo è una collettanea a cura di ben undici autorevoli studiosi, i cui interventi trattano gli argomenti più vari. Il volume è diviso in due parti: la prima ha per titolo Problemi e Metodi e la seconda Tradizioni e Prospettive.
Nella prima parte viene costruito il complesso ruolo delle scienze nell’età dei Lumi: le pagine di Paolo Casini, Vincenzo Ferrone e Antonello La Vergata contribuiscono a tessere la tela che ci permette di interpretare l’Illuminismo nei suoi complessi intrecci, da non leggere quindi secondo un’unica chiave interpretativa risolutiva, ma prendendo atto della complessità che lo caratterizza e soprattutto dell’importanza del solco tracciato in esso dalla Rivoluzione scientifica. Questo processo, a sua volta articolato e ricco di variabili, ma certamente di portata storica unica nel suo genere è stato l’evento della modernità che ha lasciato una delle più grandi eredità alla filosofia occidentale. Riguardo l’importanza del rapporto tra Rivoluzione scientifica e Illuminismo, Casini ascrive alla nascita del metodo scientifico il ruolo di aver generato la rottura con l’ipse dixit aristotelico, con la vecchia immagine del mondo, che tuttavia non vede perso per sempre il ruolo della metafisica, la quale viene ridimensionata, sulla scia del Condillac, a scienza che cerca “di vedere le cose come sono”.
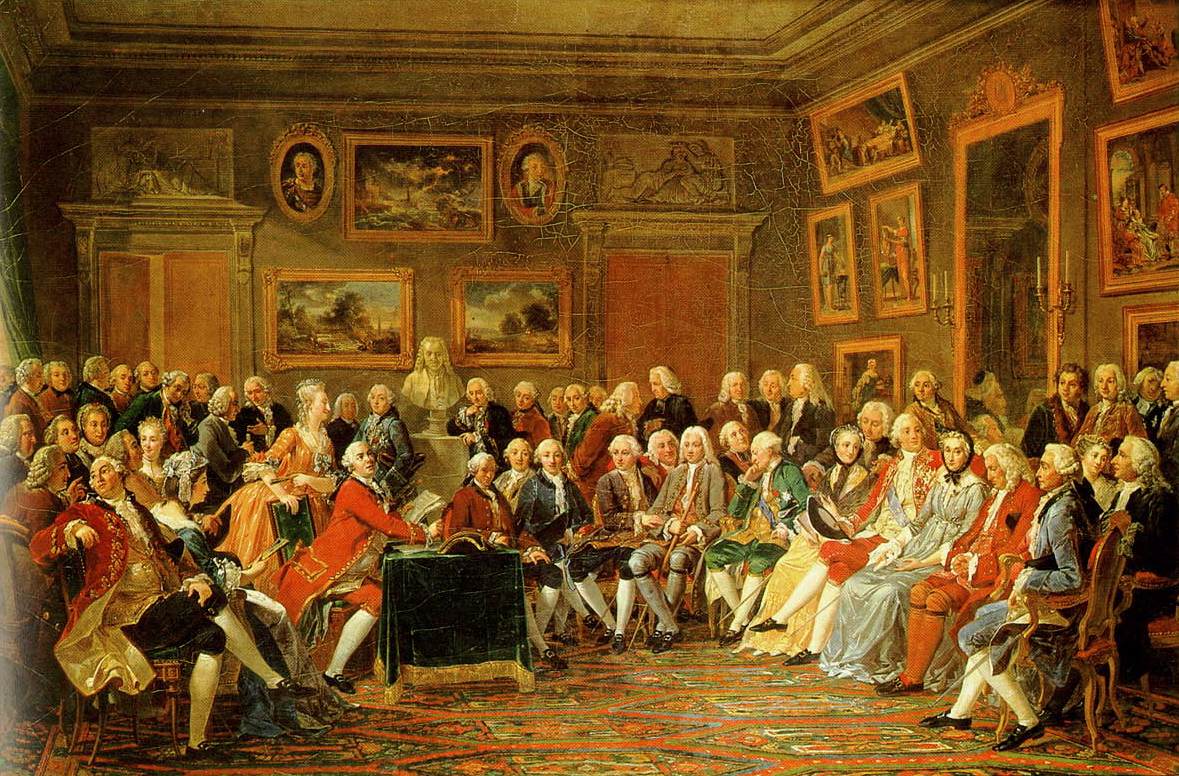
L’idea presunta di una asettica razionalità, superiore rispetto ad ogni altra facoltà conoscitiva, ha spesso avuto il suo primato nella considerazione sull’età dei Lumi. Tuttavia essa trova la sua smentita nello scritto di Ferrone, il quale sottolinea l’importanza dell’immaginazione tra le facoltà del nostro armamentario gnoseologico, così come fondamentale fu il ruolo del sogno per una figura di spicco del Settecento: l’enciclopedista D’Alembert.
Gli ultimi due scritti della prima parte, quelli di Mario Ricciardi e Giovanni Filoramo trattano del cruciale rapporto del pensiero illuministico con tematiche di natura etico politica e religiosa, dimostrando ancora una volta la variegata quantità di punti di riflessione sui quali si è focalizzata la sensibilità settecentesca.
Nella seconda parte del testo emergono questioni e problematiche differenti. Il capitolo di Giuseppe Cambiano permette subito di comprendere quanto gli autori del Secolo dei Lumi non siano stati pensatori isolati nel loro tempo storico, avendo risentito fortemente dei grandi classici, nei confronti dei quali si ponevano secondo un approccio talvolta critico, ma rispettoso, facendo così leva sull’impossibilità per i filosofi di far riferimento ai predecessori. Così dalle pagine di Gianni Paganini si può cogliere l’eredità del pensiero libertino e “clandestino”, che si caratterizzò come fonte essenziale di quel principio di autonomia e libertà che animava lo spirito dell’Illuminismo.
Quando si fa riferimento all’Illuminismo come corrente culturale permeante l’età moderna, non si può non considerare l’idea di cosmopolitismo che è stata alla base del pensiero filosofico. Questa idea è ampiamente descritta dal punto di vista storico da Massimo Mori, il quale mantiene viva la lezione degli antichi, confermando ancora una volta l’attenzione degli illuministi nei confronti della tradizione e soprattutto segnalando il valore essenzialmente polisemantico della parola “cosmopolitismo”, la quale nel Settecento aveva una molteplicità di interpretazioni e chiavi di lettura, tanto da poter essere considerata interscambiabile con quella di “filosofo” nell’Enciclopedia.
La filosofia dell’Illuminismo è eurocentrica? Una risposta pertinente e completa, che consente tra l’altro di trovare la via di uscita dai luoghi comuni e dalle errate categorie di pensiero, si trova nell’intervento di Pietro Rossi, nel quale si può notare la grande attenzione che ci fu da parte dei filosofi del XVIII secolo nei confronti dell’Oriente. I riferimenti alle pagine di Voltaire risultano eloquenti a riguardo: la sua opinione sull’Oriente, in particolar modo sulla Cina offre dei risultati più che positivi, fungendo tra l’altro da autocritica nei riguardi dell’Europa del tempo (civile, cristiana e moderna), la quale sembrava aver rinunciato ai principi del cristianesimo, con le sanguinose guerre di religione che avevano investito l’età moderna.
L’Illuminismo è un problema storiografico da relegare entro una stagione della storia conclusa? Oppure è una categoria di pensiero per potersi orientare, un “atteggiamento” adottabile per trovare un senso nella realtà?
Gli ultimi due scritti del testo tentano di rispondere a questa domanda, provando a ripensare l’Illuminismo nella contemporaneità, non soltanto per quanto riguarda i suoi aspetti storico filosofici, che possono essere collocati entro la cornice settecentesca, ma da altri punti di vista e problematiche che irrompono nella cultura contemporanea.
Nello scritto di Massimo Ferrari si rintraccia un’utile costruzione della storiografia sull’Illuminismo tra Ottocento e Novecento, dalla quale emerge quanto gli eventi storici dell’età contemporanea abbiano inciso sulle varie interpretazioni che nel tempo si sono avvicendate sulla filosofia dei Lumi.
L’ultimo intervento è a cura di Salvatore Veca il quale disegna la “silhouette” dell’Illuminismo nella cultura filosofica contemporanea. Egli non si sofferma soltanto sulla famigerata lettura negativa di Adorno e Horkheimer contenuta in Dialettica dell’Illuminismo, bensì sui tentativi di recupero dei valori trainanti dell’età dei Lumi rintracciati nelle riflessioni di Abbagnano, Putnam, Williams e Foucault. Emerge un’interessante interpretazione volta a valorizzare l’Illuminismo come “atteggiamento” nel nostro quotidiano confronto con il reale. Non si tratta di operare in favore di una fede cieca nel progresso, ma di essere mossi e di agire in virtù della credenza nella «possibilità del progresso» del genere umano verso il meglio. La ragione diviene quindi una bussola che permette di non perdersi nel mare del disorientamento postmoderno o addirittura nella negazione del pensiero come vera peculiarità dell’essere umano. Così per Veca resta valida quella che si definisce una vera e propria «educazione al pensiero», quindi all’Illuminismo stesso come ideale della ragione. A tal proposito è esplicito il riferimento a Jean Amery con il quale si chiude il capitolo: nella condizione di prigioniero ad Auschwitz aveva affermato che «chi rinnega l’Illuminismo, rinuncia all’educazione del genere umano».
Illuminismo. Storia di un’idea al plurale offre dunque al lettore l’opportunità di confrontarsi con varie interpretazioni e aspetti della filosofia e più in generale della cultura del secolo XVIII. Ogni capitolo può essere la solida base per molteplici spunti di riflessione e ulteriori ricerche, sia per lo studioso che per lo studente. Tutto ciò è permesso soprattutto dalla ricca bibliografia presente alla fine di ogni capitolo, la quale dimostra la perizia e l’attenzione che ogni studioso ha impiegato nella realizzazione del proprio intervento.
di Lucio Luceri
-
 Si tratta di una delle storie più note a chi frequenta i territori filosofici: la filosofia nasce come superamento del mito, costruisce il proprio spazio negando e lasciandosi alle spalle il mito, sforzandosi di superare il suo linguaggio, anche quando – Platone lo testimonia per primo – si ritrova a farne ancora uso. Da qui la convinzione che, in fondo, pensare significhi non raccontarsi storie, ma anche che conoscere sia l’operazione anti-mitologica per eccellenza (la finzione narrativa del mito che fa spazio alla verità razionale della scienza). A fronte di tutto ciò, un volume che ha il coraggio di riaprire il discorso sul rapporto tra mito e filosofia merita la più assoluta considerazione. Sarebbe ingeneroso pretendere di riassumere in pochi capoversi i trenta fitti saggi che compongono il testo, in cui il dibattito antropologico, storico-religioso, sociologico e psicologico si intreccia felicemente alle riflessioni teoriche e all’opportuna ricostruzione di casi storici; per questo, mi limiterò a presentare quelli che mi sembrano i due assi principali dell’opera, legati a loro volta a un’idea fondamentale che fa da basso continuo a tutti gli interventi: il mito non tanto “è qualcosa”, ma piuttosto “fa qualcosa”. La prospettiva funzionalista deve sostituire quella sostanzialista.
Si tratta di una delle storie più note a chi frequenta i territori filosofici: la filosofia nasce come superamento del mito, costruisce il proprio spazio negando e lasciandosi alle spalle il mito, sforzandosi di superare il suo linguaggio, anche quando – Platone lo testimonia per primo – si ritrova a farne ancora uso. Da qui la convinzione che, in fondo, pensare significhi non raccontarsi storie, ma anche che conoscere sia l’operazione anti-mitologica per eccellenza (la finzione narrativa del mito che fa spazio alla verità razionale della scienza). A fronte di tutto ciò, un volume che ha il coraggio di riaprire il discorso sul rapporto tra mito e filosofia merita la più assoluta considerazione. Sarebbe ingeneroso pretendere di riassumere in pochi capoversi i trenta fitti saggi che compongono il testo, in cui il dibattito antropologico, storico-religioso, sociologico e psicologico si intreccia felicemente alle riflessioni teoriche e all’opportuna ricostruzione di casi storici; per questo, mi limiterò a presentare quelli che mi sembrano i due assi principali dell’opera, legati a loro volta a un’idea fondamentale che fa da basso continuo a tutti gli interventi: il mito non tanto “è qualcosa”, ma piuttosto “fa qualcosa”. La prospettiva funzionalista deve sostituire quella sostanzialista.Il primo asse ruota attorno alla convinzione che ripensare la contrapposizione tra mito e ragione non significa semplicemente dire che il mito sia ovunque, che tutto sia mito, che in realtà anche la filosofia e la scienza sono in qualche modo “mitiche”. Il punto è piuttosto riconoscere che il mito non è stato semplicemente superato una volta per tutte, né deve essere lasciato alle spalle, perché non è una modalità di rapporto con la realtà imperfetta, incompiuta e difettosa rispetto a quella razionale: è piuttosto una modalità altra con delle proprie specificità e – soprattutto – con la propria utilità. Si tratta infatti di comprendere che le ambiguità e le contraddizioni del mito, capace di generare fascino e seduzione come repulsione e rinnegamento, sono legati al fatto che il mito è innanzitutto una prassi, che si colloca cioè in una dimensione performativa che si avvale di peculiari materiali e pratiche: il mito rappresenta la tessitura – in termini foucaultiani – di un vero e proprio ordine discorsivo, di un dispositivo di sapere-potere. In questo senso, esso ha persino una propria “razionalità”, nella misura in cui possiede una struttura e delle modalità di funzionamento e dispiegamento irriducibili ad altro e – soprattutto – insubordinabili a quelle proprie della ragione in senso stretto. Senza che ciò debba tradursi nella celebrazione della narrazione mitica a discapito della discorsività argomentativa, evidentemente; anzi, occorre proprio cominciare a vederle come complementari piuttosto che dirette antagoniste.
In particolare, il mito gioca un ruolo decisivo nella messa in opera della realtà politica e nella costruzione dell’identità sociale: il mito è produzione di memoria, di coesione, di immaginario, è fondazione del legame socio-culturale e dell’articolazione storico-temporale, offre un punto di riferimento per la stabilità di un gruppo. Il mito produce tutto ciò proprio mentre è da tutto ciò prodotto e riprodotto: il mito orienta. È per questo che esso non può essere semplicemente “demistificato”, in nome della ragion pura come della denuncia delle ideologie: il mito non è un vestito che ricopre una supposta realtà originaria e fatto proprio da una determinata classe sociale per tenerne sotto scacco un’altra; è – piuttosto – una modalità di accesso alla realtà che accomuna le diverse (supposte o effettive) classi sociali, che consente loro di far parte della medesima società. In poche parole, il mito ha una peculiare funzione soprattutto sociale, fonda la socialità umana, è un fattore di coesione e condensazione rispetto alla vita associata: il mito istituisce proteggendo e preservando – immunizzando. Ed è proprio qui che la sua funzione stabilizzatrice diventa indisgiungibile dal rischio di tradursi in un fattore di sclerotizzazione o eccessiva solidificazione; è perciò che il mito può essere tanto un orizzonte di condivisibilità quanto una cornice intrascendibile, che la sua macchina può generare forme di conoscenza e di circolazione linguistica, immaginale e simbolica che si autocertificano come verità naturali e immodificabili.
Il secondo asse attorno a cui si costruisce il volume consente però proprio di spiegare meglio il senso di questa utilità e il motivo profondo per cui il mito non può essere superato. Infatti, riprendendo soprattutto la lezione di Blumenberg, la funzione simbolico-performativa del mito va letta in chiave antropogenetica, vale a dire che l’utilità del mito è antropologica: il mito è uno dei modi tramite cui l’animale umano articola il senso della propria esistenza e il rapporto al proprio ambiente. Più specificamente, il mito consente di addomesticare il mondo e di dare così stabilità all’esistenza, è una forma di metaforizzazione della realtà e della propria posizione al suo interno che consente di dare a entrambe una figura. In altri termini, per quell’essere – quale l’uomo è – esposto, vulnerabile e consegnato al compito di dar attivamente forma al proprio rapporto con il mondo e di condurre esplicitamente la propria esistenza, il mito rappresenta un sistema di prevenzione da un’eccessiva prossimità con il reale e conseguentemente un meccanismo di misurazione delle giuste distanze da esso: troppe domande sull’origine del mondo generano angoscia, certo, ma la medesima angoscia si produrrebbe qualora non venisse prodotto nessun tipo di risposta. Il mito è proprio il tentativo di fornire una risposta che, pur non rifiutando la domanda sul senso del mondo, cerca però di limitarne la proliferazione indefinita, di interromperne il regresso all’infinito: finché l’uomo dovrà orientarsi nel mondo – a dire: finché l’uomo esisterà – il mito interverrà a offrire sostegno e supporto. In breve: il suo spettro di variazioni storiche e culturali fa dunque da controcanto all’invariante antropologica del bisogno di metafore capaci di far fronte all’assolutismo della realtà. Certamente, si potrebbe sostenere che il richiamo a Blumenberg comporti un eccessivo ricorso a quel “paradigma dell’incompletezza” o “fiction dell’essere carente” che gli sviluppi contemporanei dell’antropologia filosofica hanno cercato di ripensare (a partire da Sloterdijk, non a caso uno degli autori comunque chiamati in causa dagli interventi), così come implicherebbe di conseguenza anche un’eccessiva insistenza sul bisogno di protezione e riduzione del rischio e meno su quello di esplorazione e soddisfazione della curiosità. Come a dire che il mito può o deve essere considerato anche un dispositivo di scoperta di possibilità, oltre che di contenimento della loro dispersività, ossia che – pensando soprattutto alla dimensione sociale – al mito va riconosciuta più nettamente una dimensione simbolico-espressiva a fianco di quella contenitivo-stabilizzante. Tuttavia, ciò nulla toglie al punto di fondo da tener fermo: riconoscere che il mito è un paradossale “zero efficiente”, un nulla performativo, in ragione della stessa costituzione umana, e non il residuo di un passato oscuro da scrostarsi di dosso una volta per tutte. Ed è da questo punto fermo che il volume chiede di ripartire e di pensare.
Per chiudere, come viene pregevolmente evidenziato dai curatori, padroneggiare totalmente le problematiche scientifiche come le dimensioni pratiche connesse al mito è un’impresa ai limiti dell’insormontabilità: mito si dice e si fa senza dubbio in molti modi. Ma l’altrettanto indubbio pregio dell’opera è sforzarsi di mostrare questa molteplicità, è offrire un quadro insieme complessivo e articolato di quel solo apparente ossimoro che è la “filosofia del mito”, al fine di contribuire a rendere meno cogente la sottile violenza con cui tende a presentarsi ciò che è ovvio e a indicare così nuovi spazi di libertà possibili. Siamo insomma di fronte alla piena assunzione del compito forse più peculiare e controverso di cui la filosofia tenta di farsi carico: pensare il proprio tempo in rapporto al suo trascorrere.
di Giacomo Pezzano