-
-
M49. Filosofie per fughe animali
Longform / Ottobre 2023A Juan Carrito, benché sia morto libero
Basterebbe un colpo d’occhio al panorama filosofico più recente per ammettere che la critica dell’antropocentrismo sia diventato un tema comune a molteplici orientamenti di pensiero, anche divergenti fra di loro: dal posthuman al realismo speculativo, dal new materialism all’ecopessimismo fino ai pensieri queer e decoloniali, la protesta contro le pretese di centralità ed eccezionalità umana sembrano proliferare alla stessa velocità con cui la minaccia d’estinzione – per lo più rappresentata dal global warming, benché la guerra atomica sembri aver conquistato una nuova giovinezza – si abbatte sulla specie homo sapiens. La sincronia non è casuale e non è soltanto il prodotto di un qualche senso di colpa collettivo per la distruttività dell’azione antropica. È piuttosto il pianeta stesso inteso come tessuto di forze e agentività aliene a fare irruzione s’una scena per millenni ritagliata a misura umana. Va da sé che non ogni critica all’antropocentrismo è anche una critica antiumanista nel senso in cui l’abbiamo conosciuta nel secolo scorso, cioè di quell’Uomo prodotto da sapere-poteri recenti o da una lunga tradizione metafisica e per tagli sacrificali (l’Uomo è sempre maschio, bianco, occidentale, adulto, eterosessuale e cisgender, abile); né, tanto meno, un antispecismo. Ma anche dove manca un’esplicita convergenza, affinità, limitrofie e promiscuità restano innegabili e l’innesto sempre possibile. In qualche modo tutte queste tensioni, vecchie e nuove, sembrano spingersi a vicenda. Sarebbe per esempio difficile negare che la riflessione di Derrida sull’animale non abbia avuto, pur con picchi discontinui, un ruolo da detonatore generale: se nell’opera del filosofo franco-algerino l’avvio di una decostruzione esplicita dell’umanismo risale almeno alla fine degli anni sessanta del secolo scorso, la pubblicazione postuma della conferenza sull’animale autobiografico sotto il titolo L’animale che dunque sono (Derrida, 2006), ha scoperto, per così dire, tutte le carte del gioco critico e insieme rovesciato sul tavolo il rimosso della tradizione antiumanista. Già il concetto (ma qui ne va della concettualità del concetto stesso) di traccia, come delineato fin da Della grammatologia (Derrida, 1998), precedendo e eccedendo le opposizioni tradizionali della metafisica trasmesse alla linguistica, sollecita dalle fondamenta la centralità assegnata al linguaggio umano: la traccia infatti non esiste né come linguaggio né come sistema di segni generale, né come significato né come significante, né come fonema né come grafema, non esistendo in generale secondo i principi dell’ontologia tradizionale che informa anche quei saperi che se ne vorrebbero immuni. Precedendo tutto il sistema delle opposizioni classiche, la traccia, cancellandosi, ne permette l’emersione e al tempo stesso le eccede come un tutt’altro intrinseco e necessario che decostruisce la fondazione della presenza a sé della coscienza attraverso l’autoaffezione della phoné, senza con questo fare a sua volta origine: un sistema di tracce si configura infatti come un gioco di derivazione alla deriva e senza inizio, priva di significante trascendentale; gioco d’iterazione differenziale di simulacri e supplementi. Perciò con scrittura non si deve intendere qualcosa di semplicemente opposto al linguaggio orale: Derrida utilizza questo lessema perché nella tradizione fonologocentrica la scrittura è sempre considerata derivata rispetto alla vocalità costituente del soggetto umano, e, in questo senso, impura e minacciosa; ma è quello stesso predicato della scrittura ad essere generalizzato in maniera da incrinare la presunzione d’origine in generale: scrittura in Derrida non è la parola scritta (che resta pensata sul calco di quella parlata), ma l’essere-derivato di ogni origine. È chiaro dunque che traccia e scrittura precedono ogni soggettività umana, aprendone costantemente la crisi. Ma tale crisi è complessa: nella conferenza intitolata ai Fini dell’uomo (Derrida, 1997, 153-185), la parola fine, nella sua equivocità, indica al tempo stesso la fine e il fine che intrecciano, nella tradizione, critica e rilancio del concetto di Uomo, provocando periodicamente una rottura dialettica della tradizione stessa: non una morte dunque, ma un rilevamento (Aufhebung) dell’Uomo. Molti testi (Derrida 2004; 2009-2010; 2010; 2011) disegneranno da qui in poi una traiettoria dall’andamento carsico, fino ad una sorta di resa dei conti con quello stesso antiumanismo che nell’annuncio ripetuto della morte dell’Uomo occulta ciò che, posto in opposizione ad esso, ne permette l’autocostituzione e il ciclo dialettico delle resurrezioni: l’Animale come singolare generale e indifferenziato, separato dall’Uomo da un confine unico e non suddivisibile, iscritto ancor prima che nel linguaggio, nella capacità di rispondere piuttosto che di reagire secondo il catalogo programmato di un etogramma inderogabile; nel pudore e dunque nella nudità e nella capacità di simulare e dissimulare (il lacaniano fingere di fingere: l’Animale non cancellerebbe le proprie tracce); e perciò di rapportarsi all’ente, a sé, alla morte, secondo la modalità dell’in quanto tale. Proprietà esclusivamente umane che, concatenate in una stessa serie, aprirebbero selettivamente l’accesso alla verità, al mondo, alla presenza a sé della coscienza, all’intenzionalità e alla libertà. Se la strategia di Derrida è quella di una redistribuzione di tale esclusività in violazione all’interdetto a suddividere il confine, permettendo così di riconoscere, nell’identità forzata dell’Animale, una molteplicità di forme di organizzazione della vita e singolarità irriducibili, è lo stesso proprio dell’Uomo (anche quando il proprio designa una carenza o una mancanza) ad venirne così colpito in maniera irreversibile, disseminandosi in un’improprietà comune e non dialettizzabile che piega il potere (nel suo valore sostantivale e verbale) verso una certa passività e dunque vulnerabilità condivise fra i viventi. A venirne scossa non è soltanto l’ontologia, ma insieme l’etica, il diritto, le scienze, la politica: e perciò la legittimazione implicita di ciò che, in riferimento alla zootecnica, Derrida chiama sterminio per moltiplicazione. filosofie per fughe animali

Janko Ferlic, Fotografia in primo piano dell'orso (Pexels) Ma la rottura evenemenziale prodotta dalla gatta (una gatta reale, insiste Derrida) che, esistenza singolare irriducibile a specie, genere e persino regno, attraversa il testo del filosofo in uno scambio e inseguimento di sguardi tanto asimmetrici quanto reciproci, fa da attrattore per il baccano infernale di animali demoniaci e antiedipici che vengono a infestare il proscenio umano, producendo ibridazioni di corpi e affetti in blocchi di divenire, macchine celibi e orfane e alleanze mostruose. Non si tratta di semplici fantasie umane, né di metafore filosofiche: perché il divenire-animale di Deleuze e Gattari non è un processo linguistico di significazione o produzione simbolica, ma un’operazione reale di ibridazione deterritorrializzante. Nel celebre esempio della vespa-orchidea, l’orchidea si deterritorializza formando un’immagine della vespa, che si riterritorializza sulla prima, ma così dererritorializzandosi: diviene parte dell’apparato riproduttore dell’orchidea; la vespa riterritorializza l’orchidea portandone il polline. Non è un fenomeno di mimetismo o somiglianza, ma l’esplosione di due serie eterogenee in una linea di fuga. Questo è ciò che Deleuze e Gattari chiamano rizoma. La vespa-orchidea non si riproduce, non ha genealogia, discendenza è, come blocco, al tempo stesso sterile e proliferante. Il piano di consistenza che accoglie vespa e orchidea non imita a sua volta nulla e non tende verso nulla, ma non è definito nemmeno dalle loro posizioni, come in una struttura: piuttosto da modificazioni di velocità e intensità di affetti. Il piano non cresce e non diminuisce se non all’aumento e alla riduzione delle intersezioni dei blocchi di divenire che gli sono immanenti (Deleuze & Guattari 2017). Movimento contronatura della natura stessa, contromovimento trasversale e non arborescente dell’evoluzione: involuzione reciproca senza regressione. Frammento di DNA catturato da un virus e trasportato nella doppia elica di un altro corpo. Divenire-animale dell’uomo, come per tutti i divenire minoritari (divenire-donna del maschio, divenire-bambino dell’adulto) non significa che l’uomo imiti l’animale, che vi s’identifichi, che lo diventi: ciò arresterebbe il divenire stesso in un divenuto come filiazione; ma il divenire non si arresta, piuttosto entra in un altro divenire, intersecandosi s’uno stesso piano di consistenza a n dimensioni. In gioco non c’è rassomiglianza o differenza, né corrispondenza, di caratteri, forme o funzioni: tutto questo serve semmai allo Stato per le sue classificazioni. L’uomo può sempre immaginare di essere un animale, ma ciò che è reale del divenire è il divenire stesso come divenire tra eterogeneità. Ha a che fare con una muta, una banda, una popolazione e un popolamento, una molteplicità; espansione, propagazione e contagio, in cui le nozioni classificatorie arborescenti e seriali (dall’inferiore al superiore, dall’indifferenziato al sempre più differenziato) non hanno pertinenza. Si è presi in un divenire-animale come Achab e la balena, patto con un demone. Come il piccolo Hans e il cavallo nel caso di Freud, ma senza che il cavallo diventi un simbolo e gli affetti di Hans sintomi. Le linee di fuga di questo concatenamento (Hans, cavallo, omnibus, letto, strada, ecc…) non sono rappresentazioni in un triangolo edipico, ma affetti in un divenire che non nasconde niente, tanto meno un significante trascendentale, dispotico. E se ci sono animali tendenzialmente edipici e familiari (il mio gatto, il mio cane) e altri demoniaci (la zecca, la muta di lupi, il topo, la balena), a certe condizioni tutti gli animali possono divenire demoniaci, stringere un patto innaturale con l’umano, entrare in divenire con esso e con altro, indipendentemente dal regno in cui sono classificati. Di nuovo: in ragione di differenziali d’intensità e accelerazione di affetti.
Nonostante l’amicizia e le affinità con Deleuze e Guattari (benché a volte esagerate ex post da chi ha tentato di incasellare e binarizzare la tradizione recente, opponendo, per esempio, decostruzione e pensiero biopolitico, impoverendo la ricchezza e il dinamismo di quadri concettuali ben più complessi e fecondi), sembrerebbe difficile trovare qualcosa di altrettanto “animale” nelle genealogie dell’invenzione dell’Uomo in Foucault. Eppure è proprio nella costellazione di quel nuovo potere che si configura nell’eclissi della sovranità classica, massimizzando su scala di popolazione gli effetti dei poteri disciplinari e normalizzanti (Foucault 1978; 2005a; 2005b), che un certo pensiero ha trovato il punto d’accesso per una riflessione biopolitica sulle pratiche di domesticazione e potenziamento della vita in cui le vicende delle specie s’intrecciano in maniera differenziale ma insolubile. In particolare è la stessa scoperta del campo di ciò che Foucault chiama ontologia selvaggia, ossia una concezione della vita che ne travolge le forme in direzione di trasformabilità infinita, in cui la teoria darwiniana e le pratiche zootecniche di ibridazione e selezione s’inseguono a vicenda, a rendere non più delimitabile lo stesso campo di azione biopolitico. È uno zoopotere a venire così allo scoperta in maniera irrimediabile per ogni genealogia del vivente: non si potrà più parlare di pratiche di disciplinamento senza rendere conto di ciò che avviene nello spazio dell’allevamento e dello stabulario con i loro recinti, il governo dei corpi, l’intensificazione della produttività attraverso le pratiche empiriche e i saperi scientifici (questi ultimi mai immuni dai primi). Il lavoro di Benedetta Piazzesi ha, da questo punto di vista, aperto prospettive immense: la rottura imposta dal capitalismo al giardino come wunderkammer degli exempla di specie, microcosmo che rispecchia il macrocosmo di una natura stabile e invariante, e dell’utopia della Villa in cui ogni animale è utile per natura, in direzione di una manipolabilità della vita che solo successivamente le scienze giustificheranno de iure con la teoria dell’evoluzione e i suoi flussi morfogenetici, è un evento onto-storico che non si può spiegare solo in termini economici. A annunciarsi qui è infatti una nuova economia del vivente e della vita in cui la funzione dei corpi degli animali non umani non muta in relazione a un solo vettore del potere, ossia quello, estrattivo, del capitalismo marxista. Benché l’opposizione netta fra Uomo e Animale non tramonti mai né nei saperi né nei discorsi diffusi, a sovrapporvisi è una griglia continua e differenziata attraverso la quale l’Uomo è sì riassorbito nell’alveo del vivente – dal quale l’alleanza fra platonismo e cristianesimo l’aveva sottratto, facendone uno straniero nel mondo dei corpi e della carne – ma in posizione di eccezionalità (Piazzesi 2015). Parallelamente la stessa vicenda si ripete in ambito infraumano, dove il sapere biologico differenzia gerarchicamente il continuum della specie secondo le magnitudo dei popoli e degli individui, aprendo la strada alle scienze razziali (Foucault 2009a). Anche in psichiatria (fattore attivo nello stesso processo), all’epoca del grande internamento dei folli succederà il controllo capillare della gamma infinita delle anomalie, proiettando la psichiatria stessa fuori dai manicomi ad allagare ogni sfera dell’esistenza sociale e producendo ampie zone di indistinzione con altri poteri, a cominciare da quello giuridico (Foucault 2009b). I fasci di sapere-potere eccedono insomma i confini di specie, provocando continue retroazioni da una parte all’altra della frontiera.
Agamben ha fissato questa paradossale continuità discontinua nel dispositivo onto-politico della macchina antropologica, che nel tentativo di fissare il proprio dell’Uomo permette il transito di interi gruppi umani nell’animalità, esponendoli così alla sacertà come uccidibilità senza crimine (Agamben 2002). Tale dispositivo antropo-zoo-genico, che corrisponde alla tradizione stessa del pensiero occidentale, tenta infatti, nel suo moto incessante, di risolvere il mysterium conjuntionis fra zoé e bíos, vita animale e vita umana, ossia dell’emersione stessa della seconda dalla prima. Producendo però inevitabilmente una zona di indistinzione ed eccezione, nel modo dell’inclusione di un fuori (il barbaro e lo schiavo, l’enfant sauvage, insomma l’animale dalle fattezze umane, nella macchina antica), o dell’esclusione di un dentro (l’uomo animale, ossia l’ebreo e i suoi sostituiti, ma anche l’oltrecomatoso, nella macchina moderna). In entrambi i casi, il centro della macchina è perfettamente vuoto come lo è ogni spazio di eccezione, e il missing link della conjunctio che essa dovrebbe elaborare rilancia all’infinito un’operazione di cesure e riarticolazioni il cui risultato non è mai né una vita animale né umana, ma una nuda vita, ossia un vita separata da sé stessa. Ogni tentativo di far funzionare la macchina altrimenti produrrebbe allora lo stesso risultato: la proposta messianica di Agamben è allora di applicare la dialettica in arresto di Benjamin; non tentare più di risolvere il mistero della congiunzione, ma indagare le procedure della disgiunzione biopolitica, così da arrestare la macchina e impedire una nuova operazione dialettica tra Natura e Uomo. Ciò che allora più conterà in tale coppia sarà proprio il tra che la separa impendendone la congiunzione, e, sospendendo reciprocamente i due termini, apre a qualcosa che, insediandosi nell’intervallo, non è più né Uomo né Animale, Umanità o Natura. Secondo un altro topos benjminiano, vita insalvabile nella notte salva, abbandonata e inoperosa, consegnata al gioco e alla voluttà.
M49 cancella le sue tracce, finge e finge di fingere: traccia percorsi depistanti, doppi del suo stesso sviamento, della sua deriva gioiosa. Perché ancora più che sulle fughe e sui depistaggi, sull’agency soggettiva e attiva che l’Uomo non gli riconosce, è sull’agentività passiva, sul fare blocco con le forre e le stagioni, le pendenze della luce nella selva o nelle radure, i muschi, mille altre tracce non umane, che insiste Massimo Filippi nel volume omonimo di recente pubblicazione: M49. Un orso in fuga dall’umanità. Certo, questa fuga è un’evasione, un intreccio di diversivi e diversioni; ma è anche qualcosa come uno svago, una vacanza e un abbandono. Abbandonando l’Uomo e le prigioni che tagliano e organizzano lo spazio della sorveglianza e della cattura, egli si abbandona al possibile rischioso e improgrammabile di una vita insalvabile e perciò esposta a connessioni, contatti, contagi. Fuga, ma insieme linee di fuga lungo le quali egli diviene muschio, diviene forra, picco, bosco, cielo, pendenza di luce, calore, pietra, decodificando in flussi il codice che lo cattura come elemento tassonomico fisso, elemento di Stato e di codice di procedura: unorso non come specimen, ma in quanto molteplicità, e in quanto tale animaux, molteplicità degli animali catturati nel dispositivo di esclusione includente dell’antropogenesi prima ancora di ogni prigionia, eppure in rivolta.
Una myse en abîme interseca qui più blocchi di divenire: unorso parla, un* uman*, parlandogli, ne parla, quando unorso è di nuovo catturato; l’autore ne scrive: l’uman* fa blocco con unorso, entrambi con l’autore; ma tutti cessano così di essere semplici soggetti narranti e/o narrati, diventano qualcos’altro secondo un divenire molecolare della scrittura: zone di attrazione e vicinanza, attraversamento, zone d’intensità variabile, pullulazione e contagio che non hanno bisogno di virgolette e note al testo. Filippi tira i fili di un’immensa tradizione, ma anche questi sono altrettante linee di fuga che estraggono rizomi da strutture ramificate, gerarchiche. Fino all’eclissi dei soggetti dell’annunciazione: linguaggio come sciami di particelle, vita di un cosmo in espansione, fuga di costellazioni e galassie. Lingua straniera, lingua aliena, divenire-impercettibile. Non sappiamo chi sogni, qui – Filippi, unorso imprigionato, un alt* uman*, un altro animale. Ma il sogno è reale, e immenso. E può sognare il passato o il futuro.
Non che si dissolvano la compassione, la simpatia, l’evento del venire di un altro irriducibile, in nome del quale si scrive, e – così, anche – si lotta: ma queste passioni, azioni, avvenimenti si dislocano per riposizionarsi o avventurarsi ad un grado più profondo e più intenso della partecipazione; di quella com-parizione che per Jean-Luc Nancy era apparizione reciproca, perché non si appare al mondo senza comparire a qualcun*, con qualcun*, l’un* all’altr*; di quel partage in cui si è già da sempre gettat*, essere-insieme che non forma alcun insieme, che sia di specie, di genere, di vicinato, gruppo o collezione, o quello generale dell’ente nella sua totalità. Ondate di vibrazioni fanno risuonare le passioni, i desideri e gli incontri di un’intensità nuova e inaudita. M49, unorso, è ormai irrimediabilmente Tra.Antonio Volpe
BIBLIOGRAFIA
Agamben, G. (2002). L’aperto. L’uomo e l’animale. Torino: Bollati Boringhieri.
Deleuze, G. & Guattari, F. (2017). Mille piani. Capitalismo e schizofrenia. Trad. It. di G. Passerone. Napoli-Salerno: Orthotes.
Derrida, J. (1997). Margini della filosofia. Trad. It. di M. Iofrida. Torino: Einaudi
Id. (1998). Della grammatologia. A cura di G. Dalmasso. Trad. It. di R. Balzarotti et al. Milano: Jaca Book.
Id. (2004). Aporie. Morire – Attendersi ai limiti della verità. Trad. It. di G.Berto, Bompiani, Milano.
Id. (2006). L’animale che dunque sono. Trad. It. di M. Zannini. Milano: Jaca Book.
Id. (2009-2010). La bestia e il sovrano (I-II). Trad. It. di G. Carbonelli. Milano: Jaca Book.
Id. (2010). Dello spirito. Heidegger e la questione. Trad. It. di G. Zaccaria. Milano: SE.
Id. (2011). «Il faut bien manger». O il calcolo del soggetto. Trad. It. di S. Maruzzella & F. Viri, Milano-Udine: Mimesis.
Filippi, M. (2022). M49. Un orso in fuga dall’umanità. Roma: Ortica.
Foucault, M. (1978). La volontà di sapere. Trad. It. di P. Pasquino & G. Procacci, Milano: Feltrinelli.
Id. (2005a). Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979). Trad. It. di M. Bertani & V. Zini. Milano: Feltrinelli.
Id. (2005b). Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Collège de France (1977-1978). Trad. It. di P. Napoli. Milano: Feltrinelli.
Id. (2009a). Bisogna difendere la società. Corso al Collège de France (1975-1976). Trad. It. di M. Bertani & A. Fontana. Milano: Feltrinelli.
Id. (2009b). Gli anormali (Corso al Collège de France 1974-1975). Trad. It. di V. Marchetti, A. Salomoni. Milano: Feltrinelli.
Piazzesi, B. (2015). Così perfetti e utili. Genealogia dello sfruttamento animale. Milano-Udine: Mimesis.
-
Corpi che non contano. Judith Butler e gli animali
Recensioni / Dicembre 2015 Vengono smembrati, disossati, cucinati e infine divorati. Vengono sfruttati, vivisezionati, modificati e poi sacrificati. Sono i corpi animali, i corpi che (ancora) non contano – o meglio: contano in termini nutritivi, economici e scientifici; contano, insomma, da un punto di vista antropocentrico. Sono materia prima, corpi senza vita che l’uomo plasma come vuole e di cui non piange le uccisioni. Sono piccoli blocchi, mattoncini di carne sui quali l’uomo ha fondato il suo impero, edificato e arroccato su principi di naturalità che soltanto oggi, con immensa lentezza e fatica, iniziano a essere minimamente scalfiti. La messa in discussione dei ruoli assegnati sulla base del naturalismo è un processo complicato ma necessario, in quanto mina la binarizzazione gerarchizzante di base: natura da una parte, cultura dall’altra. Compiere questo primo ma fondamentale passo porta alla ridefinizione dei ruoli svolti dagli esseri, abolendo l’assegnazione degli stessi “per natura” e sviluppando al contempo nuove concezioni e definizioni: ruolo come dimensione in cui muoversi e agire, ruolo come spazio in cui si fa e si disfa, ruolo come luogo libero che accoglie la performance dell’animale, umano e non. Il volume collettaneo Corpi che non contano. Judith Butler e gli animali (Mimesis, 2015) si pone l’obiettivo di testare, come annuncia provocatoriamente il curatore Massimo Filippi nell’introduzione, il pensiero di Judith Butler sugli animali. Se la domanda cardine del pensiero butleriano è «A chi spetta una buona vita?», quale lavoro filosofico meglio del suo può essere utile da incorporare negli Animal Studies? Nonostante la pensatrice americana non abbia mai esteso il suo ragionamento agli animali non umani, all’interno dei suoi studi sono molteplici gli strumenti e i concetti potenzialmente utili (vita precaria, performatività, lutto…) alla demolizione delle binarizzazioni oppositive e al riconoscimento dell’altro non umano. Nella breve intervista presentata all’interno del volume, è la stessa Butler a elogiare i movimenti antispecisti per lo sforzo che stanno compiendo in questa direzione: «Sono convinta che questi movimenti si stiano sforzando di mettere in rilievo le reti di interdipendenza che normalmente non vengono riconosciute». Non resta dunque che limare le derive antropocentriche del pensiero butleriano e inaugurare nuove strade che ci portino lontano dalla norma vigente, mettendola in discussione come i movimenti femministi e queer hanno fatto nei decenni passati nei confronti del pensiero eteronormato, riscuotendo successi e raggiungimenti filosofici, sociali e mediatici allora insperati.
Vengono smembrati, disossati, cucinati e infine divorati. Vengono sfruttati, vivisezionati, modificati e poi sacrificati. Sono i corpi animali, i corpi che (ancora) non contano – o meglio: contano in termini nutritivi, economici e scientifici; contano, insomma, da un punto di vista antropocentrico. Sono materia prima, corpi senza vita che l’uomo plasma come vuole e di cui non piange le uccisioni. Sono piccoli blocchi, mattoncini di carne sui quali l’uomo ha fondato il suo impero, edificato e arroccato su principi di naturalità che soltanto oggi, con immensa lentezza e fatica, iniziano a essere minimamente scalfiti. La messa in discussione dei ruoli assegnati sulla base del naturalismo è un processo complicato ma necessario, in quanto mina la binarizzazione gerarchizzante di base: natura da una parte, cultura dall’altra. Compiere questo primo ma fondamentale passo porta alla ridefinizione dei ruoli svolti dagli esseri, abolendo l’assegnazione degli stessi “per natura” e sviluppando al contempo nuove concezioni e definizioni: ruolo come dimensione in cui muoversi e agire, ruolo come spazio in cui si fa e si disfa, ruolo come luogo libero che accoglie la performance dell’animale, umano e non. Il volume collettaneo Corpi che non contano. Judith Butler e gli animali (Mimesis, 2015) si pone l’obiettivo di testare, come annuncia provocatoriamente il curatore Massimo Filippi nell’introduzione, il pensiero di Judith Butler sugli animali. Se la domanda cardine del pensiero butleriano è «A chi spetta una buona vita?», quale lavoro filosofico meglio del suo può essere utile da incorporare negli Animal Studies? Nonostante la pensatrice americana non abbia mai esteso il suo ragionamento agli animali non umani, all’interno dei suoi studi sono molteplici gli strumenti e i concetti potenzialmente utili (vita precaria, performatività, lutto…) alla demolizione delle binarizzazioni oppositive e al riconoscimento dell’altro non umano. Nella breve intervista presentata all’interno del volume, è la stessa Butler a elogiare i movimenti antispecisti per lo sforzo che stanno compiendo in questa direzione: «Sono convinta che questi movimenti si stiano sforzando di mettere in rilievo le reti di interdipendenza che normalmente non vengono riconosciute». Non resta dunque che limare le derive antropocentriche del pensiero butleriano e inaugurare nuove strade che ci portino lontano dalla norma vigente, mettendola in discussione come i movimenti femministi e queer hanno fatto nei decenni passati nei confronti del pensiero eteronormato, riscuotendo successi e raggiungimenti filosofici, sociali e mediatici allora insperati.Quando il 26 ottobre 2015 l’International Agency for Research on Cancer – agenzia facente parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità – diffonde un comunicato con cui informa che le carni rosse sono probabilmente cancerogene e le carni rosse lavorate (insaccati e salumi) sono sicuramente cancerogene, un brivido di inquietudine – nella maggioranza dei casi carico di inesattezze scientifiche e macchiato di qualunquismo e semplificazioni – getta nello scompiglio l’opinione pubblica. Il dibattito che ne consegue è, ancora una volta, unidirezionale, tecnoscientifico e antropocentrico, ma permette di mettere in luce alcuni aspetti discussi in Corpi che non contano. La reazione alla diffusione del rapporto dello IARC infatti mette in evidenzia ciò che nell’ultimo saggio Federico Zappino definisce “norma sacrificale”. Si tratta della norma che, ancora più di quella eterosessuale, è stata forclusa, resa non evidente, inintelligibile. È il sacrificio perpetuo di miliardi di animali non umani, un sacrificio dal quale è complicato liberarci se si tengono presenti i desideri che esso soddisfa (il consumo di carne a tavola, per esempio) e la soggettivazione di cui è parte integrante. Come liberare l’uomo da un desiderio senza doverlo castrare e reprimere, si chiede Zappino? Seguendo le orme di Foucault, è bene lasciare spazio a nuovi desideri, creativi e fluidi, che possano accompagnare in modo libero la critica alla norma vigente, dando vita a nuove dimensioni da sperimentare.
Quando la norma resiste agli scossoni – come ha dimostrato la reazione al comunicato dell’OMS, veicolata attraverso messaggi pregni di “orgoglio carneo” e talvolta venati da caustico umorismo – allora è necessario intaccarla alla radice; questo è l’obiettivo che si pongono James Stanescu e Richard Iveson, che firmano un saggio a testa nel volume. Entrambi pongono l’accento sull’errore di considerare l’animale quale pre-condizione dell’umano. Si tratta di uno scivolone che coinvolge anche Judith Butler in Frames of war, in cui ancora una volta viene promulgata un’idea profondamente umanista e fondata su quell’eccezionalismo umano che dovrebbe essere la prima barriera da abbattere per intavolare una discussione critica sul rapporto interspecifico. In quest’ottica, lo stesso concetto di umano diventa norma, escludendo tutto ciò che non rientra in questa categoria dalla considerazione e relegandolo a un “grado zero” (l’animalità) su cui fondare il dominio dell’uomo sul mondo. La carne degli animali è quindi soltanto meat [carne morta] e non flesh [carne viva], è altro da noi umani, è soltanto materia inerte potenzialmente cancerosa – salsicce, wurstel, salumi, braciole, costolette – e, soprattutto, non è meritevole di lutto. La morte dell’animale per mano umana non è, dunque, omicidio, cioè morte degna di essere compianta, ma mera uccisione, morte senza ricordo, perché dovuta, necessaria e, ovviamente, naturale.
Accanto al concetto di lutto, a lungo esplorato da Butler nel corso della sua carriera, si affianca quello di vita precaria, punto cardine nell’applicazione del pensiero butleriano agli Animal Studies secondo Stanescu. La precarietà – essendo prima di tutto una condizione collettiva e non individuale – pone l’accento sulle connessioni e sulla relazione ed è, secondo Butler, un luogo da cui partire per riorganizzarsi e non uno stadio da superare. Inoltre, la precarietà è sia un luogo che una questione ontologica; un concetto cruciale ma da cui non dobbiamo difenderci, perché la minaccia reale è l’immunità con cui schermiamo la precarietà stessa, operando processi di disconoscimento nei confronti dell’Altro. «Tramite un rifiuto di affrontare la nostra finitudine corpeizzata e condivisa», scrive Stanescu, operiamo la prima spaccatura che ci separa dal bios dell’animale non umano. Solo muovendo dalla nostra precarietà possiamo comprendere che la carne che consumiamo e sfruttiamo in molteplici modi prima di essere lavorata (e diventare cancerogena) si muove, si nutre e si riproduce: è viva, ed è animale tanto quanto la nostra.
Ogni anno su questo pianeta vengono uccisi circa centocinquanta miliardi di animali non umani. Dati simili sono spesso inintelligibili, nascosti agli occhi dei più e radicati profondamente nella norma sacrificale. Come ricorda Marco Reggio nel suo intervento in Corpi che non contano, il pensiero butleriano può essere fondamentale per portare alla luce i rapporti di interdipendenza fra uomo e animali non umani e per mettere in discussione il concetto stesso di umano e il suo eccezionalismo. Fra le maglie della rete che tenta di opprimere e nascondere la solidarietà interspecifica, si fanno strada studi – come questo – che portano a galla verità soggiacenti, da sempre presenti ma, speriamo, ancora per poco ignorate.
di Danilo Zagaria

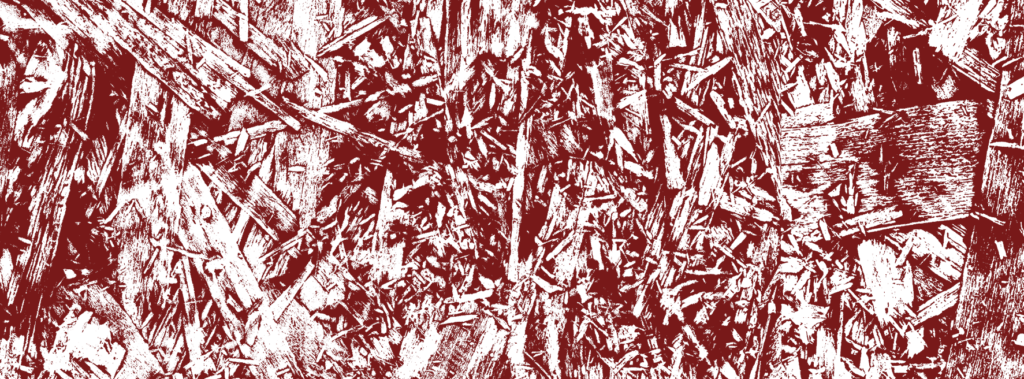
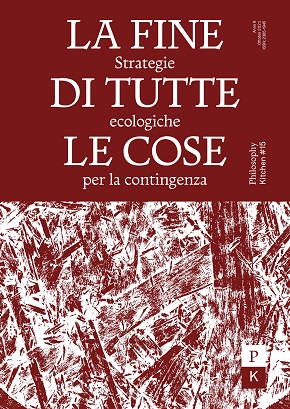

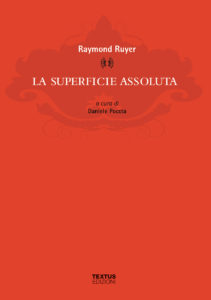

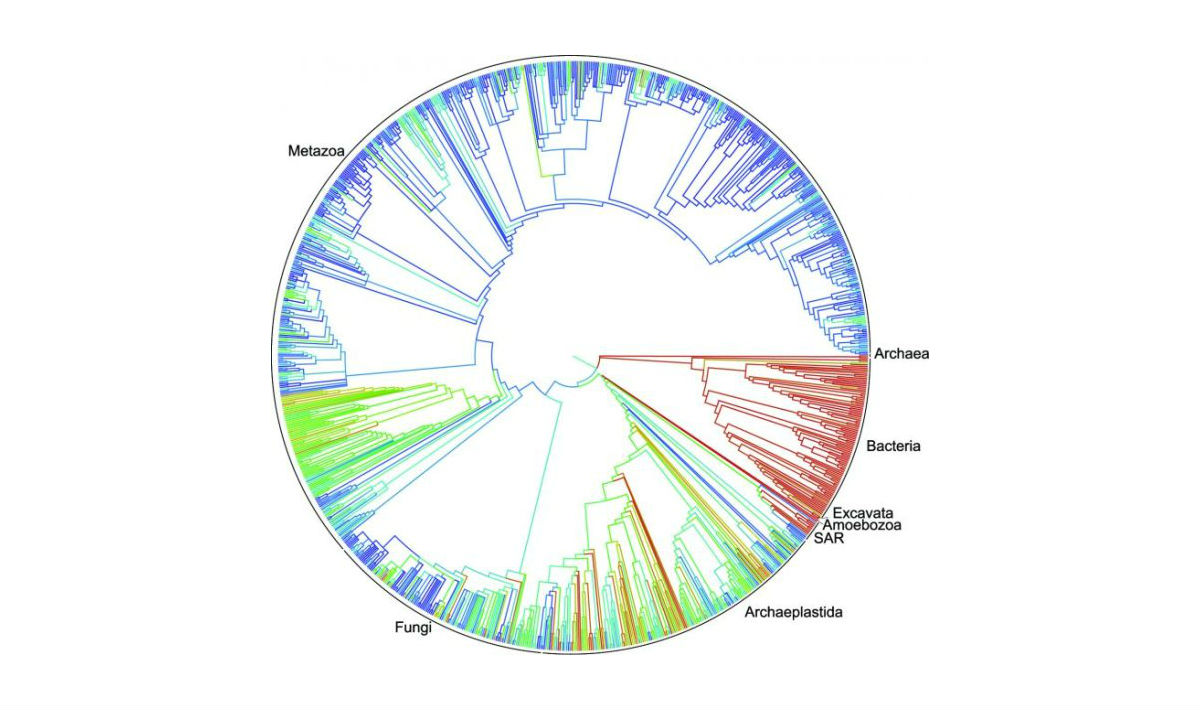
 È finalmente disponibile nella traduzione italiana l'opera che ha portato alla ribalta della scena intellettuale e accademica mondiale l'antropologo brasiliano Eduardo Viveiros De Castro:
È finalmente disponibile nella traduzione italiana l'opera che ha portato alla ribalta della scena intellettuale e accademica mondiale l'antropologo brasiliano Eduardo Viveiros De Castro: 
