In questo breve ma densissimo volume, Jacques Lacan, una scienza di fantasmi, (Orthotes 2019) Federico Leoni continua il suo lavoro di originale rilettura delle riflessioni di Jacques Lacan, facendo funzionare il complesso, monumentale e oscuro svolgersi del pensiero dello psicoanalista parigino come pungolo per costruire nuove possibilità di traiettorie teoriche. Infatti, questo libro non vuole essere tanto un testo d’introduzione a Lacan quanto la continua interrogazione e scavatura di alcune delle sue più importanti riflessioni. Un’indicazione sulla lettura del testo ci viene direttamente dall’autore alla fine del libro: “Questo è un libro insistente. Ogni capitolo mostra una stessa cosa, che si presenta ora come Uno, ora come tratto, ora come voce, ora come mana, ora come fantasma, ora come oggetto, ora come gesto, ora come miniatura, ora come ideogramma.” (Leoni 2019, p. 173). Questa “stessa cosa” che Leoni ci mostra in Una Scienza di Fantasmi è l’evento – sempre attivo – dell’insorgenza e dell’inscrizione che produce il continuo processo di soggettivazione. Il libro è, allora, una sorta di indagine sul “supporto” di questo processo, non ritrovato in un fondamento certo e stabile quanto definito e perciò perduto, ma in una materia fluida e inafferrabile che anima la soggettivazione sempre in atto. Cercheremo di riattraversare l’insistenza di questa “stessa cosa” attraverso due vettori in particolare: l’Uno e la perversione.
La struttura di questo libro è permeata da una modalità particolare, che viene in qualche modo rivelato verso la fine del libro: l’obliquità. L’obliquità, o inclinazione, è proprio quella del diwan, del lettino freudiano, residuo della regressione ipnotica (anticamera della psicoanalisi). Questa strana angolatura, caposaldo del metodo clinico psicoanalitico, viene applicata costantemente nel testo sul continuo torcersi del pensiero dei filosofi interpellati. Questo non significa che i filosofi (fra i più presenti troviamo Leibniz, Kant, Cartesio, Bergson e Deleuze) vengano interrogati sui loro fatti privati, ma che le loro teorie, in qualche modo, vengano rese “spurie”, inclinate e condotte verso nuove possibilità.
E non è un caso che nell’obliquità e nell’inclinazione ci stia anche la deviazione: infatti ciò che per eccellenza de-via in psicoanalisi è la per-versione, la negativa freudiana della nevrosi, ciò che modifica la rotta e batte strade nuove.
L’Uno, rintracciato e moltiplicato in varie figure (come il mana, il gesto, la voce, l’oggetto), è il protagonista indiscusso di questo libro e ne è anche il ritmo, la scia continua che permette ai molti percorsi anche eterogenei dipanati dall’autore di scandirsi in maniera sempre più coordinata. E, in qualche modo, da un punto di vista letterario, si potrebbe ascrivere questo libro di filosofia al genere del picaresco: assistiamo infatti a un continuo peregrinare avventuroso di questo Uno, dalla psicoanalisi lacaniana ai vari pensieri filosofici indagati, fino all’arte e alla letteratura. Un’altra maniera di mettere a fuoco la centralità di questo Uno ce la suggerisce Leoni stesso attraverso l’altro protagonista di questo libro, il fantasma, paradossalmente più nascosto rispetto alla onnipresenza dell’Uno. L’Uno è il fantasma di questo saggio filosofico, nel senso che è la cornice che anima la sua struttura e attraverso la quale si determina un continuo assemblaggio fra psicoanalisi e filosofia.
L’Uno non è, però, una nozione priva di ambiguità e addirittura strane sorte di pregiudizi sia nell’ambito filosofico che in quello della psicoanalisi lacaniana, come nota Leoni stesso. Sul lato filosofico, nel testo si insiste su come l’Uno sia uno dei marchi dell’elaborazione filosofica sin da Platone e dal platonismo (in Plotino l’Uno trova il suo apice) e non a caso Leoni riprende il Parmenide di Platone che si interroga sull’Uno e il Moltepice (Leoni 2019, p. 103). D’altronde lo stesso Lacan a suo modo notava nel seminario XVI (La logique du fantasme, ancora inedito in italiano) che Platone e Plotino sono fra i pochi filosofi che non cadono nell’errore di sovrapporre Essere e Uno e che riescono a fornire una riflessione specifica su questa dimensione dell’Uno (Leoni 2019, p. 21). Nonostante ciò, secondo Leoni, “dell’Uno non ne è più nulla, nella filosofia, da un certo punto in poi, e salvo diramazioni preziose quanto isolate” (p. 6).
Sul lato psicoanalitico si può dire che il tema dell’Uno emerge in punti diversi dello svolgimento dei seminari lacaniani. All’inizio più che essere un Uno filosofico, l’uno lacaniano è l’eredità dell’einziger Zug (tratto unico o unario) del Progetto di una psicologia freudiano del 1895. Da qui Lacan inizia a elaborare la nozione di tratto unario, che definisce una visione dell’incidenza del significante a partire da un tratto traumatico originario e di “partenza” per l’identificazione e perciò soggettivazione (Seminario IX). Più tardi questo tratto unario assumerà forme differenti nel Seminario XVII subendo una torsione e divenendo S1, il significante padrone cui ci si identifica e da cui origina la catena significante. Solo a partire dal Seminario XIX Lacan (2011) inizia a porre la questione di un Uno filosofico-psicoanalitico, e lo fa confrontandosi soprattutto con Platone e la teoria degli insiemi di Cantor e Frege. Insomma, sembra che si passi da un uno dalla lettera minuscola all’Uno con la maiuscola. Quando Miller (2013) ripercorre le riflessioni di Lacan sull’Essere e l’Uno mette in luce come Lacan passi da una “ontologia” (o ancor meglio una para-ontologia) a una “henologia”, un discorso sull’Uno. Nella lettura milleriana l’Uno di questo Lacan è esemplificabile nella messa a fuoco della dimensione del “corpo che si gode”, narcisisticamente e autisticamente, che diviene sempre più centrale nella costruzione teorica lacaniana. L’immagine dell’Uno che si è andata a definire sempre di più nella psicoanalisi lacaniana è quella concentrata dalla formula milleriana dell’Uno-tutto-solo o Uno-senza-Altro, che rifugge dalla dialettica che si istituisce fra un soggetto e l’Altro, per richiudersi su sé stesso in un godimento sterile e “perverso”. Ma è proprio a partire da un’altra lettura della perversione che Leoni vuole riconsiderare filosoficamente la nozione di Uno psicoanalitico, con l’obiettivo di mostrarne una dimensione nascosta e ricavata proprio dalla elaborazione lacaniana.
La perversione, nell’ambito clinico lacaniano, viene spesso indicata come quella struttura per la quale il soggetto si colloca nella posizione di oggetto inscalfibile, scaricando sull’Altro l’angoscia generata in lui dalla divisione inferta nel soggetto dal linguaggio. Il perverso vuole dividere l’Altro, proiettare su di lui l’angoscia della castrazione che non intende sostenere su sé stesso addirittura arrivare ad angosciare Dio, l’Altro per eccellenza (Recalcati, 2016; Lacan, 2004).
Un altro modo di dire la questione della perversione (ed è a partire da questa altra angolazione che parte la riflessione di Leoni), non contraddicendo necessariamente le altre letture ma facendo emergere un lato “positivo-creativo”, è che il soggetto della perversione “comprende” la struttura e il funzionamento del linguaggio e che in qualche modo usi questa “competenza” riversandola sull’Altro. È in questo senso che, nella prospettiva della teologia psicopatologica paolino-lacaniana suggerita da Leoni nel primo capitolo, se il nevrotico vive nel dramma innescato dalla Legge e lo psicotico non riconosce, forclude questa dimensione della Legge, non accedendo completamente al Simbolico, il perverso conosce questa Legge per negarla e superarla, per andare aldilà di essa e collocarsi al posto di Dio (pp. 8-11). Il soggetto perverso si sistemerebbe nella posizione di colui che scrive, letteralmente crea la Legge, addirittura identificandosi con essa. In questa direzione, si può suggerire, a ulteriore chiarimento, l’immagine prototipica data dall’inserto filosofico-politico di Sade (autore caro a Lacan) all’interno della sua Filosofia nel boudoir. Qui viene messo in luce come il perverso conosca lo strumento della Legge e del suo istituirsi e come utilizzi questo sapere per creare e immaginare un nuovo tipo di società iperbolica, sebbene basata su principi razionali, macabramente illuministici e “formalizzati” su un piano giuridico-filosofico.
A partire da questo lato creativo della posizione soggettiva della perversione, Leoni ci interroga sulla possibilità di concettualizzare la filosofia non come un processo paranoico (la diagnosi che Freud aveva, a suo tempo, affibbiato, e con una certa logica, alla filosofia) di iperuniversalizzazione e astrazione, purificazione dei pensieri e dei concetti. Piuttosto l’autore ci spinge a immaginare la filosofia come un processo perverso, la messa in atto di una possibilità di continua scrittura e riscrittura creativa del pensiero e del mondo a partire dall’invenzione filosofica.
C’è qualcosa come un’altra perversione, qualcosa come un altro scatenamento del possibile, che quella costellazione di pensatori cerca di mettere a fuoco. Misurarsi con la morte di Dio significa misurarsi con quest’altra perversione, con quest’altro scatenamento del possibile. Nuovi possibili si rendono possibili, nuovi impossibili si disegnano a margine di quei possibili. […] [Il perverso] Si mette al posto di Dio, e crea i possibili, o dice che al posto di Dio non c’è nient’altro che questa incessante creazione dei possibili. (Leoni 2019 p. 79)
Infatti, si può dire che la scrittura leoniana di questo testo sia in un certo qual modo perversa, producendo deviazioni, scatenamenti e misurandosi con un’esplorazioni dei possibili. Nel quinto capitolo, Leoni si riallaccia, e non a caso, proprio alla figura di Bafometto (p. 85), principe infernale delle metamorfosi e idolo templare protagonista del romanzo del filosofo “perverso” Klossowski. Nel testo klossowskiano, infatti, si esplicherebbe una condizione di continua trasformazione e implicazione di “tratti dentro altri tratti”:
Ogni tratto di divenire sposta ogni altro tratto implicandolo nel proprio percorso, facendo di ogni altro tratto un proprio segno e facendo di sé stesso un segno di ogni altro tratto. Qui leggere è fare, interpretare è fabbricare. Per questo il lettore dei segni di quel cosmo non va immaginato come davanti a un libro, immune ai segni che sta decifrando, ma come un segno esso stesso, e come un fabbricatore esso stesso. (Leoni, 2019 p. 89-90)
Dunque, in questa direzione obliqua e deviata, l’Uno inizia ad apparire non tanto come un Uno che accade, uno spazio definito nello spazio-tempo o nel soggetto, quanto il supporto continuo, la piega nel soggetto che permette che una soggettivazione, continuamente in genesi e in divenire, accada (Leoni 2019 p. 51). Dunque, se questo Uno non è l’Uno-tutto-solo della perversione, che Uno perverso della creazione sarebbe? L’Uno, che qui viene ripreso a partire dal Seminario XIX di Lacan (2011), non è semplicemente un momento atavico, uno stadio larvale della soggettività che precede cronologicamente l’incontro del soggetto con l’Altro. Viene, invece, indicato come quell’evento, o ancora meglio come quel rimasuglio dell’evento (eco de l’Y a d’l’Un lacaniano) che permette strutturalmente l’emergere di una dialettica fra il soggetto dell’Altro. L’Uno non sarebbe, dunque, un soggetto che può mettersi in dialettica con un Altro (e che eventualmente sceglie di non farlo) ma sarebbe l’evento stesso della possibilità di un’emergenza del rapporto fra un soggetto e l’Altro, in altre parole il suo supporto. È come dire che nell’Uno sta già il Due e il molteplice, nel senso che l’Uno permette, ponendosi come fondamento, l’articolarsi fra più elementi, fra più Uni:
Ovvero, che c’è dell’Uno, c’è l’operazione di un Uno molto più profondo o molto più superficiale di così, un Uno che non sta né dalla parte dell’uno né dalla parte dell’altro, ma che distribuisce le parti e opera la divisione, non cessando un istante di non-dividersi al fondo della divisione stessa. Questo Uno è nella stessa posizione dell’Altro, anzi è l’Altro stesso, ma come il suo accadere. L’Uno è l’Altro che accade, o l’Altro è l’Uno ormai accaduto. L’Altro è il regime dei rapporti istituiti, l’Uno è l’istituirsi di quei rapporti. (Leoni 2019 p. 35)
Uno, dunque, che nel suo continuo mettere in atto la divisione senza esserne compromesso (una sorta di fondo psicotico a ogni nevrosi), mostra la natura continuamente metamorfica della soggettivazione, del suo incessante divenire all’interno di una logica sostenuta dallo scandire di questo Uno fondamentale. Dunque, nella lettura di Leoni, se l’Altro è il “regime” dove si sono dati dei legami e delle leggi secondo un ordine simbolico (istituito), l’Uno sarebbe il supporto che permette che questi rapporti si istituiscano senza esso si istituisca mai.
Ancora, per rimanere nel solco del complesso svilupparsi della riflessione lacaniana attraverso i suoi seminari, il tratto unario, l’elemento di identificazione a un tratto dal soggetto che fa partire la sua soggettivazione, è sostenuto dalla dimensione dell’uniano, appunto da quel yadlun (“c’è dell’uno”) inassimilabile e allo stesso tempo motore e supporto della possibilità di far partire la soggettivazione dall’identificazione del tratto unario. Certo, seguendo Lacan non troviamo un Uno tutto-pieno, monolitico e compatto, le sue fondamenta sono instabili. L’Uno lacaniano del Seminario XIX è rappresentabile, infatti, da una sacca vuota con un buco: «Si vous en voulez une figure, je représenterais le fondement du Yad’lun comme un sac. Il ne peut avoir l’Un que dans la figure d’un sac, qui est un sac troué» (Lacan, 2011 p. 147) [1]. Insomma, di questo Uno non si sa mai quanto ce n’è davvero dentro al sacco.
[1] Se volete una figura, io rappresenterei il fondamento di Yadl’un come un sacco. Non si può avere l’Uno se non dentro la figura di un sacco, che è un sacco bucato. (traduzione mia)
Non è un caso che l’Uno di Lacan sia inavvicinabile dal linguaggio ordinato dell’istituirsi del simbolico e che lo psicoanalista francese idei proprio per questo Uno il neologismo yadlun. Questo ci porta nella dimensione della lalangue (che Leoni incrocia nell’indagine su grido e voce nel capitolo otto) di una lingua primitiva rispetto all’intervento regolativo e differenziante del simbolico, capace dunque di mostrare, più che significantizzare, l’ambigua e inafferrabile consistenza di questo Uno.
E se Leoni ci indica un modo per immaginare come un soggetto venga fuori da questo Uno è attraverso l’immagine di un piano che si piega su se stesso, producendo una singolarità in continua trasformazione, la soggettivazione sempre in divenire. È così che il soggetto appare come una monade, piega e unità singolare in cui tutto il mondo si inclina attraverso quel particolarissimo vertice che è il fantasma, meccanismo di cornice-interfaccia della realtà e allo stesso tempo suo assemblaggio. Il fantasma è, infatti, già nella riflessione lacaniana, la dimensione che permette al soggetto di aprire una vasta gamma di possibili incontri con l’oggetto piccolo a. S◊a, il matema del fantasma che Lacan (2013) indica nel Seminario VI, va a significare proprio questo: il punzone ◊ che contiene in sé più simboli (maggiore, minore, et, vel) rappresenta la plurimità delle possibilità di rapporto fra il soggetto diviso (S) del desiderio e l’oggetto causativo del desiderio, l’oggetto piccolo (a), resto di una delle forme dell’Uno lacaniano, Das Ding, la Cosa perduta per sempre dal soggetto nella rimozione originaria.

Certo, ogni singolarità, ogni soggetto non può solo creare a partire dal suo fantasma ed è inevitabilmente posto sotto il giogo della legge della coazione a ripetere. Eppure, partendo da una sorta di teoria della registrazione, Leoni nell’ottavo capitolo mette in luce come anche la più fedele registrazione sia in qualche modo una deformazione, un cambiare strada, un de-viare dall’originale (Leoni 2019 p.129). In questo senso ci viene da suggerire l’associazione a un pensatore a suo modo decisamente perverso, William S. Burroughs, che insisteva sul ruolo dello scrittore come registratore, come supporto apparentemente passivo degli avvenimenti della realtà: “Uno scrittore può scrivere soltanto di una cosa: di quello che c’è davanti ai suoi sensi al momento di scrivere… Sono uno strumento di registrazione… Non presumo di imporre una “storia”, una “trama”, una “continuità”…” (Burroughs 1959 p. 199). Nonostante ciò, la vera operazione di Burroughs non si risolveva qui: lo scrittore per lui non si può limitare a ripetere a pappagallo ciò che della realtà si imprime su di lui ma ricostruisce e trasforma il testo della realtà attraverso tagli, sovrapposizioni e giustapposizioni attraverso cui inserisce nella ripetizione un brulicante continuo differenziarsi dentro al testo stesso attraverso la tecnica del cut-up, in cui il testo viene tagliato e poi ricomposto, e la tecnica del fold-in, dove, ancor più significativamente, il testo viene piegato su se stesso.
Pieghe e monadi, dunque, sono le forme filosofiche attraverso le quali Leoni ci vuole restituire una visione della soggettivazione vista dalla prospettiva di una scienza dei fantasmi, delle singolarità. Quello che si configura in questa scienza dei fantasmi è una posizione etica (Leoni p. 105) per indagare il soggetto nella sua prospettiva singolare a partire da una presa in carico del fantasma da cui lo si guarda, indicazione questa preziosa anche per la clinica. Scienza assolutamente soggettiva da una parte e dall’altra, invece, “unica scienza rigorosa”, con le parole di Husserl, perché consapevole di indagare il fantasma a partire da una cornice che è già a sua volta un fantasma:
Che cosa sa, infatti, la scienza del fantasma? Che il fantasma è tanto il fantasma “verso cui” essa guarda per scrivere e descrivere, come suo oggetto di studio; tanto il fantasma “da cui” essa scrive e grazie a cui essa descrive ciò che descrive; quanto il fantasma “in cui” essa scrive, cioè lo spazio e l’esigenza e lo strumentario e la ragnatela di strade resesi possibili, entro cui la sua scrittura, la sua descrizione si muove.” (Leoni 2019 p. 105)
Dunque, la scienza del fantasma auspicata da Leoni sarebbe una scienza capace di mettere in luce la cornice verso cui si tende nella scrittura, la cornice “oggetto di studio”, ma anche la cornice da cui si scrive (in qualche modo, un riconoscimento del fantasma dell’autore) ma soprattutto “ragnatela di strade resesi possibili”, l’esplicazione effettiva “in cui” questa scienza scrive e si dipana. È in questo senso che il testo propone non solo una questione “epistemologica” ma soprattutto una dimensione etica, di riconoscimento e di accoglimento del fantasma singolare all’interno dell’elaborazione del pensiero, che ne è la cornice stessa ma che costituisce anche il metodo di assemblaggio degli oggetti di studio, modificandoli.
A partire dalla definizione di questa scienza, Leoni negli ultimi capitoli del libro ci permette di vedere almeno due vertici a partire dai quali si può fare una scienza di fantasmi. Da una parte troviamo il filosofo “perverso”, che dopo Nietzsche è costretto a confrontarsi con la morte di Dio e alle nuove possibilità che gli sono date da scriversi. In qualche modo il filosofo perverso è un filosofo della contingenza lacaniana, colui che fa passare “ciò che non cessa di non scriversi” al “ciò che cessa di non scriversi”. Dall’altra, invece, in una posizione differente da quella del filosofo troviamo lo psicoanalista, che può manifestarsi attraverso più forme di singolarità: cadavere, santo (saint homme) e addirittura idiota. A differenza del filosofo, che fa emergere nuovi possibili attraverso assemblaggi fantasmatici, nella posizione di colui che “crea”, lo psicoanalista si pone in una posizione di annullamento, di “cadaverizzazione”, per permettere all’analizzante di incontrare e attraversare il suo proprio fantasma singolare.
Una scienza di fantasmi, per concludere, è un libro che, fedele alla scena carrolliana descritta da Deleuze in Logica del senso, ci mostra uno scorrere obliquo e continuo di Uni, oggetti, figure, disegnando una ragnatela di associazioni attraverso le quali si inizia a vedere un fantasma emergente, una cornice ritmica. Questo testo vuole già essere, dunque, una messa alla prova di una possibile scienza dei fantasmi che animano il soggetto, lasciando libero di emergere, unico e singolare, un fantasma che anima la complessa struttura del testo:
Ciò che essa sa, e insieme ciò che essa fa, è conoscere e perciò spostare l’oggetto. Non si può conoscere il fantasma senza spostarlo. In parte perché lui stesso è mobile, metamorfico, consegnato a una perenne fibrillazione dei disparati che lo compongono. In parte perché noi stessi siamo mobili, noi che lo studiamo, noi con la nostra scienza del fantasma, la scienza stessa del fantasma che non è mai di fronte al fantasma ma è sempre spinta dal fantasma e immersa nel fantasma, dunque che è fantasma a tutti gli effetti. Se così è, la scienza del fantasma è un’arte che accompagna. (Leoni 2019 p. 105)
di Lorenzo Curti
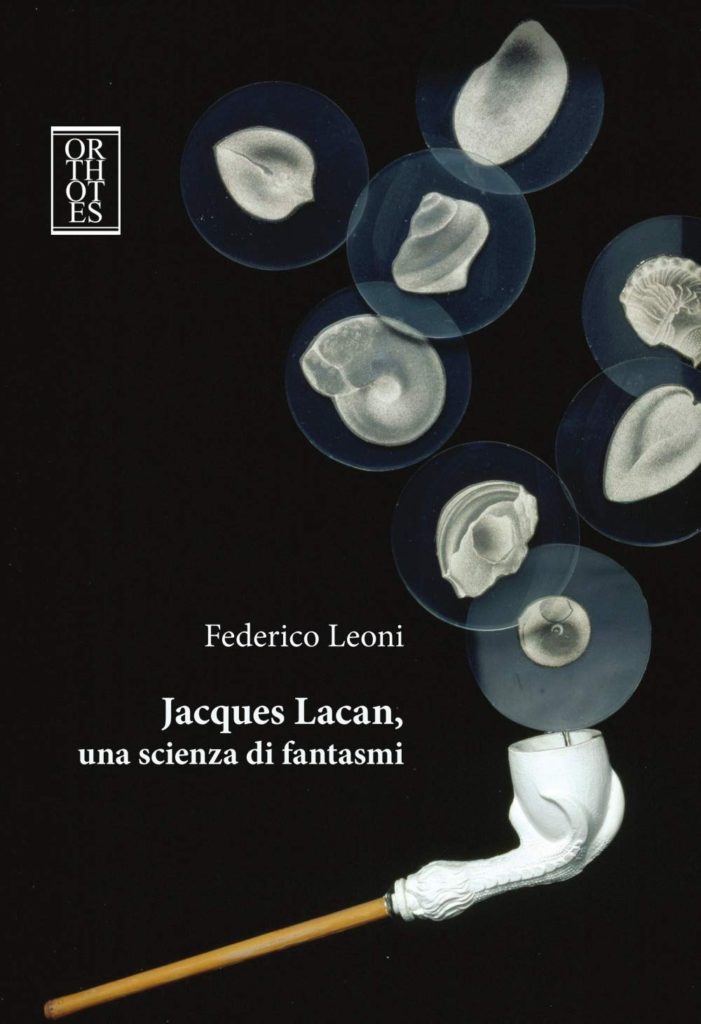

 Se volessimo individuare le idee che si collocano alla base della nascita della filosofia in India dovremmo articolare un discorso attraverso tre passaggi tra loro collegati. Innanzitutto dovremmo dire che i testi radicali della riflessione filosofica indiana, le Upaniṣad, sono interamente pervasi dalla ricerca della corrispondenza tra macro e micro cosmo. Questa istanza di unità diventò però immediatamente l’occasione per riflettere su due problemi interconnessi. Il primo problema è quello che in occidente definiremmo del “trascendentale”, intendendo con ciò un’anticipazione della visione kantiana secondo cui la realtà empirica è soltanto la forma in cui la realtà essenziale si presenta alla coscienza, ma tale realtà empirica non sussiste indipendentemente da una coscienza. In tempi antichissimi, intorno al secondo millennio avanti Cristo, tale visione della correlazione tra coscienza e mondo e insieme della necessità di un suo superamento verso una dimensione unitaria dell’esperienza divenne manifesta ai veggenti vedici assisi in meditazione nelle foreste indiane. Le Upaniṣad dettero il nome di ātman (letteralmente: “sé”) alla scoperta di questo principio trascendentale. Da un punto di vista metafisico l’ātman è un principio reggitore e ordinatore dell’universo e, quando viene considerato come Sé universale, possiede anche un aspetto psichico che lo rende auto-cosciente del tutto. Il punto centrale di questo primo aspetto della riflessione indiana delle origini è quindi l’identificazione del cosmico con lo psichico, nel senso che l’ātman si configura come un assoluto che possiede insieme i caratteri dell’essere e del pensiero. La coscienza-ātman non ha quindi niente fuori di sé, e tutti gli oggetti e le relazioni dell’universo esistono solo in quanto oggetti-di-conoscenza. Questo quadro concettuale, che possiede una innegabile connotazione trascendentalista, compare per la prima volta nella Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad (tra il IX e l'VIII secolo a.C), attraverso il punto di vista del maestro Yājñavalkya [1] e sarà una delle direttrici principali della riflessione filosofica indiana matura. Durante il periodo classico della filosofia indiana (V-VIII secolo d. C.) – in cui troviamo dei sistemi filosofici distinti che però condividono alcune idee di base che provengono dalla fase upaniṣadica – portato fondamentale di tale concezione trascendentale sarà il concetto di māyā, ovvero 1) il fatto che il mondo empirico sia “apparenza”, dal momento che non è possibile conoscere la reale essenza delle cose, e 2) che la pluralità non sia reale in senso proprio, dal momento che solo l’unità è reale, e questa unità è l’unità della coscienza, cioè dell’ātman. [2]
Se volessimo individuare le idee che si collocano alla base della nascita della filosofia in India dovremmo articolare un discorso attraverso tre passaggi tra loro collegati. Innanzitutto dovremmo dire che i testi radicali della riflessione filosofica indiana, le Upaniṣad, sono interamente pervasi dalla ricerca della corrispondenza tra macro e micro cosmo. Questa istanza di unità diventò però immediatamente l’occasione per riflettere su due problemi interconnessi. Il primo problema è quello che in occidente definiremmo del “trascendentale”, intendendo con ciò un’anticipazione della visione kantiana secondo cui la realtà empirica è soltanto la forma in cui la realtà essenziale si presenta alla coscienza, ma tale realtà empirica non sussiste indipendentemente da una coscienza. In tempi antichissimi, intorno al secondo millennio avanti Cristo, tale visione della correlazione tra coscienza e mondo e insieme della necessità di un suo superamento verso una dimensione unitaria dell’esperienza divenne manifesta ai veggenti vedici assisi in meditazione nelle foreste indiane. Le Upaniṣad dettero il nome di ātman (letteralmente: “sé”) alla scoperta di questo principio trascendentale. Da un punto di vista metafisico l’ātman è un principio reggitore e ordinatore dell’universo e, quando viene considerato come Sé universale, possiede anche un aspetto psichico che lo rende auto-cosciente del tutto. Il punto centrale di questo primo aspetto della riflessione indiana delle origini è quindi l’identificazione del cosmico con lo psichico, nel senso che l’ātman si configura come un assoluto che possiede insieme i caratteri dell’essere e del pensiero. La coscienza-ātman non ha quindi niente fuori di sé, e tutti gli oggetti e le relazioni dell’universo esistono solo in quanto oggetti-di-conoscenza. Questo quadro concettuale, che possiede una innegabile connotazione trascendentalista, compare per la prima volta nella Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad (tra il IX e l'VIII secolo a.C), attraverso il punto di vista del maestro Yājñavalkya [1] e sarà una delle direttrici principali della riflessione filosofica indiana matura. Durante il periodo classico della filosofia indiana (V-VIII secolo d. C.) – in cui troviamo dei sistemi filosofici distinti che però condividono alcune idee di base che provengono dalla fase upaniṣadica – portato fondamentale di tale concezione trascendentale sarà il concetto di māyā, ovvero 1) il fatto che il mondo empirico sia “apparenza”, dal momento che non è possibile conoscere la reale essenza delle cose, e 2) che la pluralità non sia reale in senso proprio, dal momento che solo l’unità è reale, e questa unità è l’unità della coscienza, cioè dell’ātman. [2] Che questo bel libro di Federico Leoni si ponga al crocevia di discussioni vitali nel moderno dibattito filosofico lo si intuisce già dal titolo,
Che questo bel libro di Federico Leoni si ponga al crocevia di discussioni vitali nel moderno dibattito filosofico lo si intuisce già dal titolo, 

